L'editoriale di ateatro 96
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and1
Speciale referendum costituzionale 2006: una sana e robusta Costituzione (parte I)
Un documento inedito misteriosamente recapitato alla readazione di ateatro
di Paolo Rossi di fronte alla Commissione per le Attività Anticostituzionali
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and2
Speciale elezioni 2006: lo spettacolo e i partiti (parte II)
Il teatro nella campagna elettorale 2006: lo speciale di "Hystrio"-ateatro
di Anna Chiara Altieri e Mimma Gallina
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and3
Speciale elezioni 2006: l'onorevole Gabriella Pistone in esclusiva per "Hystrio"-ateatro
I Comunisti Italiani e lo spettacolo dal vivo
di Anna Chiara Altieri e Mimma Gallina
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and4
Speciale elezioni 2006: l'onorevole Gabriella Carlucci in esclusiva per "Hystrio"-ateatro
La politica di Forza Italia per il teatro e la nascita del nuovo teatro stabile privato della Puglia
di Mimma Gallina
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and6
Semplicemente complicato (Parte III)
Un incontro con Luca Ronconi
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and8
Il Progetto Domani di Luca Ronconi: un teatro delle idee contro l’espropriazione della storia e dell’economia
Intorno a due spettacoli anomali: Il silenzio dei comunisti e Lo specchio del Diavolo
di Andrea Balzola
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and9
Le collezioni teatrali di Rosa e Ballo
Una casa editrice degli anni '40 in mostra a Milano
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and15
Le recensioni di ateatro: La pecora nera di Ascanio Celestini
L'elogio funebre del manicomio elettrico
di Valeria Ravera
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and60
Le recensioni di ateatro: Come uccidere causando inutili sofferenze con Daniele Luttazzi
Monologo scritto e interpretato da Daniele Luttazzi
di Sara Ficocelli
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and61
Adelaide Ristori a cento anni dalla morte
Un convegno a Cividale del Friuli
di Angela Felice
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and80
Harold Pinter alla X Edizione del Premio Europa per il Teatro
A Torino dall'8 al 12 marzo
di Ufficio Stampa
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and81
Corso di Alta Formazione sul Teatro di Figura
Le iscrizioni aperte fino al 15 marzo
di Atelier Teatro di Figura di Cervia
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and8
"Dionisi" cercano azionisti per nuova produzione
Una buona pratica? Una pratica praticabile?
di Renata Ciaravino, Valeria Talenti e tutti i dionisi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and83
Studio Azzurro manda Galileo all'inferno
Il debutto del nuovo lavoro a Norimberga
di Studio Azzurro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and84
La discussione sugli spettacoli di Ronconi a Torino
L'editoriale di ateatro 96
di Redazione ateatro
Nel forum divampa la discussione sugli spettacoli ronconiani a Torino, che certamente costituiscono l'evento teatrale della stagione.
Di Ronconi e delle Olimpiadi ateatro ha già scritto in più occasioni, e anche in questo numero gli dedichiamo ampio spazio. Ma la discussione resta ovviamente aperta. Per impostarla in maniera corretta ci sembra oppurtuno cercare di fissare alcuni punti fermi.
1. Ronconi è senza dubbio il migliore regista attualmente in attività. Come tutti, fa spettacoli più o meno belli, più o meno riusciti: inutile ricordare tutti i suoi capolavori, che in questi decenni hanno senza dubbio segnato e trasformato il teatro (non solo italiano), il rapporto con il testo e lo spazio, il rapporto con il pubblico. Se bisognava scegliere un uomo di teatro cui affidare un progetto che rappresentasse l'Italia nell'occasione olimpica, Ronconi era il candidato numero uno.
2. Non di ateatro vogliamo dare meno soldi alla cultura e al teatro. Anzi, pensiamo sia necessario dargliene di più (a cominciare dai reintegro del FUS e dall’1% del PIL alla cultura, che sono le nostre parole d’ordine in campagna elettorale). Infatti pensiamo si tratti di un buon investimento sul nostro futuro. I 7 (o 10?) milioni di euro per un’iniziativa teatrale di ampio respiro non ci scandalizzano, anzi. Ciò non toglie che possiamo amare (e infatti amiamo) anche spettacoli poverissimi. Tuttavia decidere che tutto il teatro deve essere miserabile, ci pare vuoto moralismo.
Insomma, è bene che si spendano soldi - i nostri denari di contribuenti - per il teatro. L'importante è che questi soldi vengano spesi nella maniera migliore: di questo si dovrebbe discutere.
3. All'annuncio del Progetto Domani (e dei costi dell'operazione) ateatro70 (giugno 2004) ha ospitato una lettera aperta di Mimma Gallina e Oliviero Ponte di Pino indirizzata a Luca Ronconi (ma in realtà a tutto il teatro italiano) , dove si ponevano alcuni ingenui interrogativi e si tentava di aprire una discussione sulle opportunità offerte dagli spettacoli olimpici. Inutile dire che la nostra provocazione è caduta nel vuoto e che nessuno di quelli che oggi sembrano così scandalizzati (ma che nel forum in genere si nascondono nell'anonimato) ha osato dare un qualche contributo costruttivo (ammesso che quelli attuali siano veri contributi e non sfoghi...).
Insomma, è inutile attaccare adesso il Progetto Domani, e per di più spesso in maniera generica e con squittii da verginelle. Bisognava farlo al momento giusto, quando poteva servire a qualcosa.
Se lo si fa adesso, a bocce ferme, bisogna entrare nel merito. Questo vuol dire due cose: entrare nel merito degli spettacoli, entrare nel merito dei loro conti economici e delle ricadute dell’operazione, entrare nel merito del progetto ronconiano nel suo insieme. Insomma, si tratta di valutare obiettivi e risultati.
4. Per cominciare bisogna riconoscere che gli spettacoli sono andati tutti in scena (la trilogia di Bond è stata bloccata dal malanno di Massimo Popolizio), e già questa è stata un’impresa titanica. Che si tratta di spettacoli di grande qualità, a volte molto belli. Che rientrano in un progetto complessivo, che ha al suo centro la scommessa che il teatro possa confrontarsi con i grandi temi dell’attualità e della politica: la guerra, che è la grande ossessione degli spettacoli ronconiani di questi anni; il rapporto della sinistra con la propria storia; la finanza; la bioetica. Insomma, non si è trattato in nessun caso di spettacoli d’evasione, e men che meno di opere create all’insegna dell’arte per l’arte.
Dopo di che, si può naturalmente discutere di tutto, come sempre. Se possibile senza essere troppo generici (e anonimi).
Anzi, ne discuteremo senz'altro. Perché a Torino, al di là delle Olimpiadi (che hanno fatto fare bella figura alla città e all'Italia), sono successe e stanno succedendo molte cose curiose e interessanti, proprio nel campo dello spettacolo: la ristrutturazione e l'apertura di nuovi spazi per il teatro, il progetto di fusione tra lo stabile e il Regio (ovvero tra la prosa e la lirica), la fondazione di una casa per il teatro ragazzi...
Perciò pensiamo di dedicare, in uno dei prossimi ateatro, un approfondimento sulla situazione torinese, e sul progetto di rilancio di una metropoli ex-industriale e automobilistica in un polo culturale, e sulle possibili ricadute, anche occupazionali, di questo "laboratorio" (se ne sta già parlando nelforum...).
Così, se avete qualche contributo da dare alla discussione (che proprio su questo nodo si è acceso), siamo a disposizione.
Speciale referendum costituzionale 2006: una sana e robusta Costituzione (parte I)
Un documento inedito misteriosamente recapitato alla readazione di ateatro
di Paolo Rossi di fronte alla Commissione per le Attività Anticostituzionali
La rivista teatrale online www.ateatro.it ha ricevuto, in forma anonima, questo testo.
Riteniamo si tratti del verbale d’interrogatorio dell’attore comico Paolo Rossi, condotto da una sedicente “Commissione per la Attività Anticostituzionali”, in data imprecisata, ma probabilmente pochi mesi prima dell’incoronazione di Berlusca I.
Il documento non ha alcun valore legale, ma ci sembra ugualmente opportuno metterlo a disposizione dei lettori. Ripercorre infatti la carriera del notorio sovversivo teatrale Rossi, evidenziando le sue attività estremistiche, dai tempi della prima giovinezza fino a epoche più recenti.
La lettura di questo testo e dell’allegato cartaceo, così come la visione del filmato allegato, va condotta con cautela: è riservata ad adulti che abbiano superato tutti i test di affidabilità politica del nostro beneamato Ministero per l’Ordine e la Pacificazione.
Abbiamo tuttavia ritenuto opportuno darne ampia diffusione, sia sul sito sia nelle librerie (BUR senzafiltro).

Per ulteriori informazioni su Paolo Rossi, consulta a ateatropedia.
Dichiaro aperta la sessione odierna della Commissione per le Attività Anticostituzionali. Si faccia accomodare il nostro ospite. Dunque, può per favore declinare le sue generalità?
Mi chiamo Paolo Rossi.
Luogo di nascita?
Monfalcone.
Data di nascita?
22 giugno ’53
Professione?
Sulla carta d’identità, “attore di prosa”.
Questo significa che non si tratta della sua vera professione? Quella di “attore di prosa” è dunque un’attività di copertura?
E' la dicitura ufficiale, quella che capiscono i Carabinieri. Non credo che sulla carta d’identità "comico" suoni bene, e penso che "guitto" non sia contemplato in nessun albo professionale o sindacale. Quindi "attore di prosa" va bene, anche perché effettivamente di prose ne ho fatte tante.
Nazionalità?
Italiana. Tenendo presente che sono nato a venti minuti dalla ex-Jugoslavia... Io la chiamo ancora così.
Con questa precisazione, che cosa ci vuol significare?
Con questo il sottoscritto vuol significare che dalle nostre parti il senso della nazione, come spesso capita nelle zone di confine, viene più sentito.
Mi sta cercando di dire che lei è un acceso nazionalista?
No, assolutamente. Ho il senso della comunità, più o meno come lo dovrebbe avere chi fa parte di un corpo. I piedi e la testa solitamente sentono di più i malesseri, li avvertono per primi.
Volendo seguire la sua bolsa metafora, i comici sarebbero i piedi o la testa di questo corpo?
Dipende dal tipo di comicità che praticano. Se scelgono una comicità di testa, sono dei comici di testa. Se scelgono una comicità di stomaco - e mi accorgo che suona come un paradosso - sono dei comici di piedi.
Procediamo con un paio di domande preliminari. Lei a questo punto garantisce di essere in pieno possesso delle sue facoltà mentali e di essere in grado di rispondere alle nostre domande?
Nella mia professione, anche se questo non è scritto in nessun albo e in nessun regolamento deontologico, è implicito il fatto tacito - insomma, lo si sa... - che non sempre la migliore comunicazione avviene nel pieno possesso delle facoltà mentali. A volte, pur perdendo momentaneamente le facoltà mentali nell’atto della performance, si hanno dei risultati di sincera comunicazione.
Lei pensa che potremmo avere dei momenti di sincera comunicazione nel corso di questo interrogatorio?
Credo di sì. Comunque non dipende solo da me.
La seconda domanda preliminare che le dobbiamo porre, in questa nostra amichevole conversazione, riguarda il suo stato di salute. Mi sembra che in questo momento lei dimostri una sana e robusta costituzione fisica.
Ho una buona costituzione. Del resto deve tener presente - e questo è l’altro motivo per cui ho fatto quella precisazione sul mio luogo di nascita - che molto spesso nelle zone di confine si creano dei meticciati. E come lei sa quanto me, i bastardi, anche tra i cani, sono più sani e forti dei cuccioli di razza.
Non cerchi di sviare il discorso con questi deliri multiculturali. Non lo sa che la propaganda multietnica è diventata reato? Ma passiamo oltre. La nostra impressione è che quando lei sostiene di avere “una buona costituzione” già ponga le basi per un conflitto di interessi, visto il suo costante impegno sul tema - appunto - della Costituzione.
Non è un conflitto di interessi, questo. Entrambi questi interessi li coltivo per gli altri, non per me. Io pratico un’attività che è rivolta agli altri e quando penso a cosa proporgli devo pensare a quale problema, a quale conflitto stanno vivendo gli altri.
A questo punto è giunto il momento di illustrare nei dettagli il reato per cui lei è stato convocato di fronte a questa Commissione. Lei, dopo attenta visione da parte nostra della registrazione dello spettacolo intitolato Il signor Rossi e la Costituzione (qui allegata), è sospettato di difesa aggravata e continuata della nostra Costituzione, da solo e soprattutto in associazione con altri, con vari atti e comportamenti. Ci pare che si configurino anche i reati di adunata sediziosa e di associazione per delinquere, visto che questa attività lei l’ha condotta con la complicità di un gran numero di persone, sia sul palco sia in platea. Signor Rossi Paolo, lei si dichiara colpevole o innocente di questi capi d'imputazione?
Assolutamente innocente, perché c’è un articolo della Costituzione che dice chiaramente che ci si può riunire dopo aver avvisato e aver avuto il permesso.
Eccolo qui, articolo 17: “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”. Questa però è la vecchia Costituzione.
In che senso, la vecchia Costituzione? No, questo è un punto che non è stato toccato.
Questo lo dice lei...
In effetti la nostra Costituzione cambia ogni giorno, ma mi pare che fino all’altro ieri fosse ancora permesso riunirsi, dopo preavviso. E io quando faccio teatro avviso sempre. Prima del debutto, in ogni città, faccio le interviste, metto i manifesti, chiedo i permessi SIAE. Sono in grado di produrre tutta la documentazione necessaria.
Quindi lei ritiene di aver svolto la sua attività di difesa della Costituzione in maniera legale?
Assolutamente legale.
Ora ci piacerebbe fare qualche passo indietro per capire come le è stato possibile arrivare fino a questo punto. Vorrei che lei riassumesse brevemente la sua carriera e la sua biografia. Altrimenti ci è molto difficile capire come un "guitto" - usiamo questa terminologia, visto che ci sembra che le piaccia - finisca per occuparsi di faccende serie e importanti, con un ampio seguito popolare.
Perché uno va a difendere la Costituzione? Beh, è molto semplice. Partiamo dal mio mestiere. Io lavoro molto su...
Calma, calma. Procediamo con ordine, le domande le facciamo noi. Per esempio, a scuola seguiva le lezioni di Educazione civica?
Fino alla seconda superiore in Educazione civica e in Condotta ho sempre avuto il massimo dei voti. Poi, quando qualcuno non ha più rispettato l’Educazione civica, anche i miei voti in Condotta si sono gravemente abbassati.
Mi sembra che siamo - dal punto di vista della cronologia - all’inizio degli anni Settanta.
Diciamo che è l'età in cui un ragazzo incomincia a occuparsi dei problemi che ci sono fuori dalla scuola, partendo dai problemi che ci sono nella scuola.
Lei ha sempre desiderato fare l’attore comico? Oppure c’erano altri mestieri che la affascinavano, altre professioni che la interessavano?
Credo di essere stato - almeno inconsciamente - sempre desideroso di fare questo mestiere, anche perché non sapevo quale strada scegliere.
In effetti abbiamo qui un brano della registrazione di un suo vecchio spettacolo: “Quando ero bambino e ci chiedevano: ‘Cosa vuoi fare da grande?’, i miei amici rispondevano: ‘Il medico’ oppure ‘L’ingegnere’. Io invece dicevo: ‘La testa di cazzo’. Sono l’unico che ce l’ha fatta”. Complimenti. Ma quel è il suo titolo di studio?
Perito chimico.
Verbalizziamo. Perché ha scelto quel tipo di studi?
Perché in quel periodo, ripeto, non avevo ambizioni particolari.
Però, ottenuto quel diploma le sarebbe stato possibile gestire una raffineria di droga, un’attività rispettata e redditizia, o magari...
...beh, lì si impara anche a far saltare in aria un ponte...
Non suggerisca, lo sappiamo benissimo anche noi.
Esperti, vero?
Insomma, ci sono diverse attività di interesse collettivo alle quali un perito chimico si può utilmente applicare...
Tuttavia ho ritenuto fosse più utile portare quei cinque anni di studi di chimica in un’altra professione, rispetto alle onorate carriere che mi state citando. Devo riconoscere che posso anche averci pensato, a quelle professioni alternative: lo so anch’io che un chimico può maneggiare droga e esplosivi. Tuttavia, sapete, io sono piuttosto maldestro e tengo fede alla parola data...
Non ci risulta siano qualità molto apprezzate sui palcoscenici.
Lasciatemi spiegare. Vedete, fortunatamente oggi la scuola italiana non è molto diversa da allora.
Per fortuna oggi è assai peggiorata...
In effetti sì, per fortuna vostra e per sfortuna di altri, per esempio me e i miei figli... Ma insomma, in terza media sulla mia pagella c’era scritto più o meno questo: "Il ragazzo è seriamente portato per lettere, storia, musica ed educazione artistica".
Quindi lei per lo spirito di contraddizione che da sempre la caratterizza ha voluto studiare da perito chimico.
No, è che poi l’indirizzo che mi hanno consigliato, dato il tenore di vita della mia famiglia, era "Istituto tecnico industriale". Evidentemente già pensavano che i miei genitori non avrebbero potuto mantenermi all’università.
Non divaghi! Le condizioni economiche della sua famiglia non costituiscono un’attenuante. Il mondo è pieno di gente povera e onesta, e non si lamentano per questo ma lavorano e si impegnano per dare il loro contributo alla società! Allora, perché mai lei, con un diploma di perito chimico, è finito a fare il guitto?
Ripeto: essendo io maldestro e avendo avuto sempre un rapporto onesto con i professori, ho semplicemente mantenuto la parola data.
Si vuole spiegare?
All’esame di diploma di perito chimico, l’unica domanda a cui ho risposto correttamente è stata l'ultima, quella fondamentale. Dopo che era finito l’altro interrogatorio, quello sulle materie d’esame, il professore mi ha domandato: "Bene, ma ci assicura che lei non entrerà mai in uno stabilimento chimico?" La mia risposta è stata decisa: "Sì". "Bene, promosso, 36 sessantesimi". Però quei cinque anni di chimica mi sono rimasti, e qualcosa di quegli studi l’ho riportato probabilmente anche nell’approccio che ho al mio mestiere.
Inutile precisare, in questi anni ce ne siamo resi conto: qualcuno deve anche averlo scritto che il suo è un talento teatrale “esplosivo” e “stupefacente”... Del resto è un po' che la teniamo d'occhio, sa? A quel punto, ottenuto il diploma di perito chimico, come ha deciso di intraprendere quella che poi sarà la sua definitiva professione? E' stata la sua esibizione all'esame di maturità a far sbocciare la vocazione di cabarettista?
No, no. A quel punto...
Siamo esattamente nel...
Nel ’73-74 mi sono trasferito da Ferrara a Milano, e mi sono iscritto all'università. Facoltà di scienze politiche. Vede che anche la chimica comincia ad avere un senso...
Beh, per alcuni chimici è stata una stagione interessante...
Era un bel periodo anche per entrare a Scienze politiche! Ma ho avuto un problema di adattamento: non riuscivo ancora a capire cosa volevo fare. Allora come tutti i ragazzi di quell'età sono andato al Distretto militare di Bologna per chiedere il rinvio del servizio militare. Ma non avendo io in quel periodo né idee precise, né una ragazza o fidanzata, né legami particolari con chicchessia, ho deciso.. Insomma, il destino mi ha dato una mano: invece di prendere il modulo per il rinvio della partenza, mi sono ritrovato in mano quello per la partenza anticipata volontaria. L’ho preso come un segno del destino e sono partito militare. Mi mandarono nel genio pionieri, dove avrei avuto di nuovo a che fare con gli esplosivi... Fortunatamente per il sottoscritto e per l'esercito italiano, il giorno stesso della partenza mi ammalai di varicella, per cui ripartii tre o quattro mesi dopo: questa volta nei carristi. La specializzazione non aveva più direttamente a che fare con i miei studi, era legata piuttosto alla mia altezza. Vorrei comunque precisare che dal servizio militare mi sono congedato con il grado di sergente.
Come mai le forze armate hanno avuto questa fiducia nelle sue doti di comando?
Nei carri armati, come sa, bisogna essere piccoli. Io comandavo sei sardi ancora più piccoli di me.
E non avete per caso incontrato Biancaneve?
No, in compenso credo di aver dato un'ottima dimostrazione della mia perizia guerresca: durante un’esercitazione mi sono perso con un carro armato. A mia discolpa posso assicurarvi che già in un carro armato si sente poco, e poi parlare con sei sardi con cui non condividevo il dialetto... Vorrei vedere lei! Insomma, è stato facile smarrirsi. Credo che il contadino a cui ho chiesto, dopo essere sceso dal carro, dove stava Rivarolo Canavese si ricorderà di noi per tutta la vita. Forse avrà pensato a un golpe o qualcosa del genere.
Non cerchi di annettersi benemerenze che non ha. Il golpe è una cosa seria. Va programmato e praticato dai professionisti! Fortunatamente, dopo questa brillante campagna militare, il sergente Paolo Rossi è tornato alla vita civile.
Tuttavia c’è un episodio importante legato al mio servizio militare: ma non sono state né le guardie in polveriera, né i campi, né l’addestramento. A un certo punto all’interno della caserma si organizzò uno spettacolo, una specie di rivista.
Ottima idea: uno spettacolo leggero per allietare le truppe!
...e fatto dalle truppe medesime. Si doveva intitolare Regimental, me lo ricordo ancora oggi.
Regimental come le cravatte?
Abbiamo evidentemente riferimenti culturali diversi: Regimental come Sentimental di Wanda Osiris. Ci tenevo molto a partecipare, ma al provino non mi hanno preso. La cosa mi ha molto indispettito, per cui appena congedato mi sono detto: vista la miopia della gerarchia militare, che andava sempre al contrario, questa è una garanzia. Se gli ufficiali non mi ritengono adatto al teatro, può darsi che questa sia davvero la mia strada. Mi hanno dato un carro armato e ho combinato quello che ho combinato. Adesso che non mi hanno fatto fare neppure una particina nella rivista, neanche come comprimario, beh, vuoi vedere che forse questa è la mia vocazione?
In ogni caso, al di là di queste sue irriverenti e opinabili valutazioni sulla lungimiranza delle gerarchie militari, lei ha dedicato un anno della sua vita al servizio della patria. In quel periodo si riconosceva nei valori della Costituzione che trovano nell’Esercito una delle sue principali articolazioni?
Nel clima politico che vivevo all’interno di un’istituzione totale come la caserma, c’erano da gestire due o tre problemi più urgenti. Primo, difendersi dai nonni; ma per fortuna noi eravamo nella compagnia con il servizio d’ordine di Lotta Continua...
Ah, uno dei gruppi sovversivi degli anni Settanta...
Così il nonnismo è finito dopo mezz'ora circa, anzi si è verificato il fenomeno contrario, a essere vessati erano piuttosto i nonni. Il secondo problema, la sopravvivenza psicologica. Terzo, la sessualità. Credo comunque di aver superato tutte queste difficoltà, non sempre grazie al servizio d’ordine di Lotta Continua: alcuni problemi me li sono gestiti da solo...
Spero per lei! Ma a questo punto ci avviciniamo finalmente al suo ingresso nella professione.
Al mio ritorno alla vita civile ho cominciato a staccarmi dall’università. Il teatro è stato prima di tutto un lavoro, all'epoca non avevo ambizioni particolari. Ho lavorato con la compagnia di Gianni e Cosetta Colla, facevo l’attore, l’apprendista, il ragazzo tuttofare...
E ogni tanto anche il burattino?
Ogni tanto sì. Ho fatto anche l’orso nella Famosa invasione degli orsi in Sicilia...
Uno spettacolo per bambini, su testo di Dino Buzzati: abbiamo schedato persino quello. Che cosa faceva questo orso?
Io ero l’orso che moriva saltando in aria. Era un’invenzione di Gianni Colla: avevo delle piccole cariche di esplosivo e quando il burattino mi tirava la bomba io saltavo in aria nel tripudio dei bambini in platea, e sempre con una certa ansia da parte mia.
Già allora pervertiva le giovani generazioni con i suoi comportamenti da dinamitardo teatrale!
No, no, glielo ripeto: l’idea era di Gianni Colla, non mia. La sera lavoravo in un altro teatro, il CTH. E' allora che ho iniziato a praticare l’improvvisazione. In realtà facevo il tecnico luci, in un trittico che comprendeva Io maschista perché, Io sono lesbica e tu? e Dove vai gay?, insomma tre spettacoli sul tema della sessualità...
In quel caso le sue esperienze sessuali con il servizio d’ordine di Lotta Continua avrebbero potuto esserle d’aiuto!
In effetti il servizio d'ordine di Lotta Continua sarebbe stato utile: Io maschista perché venne interrotto dopo una mezza replica da sessanta femministe inferocite... Dopo quella esperienza ho iniziato a seguire i corsi di mimo serali alla Civica Scuola d'Arte Drammatica. O meglio, non era propriamente mimo, perché studiavamo anche Commedia dell’Arte e Storia del teatro. All'epoca c'erano i cosiddetti Gruppi di Base, si recitava nelle case occupate, si facevano i canzonieri popolari...
Inutile sottolineare la perniciosa insalubrità di quelle frequentazioni.
Dopo di che Dario Fo mi ha preso come mimo per L'Histoire du Soldat di Stravinskij, nel 1978. Però forse si era dimenticato che mi aveva scritturato come mimo, o forse per lui non c'era differenza tra attori e mimi. Fatto sta che, mentre molti attori furono relegati in ruoli di mimo, a me diede la parola.
Quindi il primo che le ha dato in scena la parola è stato un altro sovversivo, a noi peraltro ben noto, Dario Fo.
Sì, lo ammetto.
Quali sono state le sue prime parole sulla scena?
Erano in grammelot, fin da subito. Io tornavo al mio paese ma la gente non mi capiva, e io stesso parlavo una lingua che non capivo. E' una strategia cui sono rimasto fedele e che mi ha permesso di lavorare a Belgrado e in Romania, in Francia, Spagna o Polonia, senza conoscere la lingua ma parlandone sette contemporaneamente.
E' con questo improbabile credito formativo che lei ha iniziato a fare l’attore?
Sì, ho iniziato una carriera di attore "professionista", tradizionale. Ho lavorato al Teatro Gerolamo con Umberto Simonetta, al Teatro Stabile di Trieste con Vittorio Caprioli e Giorgio Pressburger: con loro ho fatto uno spettacolo dedicato alla vita e all’opera di Karl Valentin, l'ispiratore di un altro sovversivo, Bertolt Brecht. Poi sono finito a Empoli a lavorare proprio su Bertolt Brecht con Virginio Puecher e Cathy Berberian, e sono passato per lo Stabile di Como dove ho fatto Commedia dell’Arte con una parte del gruppo di Dario Fo. Poi sono arrivato all’Elfo...
Per fare?
Nemico di classe di Nigel Williams.
Regia di Elio De Capitani, 1984. con Claudio Bisio, Riccardo Bini, Antonio Catania, Sebastiano Flocamo.
Nel frattempo avevo fatto anche Il calapranzi di Harold Pinter al Teatro Officina.
Un altro pericoloso intellettuale noto per le sue sparate sovversive! Ma a quel punto lei aveva già iniziato a fare cabaret...
A quel tempo non mi preoccupavo di avere un mio stile teatrale o di seguire un genere preciso. Mi interessava fare esperienza, anche perché mi pesava un po’ il fatto di non aver frequentato una scuola di teatro. Come ho già confessato, il mio unico diploma era quello di chimico. Quindi l’unico modo per apprendere il mestiere era quello di fare molta pratica. Così ho cominciato a lavorare nei cabaret, nei locali sui Navigli. Nel giro di pochi mesi sono passato dal ruolo di presentatore in un locale di strip tease alla Tempesta di Shakespeare con Carlo Cecchi. Insomma, dal Marocco Club al Teatro Greco di Taormina.
Abbiamo preso qualche informazione su quel periodo. Nello spettacolo di Cecchi, nel 1985, lei interpretava il ruolo di Ariel.
Se posso facilitare il vostro compito, questo Ariel, anche se non usava l’esplosivo, faceva saltare in aria un bel po’ di roba!
(segue nel prossimo numero di ateatro...)
Speciale elezioni 2006: lo spettacolo e i partiti (parte II)
Il teatro nella campagna elettorale 2006: lo speciale di "Hystrio"-ateatro
di Anna Chiara Altieri e Mimma Gallina
Prosegue con questa seconda puntata l’inchiesta di “Hystrio”-ateatro sui programmi delle forze politiche per la cultura, in occasione delle elezioni politiche del 9 aprile. Dopo la prima puntata, ospitata su ateatro 95 e dedicata soprattutto alle forze della sinistra, allarghiamo l’orizzonte spostandoci verso il centro.
Una piccola annotazione, se ci è consentito: a Mira, alle Buone Pratiche 2, lo scorso novembre, dopo anni di tagli al FUS e alla cultura, avevamo lanciato lo slogan “Non si può essere ricchi e stupidi per più di due generazioni”, chiedendo che l’1% del PIL venisse destinato alla cultura. Ci sembrava una rivendicazione controcorrente e vagamente utopica, una provocazione contro una classe politica che considerava la spesa per la cultura un lusso che si poteva ridurre a volontà. Nel corso di questi mesi, sono diversi gli esponenti politici che hanno rilanciato questa parola d’ordine: per prima l’onorevole Vittoria Franco dei DS, e più di recente persino il sottosegretario Nicola Bono di AN. E se leggerete qui troverete altre tracce dell’1%.
Si tratta certamente di una coincidenza, ma la cosa ci fa ugualmente molto piacere. Anche se sappiamo che il lavoro duro comincerà dopo il 9 aprile: chiunque vinca, dovremo fare in modo - tutti insieme - che questo impegno venga mantenuto.
La Margherita a convegno
Nel corso della legislatura, pur essendo piuttosto attiva in materia nelle commissioni parlamentari, la Margherita non si è dedicata con particolare attenzione allo spettacolo.
Giovedì 23 febbraio ha però organizzato a Roma il convegno “Spettacolo e Industria Culturale nell’era digitale. Oltre il Fus, oltre l’incertezza”. Si è gentilmente offerta di farcene una sintesi Roberta Scaglione, che ringraziamo.
Nell’introduzione Andrea Colasio, Capo Gruppo Margherita VII Commissione Cultura, enuncia i punti fondamentali dell’agenda di programma:
• procedere ad una legge quadro entro 12 mesi;
• portare l’intervento dello Stato al 1% della spesa pubblica;
• attuare una strategia concertativa nella politica di regionalizzazione del FUS: ovvero lo stato deve tenere per sé la responsabilità di definire regole e criteri e delegare alle amministrazioni locali i processi e la gestione delle risorse;
• incentivare il rapporto con il mercato per incrementare la filiera delle risorse;
• valorizzare e sostenere le attività delle Fondazioni;
• regolare i rapporti con la pubblicità
Il breve discorso introduttivo di Colasio trova riscontro e approfondimento nella bozza di programma di cui di seguito i punti fondamentali:
• denuncia nei confronti della legislatura che sta volgendo al termine che a causa delle non scelte operate ha contribuito allo stato di assoluta criticità del settore: le ricorrenti decurtazioni del Fondo Unico dello Spettacolo hanno pregiudicato qualsiasi possibilità di definire una nuova progettualità per il teatro, la musica, la danza, il circo, lo spettacolo viaggiante e di razionalizzare ¬ in termini di efficacia la logica dell’intervento e dell’interesse pubblico;
• la dimostrata incapacità di gestire il riformato Titolo V della Costituzione ha provocato un’incertezza normativa permanente che ha impedito allo spettacolo di programmare pluriennalmente la propria attività, con conseguente condizionamento della tenuta economica e della capacità progettuale del sistema;
• l’intenzione è quella di realizzare un progetto credibile, articolato su pochi ma essenziali elementi, individuati come precipui dell’azione di rilancio dello spettacolo italiano. Pur nella consapevolezza delle attuali difficoltà economiche, l’intenzione è quella di operare un’inversione di tendenza dei flussi finanziari in favore delle attività culturali, procedendo ad una riqualificazione della dotazione del FUS per rimettere a regime il sistema dello spettacolo (con un incremento di almeno 100 milioni di euro) e iscrivendo gli stanziamenti per la cultura nel capitolo investimenti e non spese.
Altri nodi evidenziati:
• l’intento di ricondurre al Fus e a criteri di gestione unitaria e meno discrezionale le risorse del Lotto e di Arcus;
• prestare maggiore attenzione alle espressioni artistiche giovanili, in particolare alla musica contemporanea e alla danza […]. In questo senso si propone di canalizzare una quota delle risorse destinate alle Fondazioni liriche a favore del balletto;
• per le Fondazioni liriche, di cui si segnala la posizione di criticità, l’intenzione è di procedere provvedendo a criteri innovativi di gestione e razionalizzazione dei costi;
• segue nel piano di lavoro la piena attuazione della legislazione concorrente prevista dall’art 117 della Costituzione, dando corpo al federalismo solidale fra le regioni e lo Stato e valorizzando il ruolo fondamentale di province e comuni;
• gli impegni enucleati si correlano alla predisposizione di un testo unico dello spettacolo che raccolga, razionalizzi ed armonizzi tra loro i numerosi provvedimenti adottati nel tempo;
[…]
• applicazione degli strumenti del welfare agli addetti del settore favorendo il recupero di dignità e professionalità, con l’obiettivo del riconoscimento dell’impegno lavorativo di artisti, tecnici e organizzatori dello spettacolo.
Negli interventi dei molti operatori presenti vengono rimarcati i punti critici del sistema: ripartizione del Fus, incremento e certezza delle risorse, necessità di definire un assetto legislativo.
Dalle dichiarazioni della Margherita emergono alcuni elementi di divergenza rispetto alle posizioni di altre forze del centro-sinistra su alcuni punti chiave. Per quanto riguarda i finanziamenti, la Margherita intende portare la spesa per lo spettacolo all’1% della spesa pubblica (e non del Pil). Anche per il Fus ha obiettivi più modesti: Colasio propone di incrementarlo di 100 milioni di euro circa (485 milioni), non di riportarlo ai livelli del 2001 (con uno scarto di circa 50 milioni di euro), come proposto dai Ds e dallo stesso programma dell’Unione. Sostiene infine la "regionalizzazione" del Fus, contro cui hanno preso posizione Rifondazione Comunista e i Comunisti italiani.
I COMUNISTI ITALIANI E LO SPETTACOLO
Vedi l'intervista all'onorevole Gabriella Pistone su ateatro.
LA CASA DELLE LIBERTÀ
"Continueremo la realizzazione del piano decennale delle grandi opere e l'azione di valorizzazione dei beni culturali quale fondamento della nostra identità e volano di sviluppo economico"
. Nel programma notoriamente sintetico della Casa delle Libertà c’è solo questo.
Ma non è certo tutto qui: la politica della coalizione di governo si può analizzare a partire da quel "continueremo" - cioè da quello che si è fatto - ma anche da quello che non si è fatto, scoprendo sfumature non lievi fra le posizioni dei singoli partiti e persone.
L'era Urbani
Sarebbe un errore pensare - dopo il periodo frenetico Veltroni/Melandri - che la politica di Urbani sia stata dimessa, anche se l'opposizione in commissione cultura della Camera ha sottolineato più volte il ruolo residuale di un ministero devastato, che si è visto erodere progressivamente le risorse, e non solo quelle del FUS.
In realtà la politica di Urbani, interpretata, letta nella sua articolazione, risulta piuttosto decisa e coerente e a maggior ragione può sembrare preoccupante che se ne ipotizzi la continuità.
Partiamo dalle risorse: la diminuzione di quelle "ordinarie" è un dato di fatto, ma è in parte compensata da quelle straordinarie (Arcus per esempio, l'uso dell'8 per mille e del lotto) tanto che, prima degli ultimi tagli del FUS, la spesa del Ministero, in rapporto al famoso rapporto col PIL, sarebbe salita - dichiara Urbani non smentito - dallo 0,17% dell'ultimo anno del governo di centro sinistra allo 0,18% del 2003. La particolarità delle risorse straordinarie sta nel fatto che la gestione è sottratta a qualunque regolamento, dipende direttamente dalla scelte del Ministro. E questo centralismo è probabilmente il segno principale della politica di Urbani, assieme al richiamo alla privatizzazione (rimasto però sostanzialmente sulla carta nel settore spettacolo).
Elenchiamo qualche azione del governo:
- la riforma dell'ETI: è stato un atto (legittimo) del Ministro, sottratto a qualunque verifica e discussione;
- quella della Biennale (la seconda in pochi anni) ne ha ulteriormente rafforzato il controllo centrale;
- l'istituzione di ARCUS spa, come emanazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e di quello delle Infrastrutture per il sostegno di attività "trasversali", innovative, promozionali: all'apprezzamento iniziale sono seguite critiche generalizzate alla gestione, non regolamentata e fortemente dipendente dai due ministri;
- la trasformazione dei regolamenti triennali in decreti annuali (cioè l'azzeramento di una delle riforme più significative sul piano operativo e "psicologico" del governo precedente) e l'introduzione di una discrezionalità pressoché assoluta nella cosiddetta valutazione qualitativa, attuata dalle commissioni nominate dallo stesso Ministro (commissioni che - con gli uffici ministeriali - ora gridano contro i finanziamenti a pioggia ma che hanno aumentato il numero dei soggetti come mai prima, riducendo significativamente il contributo medio);
- la valorizzazione del privato (cioè interazione pubblico/privato, privatizzazione, richiamo alla managerialità), fatta eccezione per una maggiore attenzione nei finanziamenti alle imprese di spettacolo market oriented, è rimasta in gran parte sulla carta: non si è regolamentata in termini efficaci l'agevolazione fiscale alle erogazioni liberali (già una legge Melandri), si è lasciata naufragare la riforma delle Fondazioni lirico-sinfoniche e si sono aumentati i lacci e lacciuoli che il ministero pone ai settori attraverso i regolamenti (fino all'atto finale - già periodo Buttiglione, ma sempre era Nastasi - di determinare per regolamento addirittura i cachet!: una scelta paradossale da parte di un governo liberista).
Lo stesso spirito accentratore si è applicato nella gestione dei beni culturali e del patrimonio, dove però la privatizzazione stava decisamente più a cuore e ha iniziato a funzionare davvero (con grave disagio delle emanazioni periferiche del ministero).
Insomma, la preoccupazione sembra sia stata mantenere il più possibile al centro le scelte concretamente rilevanti. Deriva da qui - a nostro parere - anche il braccio di ferro quinquennale con le regioni per l'applicazione della riforma costituzionale. E tuttora il punto d'arrivo, la "legislazione concorrente", si presta a interpretazioni non identiche -come abbiamo visto - anche a sinistra.
Le diverse culture di Forza Italia
Le posizioni del partito del Presidente del Consiglio sono più articolate di quanto si possa pensare, se confrontiamo la politica di Urbani con la scheda di lavoro della responsabile del settore, on. Gabriella Carlucci, o la chiusura totale del Ministro Tremonti o dell'economista Brunetta nei confronti del settore.
Il documento che riportiamo quasi integralmente qui di seguito rappresenta la posizione di Forza Italia e riprende in parte la filosofia del progetto legge del 2001 (della stessa Carlucci).
SCHEDA DI LAVORO PER LO SPETTACOLO
a cura del DIPARTIMENTO NAZIONALE SPETTACOLO F.I.
Appare opportuno varare un nuovo progetto per lo spettacolo quale risorsa strategica per la crescita del Paese, veicolo di tutela dell’identità culturale e di promozione dell’immagine italiana all’estero.
Nell’era della globalizzazione dei mercati, della concorrenza a basso costo, della clonazione e contraffazione dei prodotti industriali, artigianali, manifatturieri ed agricoli, l’Italia può “vendere” un prodotto che non può essere riproducibile: la cultura.
Per farlo al meglio, occorre essere competitivi, operare, cioè, nelle condizioni migliori per ricercare la qualità ed attuare i presupposti e le finalità dell’intervento pubblico che genera un cospicuo valore aggiunto anche in termini economici (sono oltre 200.000 gli addetti che operano nello spettacolo).
Ma non è solo una questione di finanziamenti; è anche un tema di regole certe, non più rinviabili dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (...)
Nel varare le leggi quadro per il cinema e per lo spettacolo dal vivo si dovrà:
• attuare il principio della legislazione concorrente;
• affrancare l’investimento sulla cultura dai vincoli del Trattato di Maastricht;
• sollecitare, ad integrazione dell’intervento pubblico, l’impegno dei privati sullo spettacolo quale patrimonio della nazione e bene economico;
AZIONI STRUTTURALI PER IL SISTEMA SPETTACOLO
Per perseguire la competitività dello spettacolo, si delineano interventi di sistema, strutturali e di sostegno alla quotidiana gestione imprenditoriale.
- Investimenti strategici
- Un “sistema culturale”va fondato su sei “investimenti”:
- l’educazione del pubblico, coinvolgendo sia la scuola che l’università;
- la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori;
- la promozione, per diffondere la conoscenza ed informare;
- le nuove strutture, ancora carenti in molte aree del Paese;
- l’integrazione progettuale tra patrimonio culturale, storico, monumentale, paesaggistico e le attività turistiche; (...)
- Fonti di finanziamento
Fondo unico dello lo spettacolo: occorre operare una netta e definitiva inversione di tendenza. Va realizzata la riforma del Fus per rimuoverne gli elementi di criticità e prefigurare nuove logiche di intervento, più correlate all’efficacia/efficienza dell’investimento pubblico in termini qualitativi, quantitativi e di ricaduta sociale e solo dopo adeguarne le risorse ai nuovi obiettivi.
Arcus spa: pccorre ricondurne l’ambito di intervento all’interno di logiche, criteri e metodologie di azione che ispirano l’attività istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali preposto dicastero.
Fondo perequativo: si propone l’istituzione di un fondo strutturale per investimenti strategici in favore delle aree meno servite del Paese, della presenza in ambito internazionale e della innovazione produttiva e tecnologica del settore. Varie sono le ipotesi per alimentare tale fondo e non necessariamente gravanti sull’erario.
- Il credito
E’ indispensabile delineare un modello dedicato espressamente alle attività imprenditoriali dello spettacolo, d’intesa tra Stato e Regioni (...)
AGEVOLAZIONI DI SISTEMA
- Nuova fiscalità
- razionalizzazioni e semplificazioni (applicazione della minima aliquota Iva agevolata);
- incentivi fiscali (tax shelter, crediti di imposta, detassazione dei costi pubblicitari e di affissione, premio fiscale proporzionale ai biglietti venduti, crediti di imposta per l’acquisto, ristrutturazione e innovazione tecnologica delle sale di spettacolo e per la formazione e l’aggiornamento professionale).
- Il lavoro
-
Non è più rinviabile:
- una complessiva revisione dei ccnl;
- ridurre i livelli di precarietà;
- sostenere la nascita di nuovi posti anche attraverso l’introduzione dei nuovi modelli di lavoro con relative agevolazioni (interinale, apprendistato, borse di studio, lavoro socialmente utile);
- conseguire il riconoscimento professionale degli operatori.
- Razionalizzazione e semplificazione amministrativa
Occorre un’ulteriore semplificazione delle procedure amministrative (...)
- Ulteriori interventi
-
E’ opportuno rimuovere una serie di balzelli, imposizioni e limiti che ancora gravano, immotivatamente, sul settore:
- esenzione dalla ritenuta d’acconto sui contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche
- esenzione delle sale teatrali e musicali dal servizio obbligatorio di vigilanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- esenzione delle sale di spettacolo dalle imposte erariali e addizionali (...)
- integrale deducibilità delle spese per vitto, alloggio e viaggio durante le trasferte.
Sulle posizioni di Forza Italia, vedi anche l'intervista all'onorevole Gabriella Carlucci su ateatro.
(segue)
Speciale elezioni 2006: l'onorevole Gabriella Pistone in esclusiva per "Hystrio"-ateatro
I Comunisti Italiani e lo spettacolo dal vivo
di Anna Chiara Altieri e Mimma Gallina
Abbiamo chiesto all'On.le Gabriella Pistone, molto attiva nel campo delle politiche culturali e dell'informazione durante la legislatura, di illustrare le posizioni dei Comunisti Italiani. La ringraziamo di aver trovato il tempo per risponderci in modo particolarmete approfondito, franco e partecipato.
Sintizziamo le domande, che seguono la falsariga delle interviste a Vittoria Franco dei DS e di Patrizia Bortolini e Stefania Brai del PRC, nella prima puntata della nostra inchiesta, su ateatro 95.

Devo premettere che ho lasciato il mio partito la scorsa settimana per personale dissenso nei confronti della linea politica. Sono stata per tre anni Responsabile Spettacolo del PdCI e devo dire che non ho mai avuto alcun problema con il mio partito nella definizione delle politiche per lo spettacolo che ho piuttosto adeguato alle esigenze e alle richieste del mondo delle imprese, degli attori, degli autori e degli operatori che non ispirato a premesse ideologiche o a prese di posizione strategiche. Le mie convinzioni restano quelle acquisite sul campo in questo triennio di appassionato lavoro con la gente dello spettacolo per cercare di arginare il disastro nel quale un’assenza totale di capacità governativa lo ha sprofondato.
Sono quindi contenta di poter rispondere alle vostre domande in quanto relatrice di una proposta di legge, di numerose interrogazioni parlamentari, di un question time sui tagli al FUS rivolto al Ministro Buttiglione e di una costante presenza accanto alle associazioni di categoria e ai sindacati di settore: ai quali prometto che la mia futura attività continuerà a farsi carico dei loro problemi e della loro ansia di riforma radicale.
1. LA FUNZIONE DELLA CULTURA
La cultura è sicuramente il segno più forte dell’identità di una nazione e non un esercizio di narcisismo individuale da affidare ai privati. Uno Stato forte e consapevole dei propri doveri di indirizzo non può non collocare la cultura tra le priorità della propria azione di governo: e una politica culturale intelligente ha sempre fatto grande insieme l’arte e lo stato. Ce lo insegnano i secoli di Pericle, di Augusto, di Leone X, di Luigi XIV ma anche quelli di De Gaulle e di Malraux..
2. LA QUESTIONE DELLE RISORSE
Mi sembra ragionevolmente condivisibile l’impostazione contenuta nel programma dell’Unione. Si passa, appunto dopo vent’anni di diminuzione delle risorse reali del Fus, alla presa d’atto che lo Stato deve impegnare più risorse nella cultura. L’impegno a riportare subito il FUS ai livelli del 2001 è una prima misura d’emergenza che vuol dire intanto un aumento immediato tra il 30 e il 40 % dell’attuale stanziamento ministeriale: una boccata d’ossigeno a tutte le imprese italiane se l’Unione arriverà al governo del Paese. E quello di arrivare all’1% del prodotto interno lordo nel corso della legislatura è un’affermazione epocale che ci colloca finalmente, almeno a livello di intenzioni tra le grandi nazioni europee: siamo per il momento allo 0,39 % del Pil, a una percentuale inferiore a quella del Portogallo, e l’1% è quasi tre volte la spesa attuale. Credo che sia ragionevole non cercare a tutti i costi soluzioni massimalistiche che, in una situazione di bilancio da tutti percepita come drammatica, sarebbero semplicemente inascoltate. Mentre la proposta del programma è stata sottoscritta da tutti.
3. LA QUESTIONE LEGISLATIVA:
LO SPETTACOLO E LA BOZZA ROSITANI
La bozza Rositani non è evidentemente un punto di partenza accettabile: è il risultato abborracciato di un assemblaggio tra 7 proposte diverse e non riesce a indicare una scelta vera, una direzione di ricerca, una prospettiva di rinnovamento. Credo che si debba assumere una nuova iniziativa forte, pur prestando attenzione alle proposte delle Regioni: ma lo Stato (e se vogliamo, chiamiamolo pure Repubblica) deve esprimere un indirizzo finalmente unitario. E qui si apre l’altra delicata questione: il tema della legislazione concorrente è definitivamente stato chiarito dalla sentenza 285/2005 della Corte Costituzionale. Lasciatemi ricordare, inoltre, (anche ad alcuni colleghi dell’Unione particolarmente ansiosi) che nel popolo del cinema, del teatro, della danza e della musica pochi argomenti sono impopolari come la suddivisione regionale del FUS, proprio perché loro, che sono i protagonisti del lavoro culturale, lo sentono come una risorsa nazionale non parcellizzabile in rivoli localistici o, peggio, in catalogazioni “di interesse europeo, nazionale o regionale”: lo sentono come lo strumento più forte dell’espressività italiana e vogliono continuare a sentirsi parte di quest’unica identità. Del resto, mi piace pensare che il prossimo referendum sulla riforma federalista dello stato riserverà qualche sorpresa a chi in quest’ultimo decennio ha voluto farsi portavoce di una visione radicalmente antistatalista e anticostituzionale. Aspettiamo quindi con saggezza. E con tutto ciò vorrei riaffermare che il ruolo delle Regioni è importantissimo ed è destinato a diventarlo sempre di più: ma in una misura, appunto, concorrente e non antagonistica.
4. QUALCHE PUNTO CONCRETO
MINISTERO. Il tema della riorganizzazione del Ministero è stato indicato nella bozza dell’Unione e sarà un problema importante al momento della formazione del nuovo governo. So che Vittoria Franco, al tavolo dei partiti da lei coordinato per il programma di centro sinistra, lo ha più volte dibattuto: ma è un tema complesso che coinvolge i beni culturali, oltre che le attività e non vorrei entrare in una discussione che oltre tutto non mi compete: Vittoria è stata un’ottima coordinatrice per il capitolo cultura mentre a me è toccato il coordinamento della comunicazione e dell’informazione. Ci sono sicuramente interessanti proposte all’orizzonte: soprattutto vedo che, a differenza del passato, importanti leader del centro-sinistra si compiacciono di pensarsi futuri ministri della cultura: è un segnale positivo, quasi “francese”, di attenzione a un tema che riassume una posizione centrale nella vita della società italiana dopo troppi anni dedicati soltanto all’adorazione del feticcio televisivo.
ETI. Nello spazientito mondo dello spettacolo italiano, ogni accenno allo scioglimento dell’ETI provoca unanimi consensi: non c’è stato tentativo di riforma, negli anni, che abbia portato a qualche tangibile risultato. Ma dobbiamo interrogarci con onestà se, nel panorama europeo, l’Italia debba essere l’unico grande paese senza un istituto centrale per la promozione della cultura teatrale italiana nel mondo: e allora in questo senso dobbiamo muoverci per disegnare i confini di una riforma dell’ente che gli faccia assumere una vocazione istituzionale moderna ed efficace.
ARCUS. Perché non approfittare di uno strumento che può attirare e razionalizzare l’investimento privato in cultura? Il programma dell’Unione affronta il problema di una razionalizzazione della società inventata da Urbani e, giustamente, chiede che venga dotata del regolamento previsto dalla legge attuativa: è indispensabile dare la massima trasparenza alla gestione, è indispensabile superare la logica dei micro interventi che finora sembra prevalere. Ma non abbiamo mai detto no all’investimento privato: abbiamo soltanto condannato un’idea di cultura sottoposta soltanto al criterio di redditività e abbiamo sempre sostenuto che l’apporto privato deve essere aggiuntivo e non sostitutivo di quello pubblico, al quale spettano comunque compiti non delegabili di indirizzo e di tutela. Penso per esempio a finanziare una parte della produzione di spettacolo e cinema con una quota degli introiti delle transazioni pubblicitarie delle emittenti televisive nazionali.
SPOIL SYSTEM. E’ uno dei peggiori insegnamenti del filo americanismo radicale e mi trovate freddissima al riguardo: in questi anni di devastazione del centro destra spesso la salvezza è venuta dai funzionari e dai dirigenti delle amministrazioni che hanno, insieme ai teatranti, cercato di salvare il salvabile. Anche quando erano di nomina governativa e delle maggioranze di centro destra. Certo, occorrerà cominciare una rivoluzione culturale dei costumi nel teatro italiano: il panorama è umiliato da troppe nomine indecorose, da troppe clientele immobili al potere da troppi anni, da collusioni d’affari di ogni tipo. Ma dobbiamo avere il coraggio di confessare che non è una responsabilità da addebitare solo al centro destra: negli anni è cresciuto un “teatro dei potenti” trasversalmente occupato a garantire soprattutto la sua sopravvivenza, operazione che finora gli è riuscita brillantemente. Ed è proprio contro queste cose che negli ultimi anni mi sono mossa nella denuncia e nella attività parlamentare: aiutata da un’associazione (l’ApTI) che è nata intorno al convegno del 2002 Il teatro italiano: valore e risorsa per l’Europa; oltre quattrocento dei nomi più noti dello spettacolo italiano mi hanno suggerito, in un documento, le linee lungo le quali bisognava muoversi per dare uno scossone alle sclerotizzate membra del teatro nazionale. E sono proposte concrete, che non richiederebbero neppure interventi legislativi di grande portata ma potrebbero utilmente indirizzare i prossimi criteri regolamentari: più risorse e più attenzione pubbliche al teatro, una seria regolamentazione del mercato del lavoro, che preveda le necessarie tutele sociali, lotta all’evasione e all’elusione contributiva, criteri per la moralizzazione nelle nomine dei teatri pubblici (per esempio, con un limite alla durata dei mandati di direzione), promozione della drammaturgia nazionale contemporanea, sovvenzioni al progetto artistico e non soltanto alle imprese, quote di attenzione televisiva alla produzione teatrale e così via. Sono contenta che molte di queste cose siano oggi parte del programma dell’Unione.
Per parlare di questo, insieme a Vittoria Franco e a numerose associazioni ho dato appuntamento al mondo dello spettacolo, ai sindacati di settore, alle forze politiche al Teatro Valle di Roma, martedì 27 marzo alle ore 16,30. Dobbiamo dire a Romano Prodi che lo aiuteremo a vincere ma vogliamo che lui aiuti lo spettacolo italiano a rinascere: e che i buoni propositi del programma dell’Unione dovranno tradursi in concreti atti di governo.
Speciale elezioni 2006: l'onorevole Gabriella Carlucci in esclusiva per "Hystrio"-ateatro
La politica di Forza Italia per il teatro e la nascita del nuovo teatro stabile privato della Puglia
di Mimma Gallina
Abbiamo approfondito le posizioni di Forza Italia in un'intervista telefonica con l'On. Gabriella Carlucci, candidata in Puglia per le prossime elezioni.
(Ricordiamo che ateatro ha rilanciato anche una sua intervista al "Giornale dello Spettacolo").
Carlucci è cordiale, informata, concreta e disponibile. Alcune sue posizioni non sono apparentemente distanti da quelle dell'Unione, e infatti ritiene che una politica per lo spettacolo possa essere condivisa, né di destra, né di sinistra.
Ma al di là dei punti di contatto teorici fra schieramenti e singoli partiti, questo esame comparato ci ha rafforzato nella convinzione che, in una situazione povera come quella in cui ci dibattiamo, a fare la differenza sia (sarà) la questione dei finanziamenti e le priorità, le scelte concrete di distribuzione degli stessi.

Non per polemica, ma a leggere le sue dichiarazioni e documenti sembra quasi che lei non sia un'esponente dell'area di governo. Come mai è così difficile fare una politica per lo spettacolo in Italia?
L'obiettivo del governo era, dopo anni finanziamento a pioggia allo spettacolo senza verifiche di efficacia né trasparenza, introdurre criteri effettivamente meritocratici. Nel cinema ci siamo in parte riusciti. Per il teatro il governo ci ha provato, ma non c'è stato il coraggio di effettuare scelte drastiche, anche se sarebbe bastato applicare con coerenza i criteri già previsti nei regolamenti.
Un problema è derivato anche dagli scontri sulla riforma costituzionale (quella varata dalla sinistra): si è creato un caos fra le competenze di stato e regioni, che ha determinato ritardi,conflitti, fortissime resistenze da parte del parlamento, il blocco legislativo, per poi arrivare alla legislazione concorrente (come avevo ipotizzato nella mia legge del 2001). In questo quadro ho combattuto le leggi di settore che non potevano che nascere morte.
Nel programma della casa della Libertà abbiamo trovato solo la frasetta che sa su beni e attività culturali. Possiamo considerare condivisi almeno nel suo partito i contenuti articolati del documento di FI sopra citato?
E pensa che un nuovo governo di centro destra possa rimeditare la politica dei tagli?
Naturalmente: si tratta di posizioni ufficiali che integrano il programma che sarebbe stato assurdo appesantire con eccessivi dettagli.
Certo, personalità del governo come Tremonti o economisti come Brunetta non vedono lo spettacolo dal vivo come un settore economicamente serio e affidabile (e ha volte non hanno torto), ma possiamo dimostrarne la serietà con un'inversione di tendenza, un nuovo corso più attento all'equilibrio gestionale, alla managerialità.
Quanto ai tagli di bilancio non saranno facilmente recuperabili: giocano contro le normative (Maastricht) e le verifiche dell' Unione Europea e più di tanto non si può fare. Bisogna puntare sulle fiscalità alternative (V. documento) e sul credito agevolato (finalmente è arrivato a funzionare l'istituto del credito sportivo esteso allo spettacolo, una riforma votata già nel 2003).
In questo quadro, e nella prospettiva della legislazione concorrente, la Legge Rositani - anche se in effetti, in quanto frutto di una complessa mediazione tende a dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte - sarà un punto di partenza accettabile, condiviso fra l'altro da tutti i partiti.
A proposito di fondi alternativi. Mi sembra significativo che nella frasetta del programma della Casa delle Libertà siano accomunate grandi opere e beni culturali. Nel suo documento lei scrive a proposito di Arcus spa: "Occorre ricondurne il suo ambito di intervento all’interno di logiche, criteri e metodologie di azione che ispirano l’attività istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali". Può precisare?
Arcus è un ottimo strumento, ma è necessaria una regolamentazione: ora finanzia un po' a casaccio, ha subìto il passaggio Urbani/ Buttiglione e non bisogna dimenticare che è arrivato ad operare in fase di tagli, ad intervenire in una situazione di emergenza.
Non condivido in linea di massima la tendenza a privilegiare gli interventi sulle strutture, che sono importanti (sono ancora molti ad esempio i teatri chiusi su cui si dovrebbe intervenire), ma a mio parere si dovrebbe orientare con più decisione verso la promozione, penso in particolare alle aree disagiate, al sud.
Anche l'ETI, che pure sta facendo molto, dovrebbe indirizzare prevalentemente la sua attività in senso promozionale verso aree di rischio (direi anzi esclusivamente: anche nella programmazione delle sue sale).
Arcus dovrebbe anche attrezzarsi per interagire a livello europeo, ottenere finanziamenti da quel fronte, imparare a far leva su programmi come Interreg e altri.
Nella recente intervista al Giornale dello Spettacolo ribadisce l'importanza del "successo al botteghino", precisa però anche che "Lo stato dovrà intervenire solo dove è davvero necessario il suo sostegno": giovani autori/promozione pubblico/scuole/memoria.
Si deve moralizzare l'area imprenditoriale dello spettacolo: chi già cammina con le sue gambe deve essere in grado di stabilire un rapporto accettabile fra l'intervento statale, i risultati di pubblico (che devono esserci), la capacità di reperire entrate proprie. C'è chi ci è riuscito: non penso solo a realtà strettamente legate al successo di botteghino (come il Sistina e altre che conosco meglio per la mia attività professionale), ma a istituzioni come il Piccolo Teatro di Milano, ad esempio, che ha costruito un equilibrio ammirevole fra intervento pubblico ed entrate proprie, rivelando grandi abilità manageriali.
Naturalmente per l'area del teatro pubblico, come per l'innovazione, non potrebbero bastare gli interventi sulla fiscalità.
E' soprattutto in questa direzione - verso l'arte allo stato puro - che devono indirizzarsi gli interventi pubblici: e devono essere improntati alla massima libertà: se queste realtà non vengono lasciate libere, non si può parlare di ricerca. Gli interventi devono essere commisurati alla valenza artistica e vanno premiati i risultati ottenuti, che anche in questo caso non possono però essere del tutto estranei all'interesse da parte del pubblico.
I criteri sono inevitabili e l'eccessivo dettaglio della normativa attuale è legato alla carenza di mezzi. Andrebbero solo applicati con coerenza.
Però io ribalterei la tendenza a sostegni prevalentemente indirizzati alla produzione, a favore di un sistema di interventi promozionali: rivolto prevalentemente ai giovani e alle scuole, alla valorizzazione del territorio, alla formazione del pubblico, facendo leva anche sulla funzione della RAI - ad esempio con la creazione di un canale tematico satellitare che non sarebbe neppure troppo oneroso - e a qualche idea un po'creativa e tutt’altro che irrealizzabile (come un piano sistematico di informazione e pubblicizzazione sui treni).
Lei è candidata in Puglia ed è evidente la Sua attenzione al problema della sperequazione territoriale. Vuole dirci una cosa che farebbe concretamente per lo spettacolo al sud?
Molto concretamente: sto promuovendo la creazione di una Fondazione che coinvolgerà 10 comuni in Puglia, farà leva anche su erogazioni liberali e opererà su più sedi secondo la forma e gli obiettivi della Stabilità Privata (che non è presente in quella regione, come quella pubblica del resto) ma prefigurando un modello innovativo: produzione, programmazione, ma in particolare formazione, di quadri artistici e tecnici ma soprattutto manageriali, anzi artistico-manageriali, di cui si sente molto la carenza. Siamo già piuttosto avanti: si comincerà ad operare dalla prossima estate. Mi sembra un ottimo modo di far leva sul territorio, su comuni che hanno appena ristrutturato il proprio teatro, come Corato, o che hanno risorse monumentali e paesaggistiche meravigliose, come Trani.
Semplicemente complicato (Parte III)
Un incontro con Luca Ronconi
di Oliviero Ponte di Pino
Le prime due parti di questo testo sono state pubblicate in ateatro 94 e 96. L'intero testo è in corso di pubblicazione nel volume Luca Ronconi. Spettacoli per Torino, Umberto Allemandi Editore.
Forse uno dei segreti della semplicità ronconiana è questo: è talmente consapevole delle complessità labirintiche del reale e della comunicazione che le esplicita e le rende limpide
e comprensibili. E’ senz’altro il creatore di clamorosi eventi teatrali, che hanno spostato i confini stessi della sua arte, ma al centro del suo lavoro ci sono da sempre il testo, gli attori e naturalmente il pubblico. Tenendo tuttavia presente una di quelle fulminanti verità che d’improvviso sembrano quasi sfuggire alla timidezza ronconiana.
Il pubblico ha tutti i diritti. Il che non vuol dire che abbia sempre ragione.
(intervista di Mario Baudino, “La Stampa”, dicembre 1990)
Ogni testo, ribadisce ossessivamente, va affrontato per quello che è. Ronconi è sempre consapevole dei materiali su cui lavora e sulle interpretazioni che ne sono state date. Per cominciare, utilizza spesso la categoria di “genere” (partendo magari dalla classica contrapposizione aristotelica tra commedia e tragedia). Per esempio, nell’affrontare Strano interludio di Eugene O’Neill traccia una mappa assai meticolosa di interpretazioni e dunque di possibili ricezioni.
Questo testo, se lo prendi alla leggera, puoi vederlo come un fumettone, oppure come una saga, o ancora come una trascrizione di alcuni schemi mitici europei in chiave americana; c’è poi chi lo legge come dramma psicologico e chi lo interpreta come volontaristico modello di dramma biologico. E tuttavia il dato rilevante è il fatto che ancora oggi di tratta di un corposo testo sperimentale. Per questo vale la pena di affrontarlo.
(intervista di Gian Luca Favetto, “la Repubblica”, 20 dicembre 1989)
Il lavoro preliminare consiste nell’esaminare quali strade siano state imboccate, e perché non abbiano funzionato – o perché non possano più funzionare. E su questo Ronconi può perfino permettersi una forma di civetteria.
Non sono mai sufficientemente informato e documentato sui testi che faccio e non voglio farlo. Per fare filologia non ho altra guida che la lettura del testo e gli attori. Allo stesso modo, non amo rapportare il testo alla sua epoca o alla storia del suo autore. Non me la sentirei mai di stiracchiare un testo. Già non so bene cosa succeda nella nostra epoca. Ma nella nostra per lo meno ci vivo e ci partecipo. È lei che mi guida all’interno del testo. Lavoro molto con gli attori e del dove voglio andare non so nulla. Posso sapere dove non voglio andare, posso in qualche modo precludermi delle strade. Faccio un esempio non su ciò che ho fatto, ma su ciò che sto facendo in queste settimane. Si dice che Troilo e Cressida sia una parodia degli eroi omerici. Prima di dire no perché è stato già fatto in quel modo, bisogna verificare che significa parodia, chi sono gli eroi omerici e se veramente dentro il testo c’è qualcosa di parodistico. La parodia è ciò che non voglio, non mi interessa. Ma non è detto che Troilo e Cressida sia parodia. Probabilmente il nostro concetto di parodia è diverso da quello che poteva avere un inglese del 1600. Procedo chiudendo delle strade e vedendo qual è quella percorribile, quella che può aprire altre strade e altre prospettive.
Al termine di questo percorso le risposte possono essere assai sorprendenti e innovative.
Oltretutto per Ronconi, in un modo o nell’altro, tutti i testi che affronta sono “sperimentali” e dunque possono mettere alla prova le strutture profonde della comunicazione teatrale. Perché nella visione ronconiana c’è una pars destruens preliminare: gli è sempre ferocemente chiaro quello che non vuole, e quello che non vuole essere. Qui la sua semplicità (e la sua ironia) possono raggiungere la forza sintetica di un aforisma. Per cominciare, pur avendo rivoluzionato molti degli schemi tradizionali della regia, rifiuta ogni assimilazione all’avanguardia.
Non sono mai stato un sessantottino, sono stato in genere molto inviso a quelle che erano le avanguardie. Il mio atteggiamento è sempre stato questo, e non credo di aver visto male: l’alternativa programmatica rischia di diventare un’accademia, o una sostituzione della convenzione: rischia di creare solo nuove convenzioni. Il rinnovamento è un’altra cosa: tener sempre gli occhi aperti, e il naso lungo, e le orecchie aperte per capire che cosa succede realmente. Sono sempre stato convinto che alla lunga l’avanguardia sia sempre stata una questione di stile, e non una questione di linguaggio. Per linguaggio intendo qualcosa che si modifica continuamente, che ha un iter storico evolutivo, che genera continuamente nuove forme, che ha una dinamica interna, che può camminare come il cavallo o come il gambero, secondo necessità. Lo stile non è questo: è comunque una codificazione, un genere, e molto spesso è accettato proprio in quanto genere.
Allo stesso modo rifiuta con decisione ogni etichetta generazionale.
A differenza di quello che accade adesso, quando gli attori che escono dallo stesso corso provano a fare compagnia, io un legame generazionale non l’ho mai avuto. Non l’ho mai cercato, perché guardavo ad altro. Quando ho avuto trentacinque anni, mi sono immediatamente rivolto a chi ne aveva venti: e quando ne avevo diciotto o diciannove mi sono immediatamente rivolto a chi ne aveva trentacinque. Anche da questo, credo, mi viene un’insofferenza per le letture generazionali.
Nei confronti del teatro italiano, ha espresso giudizi assai duri, che in qualche rara ma cruciale circostanza si sono riverberati anche in una delle sue rare esternazioni sulla situazione del paese.
Gli attori italiani non hanno altra vocazione che quella di fare ditta, di diventare capocomici. Questo svilisce il loro lavoro, la loro qualità. Un capocomico finisce col non essere un attore, ma un amministratore che la sera sale truccato in palcoscenico. Ce ne sono tanti così, troppi. (...) Veniamo agli autori: Strehler, e poi Visconti, per qualche anno, hanno fatto un teatro con la “T” talmente maiuscola da sfondare il soffitto delle sale. Poi più niente. Ma non era un teatro che facesse posto agli autori. D’altra parte la letteratura ha sempre considerato il teatro un lavoro da mano sinistra. Non c’è in Italia né la continuità di un teatro di regia, né quella di un teatro di drammaturgia. E’ la nostra società che ama specchiarsi soltanto nei capocomici. Non rischia forse di farne anche un problema politico, o il problema della politica attualmente? Tutto si tiene.
(da un’intervista di Enzo Siciliano, “la Repubblica”, 11 aprile 1994)
Nel lavoro sui testi e con gli attori, diffida di quelle che spesso gli appaiono comode scorciatoie, semplificazioni fuorvianti. In primo luogo la psicologia (alla base del metodo Stanislavskij), che rischia di occultare le trappole del rapporto tra il testo e il corpo dell’attore.
Si può recitare solo ciò che è recitabile. La psicologia, per esempio, non lo è. La lingua è recitabile, lo spazio lo si può recitare. Il precetto che girava nelle scuole e nelle accademie italiane era dire ciò che si pensa, ma ciò che si pensa non lo si può dire. O, peggio ancora, chiedevano di pensare ciò che si dice. Dire e pensare sono due attività completamente differenti. Non ho mai creduto che la lingua sia il veicolo esclusivo della comunicazione; ma allo stesso modo, pur ritenendo il lavoro fisico molto importante nel teatro, non credo che il corpo da solo “dica”. Il corpo comunica in attrito con la lingua e con lo spazio. Il problema del teatro italiano è che c’è pochissima drammaturgia italiana. Gli attori italiani sono costretti a lavorare su testi che implicano un notevole scarto fra ciò che si vorrebbe dire e ciò che effettivamente si dice. Ciò rappresenta una difficoltà e una sfida che vanno affrontate e superate. Il lavoro che stiamo facendo su Troilo e Cressida è soprattutto questo: essere consapevoli se si è governati da ciò che si dice, capire fino a che punto si è in grado di governare ciò che dice e soprattutto perché lo si dice. Perché c’è sorta di “autorità della violenza del linguaggio” sull’individuo.
Un altro aspetto che tende a generare sospetto (anche se non sempre) è la presunta narratività di molta drammaturgia. A proposito di Spettri di Ibsen (1982), che il regista ambienta in una serra (progettata da Mario Garbuglia) dove coabitano i cinque attori e i trecento spettatori.
La maniera, chiamiamola convenzionale, di fare un testo è quella di utilizzare il dialogo in funzione della narrazione di una storia e non, invece, le battute del dialogo come spiragli, come segni e indicazioni di una condizione dei personaggi. Secondo me, quello che può dare oggi unità e consistenza a un testo come Spettri è l’indagine sulla condizione dei personaggi momento per momento, e non usare il dialogo come veicolo di una narratività che in questo testo non esiste. C’è un antefatto sottinteso e ritardato ingiustificatamente: la giustificazione in ritardo di questo antefatto è la trama della commedia. Ci sono dei personaggi che ritardano, non per tirare in lungo, ma perché sono nell’impossibilità psicologica di dire le cose come stanno. E’ chiaro che il tema della rappresentazione diventa l’impossibilità di dire le cose come stanno e non la perveristà nel ritardarle. Basterebbe che certe rivelazioni venissero fatte un attimo prima invece che un attimo dopo e la commedia andrebbe subito al terzo atto. E, in fondo, il rammarico di certa parte del pubblico è che, siccome la maggior parte degli spettatori identifica la commedia con l’ultima battuta, questa arrivi troppo tardi.
(intervista di Maurizio Giammusso, “Rinascita”, 2 luglio 1982)
Anche – anzi, soprattutto – quando si tratta di portare sulle scene il genere narrativo per eccellenza, il romanzo, il taglio narrativo non è l’approccio privilegiato.
Nella mia memoria di spettatore, ci sono tanti romanzi portati sulla scena e sullo schermo. Non considero, quindi, una sfida la ricerca dentro la narrativa. Quello che ho sempre cercato di fare è evitare di snaturare un romanzo per farne un dramma a tutti i costi e, anzi, di mantenerne il carattere di letteratura narrativa. Le realizzazioni sceniche de I fratelli Karamazov e Quer pasticciaccio brutto, ad esempio, sono state un semplice trasferimento della pagina sul palcoscenico, non una teatralizzazione. Per cui è piuttosto improprio parlare di lavoro drammaturgico. Se ho fatto spettacoli dalla letteratura, non è perché ritenga la letteratura un tema indispensabile alla rappresentazione teatrale. Un impulso all’affrontare queste scelte deriva sicuramente dall’insoddisfazione che provo rispetto a ciò che si definisce “drammaturgia contemporanea”. Ritengo che molti testi cosiddetti contemporanei costituiscano un vero e proprio oltraggio alla contemporaneità. E ritengo difficile riversare i temi della contemporaneità in strutture formali legate a una drammaturgia illuministica, ottocentesca. La mia insoddisfazione nasce da questo. Il problema, dunque, è legato alla qualità dei temi e delle strutture. Che si affronti un tema o una struttura, il lavoro deve essere fatto con qualità. Infinities, ad esempio, non è un dramma ma una trattazione scientifica. Il testo è stato scritto da uno scienziato e non da qualcuno che, desiderando scrivere di scienza, fa un corso di cosmologia e applica le nozioni acquisite alla stesura di un copione teatrale. Quando parlo di strutture drammaturgiche formali non voglio dire né che dialogo e personaggio siano elementi obsoleti né, al contrario, che siano insostituibili. Non è una questione di predilezione o insofferenza.
Nonostante questa resistenza nei confronti della narrazione, alcuni spettacoli ronconiani – vedi Strano interludio di Eugene O’Neill nel 1990 e più di recente Il professor Bernhardi di Arthur Schnitzler (2005) – possono avere il ritmo travolgente delle telenovelas, come se si divertisse a contraddirsi, non appena possibile...
Quello che emerge da uno sguardo ravvicinato a lavoro di Ronconi è insomma il rifiuto di un metodo, dei suoi vincoli e delle sue complicazioni, per andare ogni volta a misurarsi con il problema concreto del lavoro in quel preciso contesto (la commissione, lo spazio), su quel determinato testo e con quegli attori. La sua attenzione per la specificità coinvolge ovviamente anche le diverse tradizioni nazionali, a cominciare da quella in cui si trova a operare.
Io sono contrario a un’estetica dell’internazionalismo, anzi alla facilità di quest’estetica. Credo che ogni paese abbia un proprio rapporto fra drammaturgia e pubblico, che va conosciuto e rispettato: però è pure vero che la funzione e l’incidenza del fatto teatrale nella vita culturale di un paese andrebbe rapportata anche a ciò che succede nel resto del mondo. (…) Da noi si è avuto, in passato, questo concetto: il teatro imita [modelli stranieri], e non piuttosto il teatro propone, o inventa, o fa esplodere, o riflette. Oggi, per noi, quel tipo di teatro imitativo non è più possibile, perché siamo in presenza di originali, o di originali culturali, oppure di imitazioni al di fuori del teatro. Oggi ce l’hai sotto gli occhi, non ha più funzione quel tipo di teatro. (…) Ritengo che per noi il teatro sia semmai qualcosa di occasionale, un’interruzione del tempo, non una conclusione di serata, come lo è in altri paesi. Il teatro nella nostra vita culturale è considerato tuttora un evento, un’eccezione senza una sua necessaria continuità.
(Il Patalogo 17, p. 125-126)
Non a caso, questa attenzione al particolare emerge anche quando Ronconi affronta l’attività che forse predilige e affronta con grande passione, quella: la pedagogia teatrale. Ha insegnato a lungo sia all’Accademia d’Arte Drammatica di Roma, sia alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano. A Torino ha addirittura fondato la scuola del Teatro Stabile. In questi anni, al Centro Teatrale Santa Cristina, in Umbria, ospita ogni estate una scuola di alta specializzazione. Nel corso del tempo ha lanciato generazioni d’attori, facendoli spesso debittare nei suoi spettacoli: tra gli altri Massimo Popolizio, Riccardi Bini, Luca Zingaretti, Galatea Ranzi, Michela Cescon...
Il termine pedagogia non è esatto. In realtà, il percorso che faccio con gli attori principianti è esattamente lo stesso che faccio con gli attori formati, il contrario della pedagogia: il confronto con il testo e con problemi interpretativi piuttosto complessi. Un attore di 23-24 anni, anche se può essere professionalmente inesperto da un punto di vista tecnico, possiede una maturità sufficiente per affrontare l’interpretazione. Se non ce l’ha, è bene che se la faccia. La tecnica non esclude le capacità interpretative, le potenzia. Per questo non è esatto parlare di pedagogia. Ciò che mi interessa è sollecitare la fantasia e la curiosità, non trasmettere delle capacità tecniche.
Non si tratta dunque di mettere a punto e imporre un metodo.
No. Quando affronto un testo, mi piace confrontarmi con quel testo e non mettere in quel testo l’esperienza che ho fatto con un altro. Allo stesso modo, di fronte a un gruppo di una ventina di allievi, mi piace pensare a venti persone diverse, con problemi e capacità differenti. Se avessi un metodo, cercherei di formarli e questo non mi piace. Non sono capace e non mi interessa. Ci sono attori simpatici e attori antipatici, persone con cui mi piace lavorare e persone con cui non mi piace affatto. Viceversa, se esistesse un metodo “buono”, si presuppone che tutti quelli che lo adottano diventerebbero bravi e questo non succede mai. Il che vuol dire che non esiste un buon metodo.
Un “metodo teatrale” di Luca Ronconi non esiste e non può esistere, ribadisce con forza l’interessato. Ogni testo – che la scelta giunga da una commissione o che emerga da un’intuizione, da una curiosità, da un’ipotesi di lavoro da verificare – va affrontato per quello che è, per quello che dice, senza facili scorciatoie. Sapendo che ci possono essere discrepanze e fratture tra quello che l’autore scrive e le sue intenzioni, tra le sue intenzioni e il suo linguaggio; tra l’epoca e il luogo in cui è stato scritto e quelli in cui ci troviamo; tra le mille interpretazioni che di quel testo sono state date e la nostra attuale percezione; tra il personaggio e l’attore; tra la consapevolezza dell’autore e quella degli attori o dello spettatore; tra le attese del pubblico e quello che il testo effettivamente dice…
Allora forse un’altra delle intuizioni davvero semplici – originarie - di Luca Ronconi, una folgorazione sulla quale lavora da sempre, è che quello che ci sembra semplice è in realtà piuttosto complicato. Che è la semplicità a essere complicata. E che anzi proprio dietro questa apparente semplicità possano nascondersi le trappole più pericolose, quelle di cui siamo meno consapevoli. Ricordando sempre che per smontare una retorica e creare le condizioni per comunicare di nuovo è necessaria una retorica ancora più sofisticata.
Allora per capire il “metodo Ronconi” – per cogliere la sua “complicata semplicità”, o la sua “semplice complicazione” – è forse opportuno rovesciare la prospettiva. Non esiste un metodo da applicare al teatro, un “sistema” da utilizzare sui testi e con gli attori. E’ l’esatto contrario. E’ il teatro stesso a costituire un metodo per conoscere i testi e la realtà. E noi stessi. Perché solo in teatro tutte queste diverse linee di faglia possono trovare la verifica del corpo, nel tempo e nello spazio.
Molte volte quando scelgo un testo, lo faccio d’istinto e per curiosità, e senza troppa consapevolezza. Cerco di fare in teatro ciò che mi piace. Mi piace ciò che eccede, o può eccedere, le forme consuete del teatro. Ciò che si chiama “teatralità” non è l’eccesso o l’esteriorità. È un’altra cosa: uno schema conoscitivo, un modo di comporre le cose e di rappresentarle.
Questo sposta il problema del teatro dalla rappresentazione alla conoscenza.
La rappresentazione è il modo, non lo scopo. Lo scopo è altro. La rappresentazione stabilisce delle connessioni tra luoghi o concetti diversi. Crea opposizioni, attriti, antinomie che hanno bisogno della rappresentazione per essere comunicate. Ma la rappresentazione è solo un mezzo. Non amo il teatro in cui la rappresentazione è lo scopo.
Il metodo conoscitivo di uno spettatore è diverso da quello di un attore o è analogo? Se ci sono delle connessioni e degli attriti, vengono colte allo stesso modo dall’uno e dall’altro?
E’ il momento del processo a essere diverso. L’attore vive la fase della preparazione dello spettacolo. Se la preparazione entra a far parte del processo, è probabile che a qualche spettatore fra il pubblico arrivino dei riflessi di questo processo.
In ogni caso, è un processo conoscitivo diverso dagli altri, perché agisce attraverso la rappresentazione. Il teatro non è solo linguaggio, è anche altro.
Il linguaggio è il veicolo degli attori, ma per il pubblico il veicolo è il linguaggio più qualcos’altro: la rappresentazione. Naturalmente l’attore non accede alla rappresentazione se non passa attraverso il codice del linguaggio. Non si può rappresentare una trama o una vicenda. Per vicenda non intendo solo la fabula, ma anche il modo in cui la fabula viene organizzata nel processo. Si può rappresentare lo scarto, o la coincidenza, fra la vicenda e il linguaggio del processo che porta allo spettacolo.
Dunque anche il testo è uno strumento.
Il testo è uno spiraglio che apre altri mondi. Se volessi leggere Amleto, la cosa migliore per “conoscerlo” sarebbe prenderlo in biblioteca e leggerlo. Sarebbe il miglior processo conoscitivo, se intendessi Amleto come letteratura. È chiaro che la letteratura è indispensabile perché, se non si rispetta la letterarietà di un testo, lo spettacolo non funziona. Ma non basta, non è sufficiente.
Perché mancano il corpo, il respiro, la carne, la voce. Insomma, gli attori. Allora forse diventa più facile capire perché il teatro di Ronconi è così “semplicemente complicato”: è semplice e complicato come il rapporto tra il pensiero, la parola e la realtà. Lo possiamo vivere con l’innocenza dei bambini, abbandonandoci alla noncuranza della chiacchiera quotidiana, fidandoci dell’efficacia servile della comunicazione. Ma questo rapporto è anche e sempre sospeso sopra un abisso. Da un lato ci sono le voragini metafisiche che separano l’interiorità, il linguaggio e il mondo, e che rendono il senso un mistero insondabile, un interrogativo che ci proietta verso la trascendenza (un tema caro alla cultura della finis Austriae, che il filosofo Ludwig Wittgenstein ha esplorato nelle conseguenze estreme). Dall’altro ci sono mille convenzioni e abitudini, le stratificazioni del passato - nelle parole, nelle arti e in generale nella comunicazione, e pure nel nostro sguardo, e persino nella nostra carne - che s’incrostano e irrigidiscono ogni vera comunicazione (anche per questo il regista ama la drammaturgia elisabettiana, dove certe forme non si sono ancora rinserrate).
Tuttavia Ronconi non ama speculare. Rifiuta le astrazioni. Il suo è un talento empirico, è il mestiere paziente di un artigiano - anche se questo artigiano ha le inquietudini e le ossessioni dello sperimentatore, e la sua bottega è sempre un laboratorio. E così gli snodi tra pensiero, linguaggio e realtà li verifica con i suoi attori, sulla scena. O meglio, li verifica nei suoi attori, facendo teatro, ovvero costruendo una forma per rappresentare la realtà (o meglio, per riflettere sulla natura della realtà) e insieme un mezzo di comunicazione, di scambio. Lavorando con gli attori, interroga minuziosamente il testo e verifica il rapporto tra il suo significato e il tempo e lo spazio (ovvero il ritmo e la gestualità degli attori), come se si trattasse di ricucire uno strappo - ogni volta, in ogni frase, in ogni parola, in ogni sillaba, con la minuzia di un ebanista.
In qualche caso inventa macchine spettacolari di visionaria grandezza e di vertiginosa sofisticazione: quasi a nascondere questa angosciante lacerazione, i vuoti di senso di cui è consapevole e che la sua maieutica cerca di riempire. Oppure – senza che questo diventi una contraddizione - per celebrare allo stesso tempo le gioie di un equilibrio riconquistato e i fasti della teatralità.
Ecco, il genio semplicemente complicato di Ronconi, quello che riverbera nei suoi spettacoli, è insieme quello di un provocatore, che si diverte a demistificare le nostre certezze e a liberare nuove possibilità di senso. Ma è anche quello di un costruttore paziente, che tesse continuamente una tela sottile, fragile: quella della verità. Una verità che a volte si può distillare più facilmente in un’altra realtà, in quel laboratorio di parole e corpi, tempo e spazio che è il palcoscenico.
BIBLIOGRAFIA
In assenza di ulteriori specificazioni, le dichiarazioni di Luca Ronconi sono tratte da alcune conversazioni con Oliviero Ponte di Pino, Milano, Roma e Torino, dicembre 2004-ottobre 2005; trascrizioni di Oliviero Ponte di Pino ed Elena Cerasetti. Per completare la stesura di questo “incontro” ho utilizzato innanzitutto i programmi di sala degli spettacoli del regista e le diverse annate del Patalogo, l’annuario di teatro curato da Franco Quadri (cui è dedicato questo scritto) edito da Ubulibri; e ancora Il laboratorio di Prato, a cura di Franco Quadri con Luca Ronconi e Gae Aulenti, Ubulibri, Milano, 1981.
Qualunque riflessione sul teatro di Luca Ronconi non può prescindere da Franco Quadri, Il rito perduto.Saggio su Luca Ronconi, Einaudi, Torino, 1973; di Franco Quadri vedi anche La politica del regista, 2 voll., Il Formichiere, Milano 1980; e Il teatro degli anni Settanta. Tradizione e ricerca, 2 voll., Einaudi, Torino, 1982.
Inoltre:
AA.VV:, Ronconi: frammenti di storia, Archinto, Milano, 2001.
Alba Andreini e Roberto Tessari (a cura di), La letteratura in scena. Gadda e il teatro, Bulzoni, Roma, 2001.
Livia Cavaglieri, Invito al teatro di Ronconi, Mursia, Milano, 2003.
Rita Cirio, Serata d’onore. Diletto e castigo a teatro, Bompiani, Milano, 1983.
Cesare Garboli, Un po’ prima del piombo. Il teatro in Italia negli anni Settanta, prefazione di Ferdinando Taviani, Sansoni, Milano, 1998.
Isabella Innamorati (a cura di), Luca Ronconi e il suo teatro, Bulzoni, Roma, 1996.
Italo Moscati (a cura di), Luca Ronconi: utopia senza paradiso, Marsilio, 1999
Oliviero Ponte di Pino e Anna Maria Monteverdi, Il meglio di ateatro 2001-2003, il principe costante, Milano, 2004.
Franco Quadri in collaborazione con Alessandro Martinez (a cura di), Luca Ronconi. La ricerca di un metodo. L'opera di un maestro raccontata da lui stesso al VI Premio Europa per il teatro a Taormina Arte, Ubulibri, Milano, 1999.
Luigi Squarzina, Il romanzo della regia. Duecento anni di trionfi e sconfitte, Pacini, Ospedaletto (Pisa), 2005.
Teatro Aperto (a cura di), Il teatro nascosto nel romanzo, il principe costante, Milano, 2005.
Il Progetto Domani di Luca Ronconi: un teatro delle idee contro l’espropriazione della storia e dell’economia
Intorno a due spettacoli anomali: Il silenzio dei comunisti e Lo specchio del Diavolo
di Andrea Balzola
Il Progetto Domani, pentatlon olimpico di Ronconi a Torino, è un Kolossal a puntate del Teatro delle idee. Infatti, da molti anni ormai, Ronconi risponde al dramma della realtà e alla telecronaca del disastro (disfatta delle utopie, conflitti culturali e religiosi, guerre endemiche e d’esportazione, recessione economica, tentazioni autoritarie, politica mediatica, economia globale e finanza gangsteristica...) con una regia teatrale del pensiero, come dire: “è ancora possibile pensare oggi, con la propria testa? E’ ancora possibile pensare la realtà in relazione a un progetto umano, che non sia più l’apriori ideologico e religioso o la precettistica di un mercato globale?” Poiché si fa fatica a pensare così, nella ragnatela mediatica e nell’agorà sociopatologico in cui siamo immersi, subacquei in carenza di ossigeno, Ronconi offre quel doppio della realtà che è il teatro, di cui egli è illuminato sovrano, come laboratorio del libero pensiero non organizzato, come Stabile del dubbio, come “vorace” osservatorio critico sul mondo e sulla trinità temporale di passato presente futuro.
Per fare questo, e lo sa fare molto bene, rimescola le carte: fa scrivere i suoi copioni a matematici (come Barrow con Infinities), economisti di alto profilo intellettuale (come Ruffolo con Lo specchio del Diavolo), o porta sulla scena le voci di politici di passione più che di professione per riflettere su un passato non abbastanza elaborato (come ne Il silenzio dei comunisti), ripropone tragedie post-moderne, dove non è più il Fato o la Natura ma l’uomo l’unico assoluto responsabile del disastro (Atti di Guerra di Bond), esplora il repertorio per estrarre tutto ciò che può “parlare” nel dibattito contemporaneo senza essere schiavo dell’attualità (come il Professor Bernardi, attualissima incursione nel travagliato rapporto tra scienza, etica e fede), rivisita i classici in chiave contemporanea (dalle Rane di Aristofane fino all’ultimo Troilo e Cressida di Shakespeare) non per il consueto ammiccamento all’oggi che consente un riciclaggio tanto più appetitoso quanto esteriore dei testi canonici, ma selezionandone gli aspetti più sostanziali, quelli capaci di trascendere le frontiere del tempo.

Il bozzetto della scena per Lo specchio del Diavolo.
Fare un Teatro delle idee, significa avere un‘idea del Teatro e non c’è dubbio (sia tra i suoi cultori sia, spero, tra i suoi detrattori) che Ronconi sia uno dei pochi “resistenti”, almeno nell’attuale Italia devastata dal berlusconismo, ad aver mantenuto e maturato un’idea del Teatro (del suo senso e della sua funzione), che è in fin dei conti, semplificata al massimo, l’idea di una realtà commentata, elaborata, eventualmente trasformata, mediante la finzione, come se la finzione potesse essere, o diventare, coscienza critica della realtà ma anche creatrice di un’altra realtà possibile, quella di un etica della responsabilità (opposta agli imbonimenti “neo-napoleonici” e alla grigia retorica dell’ineluttabile). Non l’utopia rivoluzionaria brechtiana o quella metafisica artaudiana, ma una tessitura dell’intelligenza sull’intricatissimo e contraddittorio ordito del divenire.
In particolare mi vorrei soffermare su due spettacoli del progetto Domani, forse i più anomali: Il silenzio dei comunisti di Vittorio Foa, Miriam Mafai, Alfredo Reichlin e Lo specchio del Diavolo di Giorgio Ruffolo. Una “doppietta” che si potrebbe pensare come una risposta (aperta) a due interrogativi cruciali, in qualche modo collegati tra loro: Il fallimento di un regime è necessariamente il fallimento di un’utopia? L’economia è al servizio dell’uomo o l’uomo dell’economia?
Con Atti di guerra di Edward Bond se ne aggiunge una terza: Cosa succede quando si porta alle estreme conseguenze e si interiorizza la logica della guerra?
Il denominatore comune c’è ed è l’espropriazione.

Il bozzetto della scena per Il silenzio dei comunisti.
Nel Silenzio dei comunisti, emerge in modo limpido l’espropriazione dell’utopia e della memoria: la storia tragica del sistema politico che prende avvio e si proclama realizzazione concreta dell’ideologia marxista espropria l’utopia di un superamento della società capitalistica e tutti coloro che le hanno dedicato la loro vita. Il fallimento di quel sistema nella sua dimensione storica è indubitabile, ma se ne sono valutate attentamente le diverse varianti, come ad esempio quella italiana? E soprattutto, da questa sconfitta dell’idea è legittimo dedurre che il capitalismo sia un sistema indiscutibile e senza alternative, il migliore di quelli possibili? e che le vite e le passioni di milioni di comunisti siano state, per dirla con De Andrè, “sbagliate”? e se non è così, quale elaborazione del lutto di un’ideologia bisogna fare per rigenerare l’idea e soprattutto la possibilità reale di un cambiamento? Questa, in sintesi, era la domanda sapiente innescata dal grande vecchio Vittorio Foa. Scrive Foa: “Il comunismo in Italia ha avuto grande importanza e una sua propria peculiarità rispetto al comunismo mondiale, ed ha contribuito alla formazione delle nostre istituzioni, della nostra democrazia, della nostra liberazione da brutti momenti.” Come mai allora si tende oggi a perderne la memoria, lasciando spazio solo una strumentale demonizzazione o a un’emotiva nostalgia?
Deleuze diceva che era assurdo stabilire una connessione diretta tra le rivolte, le rivoluzioni, le utopie e le loro conseguenze storiche, le rivoluzioni falliscono, forse falliscono sempre, ma questo non significa che siano inutili. Il 68’ ad esempio è stata solo una grande illusione? Non ha cambiato i sistemi politici ma ha sicuramente cambiato il nostro quotidiano, i costumi, i modelli culturali, la percezione dei diritti civili e umani. La non violenza è stata una risposta data alle tragedie della storia da chi ha creduto e crede nella possibilità di un cambiamento, non da chi stigmatizza come violento ogni radicalismo progressista e poi affida regolarmente alla guerra il compito di difendere lo status quo dei propri privilegi.
Naturalmente, la messa in scena di Ronconi, che riproduce un concentrato fedele dell’epistolario dei tre militanti comunisti “non pentiti”, non si spinge così lontano e non vuole dare risposte univoche, pone teatralmente il problema. Ronconi affida la voce conduttrice di Foa a un bravissimo Lo Cascio, raro esempio italico di recitazione intensa e disinvolta senza retorica e senza “spasimi”, quella della Mafai alla fervente Maria Paiato e quella di Reichlin a un travagliato Fausto Russo Alesi; allestisce tre ambienti paralleli e adiacenti (un salotto spoglio, da intellettuale di sinistra, uno stanzone da imbiancare, una stanza semivuota con un angolo piastrellato che fa intuire un’ex cucinotto) che sembrano luoghi dismessi in stile e colori anni Settanta, metafora di una fatiscenza della memoria storica (con una pigra vocazione al riabbellimento: solo una parete dei 3 ambienti sta per essere imbiancata), a cui le apparizioni monologanti ridanno vita; e mantiene l’isolamento epistolare-spaziale dei personaggi fino a una ricongiunzione finale che si proietta sul futuro come speranza non retorica e non scontata. Questo testo non teatrale volutamente poco “drammatizzato” azzera lo spettacolo in funzione dell’ascolto e della riflessione, pretende attenzione, colpisce sicuramente al cuore le generazioni che hanno vissuto in prima persona le battaglie e i travagli di cui si parla e resta forse di fruizione più problematica per le generazioni più recenti, quelle nate o cresciute già oltre le macerie del muro di Berlino che non solo hanno altra memoria ma anche altri linguaggi. Ma forse proprio questa differenza esprime l’esigenza di ritrovare, con qualche necessario impegno, gli anelli di congiunzione che possono fare da radici ai nuovi alberi.
Anche in Lo specchio del Diavolo di Giorgio Ruffolo, “cavalcata sulla storia dell’economia, dal Paradiso terrestre ai giorni nostri”, il tema è quello dell’espropriazione, nell’economia neocapitalista e liberista infatti la finanza prevale sulla produzione industriale, il valore astratto espropria a proprio vantaggio il valore reale delle cose, in termini ancora più generali espropria la relazione fra natura, cultura ed economia. Scrive Ruffolo: “Proprio come nello specchio di Alice (...) che, anziché riflettere l’immagine dritta, riflette l’immagine al rovescio, nei mercati finanziari non sono i prezzi dei titoli che riflettono il valore reale delle cose ma il valore reale delle cose è condizionato dal prezzo dei titoli. Questo è quanto fondamentalmente significa “Lo specchio del diavolo”.” Per la prima volta l’economia politica arriva in scena, non per via di metafora o di proclama ideologico, ma raccontata direttamente, anche nelle sue formule più ostiche, con i suoi protagonisti illustri e illusionisti, con le sue evoluzioni, rivoluzioni e involuzioni.
La struttura del testo prevede tre parti: l’economia e la tecnica, dove si tratta il tema delle origini delle relazioni tra uomo, ambiente e risorse naturali; l’economia e la moneta, dov’è appunto protagonista il tema dello scambio, le logiche del mercato e le teorie monetarie; l’economia e la politica, dove si affronta il tema più attuale e inquietante, cioè il rapporto tra capitalismo e democrazia, e in particolare l’ascesa e la crisi delle teorie liberiste, con un fugace sguardo al futuro possibile.
La scena scelta da Ronconi è un supermercato modulare che si trasforma continuamente e scandisce un accelerato orologio della storia economica con una serie di tappe emblematiche spazializzate in ambienti stilizzati e sempre venati di ironia: dai gilardiani “tappeti natura” che rappresentano un Eden coltivato da Adamo ed Eva e severamente controllato dal Creatore, dove poi si aggira una famiglia di primati, avi dell’homo economicus moderno, al libertino salotto settecentesco che emerge dalla botola del passato con geniali avventurieri come John Law (fondatore in Francia della prima banca - “Banque Royale”- che emette carta moneta); alle banche con le loro riserve auree in cui si avvicendano i primi investitori dell’800 sedotti e truffati dalle più assortite imprese speculative, o dove appare Napoleone III sovrano da operetta e fautore del nascente capitalismo moderno. Un capitalismo che viene radiografato da Marx ed entra in cortocircuito con il crollo della borsa di Walll Street del 1929, in un mondo fatto di arene finanziarie e grattacieli da cui si lanciano le vittime dei giochi della finanza. Fino allo sganciamento autocratico del dollaro dall’oro e all’imposizione della moneta americana come moneta universale. Il mondo diventa a stelle e strisce quando i Keynesiani sono sconfitti dai seguaci di Milton Friedman, padre del liberismo (trionfante negli Usa dagli anni Settanta-Ottanta e ancor oggi baluardo dalla destra anglo-europea) consulente di Pinochet e fautore del darwinismo sociale, secondo cui “il capitalismo è quel sistema che rende l’avidità funzionale al benessere della società”. Ruffolo scrive: “Il compromesso socialdemocratico si fondava sulla base ideologica del pensiero keynesiano, favorevole all’intervento pubblico sulla domanda e sulla distribuzione delle risorse. La controffensiva capitalistica respinge nettamente l’interferenza dello Stato nel Mercato, e rimette in onore un idolo che sembrava distrutto: la fede inconcussa nella capacità di autoregolazione di quest’ultimo”. Con il crollo del blocco sovietico e gli Stati Uniti che si affermano non solo come la più forte potenza politica e militare del mondo, ma anche come “Quartier Generale della finanza mondiale”, nasce “una plutocrazia cosmopolitica e apolitica” o per meglio dire “ademocratica” e “amorale” che trascende gli stati nazionali, alleandosi anche con la criminalità organizzata e con le strategie politico-militari più destabilizzanti. In questo contesto l’apparizione dell’euro, che Ronconi tra ironia e speranza immagina incarnarsi in una bambina, diventa possibile alternativa alla supremazia di un unico impero turboeconomico. Anche l’onnipervadente innovazione tecnologica, che Ronconi visualizza come spazio invaso da una sorta di videoinstallazione con colonne di monitor, è permeata da un modello autoreferenziale, sganciato da un progetto etico e cognitivo, che privilegia il consumo sul servizio ed è finalizzato non a liberare - come speravano gli utopisti - gli uomini dal lavoro, ma viceversa a liberare il lavoro (e il profitto) dall’uomo. Alla fine Ruffolo e Ronconi si affidano al buon senso del Demiurgo (icona simbolica di un socratico sapiente) che dice: “- No: non è la tecnica il pericolo. E’ l’uso che se ne fa. E questo è oggetto delle nostre scelte.” E immaginano il Creatore che ritorna a riflettere su quanto accaduto da Adamo ed Eva a oggi, su come l’uomo ha amministrato il pianeta. Un Dio indignato (o sconsolato) che commenta l’oggi con parole, è proprio il caso di dire, “sante”: “- Qualcuno dovrà spiegare perché le risorse destinate a inondare incessantemente il mercato di nuove generazioni di gadgets siano state negate alla cura dell’ambiente, alla sicurezza delle infrastrutture, alla protezione del territorio, alla promozione della cultura.” Ma la conclusione del testo di Ruffolo non si limita al bilancio storico e critico dell’economia, interviene con spirito pragmatico e illuminista sulle prospettive: “alla fine, è compito della politica, non della futurologia, tracciare il percorso (...) E allora, ciò che conta non è prevedere. E’ volere: è decidere. Nel mondo dell’incertezza, l’unica certezza è la nostra volontà.” Uno spettacolo molto “colorato” per la ricchezza quasi pirotecnica delle idee concettuali e sceniche, ambientate dalle vivaci scene modulari di Tiziano Santi (che ha firmato con grande e raffinata perizia tutte le scenografie del Progetto Domani), sonorizzate da una complessa e sapiente regia del suono di Hubert Westkemper, vestite dai costumi straordinari e sorprendenti di Simone Valsecchi e Gianluca Sbicca che hanno utilizzato x tutti gli abiti il materiale sintetico delle confezioni dei prodotti industriali, e agite da un team di affiatatissimi attori, nella maggioranza giovani, molto concentrati e poliedrici nel loro attraversamento di ruoli ed epoche diverse, nella recitazione puramente vocale quanto nella coreografia, talvolta acrobatica, dei movimenti. Uno spettacolo dunque che è davvero, come aveva promesso Ronconi, “una cavalcata”, che scorre veloce, nonostante le sue cinque ore, avvincente nonostante la densità e la complessità dei contenuti, assolutamente teatrale nonostante il carattere saggistico del testo di partenza.
Devo dire che quando mi capitò di leggere il copione, prima di vedere lo spettacolo, non solo fui ammirato dalla limpidezza della scrittura di Ruffolo, ironica, mordace e capace di acutissima sintesi, ma con la curiosità del drammaturgo mi domandai subito come sarebbe stato possibile trasformare quel racconto pur straordinario ma saggistico in una regia teatrale; conoscendo bene le sfide ronconiane non nutrivo molti dubbi sui risultati ma le modalità per arrivarci costituivano un’incognita assai intrigante. E la sorpresa c’è stata: le chiavi registiche sono la polifonia delle voci e il ritmo incalzante dell’azione, segmentare il testo in brevi monologhi, contestualizzare la recitazione in ambienti forti, vivaci, luminosi e articolati e in un’azione quasi sempre corale, ricreare nell’associazione dei monologhi il ritmo del dialogo teatrale, incarnare i concetti nei personaggi citati da Ruffolo e inventarne altri per gli altri segmenti testuali, mantenere alcuni personaggi come filo conduttore e quasi voce narrante dello spettacolo, rendere ciclici i nodi tematici più importanti che ritornano a ondate per ricucire il senso dei frammenti di storia e di testo, in alcuni momenti riprodurre ironicamente il modello della “lezione” di economia, esplicitare sempre ironicamente le citazioni colte (una “lettrice” gira sul palco con un carrello da supermercato pieno dei libri citati da Ruffolo e li estrae sulla relativa battuta nominandoli e mostrandoli ostentatamente al pubblico)...
Dunque la scelta ronconiana dell’”anomalia” drammaturgica, usando testi non teatrali per affrontare una nuova drammaturgia del contemporaneo che, a differenza del cinema, non è adeguatamente rappresentata dalla letteratura teatrale (questo però in larga parte per la grande responsabilità che ha il circuito produttivo italiano nel negare accesso e sperimentazione ai nuovi autori), si dimostra una strategia vincente di spiazzamento del repertorio e della mummificazione delle idee e quindi anche una strategia vincente di riappropriazione teatrale rispetto a quel processo di espropriazione della storia, dell’economia e della cultura che si sta consumando attraverso le demagogie e le mistificazioni mediatiche del nostro opaco presente.
Le collezioni teatrali di Rosa e Ballo
Una casa editrice degli anni '40 in mostra a Milano
di Oliviero Ponte di Pino
Un sogno editoriale: Rosa e Ballo nella Milano degli anni '40
"L'importante ormai non è di fare, ma di fare bene"
lettera di Emilio Cecchi a Ferdinando Ballo, 1944
Teatro, musica, architettura, arte, letteratura, politica: dal Fondo Rosa e Ballo – conservato presso la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori – emergono il ruolo della casa editrice e la sua eredità nella cultura del dopoguerra.
In mostra carte e documenti che raccontano l'avventura di una piccola e ambiziosa casa editrice nella Milano degli anni Quaranta, tra guerra e ricostruzione.
Biblioteca Nazionale Braidense
Sala Maria Teresa
Via Brera 28, Milano
Mostra documentaria
a cura di Stella Casiraghi
22 marzo 2006 – 24 aprile 2006
Inaugurazione
21 marzo 2006 ore 18,00
Intervengono
Roberto Cerati
Roberto Di Carlo
Sergio Escobar
Luca Formenton
Luigi Ganapini
Tullio Kezich
Anna Modena
Oliviero Ponte di Pino
Marco Vallora
Qui di seguito, il testo di Oliviero Ponte di Pino per il catalogo della mostra.
C’è qualcosa di misterioso e quasi di commovente nell’affettuosa memoria che i teatranti hanno continuato a riservare a una piccola casa editrice dalla vita assai breve, presto dimenticata dai più, anche per le sfortunate vicissitudini dei suoi artefici. In circa tre anni di attività, tra il 1944 e il 1947, Rosa e Ballo pubblicò tra l’altro una quarantina di volumi in due collane, la Collezione Teatro Moderno e la Collezione Teatro. Un periodo limitato e una produzione esigua in un settore marginale e poco redditizio, allora come oggi. Eppure quei volumetti dalla grafica essenziale e raffinata, color mattone (per la Collezione Teatro Moderno) e grigio (per la Collezione Teatro), hanno lasciato un segno indelebile e qualche seme destinato a fiorire nei decenni successivi. Tra i mille progetti e sogni di quel periodo tragico e fervido, che cosa ha salvato dall’oblio e tenuto vive così a lungo le intuizioni di un marchio a cui le storie dell’editoria dedicano solo poche righe?
Come altre iniziative nate nella vergogna del fascismo e tra i disastri della guerra, e tuttavia proiettate nella speranza di un futuro migliore, Rosa e Ballo – non solo sul fronte della drammaturgia ma nel suo progetto complessivo – si assegnò il compito di aprire l’orizzonte culturale italiano alle esperienze delle avanguardie europee, dopo vent’anni di regime e una censura via via più oppressiva. Era un’intuizione necessaria ma niente affatto facile, in quelle fasi convulse, quando la lotta contro la dittatura viveva la sua fase più cruenta, quando la Repubblica di Salò e gli occupanti nazisti organizzavano l’ultima difesa, quando le difficoltà della guerra si facevano insormontabili, tra ostacoli e impedimenti di ogni genere: la repressione poliziesca, i bombardamenti, i continui trasferimenti di sede, la censura, la mancanza di materie prime (la carta era contingentata), le difficoltà di comunicazione, l’impossibilità di prendere contatto con autori, traduttori, agenti, editori, soprattutto se stranieri.

Luigi Rognoni a Rosa e Ballo.
Per fare una scelta di quel tipo, non bastava l’assoluta certezza della vittoria: bisognava anche accantonare le necessità immediate della lotta – uno scontro mortale – e pensare al “dopo”. Meglio: quel “dopo” si doveva iniziare a costruirlo, subito. O almeno si dovevano preparare gli strumenti per iniziare la ricostruzione. Questo pensiero lo espresse con grande consapevolezza Paolo Grassi in un articolo pubblicato nel giugno 1943, poche settimane prima della caduta del fascismo e dunque in un momento delicatissimo per la storia del nostro paese e per la sua personale evoluzione. Dopo aver dichiarato la propria estraneità al “cosiddetto teatro ‘normale’”, il giovane critico, regista e organizzatore tracciava il suo programma per l’immediato futuro:
Penso che il nostro compito, il compito di noi giovani, sia attualmente quello di immagazzinare libri, notizie, dati, cognizioni, conoscenze, documenti; quello che necessita è un lavoro oscuro, durissimo di studio, di preparazione, di affinamento dei nostri mezzi e delle nostre qualità. (...) Il mio personale voto è che si abbia a formare nel nostro Paese un nucleo vasto di giovani colti, documentati, esperti tecnicamente, sensibili e onesti, che sappiano e vogliano lavorare, per il teatro, solo per esso, senza dilettantismi (...) senza la abituale incoscienza. Mentre i poeti ci danno e ci daranno la parola nuova, noi prepariamo l’apparato entro cui la parola possa a suo agio vivere. (...) Siamo orgogliosi di questo “splendido isolamento”.
(Lettere sul teatro, “Eccoci”, 1° giugno 1943, citato in Meldolesi, Fondamenti, pp. 100-101)
Un giudizio sul presente, un atteggiamento, un progetto che Grassi applicava al teatro, ma validi per altri ambiti, dalla musica all’architettura, e che nel progetto editoriale di Rosa e Ballo avrebbe trovato uno strumento esemplare, persino nelle ambizioni più velleitarie.
Anche nelle scelte culturali, la direzione imboccata dalla casa editrice non era affatto scontata. L’unica avanguardia artistica italiana di respiro europeo, il futurismo nazionalista, affascinato dalla velocità e dalla guerra, aveva affiancato e sostenuto il fascismo fin dagli inizi. Poi, negli anni del consenso di massa, gli eccessi destabilizzanti dell’Accademico d’Italia Filippo Tommaso Marinetti e dei suoi erano stati in parte neutralizzati dal regime, che aveva finito per compensare le accelerazioni moderniste del movimento con il più assimilabile filone “strapaesano”. Sull’altro versante della battaglia culturale, la sinistra – a cominciare dal Partito comunista di Palmiro Togliatti, sempre pronto a intervenire nel dibattito estetico – sosteneva il realismo socialista di ispirazione sovietica (salvo poi riscattarsi nella pratica con i capolavori del neorealismo); la condanna del “formalismo” delle avanguardie da parte di Stalin e Zdanov era già stata decretata – il suicidio di Majakovskij nel 1930 aveva segnato una svolta – e nei decenni successivi avrebbe avuto un peso determinante sulla linea culturale ed estetica della sinistra: emblematica, poco dopo, la vicenda del “Politecnico” di Elio Vittorini.
In questo scenario, nella breve finestra della transizione, Rosa e Ballo offrì una risposta informata e aggiornata – per certi versi anticipatrice – rispetto alla situazione del momento. Cercava l’emancipazione dalle pastoie e dal provincialismo del regime, senza per questo accontentarsi dei diktat estetici imperanti a sinistra. Non a caso l’iniziativa nasceva a Milano, la più moderna città italiana, il cuore pulsante della ricostruzione e del futuro boom economico, proprio quando la resistenza era più accesa e le spinte innovative effervescenti. Malgrado il fascismo, la vita culturale cittadina aveva infatti continuato a manifestare una qualche vitalità, e i frutti di quei fermenti si sarebbero visti al momento opportuno.
Erano gli anni [Venti e Trenta, n.d.r.] in cui la via del Monte Napoleone con le sue quattro librerie, luoghi di incontro di artisti e scrittori, Bestetti e Tuminelli, San Marco, la Libreria Editrice Scolastica dei fratelli Puccini, al n. 18, e le sedi circonvicine di Hoepli in galleria De Cristoforis, Esame in Crocerossa (dove arrivò il giovane Comisso, in fuga dalla provincia, per diventare il più grande libraio di Milano) si identificava a tutti gli effetti con la contrada dell’arte. Si avviava qui quella vocazione degli intellettuali e della borghesia cittadina al libro di cultura e d’arte, che procedeva accanto a quella industriale, e che avrebbe visto in città la nascita di imprese editoriali vive ancora oggi, come Ricciardi e Scheiwiller, e circoscritte nel tempo, ma non effimere, come Rosa e Ballo e Cederna.
(dalla prefazione a Botteghe di editoria, a cura di Anna Modena)
Tra tutte, la casa editrice Convegno – legata alla rivista omonima, animata da Enzo Ferrieri, letterato e uomo di teatro che fece conoscere in Italia la grande letteratura europea del Novecento – aveva pubblicato nel 1921 come primo titolo Risveglio di primavera di Frank Wedekind nella traduzione di Giacomo Prampolini; un paio d’anni dopo la rivista aveva dedicato un numero speciale ad Adolphe Appia.
Nello spirito delle avanguardie – ma senza alcun esplicito intento o manifesto programmatico, piuttosto come prassi inevitabile, come metodo di lavoro quasi naturale – era anche l’intreccio di diverse discipline che avrebbe caratterizzato l’atteggiamento di Rosa e Ballo. Il progetto più ambizioso della casa editrice – destinato a restare tale – era peraltro un Dizionario delle arti contemporanee, che ricorda il progetto di regime del Dizionario dello spettacolo e quello di un amico della casa editrice come Valentino Bompiani, che in quegli anni varava eroicamente il suo Dizionario delle Opere e dei Personaggi.
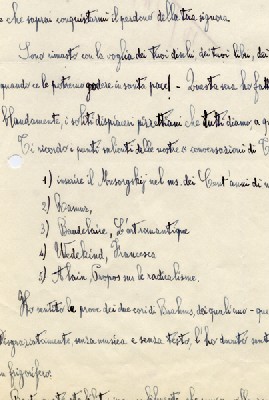
Massimo Mila a Rosa e Ballo.
A questa impostazione non può essere estranea la formazione di musicologo di Ballo, che certo avrà riflettuto sulle suggestioni wagneriane dell’opera d’arte totale e su Appia. All’inizio degli anni Trenta, Ballo era stato con Luigi Rognoni tra i fondatori della galleria Il Milione, dove esponevano artisti come Max Ernst, Lurçat, Marcoussis, Léger, Pascin (1932) o Seligmann, Kandinskij, Vordemberge-Gildewart, Albers (1934), circolavano riviste come i “Cahiers d’Art”, “Cercle et Carrè”, “Abstraction-Création” e soprattutto i “Bauhausbücher”; lì era possibile ascoltare la musica dodecafonica di Schönberg, di fatto bandita dalle sale da concerto.
Fedele a questa impostazione, caratterizzata dall’apertura al nuovo e dall’interdisciplinarietà, Rosa e Ballo pubblicò in un arco di tempo relativamente breve diversi libri importanti, destinati a essere ristampati per decenni, soprattutto nel campo dell’architettura, della musica e della politica. Già questo fu un risultato eccezionale.
L’avventura teatrale della giovane casa editrice fu ancora più straordinaria e importante. Nei primi anni Quaranta i due aspiranti editori erano entrati in contatto con quello che sarebbe stato il terzo protagonista dell’impresa, uno dei grandi riformatori del teatro italiano – o forse uno dei pochi rivoluzionari delle nostre scene, almeno in quella fase. Paolo Grassi aveva poco più di vent’anni (era nato il 30 ottobre 1919). Suo padre Raimondo era arrivato a Milano da Martina Franca, in Puglia, e lavorava da tempo al quotidiano economico “Il Sole”. Sua madre, Ines Platesteiner, discendeva da una famiglia bavarese ma veniva da Fiorenzuola d’Arda, non lontano da Parma; amava la musica e il teatro.
Grassi era socialista come i due editori. In una Milano “viva e seria” (l’impressione, in una lettera del 29 dicembre 1943, è di Valentino Bompiani, in Cinquant’anni e più. Lettere 1933-1989, a cura di Valentina Fortichiari, Bompiani, Milano, 1995), che già intuiva il tragico sbocco del fascismo, il giovane “vice” (a diciassette anni aveva iniziato a collaborare anche lui con “Il Sole”, affiancando il critico teatrale titolare Angelo Frattini) si era fatto una certa fama.
Paolo era quello che poi ha continuato a essere: una specie di fiume in piena con una grande volontà e molto rigore (...) uno che sapeva molto e che sapeva quello che voleva.
(Ernesto Treccani, “Un’amicizia lunga una vita”, in Il Piccolo Teatro di Milano. Cinquant’anni di cultura e di spettacolo, p. 14)
Nel marzo del 1940, alla vigilia dell’entrata in guerra dell’Italia, Grassi era stato tra i protagonisti di una memorabile serata milanese (nei suoi ricordi, Quarant’anni, p. 100, è la sera del 18 marzo; nell’accurata ricostruzione di Meldolesi, Fondamenti, p. 44, è quella del 28 marzo). Debuttava al Teatro Nuovo di Milano Piccola città di Thornton Wilder e il battagliero Grassi, con gli amici di “Corrente” strategicamente disposti in platea, si era segnalato tra i più accesi sostenitori di una pièce che sfidava la tranquilla convenzionalità degli spettacoli italiani dell’epoca. La gazzarra lasciò il segno, ma non fu certo l’unica nella lunga guerra, ispirata alle riflessioni di Silvio D’Amico, per un teatro d’arte e di cultura, per l’affermazione di una nuova drammaturgia e per l’avvento della figura del regista.
Secondo un racconto diventato leggenda, nel 1938 tra i frequentatori degli “ingressi” dei teatri milanesi Grassi aveva notato un altro spettatore abituale: di un paio d’anni più giovane di lui, ugualmente appassionato, abitava dalle parti di casa sua. Era Giorgio Strehler. Sia la mamma di Giorgio sia quella di Paolo amavano la musica, così i due amici passavano assieme le serate, a casa dell’uno o dell’altro, ascoltando soprattutto Stravinskij.
Ma ascoltano anche Kurt Weil, Malipiero, Satie, Schönberg a casa di Luigi Rognoni, il padre della impossibile dodecafonia italiana, o da Fernando Ballo, al quale piace anche il recupero di Offenbach.
(Grassi, Quarant’anni, p. 97)
Il musicologo Ballo non era solo un fan di Offenbach, oltre che amico e collaboratore di Malipiero (vedi il suo libretto per I capricci di Callot, La Lampada, Milano, 1942): era uno degli animatori della vita culturale della città. Il giovane Grassi se ne accorse subito.
Fernando Ballo è il polo catalizzatore di una certa Milano che, attenta alle cose del mondo, aspira a uscire dai limitati orizzonti provinciali in cui l’ottuso controllo fascista aveva rinchiuso la vita culturale italiana. Nella casa di Ballo si incontravano, tra gli altri, Luigi Rognoni, Edoardo Persico, Giulia Veronesi, Raffaello Giolli, Angelo Saraceno (cognato di Ballo e fondatore, con altri, del Partito della sinistra cristiana), i pittori Umberto Lilloni, Angelo Del Bon, Adriano Spilimbergo (conosciuti come i “chiaristi”). Un gruppo vivo, intelligente, aperto alle suggestioni e alle influenze più positive provenienti da oltre frontiera.
(ivi, p. 118)
Casa Ballo diventò un polo d’attrazione per tutta la “generazione del ’45”, in cui si riconoscevano tra gli altri Carlo Lizzani, Mario Alicata, Vito Pandolfi, Marco Valsecchi, oltre naturalmente a Grassi e Strehler, che nel ’73 ricorderà:
Certo la generazione “del ’45” esiste. Una generazione senza maestri. Questa è una realtà. Andavamo a frugare tra i libri della biblioteca di Nando Ballo, un amico saggio, a scoprire da soli il mondo. Un mondo di cui nessuno ci aveva parlato. Cantavamo l’Opera da tre soldi in segreto come un peccato carnale. E tutto ciò ci è rimasto addosso, ce lo portiamo sulle spalle. La generazione di oggi vive nella dissacrazione del maestro. Noi invece ne sentivamo la mancanza in termini di riferimento. Noi volevamo avere dei maestri. E ce li fabbricavamo, magari. Ce li costruivamo.
(Strehler, Per un teatro umano, p. 21)
E’ bene seguire passo passo, in quei mesi cruciali, le attività di quei ragazzi ambiziosi e sempre in movimento. Fu uno di quei periodi in cui lo sviluppo culturale e artistico sembra subire una violenta accelerazione, in una sorta di esplosione creativa. Solo attraverso i rimandi tra attività editoriale e pratica scenica è possibile cogliere il ruolo centrale della casa editrice, dei suoi artefici e degli autori che ha pubblicato nel rinnovamento del teatro italiano.
I due amici Grassi e Strehler, le loro compagne Enrica Cavallo e Rosita Lupi, entrambe musiciste, i loro coetanei Mario Feliciani (compagno di Strehler all’Accademia dei Filodrammatici) e Franco Parenti, tutti antifascisti, erano i capofila di una nuova scapigliatura milanese che aveva subito legato con il gruppo di “Corrente”, o meglio con quello che ne era rimasto dopo che il regime, nel 1940, aveva chiuso la rivista “Corrente di vita giovanile”. La collaborazione tra Grassi e quel gruppo illumina l’impostazione di una casa editrice come Rosa e Ballo, che per alcuni aspetti ne è l’erede. “Corrente” voleva svecchiare un orizzonte culturale chiuso dalle censure e dall’autarchia del regime, riaprendo i contatti con le tendenze più vive e moderne delle arti e del pensiero contemporanei. Al gruppo facevano riferimento diversi pittori: Birolli, Guttuso, Valenti, Mucchi (che diverrà amico e traduttore di Brecht), De Grada, Cassinari, Morlotti, Sassu, Badodi, Vedova, Migneco e naturalmente Ernesto Treccani, che aveva diretto la rivista del gruppo. Accanto a loro c’erano filosofi come Enzo Paci e Luciano Anceschi, letterati come Vittorio Sereni, Alfonso Gatto, Salvatore Quasimodo, Luigi Rognoni, Alberto Lattuada, Giansiro Ferrata, Beniamino Joppolo, Cesare Zavattini… Questo intreccio di esperienze e discipline diverse avrebbe fecondato la cultura milanese del dopoguerra: basti pensare a due artisti formatisi in quegli anni, un pittore diventato attore e drammaturgo come Dario Fo, o un pittore-critico-drammaturgo-romanziere-poeta come Emilio Tadini. L’impostazione del catalogo di Rosa e Ballo, con le sue aperture multidisciplinari, respira quell’atmosfera.
Dopo essersi fatto le ossa organizzando la fortunata tournée della Cena delle beffe di Sem Benelli per la compagnia Ninchi-Tumiati (Grassi, Quarant’anni, pp. 102-104), Grassi era stato tra i fondatori di “Palcoscenico”, una delle filiazioni di “Corrente”. Attivo alla Sala Sammartini, diretto da Grassi “con sacro furore” (Leonida Repaci, Teatro d’ogni tempo, Ceschina, Milano, 1967, p. 567), era l’unico gruppo teatrale sperimentale esterno ai GUF: “il repertorio è eclettico; ma ci sono i segni di una ricerca e di una problematica lontane dal teatro di consumo”. Nella primavera del ’41 “Palcoscenico” programmò sette serate con 19 titoli (soprattutto atti unici), in cui figuravano diversi autori italiani ma soprattutto “più consolidate (...) scelte di drammaturgia straniera”: tra l’altro La poverella di Yeats, Cavalcata a mare di Synge, e poi O’Neill, Cechov, Evreinov e la scena del balcone da Romeo e Giulietta. Grassi era principale capocomico e regista, tra gli attori figuravano Strehler, Feliciani e Parenti, Giuliana Pogliani e Aegle Sironi (figlia del pittore). Per quei giovani teatranti fu una palestra decisiva: si trattava di riportare la parola poetica al centro della scena, e al tempo stesso rifiutare la trionfalistica retorica del fascismo (Grassi, Quarant’anni, pp. 107-108; Meldolesi, Fondamenti, p. 61).
Sul finire della stagione 1940-41 “Palcoscenico” ebbe la possibilità di produrre uno spettacolo: la scelta cadde su Ultima stazione del siciliano Beniamino Joppolo, che nel 1941 era stato pubblicato proprio dalle Edizioni di Corrente. Paolo Grassi si incaricò della regia, c’erano particine per quattro pittori (Migneco, Valenti, Birolli e Badodi) e un ruolo – quello del capostazione – per Giorgio Strehler.
E’ interessante guardare alla locandina di questo “spettacolo d’arte” che portava una scritta in cui si diceva “tutti gli artisti di tutte le arti devono intervenire”. Questo era un po’ lo spirito di quegli anni in cui cominciavamo. Alberto Lattuada, redattore della rivista [“Corrente”, n.d.r.], scriveva racconti. Guido Morosini, critico d’arte, curava la scenografia dello Spazzino e la luna, l’atto unico che avevo scritto [anch’esso pubblicato da Corrente nel 1941, n.d.r.] e che Franco Parenti interpretava. Un fervore artistico in cui uno si legava all’altro anche perché eravamo tutti così giovani e sentivamo molto fortemente l’interdisciplinarietà. E questo si rifletteva anche nei nostri rapporti, rendeva molto ricco lo scambio di esperienze che non potrei definire come eclettismo, ma piuttosto come interesse globale per la pittura e l’arte tenendo conto che c’era il fascismo e che tutto quello che noi volevamo era proprio il contrario dell’autarchia fascista.
(Treccani, “Un’amicizia...”, pp. 13-14)
Lo spettacolo andò in scena al Teatro dell’Arte il 25 giugno 1941 e fu un successo, anche se procurò al giovane regista l’immediata espulsione dal GUF, perché contro le regole aveva continuato a svolgere attività teatrale fuori dal Gruppo Universitario Fascista (Grassi, Quarant’anni, p. 109; Meldolesi, Fondamenti, pp. 65-66).
Fu l’ennesima feroce polemica prima della partenza di Grassi (che nel frattempo aveva firmato anche la regia di un testo di Benavente) per il servizio militare. Ma anche sotto le armi il teatro rimase al centro delle sue preoccupazioni: collaborava tra l’altro a due riviste universitarie – e dunque legate ai GUF, nell’ambito della fronda che i Gruppi Universitari Fascisti tolleravano più o meno consapevolmente – edite a Forlì, “Via consolare” (poi “Spettacolo – Via consolare”) e “Pattuglia”. Nel luglio-agosto del 1942 quest’ultima pubblicò un numero speciale monografico dal titolo Per il teatro, a cura di Walter Ronchi e Paolo Grassi.(1) Il 1° aprile 1943 l’infaticabile Grassi curò con il suo staff il numero monografico di un’altra rivista “gufina” con cui collaborava, “Eccoci”, intitolato Per un nuovo teatro.
Strehler aveva anche uno sbocco a Novara, all’epoca vivace centro culturale: originari della città piemontese erano, oltre a Ballo, anche i fratelli Bonfantini, in particolare Mario, amico di Ballo e collaboratore della casa editrice. Dall’agosto 1942 a Novara veniva pubblicato il mensile dei GUF “Posizione”, che ospitò diversi significativi articoli di Strehler; sempre a Novara con il teatro dei GUF locali Strehler debuttò come regista con un trittico pirandelliano il 24 febbraio 1943 (Battistini, Strehler, p. 7, pp. 19-25; pp. 29-30).
Dopo l’8 settembre, mentre Strehler si rifugiava in Svizzera (un soggiorno determinante nella sua formazione), Grassi abbandonò l’esercito (all’epoca era sottotenente in Carnia), tornò a Milano sotto falso nome e “su invito di Fernando Ballo entr[ò] a far parte della nuova casa editrice Rosa e Ballo” (Grassi, Quarant’anni, p. 118). Il 10 ottobre del 1943 le Schede contabilità registrano un pagamento a Paolo Grassi (Fondo Rosa e Ballo, Fondazione Mondadori [da ora RB] 1/1, n. 33 verso; la scheda personale di Grassi registra analogo pagamento per “acconto direzione collana”, RB 1/1, n. 3 recto).
Il progetto editoriale era già ben delineato nei primi mesi del 1944, almeno per quanto riguarda il teatro. I collaboratori erano di ottimo livello e potevano fornire materiali e informazioni sui diversi ambiti di interesse della casa editrice. Enzo Ferrieri, intellettuale e regista, fondatore nel 1924 del Teatro del Convegno, direttore artistico dell’EIAR a Milano dal 1929, era come abbiamo visto un animatore della vita culturale della città; avrebbe dato a Rosa e Ballo la sua fortunata traduzione del Gabbiano di Cechov, utilizzata tra l’altro anche da Strehler al Piccolo Teatro nel 1948 (Il Poligono avrebbe pubblicato nel 1946 un volume con altre traduzioni cechoviane di Ferrieri, Le tre sorelle, Il giardino dei ciliegi e Zio Vania); nel dopoguerra avrebbe diretto circa 600 testi per la prosa radiofonica. L’anglista Carlo Linati aveva avuto un ruolo chiave nel presentare nel nostro paese la nuova drammaturgia irlandese di Synge (nell’ormai lontano 1917), Yeats e Joyce. Glauco Viazzi (ovvero Jusik Achrafian), ingegnere chimico ma soprattutto critico letterario e cinematografico,(2) copriva l’area russa. Alessandro Pellegrini, germanista e scrittore, si dedicò a Strindberg, con traduzioni e scritti saggistici. Grassi – traduttore in proprio di Wedekind – coinvolse una pattuglia di germanisti e traduttori dal tedesco come Emilio Castellani, Ervino Pocar e Bruno Revel. Tra i collaboratori di Rosa e Ballo figuravano inoltre alcuni registi (e teorici della regia) che cercavano spazio sulle scene italiane e che con Grassi collaboravano anche sul fronte teatrale: Strehler e Ferrieri (animatore del Teatro del Convegno e dal 1929 direttore artistico dell’EIAR a Milano), naturalmente, e poi Vito Pandolfi e Ruggero Jacobbi (oltre al giovane Luigi Comencini).
La casa editrice si sarebbe dunque occupata soprattutto di traduzioni, e in particolare della traduzione di testi teatrali. Neppure questa era una scelta ovvia. Per quanto riguarda il settore di mercato, gli editori erano ben consapevoli delle difficoltà che avrebbe potuto incontrare la loro proposta, quando avevano presentato la Collezione Teatro Moderno:
Gran parte della storia dell’arte ha la sua vita nel teatro. Il pubblico italiano in generale non legge le opere di teatro, preferisce ascoltarle, rappresentate. Con tanto parlare e scrivere che si è fatto di crisi, di regìe, di problemi scenografici, non sarebbe opportuno conoscere anche le opere che ne hanno motivata la discussione?
Oltretutto la censura fascista faceva di tutto per disincentivare le traduzioni, in base alle precise indicazioni di Benito Mussolini. Anche se il Ministero della Cultura popolare della Repubblica di Salò operava in condizioni difficili e la sua azione incontrava notevoli ostacoli (certo inferiori a quelli che, in una economia di guerra, doveva affrontare una giovane casa editrice...), la vigilanza sulle traduzioni era occhiuta e attenta.
La censura tiene d’occhio la casa editrice. Ballo e Grassi più di una volta devono sobbarcarsi viaggi, per quei tempi assai avventurosi, a Salò, ove hanno sede gli uffici del governo fantoccio, e a Venezia, ove è installato il sempre petulante ministero della Cultura popolare, Minculpop. I negoziati con i funzionari della censura sono laboriosi e delicati: l’ignoranza e la prepotenza mettono a dura prova l’abilità e la pazienza dei due esponenti editoriali. (...) Al ritorno a Milano i resoconti di questi pellegrinaggi in censura sono commentati nell’ambiente della casa editrice, ora con sarcasmo, ora con sdegno. Autori, traduttori, collaboratori, sono tutti fortemente antifascisti, alcuni addirittura partigiani combattenti, come i grafici Luigi Veronesi e Remo Muratore, quest’ultimo comandante di una brigata. Si sa, comunque, che i censori sono destinati a sparire.
(Grassi, Quarant’anni, p. 119)
Nonostante tutto, l’impresa partì subito con un ritmo incalzante e obiettivi ambiziosi. A sospingerla fu una vera e propria urgenza, un disperato entusiasmo che si può capire solo con la gravità del momento. Una serie di appunti dattiloscritti ricapitola tre successivi invii di materiale con la richiesta dei permessi di traduzione al Ministero della Cultura popolare: il 10 marzo 1944 dieci titoli, il 28 marzo altri diciassette e il 10 (o 15) maggio 1944 ancora quattordici, più tre aggiunti a matita (RB 5/26, n. 65; ma vedi anche i fascc. 5/27 e 5/28).(3) In totale, 45 titoli in un paio di mesi: sarebbero stati sufficienti a riempire il programma editoriale di una piccola casa editrice per diversi anni, Rosa e Ballo li pubblicò quasi tutti negli ultimi mesi di guerra e nelle settimane immediatamente successive.
Si trattava in grandissima maggioranza di testi teatrali, che nel loro insieme costituirono l’ossatura delle due collane dirette da Grassi: nei primi due elenchi comparivano già una quindicina di pièce destinate a confluire nella Collezione Teatro Moderno, mentre nel terzo si trovavano l’opera omnia (in pratica) di Büchner (Woyzeck, La morte di Danton e Lena e Leonce, più Lenz, che uscirà nella Collezione Varia) e I corvi di Becque, ovvero quasi la metà della Collezione Teatro, quella dedicata ai classici – ma classici, lo si sarà già capito, eccentrici e anticipatori.(4)
Non tutti i testi ottennero il nulla osta, secondo quei riepiloghi. Wedekind venne bocciato (ma c’era un pizzico di malizia nel sottoporre ai censori un testo intitolato proprio La censura), così come Gide.(5) Kaiser inizialmente aveva passato l’esame ma un telegramma arrivato il 20 agosto lo bloccò, insieme a Büchner:
Comunicasi divieto pubblicazioni opere autori Buchner et Kayser [sic]. non essendo graditi punto pregasi assicurare urgentemente punto
Sottosegretario Cucco
(RB 5/27, n. 2; il telegramma è del 17 agosto; seguì un dispaccio che ribadiva il divieto: vedi RB 5/27, n. 2)
E’ probabile che a questo vaglio non siano stati nemmeno sottoposti alcuni testi che forse rientravano già nel piano iniziale, ma che dovevano essere certamente sgraditi al regime perché “di autori ebrei “, o “di autori appartenenti a paesi nemici o comunque (...) pubblicati in tali paesi e nei loro possedimenti” (Circolare del ministro Fernando Mezzasoma, 24 novembre 1943, in Fabre, L’elenco, p. 482) oppure “sovversivi”. Nell’elenco dei circa 900 “Autori le cui opere non sono gradite in Italia” diffuso dal Ministero della Cultura popolare il 23 marzo 1942, e rilanciato nel maggio del 1944 (ivi, pp. 474-481), figuravano Schnitzler, Toller e Wedekind – però mancava Brecht. Molti dei testi “proibiti” risultano tuttavia stampati ugualmente nel 1944, a cominciare proprio da Kaiser e Büchner.
Va sottolineata la presenza, in questi elenchi, di alcuni progetti variamente legati al teatro, che però non avrebbero potuto trovare posto in una collana di testi: tra gli altri, oltre al Lenz di Büchner (che è una prosa biografico-narrativa), l’epistolario di Ibsen (aggiunto a matita in calce all’elenco del 10-15 maggio 1944) e L’oeuvre d’art vivant di Adolphe Appia.
La scelta dei titoli e degli autori parla da sola. Grande attenzione per l’area tedesca (ovviamente per autori ostili a Hitler e al nazismo), grazie alle competenze linguistiche di Grassi, ma anche per la fascinazione in quel momento di un taglio espressionista (e in qualche modo “pessimista”, di fronte ai trionfalismi mussoliniani): vedi l’inserimento di Brecht, Kaiser, Toller e Wedekind, oltre all’interesse per un precursore come Büchner. Si trattava anche di ricucire i rapporti con la cultura tedesca dopo la frattura hitleriana, con particolare attenzione alla vivace Monaco di Baviera d’inizio secolo; e agli autori che avevano saputo dare forma alla crisi seguita alla Prima guerra mondiale: Toller, Kaiser e Brecht, che si erano già confrontati con la prima grande stagione della regia tedesca. Un altro importante punto di riferimento erano senz’altro i memorabili allestimenti di Erwin Piscator (Oplà noi viviamo di Toller nel 1927 e l’anno successivo lo Schwejk riscritto da Brecht); e soprattutto quelli di Vsevolod Mejerchol’d, che nella Mosca post-rivoluzionaria aveva portato in scena Albe di Verhaeren (1921) e Il magnifico cornuto di Crommelynck (1922), oltre a Mistero buffo (1918 e 1921), La cimice (1929) e Il bagno di Majakovskij (1930). Poi notevole spazio al “rinascimento irlandese” con Yeats, Synge e O’Casey (e naturalmente Joyce).(6)
Ancora, una presenza massiccia di August Strindberg, con ben cinque volumi nelle prime quattordici uscite della Collezione Teatro Moderno; per comprendere il potenziale impatto culturale della proposta, basti il titolo della monografia dedicata allo scrittore svedese da Alessandro Pellegrini, prima uscita della Collezione Il Pensiero: Il poeta del nichilismo.
Per coprire l’area angloamericana, Grassi poteva contare sulla consulenza di Gerardo Guerrieri, prodigo di segnalazioni per il “Carissimo Pablo”:
Ho in macchina Odets, che è una commedia molto importante e che nessuno conosce, e sto lavorando a un saggio su Stanislavschi da premettere alla traduzione che vi manderò a suo tempo. In questa sono anzi molto impegnato, perché con i due saggi su Meyerhold che preparo per Prampolini, e che usciranno nella collezioncina di cui ti ho parlato, sto preparando e studiando per una storia dello spettacolo russo ora che posso servirmi della lingua originale.
(senza data, RB 3/16, n. 3)
In una lettera (probabilmente successiva) del 4 marzo 1944 a Enrica Cavallo, che in quel periodo raccoglieva la corrispondenza di Grassi, Guerrieri specificò le sue proposte.
O’Neill Tutti i figli di Dio hanno le ali
Rice Street Scene
Odets Awake and Sing e (se vi serve)
Till the Day I Die (che ho trovato in questi giorni)
Golden Boy
Connelly Green Pastures
Hughes Theatre
Max Anderson High Tor
una raccolta di 5 atti unici (Odets, Dreiser, Shaw Ir., Susan Glaspell)
Dos Passos Airway’s Inc.
...i due di Auden e Isherwood, Geneva di Shaw ecc. Ho ancora Women di Claire Boothe, e varie altre commedie di gran successo ma minore interesse.
(RB 3/16, n. 5)
Non se ne fece niente. Finita la guerra, quando ripresero i contatti, Grassi – che aveva ormai pubblicato numerosi volumi – ne spiegò i motivi allo stesso Guerrieri in una lettera del 2 luglio 1945.
Sto preparando varie altre cose, ma la difficoltà enorme è nei diritti di Autore, specie di americani e inglesi per cui non sono riuscito ancora a trovare la strada.
(RB 3/16, n. 17)
Così nel repertorio di Rosa e Ballo figurò un solo dramma di un autore nordamericano, William Saroyan; allo stesso modo rimase unica la presenza italiana, quella di un amico della casa editrice come il poeta e pittore Alfonso Gatto, con Il duello.(7)
Il varo delle collane fu un vero tour de force. In quelle settimane febbrili il pragmatismo e l’efficienza del “tedesco-pugliese” Grassi travolsero le titubanze dei due intellettuali “nordici” Rosa e Ballo. Per cogliere il clima in cui nacquero quelle collane – dentro e fuori la casa editrice – è sintomatica la lunga lettera, tre cartelle dattiloscritte fitte fitte (con un post scriptum aggiunto a mano), scritta da Grassi su carta intestata del quotidiano “Il Sole” il 16 aprile 1944 (RB 5/29, nn. 3, 2, 1).
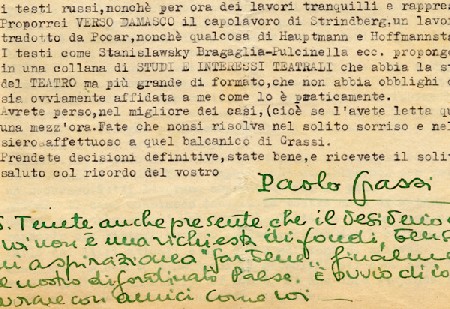
Paolo Grassi a Rosa e Ballo.
Quello esposto da Grassi nella sua travolgente e per certi versi esilarante missiva era un preciso progetto imprenditoriale, anche nei dettagli; non si riferiva solo alle collane teatrali ma investiva l’intera casa editrice. In primo luogo era necessario impiantare un’azienda moderna ed efficiente.
Io propongo URGENTEMENTE: LOCALI, organizzazione PERSONALE, FUNZIONAMENTO PRECISO della casa attraverso le dirette competenze di tutti e il lavoro di tutti. Propongo pure ufficialmente la mia assunzione in breve giro di giorni affinché sia possibile potenziale al 100% la casa e preparare un lancio come si deve. Il mio lavoro dovrebbe essere quello da me proposto tempo fa, più il lavoro della Veronesi appena ella lascerà la casa, ed è logico ch’io chieda ciò date le mie capacità intellettuali.
In secondo luogo, le pubbliche relazioni e il marketing: si trattava di segnalare i volumi alla stampa e ai librai, e dunque ai lettori.
In questo mese del resto io ho mandato via diecine di lettere in tutti i luoghi, ho assunto informazioni preziose, ho tutte le tariffe in mano della pubblicità, ho stabilito contatti utili con librerie, ho assicurato recensioni ai libri, ho preparato quindi un lavoro che, con una dattilografa e con la possibilità economica di mandar via centinaia anziché decine di lettere, avrebbe potuto essere preciso e più completo.
Le difficoltà in cui si trovavano alcune delle case editrici maggiori (dal novembre ’42 la sede della Mondadori si era trasferita ad Arona, un anno dopo lo stesso Arnoldo Mondadori raggiungeva i figli in Svizzera) lasciavano ampi spazi di manovra. Tuttavia andava contrastata la concorrenza di iniziative analoghe.
Voi dovete entrare nell’ordine di idee che a Milano sono in funzione otto nuove case, tutte più o meno forti. Io ho visto firmare contratti amplissimi e impegnativi con opere importantissime, ho visto offrire somme superiori alle nostre e accaparrare testi indubbiamente fondamentali. Non bisogna presumere, ché tutti lavorano bene e la concorrenza si farà sentire in tutti i campi.
La produzione, come abbiamo visto dagli elenchi per la censura, si concentrava sui testi: per dare maggiore visibilità all’impresa era necessario pubblicare “per ora dei lavori tranquilli e rappresentabili”. La messinscena dei testi pubblicati e gli adattamenti radiofonici avrebbero dato visibilità alla collana, lasciando sperare in introiti collaterali. Era dunque ancora più indispensabile mantenere buoni rapporti con il mondo del teatro. Malgrado i teatranti, se necessario.
Ferrieri. Vi sarà antipatico, può essere. Però gli uomini di teatro sono questi e noi abbiamo BISOGNO di rappresentazioni per lanciare la collana. Ora questo è anche il caso di Pandolfi.
Lo stesso Grassi si era riservato un bonus in caso di allestimento di un testo da lui fatto pubblicare. Tanto è vero che quando Il gabbiano nella traduzione di Ferrieri andò in scena al Piccolo Teatro, l’ex direttore di collana, dopo aver calcolato in 158.000 lire i proventi per i diritti d’autore della casa editrice per la rappresentazione, batté cassa presso il “Carissimo Rosa” con una lettera su carta intestata del Piccolo Teatro, datata 19 gennaio 1949.
Mi permetto di chiederti, come da tua promessa di un tempo se io fossi riuscito a far rappresentare testi di edizione Rosa e Ballo, la somma per me di lire 60.000==
Ti faccio notare che avrei potuto benissimo far fare una nuova traduzione apposita, pagarla a forfait e guadagnare il triplo perlomeno, ma non ho voluto tradire uno dei nostri primi volumi e dei nostri impegni reciproci.
(RB 15/8, n. 1)
Nell’occasione Grassi pretese anche una sorta di liquidazione: ricevette le 60.000 lire relative al Gabbiano, ma – a quanto risulta – null’altro. (RB 15/8).
Era inoltre già prevista la possibilità di ampliare il catalogo, con saggi di teoria e storia del teatro (Piscator, Stanislavkij e Bragaglia).
Per la collana TEATRO, torno a proporre DAS POLITISCHE THEATER di Piscator, i testi russi, nonché per ora dei lavori tranquilli e rappresentabili. Proporrei VERSO DAMASCO il capolavoro di Strindberg, un lavoro di Bjornson tradotto da Pocar, nonché qualcosa di Hauptmann e Hofmannsthal.
I testi come Stanislawsky Bragaglia-Pulcinella (8) ecc. propongo di riunirli in una collana di STUDI E INTERESSI TEATRALI che abbia la stessa copertina del TEATRO ma più grande di formato, che non abbia obblighi di uscita, e che sia ovviamente affidata a me come lo è praticamente.
Grassi però considerava i due soci un po’ troppo mondani e chiacchieroni, e cercava di rimetterli in riga.
Da noi è un caos assoluto, c’è un sacco di gente che non combina, ci sono idee, c’è la festa del “faremo” ma non si fa nulla. Ci vogliono MESI per avere clichés, copertine, cartoncini, il tutto a prezzi altissimi. Quando faremo la carta igienica ROSA E BALLO la faremo fare all’Archeotipografia.
Che le accuse esposte dal giovane direttore di collana fossero giustificate o meno, la missiva ebbe effetto. Dal “Libro giornale” della casa editrice, compilato a partire dal 9 ottobre, risulta che Grassi abbia ricevuto uno stipendio, almeno da quello stesso ottobre 1944 fino all’estate 1946, oltre a una serie di rimborsi spese (RB 1/2). La casa editrice cominciò a sfornare testi teatrali a ritmo frenetico. I primi otto titoli (tra cui due opere di Kaiser) della Collezione Teatro Moderno portano il finito di stampare “luglio 1944”, e – se il finito di stampare è credibile – altri dodici (compresi il Wedekind tradotto da Grassi e Yerma tradotto da Bo) vennero stampati prima del novembre del ’44, I giorni della vita di Saroyan nel gennaio del ’45. I primi cinque testi della Collezione Teatro vennero stampati tra il luglio e il novembre del ’44 (compresi i tre Büchner), il sesto, Una donna uccisa con la dolcezza, porta il finito di stampare “20 aprile 1945”. Quasi folle e incredibile, soprattutto se si pensa alle condizioni dell’Italia in quei mesi.
Le collane ideate da Grassi erano un abile mix di testi già tradotti e pubblicati in rivista (a cominciare dal primo titolo della Collezione Teatro Moderno, Esuli di Joyce, pubblicato su “Il Convegno”, nn. 2-3-4, 1920) e di novità. Proponeva autori come Strindberg, ancora poco frequentato ma già destinato a diventare un classico, per i quali si sperava in prossime messinscene (e relativi emolumenti dalla SIAE): per esempio, scrivendo a Enzo Ferrieri il 1° aprile 1944 a proposito della sua traduzione di Crommelynck, gli chiedeva anche di Cocteau, in vista di un possibile allestimento.
Hai letto I PARENTI TERRIBILI? Credo che la Ferrati dovrebbe entrare come in un guanto in Leo. Ma hai Yvonne?
(RB 3/6, n. 1)
(Il testo fu allestito nel 1946 da Luchino Visconti, con Andreina Pagnani e Lea Padovani.)
Alcuni testi erano da tempo al centro dell’attenzione di intellettuali e teatranti, e la loro pubblicazione era assai attesa: all’inizio del 1946, presentando le collane teatrali di Rosa e Ballo alla radio, Silvio D’Amico spiegava: “sono, come si vede, i nomi che in Italia si andavano ripetendo da un pezzo, fra gli amatori, con una curiosità più o meno inappagata. Adesso costoro potranno cominciare a leggerseli, e non più sporadicamente ma con un certo metodo; farsene un’idea consapevole, considerarli con giudizio critico”; nel seguito della puntata, D’Amico si concentrava su Georg Kaiser (Silvio D’Amico, Cronache del teatro drammatico. Commedie in volume, datato 27 febbraio 1946, RB 24/5). Anche le vicissitudini italiane dell’Opera da tre soldi di Brecht sono indicative: travestita da messinscena del testo di John Gay per aggirare la censura, venne allestita da Anton Giulio Bragaglia al Teatro degli Indipendenti di Roma con il titolo La veglia dei lestofanti l’8 marzo 1930 (quindi solo due anni dopo la prima berlinese). Il testo di John Gay andò in scena anche nel febbraio del 1943, protagonisti Gassman, Mazzarella e Albertini, con le scene di Toti Scialoja e la regia di Vito Pandolfi, che “ricollocava il testo negli anni della nascita del fascismo”: si scatenò un putiferio che portò all’arresto di Pandolfi e Mazzarella (Meldolesi, Fondamenti, p. 105).
Il 25 aprile 1945 – la Liberazione – segnò ovviamente un momento di forte discontinuità. Sembrava davvero che i sogni potessero diventare realtà. Tanto per cominciare all’“Avanti!”, il quotidiano del Partito socialista diretto da Guido Mazzali, le rubriche di spettacolo erano state “affidate a Fernando Ballo (musica), Alfredo Panicucci (cinema), Paolo Grassi (teatro)” (Grassi, Quarant’anni, p. 133). Nel frattempo Strehler, tornato dalla Svizzera, era diventato critico teatrale per “Milano Sera”; Pandolfi scriveva da Milano per l’“Unità” e avrebbe partecipato all’avventura del “Politecnico” con articoli sul teatro (e su altro); sul quotidiano del PCI si occupava di teatro anche Virgilio Tosi, che con Grassi, Strehler e Mario Apollonio avrà un ruolo centrale nella fondazione del Piccolo Teatro.
La lotta e le sofferenze dei mesi precedenti non parevano vane. In teatro le antiche battaglie ripresero subito con rinnovata foga.
Il popolo dei ceti medi, degli operai, dei contadini, degli artigiani, degli intellettuali (...) riconoscerà nel teatro di Wedekind (...) e di Saroyan, di Brecht, di Toller e di Sternheim (...) i motivi che lo hanno portato alla lotta contro la borghesia capitalistica.
(Paolo Grassi, Teatro del popolo, “Avanti!”, 30 aprile 1945, in Meldolesi, Fondamenti, cit., p. 156)
Ma il rinnovamento auspicato in tutti i settori della vita civile, politica e culturale non aveva il ritmo sperato. Sui palcoscenici milanesi le compagnie continuavano ad appoggiarsi al solito repertorio, malgrado la ritrovata libertà non si trovava spazio per gli autori proibiti dal fascismo. La rabbia non poteva non esplodere.
Dopo averlo ripetutamente scritto sull’“Avanti!” che il repertorio va rinnovato, che non è con La resa di Titti di Aldo De Benedetti che si cambia la pelle del teatro, Grassi va a dirlo sulla faccia degli attori, al Teatro Nuovo, in un incontro promosso dal Partito socialista e che si svolge nel ridotto. Ci va con Virgilio Dagnino e si infuria. “Ci sono ancora i partigiani e i fascisti fucilati per le strade, il cadavere di Mussolini è a piazzale Loreto, le SS hanno appena lasciato l’Hotel Regina e voi con il repertorio che proponete sembrate non voler capire che qualcosa di storico è avvenuto, che un ciclo è chiuso e un altro atto si apre nella storia del nostro paese”. La passione lo fa trascendere e una pesante allusione ad alcune attrici che notoriamente sono state “protette” da gerarchi, determina una reazione violenta. “Ha offeso le nostre donne”, grida qualcuno, e c’è chi tenta di avventarsi su di lui per vendicare l’onore. Vittorio Gassman è tra i giovani attori uno che condivide le necessità del rinnovamento. Salta su una sedia e dice: “Il teatro è un fatto di cultura; o voi diventate colti o siete destinati a sparire”. E cita, tra gli autori da conoscere e valorizzare, Kaiser e Strindberg, cioè proprio due degli autori di cui Rosa e Ballo ha fatto conoscere più di un testo. Renzo Ricci si avanza dal fondo del ridotto e, come avvolto in un invisibile ferraiolo, guardando Gassman che è suo genero (ha sposato sua figlia Nora) ma rivolgendosi a tutti, declama: “Tu Vittorio parli di Kaiser e Strindberg, ma io ho recitato… Shakespeare!...”. A questo punto l’irruento Grassi si dimentica di essere di fronte al mito teatrale della sua adolescenza e sbotta: “Sì, lei ha fatto Shakespeare, ma lei è un trombone”. Un urlo quasi isterico dei presenti e si trova circondato da mani minacciose, come in una scena corale. E Gassman, saltando dalla sedia, fa scudo col suo corpo atletico.
(Grassi, Quarant’anni, pp. 134-135; vedi anche Meldolesi, Fondamenti, pp. 171-172)
Qualche giorno dopo, auspice il sindaco socialista Antonio Greppi, Grassi presentò le sue scuse a Ricci, che le accettò chiudendo l’incidente. Ma l’episodio resta indicativo sia dell’atteggiamento di Grassi e dei suoi compagni di lotta, sia del ruolo cruciale giocato dalla casa editrice nel rinnovamento del teatro italiano.
In un turbinare di attività (Grassi a quel punto era critico teatrale dell’“Avanti!”, organizzava manifestazioni, concerti, convegni, si occupava del Fondo Matteotti alla Federazione socialista di via Valpetrosa, nel dicembre ’45 lanciava un centro sperimentale con annesso “Studio d’arte drammatica”, nel ’46 fu addirittura responsabile della campagna elettorale del Psi a Milano) la sua collaborazione con Rosa e Ballo – e in particolare con Fernando Ballo – sembrò ampliare gli obiettivi:
Vi continua a dirigere la collana di teatro con maggior vigore, così come si occupa a latere della casa editrice “Il Poligono” dell’ing. Silvio Tanziani (9) e mette le basi per un consorzio di piccoli editori per organizzare in modo razionale la loro diffusione rendendosi autonomi da quei circuiti che privilegiano le grandi case. (...) Alcuni progetti, ovviamente, restano per strada, come la creazione della rivista “Lo Spettatore”, che avrebbe dovuto dirigere con Glauco Viazzi e Fernando Ballo. E, come non bastasse tutto questo, a titolo personale Fernando Ballo e Paolo Grassi danno vita a uno studio, “B. G.”, con il quale tentano di promuovere altre iniziative culturali senza coinvolgere necessariamente la Rosa e Ballo. Sono ospitati (in via Rossini, 4), pagando un affitto simbolico, nello studio di Marcello Nizzoli, un nome fondamentale del design italiano. Fanno stampare carta da lettere con intestazione e indirizzo; l’iniziativa però non decolla.
(Grassi, Quarant’anni, pp. 140-141)
Incredibilmente nel gennaio del 1946 Grassi trovò anche il tempo per tornare a lavorare in palcoscenico: si impose come regista alla compagnia Adani-Gassman-Carraro-Calindri per uno dei testi più discussi del momento, pubblicato nella sua collana di Teatro Moderno (di cui dunque controllava i diritti), Giorno d’ottobre di Georg Kaiser; scenografo il pittore Luigi Veronesi, che sugli intrecci tra il teatro e le altre arti sperimentava dalla metà degli anni Trenta. Critica e pubblico si divisero. Ettore Capriolo, citato da Luigi Squarzina, ricorda che “fu uno spettacolo talmente brutto, nonostante la presenza di attori tra i più importanti di allora, che Grassi decise di non fare più il regista. E diede a Strehler che al GUF era un suo ex attore (...) l’occasione di fare il regista al Piccolo Teatro” (Squarzina, Il romanzo della regia, p. 328). Un intervento del critico del quotidiano liberale “La Libertà”, Enrico Damiani, rilanciò la polemica: “E’ compatibile l’attività del critico teatrale d’un quotidiano abbinata a quella del regista con regolare assunzione a contratto di una compagnia?”. Che fosse per consapevolezza dei propri limiti artistici o per questo conflitto d’interessi da critico militante, Grassi decise di abbandonare per sempre la regia (Grassi, Quarant’anni, pp. 146-147).
Nel frattempo con l’amico Strehler aveva rilanciato gli antichi progetti e ne aveva intrapresi altri.
Grassi e Strehler, ospitati dalla libreria Zanotti, danno vita con l’aiuto di altri critici e di giovani appassionati di teatro e politicamente coscienti, al “Diogene”, un circolo di cultura teatrale che rappresenta lo stimolo di dibattito più vivo di questi mesi nel campo dello spettacolo. Qui si leggono testi italiani e stranieri, nomi nuovi vengono alla ribalta, si dibattono i temi generali del rinnovamento del teatro, si discutono gli spettacoli che le ribalte milanesi offrono.
(Grassi, Quarant’anni, p. 139)
Il Diogene, fondato nell’autunno del 1945 (ma cresciuto l’anno successivo) come centro di lettura di “commedie contemporanee eccezionalmente valide”, “si era guadagnato dei meriti, prefigurando un repertorio di punta nell’impossibilità di immediati allestimenti” (Meldolesi, Fondamenti, p. 173). Ancora una volta, gli autori pubblicati da Rosa e Ballo – per primo il solito Kaiser, ma non solo – ebbero un ruolo cruciale.
Fra la messinscena di Giorno d’ottobre nel gennaio 1946 a Venezia (...) e quella di Mississipi (...) il teatro di Kaiser fu presente nelle riunioni del Diogene con Il soldato Tanaka, L’incendio del teatro dell’opera a cura di Ruggero Jacobbi e Il cancelliere Krehler, interpretato da Vittorio Gassman, Giorgio Strehler e Tino Carraro.
(Battistini, Strehler, p. 47)
Al Diogene furono presentati e discussi anche L’unicorno e le stelle di Yeats, La cimice di Majakovskij e, a cura di Paolo Grassi, La linea di condotta di Brecht. Per la drammaturgia straniera la collana di Rosa e Ballo restava il punto di riferimento, nelle riunioni del Diogene e in generale per il teatro italiano. Altri “teatrini” scelsero infatti di attingere allo stesso repertorio: a Genova lo “Sperimentale” di Gian Maria Guglielmino tra il 1944 e il 1946 presentò, tra gli altri, Esuli di Joyce (che a Milano venne allestito, com'era ovvio, da Enzo Ferrieri, nel 1946), oltre che testi di Synge e Yeats (Meldolesi, Fondamenti, p. 170).
Il soldato Tanaka andò in scena il 7 marzo 1947 al Teatro Olimpia di Milano, con la compagnia Tofano-Randone-Negri: la regia venne curata da Strehler, che però si ammalò, lasciando all’amico Mario Landi il compito di completare la messinscena. Fu l’ultima regia strehleriana prima dell’Albergo dei poveri di Gorki, lo spettacolo che inaugurò il Piccolo Teatro in una serata destinata a passare alla storia, il 14 maggio 1947.
Poche settimane prima, il 1° aprile 1947, entrando ufficialmente a far parte dell’organico del neonato Piccolo Teatro, Grassi aveva chiuso definitivamente con la critica teatrale: dopo due anni di battaglie lasciava il posto all’“Avanti!” a Ivo Chiesa, il futuro animatore dello stabile di Genova.
Nel frattempo, travolta dai mille impegni del direttore di collana da un lato e dalle difficoltà della casa editrice dall’altro, anche la sua collaborazione con Rosa e Ballo si era di fatto conclusa. Non si sarebbe invece concluso il rapporto con l’editoria di Grassi, che negli anni successivi avrebbe curato, oltre alle pubblicazioni del Piccolo Teatro, altre collane: dal 1953 per Einaudi, con Gerardo Guerrieri, la Collezione di teatro, dove sarebbero stati ripresi alcuni dei testi pubblicati da Rosa e Ballo; dal 1959 i saggi Documenti di teatro, insieme a Giorgio Guazzotti, per l’editore bolognese Cappelli; per Feltrinelli avrebbe varato negli anni Sessanta una collana di studi sul teatro.
L’abbandono di Grassi coincise dunque con la crisi della casa editrice. Anche se le collane teatrali avevano avuto un notevole successo di vendite: nell’ultimo listino numerosi volumi figurano esauriti, in particolare buona parte delle prime venti uscite della Collezione Teatro Moderno. Molti di quei titoli vennero poi ristampati da un’altra piccola casa editrice milanese fondata nel 1944 e legata al Partito d’Azione, La Fiaccola, che a quel punto gestiva le collane teatrali di Rosa e Ballo e si avvaleva della consulenza di Grassi (RB 15/8, nn. 1-2): Dibbuk (1948), Il pappagallo verde (1948), Il bagno (1950), Quando noi morti ci destiamo (1955), La sonata dei fantasmi (1956), Esuli (1956), Il magnifico cornuto (1956), Il furfantello dell’Ovest (1956). La Fiaccola continuò per qualche tempo a pubblicare altri testi teatrali, tra cui Mississipi di Georg Kaiser (trad. Carla Bosco, 1949), Paura di me di Valentino Bompiani (1950), Estate e fumo di Tennessee Williams (trad. Gerardo Guerrieri, 1951), Verso Damasco di August Strindberg (trad. Alessandro Pellegrini, 1954). Molti dei testi pionieristicamente pubblicati da Rosa e Ballo vennero – prima o poi – ripresi anche da altre case editrici, fino a diventare dei classici moderni.
L’obiettivo culturale delle collane teatrali dirette da Grassi era a prima vista chiaro: quei testi offrirono un indispensabile aggiornamento culturale e una palestra per i giovani registi con le serate di Palcoscenico e del Diogene; costituirono un’arma polemica nei confronti del teatro “tradizionale”, ancorato al vecchio repertorio. In prospettiva, servirono anche a limitare le ambizioni degli autori italiani (che non a caso trovarono poi così poco spazio nel percorso dei registi). Tuttavia quel repertorio non passò automaticamente al Piccolo Teatro e agli stabili nati sulla sua scia. Sul palcoscenico di via Rovello approdarono – dopo Il gabbiano – solo La morte di Danton, regia di Strehler, il 19 marzo 1951, e Oplà noi viviamo, sempre con la regia di Strehler, il 20 novembre dello stesso anno, “con un occhio sulla famosa messinscena diretta nel 1927 da Piscator” (Giorgio Guazzotti, “l’Unità”, 16 gennaio 1952); negli anni precedenti erano arrivati in scena – ma con testi diversi da quelli editi da Rosa e Ballo – Giraudoux, Becque e García Lorca. Per L’opera da tre soldi di Brecht, fu necessario attendere quasi un decennio.
Certo, nei primi anni del dopoguerra sul fronte della drammaturgia straniera, in quel vorace ampliamento d’orizzonti, ci si rivolse soprattutto a una certa produzione anglosassone e alla letteratura francese engagé di Salacrou, Camus e Sartre; successivamente fu la volta del cosiddetto teatro dell’assurdo (che però negli stabili e soprattutto al Piccolo non ebbe mai particolare fortuna).
L’abbandono dello “sperimentalismo” del periodo dei GUF da parte di Grassi e di Strehler (il quale si era orientato a quel punto – semplificando – più verso Reinhardt, Copeau e Jouvet che verso Piscator e Mejerchol’d) è un nodo sul quale la storiografia continua a dibattere. Perché la svolta di Strehler e del Piccolo Teatro aveva aperto qualche ferita. Nel 1957, dopo un lungo silenzio, Vito Pandolfi tornò sulla vicenda, dichiarandosi
colpevole di estremismo settario, cioè di inconsapevole ottimismo. Pensavo che si potesse e si dovesse osare molto di più sul piano del repertorio, scartando quanto si limitasse a riesumare classici di interesse prevalentemente culturale, e non vitale, non nutriti di un significato che si rivelasse attivo nell’esistenza quotidiana dello spettatore. Ritenevo necessario un repertorio di straordinaria attualità, inscenato in modo critico, che mette a nudo il loro substrato storico, grazie al solvente dei metodi di Meyerhold e di Piscator; tesi, come è noto, a rivoluzionare il testo per scoprirne il tessuto sociale, Meyerhold, Piscator... come erano lontani, inarrivabili! Qui si trattava di affrontare un problema ben diverso: far vivere il teatro con le sovvenzioni ministeriali, con l’appoggio della critica milanese, con il concorso del pubblico. A questo scopo, niente di rivoluzionario: ma brillanti presentazioni registiche, di testi culturalmente inappuntabili, senza punte di particolare audacia in ogni senso.
(Vito Pandolfi, Confidenze di autori, attori, registi, in "Il Ponte", numero speciale "Lo spettacolo in Italia", agosto-settembre 1957, p. 1290, cit. in Marco Martinelli, “In solitudine vitae”, pp. 50-51)
Grassi gli rispose senza nominarlo e a stretto giro di posta, nel volume che nel ’58 celebrò il primo decennio del Piccolo, e nel ’65 Giorgio Guazzotti volle ribadire il concetto.
“Volendo passare dal periodo sperimentale ad una stabilità e continuità di lavoro, dovevamo pensare ad un cartellone con una diecina di opere”: così scrive Grassi nel ricordare il passaggio dalla “fase eroica” alla “fase costruttiva”.
(Guazzotti, Teoria e realtà, p. 59; la frase di Grassi è in 1947-1958: Piccolo Teatro, p. 41)
Di recente Luigi Squarzina ha riassunto:
Se era inevitabile che a Strehler nel corso degli anni venisse addebitata da una parte della critica una astensione precoce e quasi prudenziale dello sperimentalismo che lo aveva caratterizzato ai tempi dei GUF, quantunque non ne mancassero spunti in molti spettacoli di via Rovello, questo rilievo non poteva non sommarsi alla imputazione iniziale, a lui e a Grassi, di una partenza ‘riformistica’ del Piccolo contro un indirizzo ‘rivoluzionario’ ritenuto non impossibile nella Milano postresistenziale del ’47.
(Squarzina, Il romanzo della regia, pp. 328-329)
In ogni caso con l’“istituzionalizzazione” dei nuovi teatri stabili (e della regia) il repertorio si andò orientando principalmente verso i classici. A questo andava aggiunta una certa prudenza politica, soprattutto dopo la sconfitta del Fronte Popolare socialcomunista alle elezioni del 18 aprile 1948, che portava a limitare i testi più controversi. Inoltrandosi negli anni Cinquanta l’orizzonte culturale di Rosa e Ballo parve superato dalle circostanze e dall’avvicendarsi delle mode – con l’eccezione della drammaturgia brechtiana, ma un Brecht lontano dagli esordi espressionistici. L’eredità della casa editrice riemerse però con forza imprevedibile in un altro periodo di violenta crisi, intorno al 1968.
Quello che accadde al Piccolo Teatro, con gli stessi protagonisti d’un tempo, è emblematico: Strehler abbandonò all’improvviso via Rovello, lasciando Paolo Grassi unica guida. Al di là della contrapposizione (vera o presunta) che avrebbe causato la rottura Strehler-Grassi – con il primo più orientato al “teatro d’arte” e il secondo più al “servizio pubblico” – quella frattura offrì l’opportunità per tentare un rinnovamento generazionale, di linguaggio e anche di repertorio. Nel giro di un paio di stagioni andarono in scena la pièce biografica di Tankred Dorst Toller (regia di Patrice Chéreau), Il bagno di Majakovskij (regia di Franco Parenti) e fece il suo debutto al Piccolo Frank Wedekind, l’autore che il giovane Grassi aveva tradotto per Rosa e Ballo: nel 1972 la sua Lulu arrivò in scena nel memorabile allestimento dello stesso Chéreau. Dopo venticinque anni di impegno quotidiano, quello fu di fatto l’ultimo spettacolo del Piccolo Teatro di Paolo Grassi, che stava per assumere la direzione della Scala, lasciando spazio all’inevitabile ritorno di Strehler.
Si era chiuso un cerchio. Gli autori pubblicati da Rosa e Ballo avevano trovato nuova attualità: non tanto per una qualche nostalgia da parte di Grassi, ma proprio perché quei testi parevano rispondere alle esigenze del momento. Strindberg, Wedekind e Majakovskij erano tornati di moda. Si partì alla ricerca di un Brecht più inquieto e inquietante, meno ideologico (e monumentale), anche in polemica con le messinscene strehleriane. Büchner divenne un passaggio obbligato, una prova di iniziazione per tutti i giovani registi. Un esempio tra tutti, alcuni spettacoli degli esordi di Carlo Cecchi: Prova del Woyzeck di Büchner (1969), Il bagno di Majakovskij (1971), Tamburi nella notte di Brecht (1972), Woyzeck (1973), La cimice di Majakovskij (1975).
Forse, come suggeriscono le sue ultime scelte, la prospettiva culturale in cui Grassi si sentiva più a proprio agio era quella sperimentata ai tempi di Rosa e Ballo, e al momento opportuno non ebbe difficoltà ad attingere a quel repertorio. Poco dopo la morte di Grassi nel 1981, Ettore Capriolo ricordava sul Patalogo
le due anime del personaggio (…): quella dell’intellettuale attento al clima del tempo e curioso delle sue manifestazioni e quella dell’organizzatore di cultura che ha il compito di rendere in qualche modo possibile il realizzarsi di sogni e aspirazioni, tenendo conto delle condizioni oggettive e con esse misurandosi quotidianamente. (…) Grassi aveva dato un contributo notevolissimo alla cultura teatrale italiana, come direttore della collana teatrale della casa editrice Rosa e Ballo. Comparivano nel suo catalogo i drammi da camera di Strindberg e le utopie rivoluzionarie di Majakovskij, gli umori sulfurei di Wedekind e le anticipazioni geniali di Büchner, le dolorose riflessioni di Toller e gli irlandesi da Joyce a O’Casey e la prima traduzione italiana dell’Opera da tre soldi: vale a dire, con qualche eccezione, proprio quegli autori cui si rivolse dagli anni Sessanta la generazione teatrale che a quella rappresentata da Grassi più apertamente s’opponeva.
(Ettore Capriolo, “Il manager di un ‘teatro civile’”, in il Patalogo 4, Ubulibri, Milano, 1982)
Claudio Meldolesi pare condividere, quando riflette sull’attività critica di Grassi e la mette in relazione proprio al suo impegno per Rosa e Ballo:
La contraddittorietà delle recensioni di Grassi può spiegarsi con una sorta di scissione fra il piano del giudizio specifico (prevalente in “Cinetempo”) e il piano del giudizio politico (prevalente sull’“Avanti!”); e ancora con un certo attaccamento di pelle ai luoghi comuni del mestiere e un singolare impegno a pensare il teatro oltre il presente, volontaristicamente. In questo senso, Grassi contribuì al teatro post-bellico soprattutto con la sua attività editoriale. (Meldolesi, Fondamenti, p. 157, n. 17)
Sono annotazioni che danno ragione della piccola leggenda fiorita intorno a Rosa e Ballo: la casa editrice ebbe come animatore uno dei fondatori del Piccolo Teatro, la più importante invenzione teatrale del dopoguerra; e al tempo stesso formò il gusto e prefigurò le inquietudini delle stagioni teatrali successive.
RINGRAZIAMENTI E NOTA BIBLIOGRAFICA
Mi piace ringraziare (ma ovviamente la responsabilità di quanto scritto è mia) alcuni amici che mi hanno aiutato. In particolare – oltre alle persone coinvolte nella realizzazione della mostra e del catalogo, di cui ho apprezzato la competenza e la disponibilità – Giorgio Fabre, Mimma Gallina, Marco Martinelli ed Emilio Pozzi. E non posso dimenticare le lezioni di Ettore Capriolo e Giorgio Guazzotti alla Civica Scuola d’Arte Drammatica di Milano, quando per la prima volta sentii con ogni probabilità parlare di Rosa e Ballo.
Per stendere questo testo, ho consultato in primo luogo il Fondo Rosa e Ballo, Fondazione Mondadori, Milano, ma il materiale è tanto e il lavoro da fare è ancora moltissimo.
Ho poi cercato di inserire la vicenda di Rosa e Ballo nel suo contesto storico, culturale e teatrale. La bibliografia sarebbe sconfinata, cito qui di seguito alcuni dei testi che ho utilizzato e citato, raggruppandoli per temi.
Sulla Milano di quegli anni, Luigi Ganapini, Una città in guerra. Lotte di classe e forze politiche a Milano 1939-1951, Franco Angeli, Milano, 1988.
Su Rosa e Ballo nella storia dell’editoria: Gian Carlo Ferretti, Storia dell’editoria italiana. 1945-2003, Einaudi, Torino, 2004, pp. 70-71; Anna Modena, “Breve storia (con catalogo) della casa editrice Rosa e Ballo”, in Studi di storia dell’editoria, a cura di Gianfranco Tortorelli, Baiesi, Bologna, 1995; Stella Casiraghi, Rosa e Ballo editori tra spettacolo e poesia, in “Wuz”, n. 4, luglio-agosto 2005.
Sull’editoria teatrale di quel periodo, vedi Giorgio Guazzotti, Teoria e realtà del Piccolo Teatro di Milano, Einaudi, Torino, 1965, pp. 40-41.
Per quanto riguarda l’esperienza di “Convegno” e di “Bottega di Poesia”: Botteghe di editoria: tra Montenapoleone e Borgospesso. Libri, arte, cultura a Milano 1920-1940, a cura di Anna Modena, Biblioteca di via Senato-Electa, Milano, 1998 (catalogo della mostra, Milano, Biblioteca di via Senato, 23 settembre-25 ottobre 1998); il numero di “Convegno” dedicato ad Appia, in occasione della sua regia del Tristano e Isotta alla Scala, direttore Arturo Toscanini, fu il numero 10, ottobre 1923, dove venne pubblicato anche il suo La messa in scena e il suo divenire; quasi contemporanea la pubblicazione su “Bottega di Poesia” di Arte viva o natura morta?; questi rimasero a lungo gli unici testi di Appia in italiano (vedi Adolphe Appia, Attore musica e scena, prefazione e cura di Ferruccio Marotti, Feltrinelli, Milano, 1975).
Su Corrente: Raffaele De Grada, Il movimento di Corrente, Edizioni di Cultura Popolare, Milano, 1975; Franco Catalano, La generazione degli anni ’40, introduzione di Raffaele De Grada, Contemporanea Edizioni, Milano, 1975; Gioia Sebastiani (a cura di), I libri di Corrente, Milano 1940-1943: una vicenda editoriale, Pendragon, Bologna, 1998.
Sul rapporto tra Ballo e Malipiero: Gillo Dorfles-Riccardo Malipiero, Il filo dei dodici suoni. Dialogo sulla musica (Aprile 1984), Scheiwiller, Milano, 1984, pp. 9-10.
Su Enzo Ferrieri, Il Convegno di Enzo Ferrieri e la cultura europea dal 1920 al 1940: Manoscritti, immagini e documenti, a cura di Anna Modena, Università di Pavia, Pavia, 1991 [catalogo della mostra a Pavia, Sala dell’Annunciata, 11-25 maggio 1991] e Enzo Ferrieri, La radio! la radio! la radio!, a cura di Emilio Pozzi con un saggio di Maria Corti, Greco & Greco, Milano, 2002.
Sulla censura libraria nel periodo fascista: Giorgio Fabre, L’elenco. Censura fascista, editoria e autori ebrei, Zamorani, Torino, 1998; in particolare sul periodo della RSI vedi le pp. 416-425. Le procedure per i nulla osta per le rappresentazioni teatrali e quelli per le traduzioni di testi stranieri seguivano procedure diverse, anche se facevano entrambe capo al Ministero della Cultura popolare (vedi Dizionario del fascismo, a cura di Victoria De Grazia e Sergio Luzzato, Einaudi, Torino, 2002, s.v. Censura). Sulla censura teatrale: Leopoldo Zurlo, Memorie inutili: la censura teatrale del ventennio, Edizioni dell’Ateneo, Roma, 1942; Carlo Di Stefano, La censura teatrale in Italia, Cappelli, Bologna, 1964; Pasquale Iaccio (a cura di) La scena negata: il teatro vietato durante la guerra fascista, 1940-43, Bulzoni, Roma, 1994; Nicola Fano, Tessere o non tessere: i comici e la censura fascista, Liberal Libri, Roma, 1999; Archivio Centrale dello Stato, Censura teatrale e fascismo, 1931-1944: la storia, l’archivio, l’inventario (a cura di Patrizia Ferrara), Mistero per i beni e le attività culturali, Roma, 2004.
Sulle vicende teatrali di quel periodo, è imprescindibile la meticolosa ricostruzione di Claudio Meldolesi, Fondamenti del teatro italiano. La generazione dei registi, Sansoni, Firenze, 1984, anche nella sua capacità di sviscerare i risvolti problematici, dai rapporti con lo sperimentalismo di Bragaglia alle diverse possibilità della regia – quelle effettive e quelle virtuali – nel dopoguerra; di Rosa e Ballo parla a p. 157, n. 17. Utile la testimonianza di un protagonista di quella stagione come Luigi Squarzina, Il romanzo della regia. Duecento anni di trionfi e sconfitte, Pacini, Ospedaletto (Pisa), 2005.
Su Strehler e sulla nascita del Piccolo Teatro, la bibliografia è relativamente ampia e conosciuta; in particolare ho utilizzato Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, Feltrinelli, a cura di Sinah Kessler, Milano, 1974; 1947-1958: Piccolo Teatro, Moneta, Milano, 1958; Giorgio Guazzotti, Teoria e realtà del Piccolo Teatro di Milano, Einaudi, Torino, 1965; Ettore Gaipa, Giorgio Strehler, Cappelli, Bologna, 1959; Fabio Battistini, Giorgio Strehler, prefazione di Paolo Grassi, Gremese, Roma, 1980; Il Piccolo Teatro di Milano. Cinquant’anni di cultura e di spettacolo, a cura di Maria Grazia Gregori, fotografie di Luigi Ciminaghi e Gérard Uféras, Leonardo Arte, Milano, 1997.
La figura di Paolo Grassi resta più in ombra, e i suoi archivi sono ancora relativamente inesplorati: Paolo Grassi, Quarant’anni di palcoscenico, a cura di Emilio Pozzi, Mursia, Milano, 1977; Paolo Grassi, Lettere, a cura di Guido Vergani, Skira, Milano, 2004 (dove a p. 12 si legge che Paolo Grassi nel 1944 “fu assunto come direttore editoriale della casa editrice Rosa e Ballo”, mentre in effetti aveva la responsabilità delle sole collane teatrali); e la voce del Dizionario degli italiani, curata da G. Taffon.
Sul ruolo di un altro protagonista di quella stagione, Vito Pandolfi: Marco Martinelli, “In solitudine vitae. Una biografia teatrale”, in Teatro da quattro soldi. Vito Pandolfi regista, a cura di Andrea Mancini, Nuova Alfa Editoriale, Bologna, 1990; la ricostruzione di Martinelli (che tra l’altro ha battezzato il suo gruppo teatrale Le Albe di Verhaeren) documenta la rottura tra Pandolfi e Grassi-Strehler subito dopo la fondazione del Piccolo Teatro; sull’episodio, che aiuta a valutare in prospettiva l’esperienza di Rosa e Ballo, insistono anche Meldolesi e Squarzina.
NOTE AL TESTO
(1) Su quel numero di “Pattuglia” e sui suoi risvolti, vedi Meldolesi, Fondamenti, p. 87-94. Per le due riviste, tra l’altro, Giorgio Strehler scrisse diversi articoli e tradusse testi di Cocteau, Appia (Art vivant ou nature morte?) e Apollinaire. Sul rapporto tra i giovani registi e Appia, vedi Meldolesi, Fondamenti, p. 53-54.
(2) Con Ugo Casiraghi, Viazzi curò nel dopoguerra una collana di saggi sul cinema per “Il Poligono”.
(3) Gli elenchi non sono peraltro completi: per esempio, Valgioconda di Nathaniel Hawthorne non ottenne il permesso e tuttavia non risulta in nessuna di queste liste riassuntive; vedi RB 5/27, n. 33.
(4) Vale la pena di ricordare che l’incompiuto Woyzeck venne pubblicato solo nel 1879, 42 anni dopo la morte dell’autore. A Roma nel 1942, dribblando la censura, c’era stata la prima italiana dell’opera di Alban Berg Wozzeck, che aveva suscitato feroci polemiche (se ne avverte l’eco in Alberto Savinio, Scatola sonora, Einaudi, Torino, 1988, pp. 285-292).
(5) Nel 1936 lo scrittore francese era stato al centro di una complessa vicenda censoria, che aveva avuto tra i protagonisti lo stesso Mussolini: vedi Giorgio Fabre, Il fascismo e la censura delle traduzioni, di prossima pubblicazione.
(6) Erano autori in grado di provocare addirittura una “folgorazione” su un altro giovanissimo scrittore, poeta, pittore e drammaturgo, Pier Paolo Pasolini, amico di Alfonso Gatto dagli anni bolognesi e poi contattato da Paolo Grassi che gli chiese di collaborare alle riviste “Eccoci” e “Spettacolo” (vedi Pier Paolo Pasolini, Lettere 1940-1954, a cura di Nico Naldini, Einaudi, Torino, 1986, p. 174); nello sviluppo della poetica pasoliniana fu determinante soprattutto Synge, che gli era noto grazie alla presentazione di Carlo Linati sul “Dramma”, 1° febbraio 1940, n. 323 (vedi Pasolini, Lettere, p. XXXII; e Stefano Casi, I teatri di Pasolini, Ubulibri, Milano, 2005).
(7) Il rapporto della nascente regia con la drammaturgia italiana è uno dei nodi centrali di quel periodo: “Non si è riflettuto abbastanza sul potere acquisto dalla corporazione degli scrittori di teatro nei secondi anni trenta”, Meldolesi, Fondamenti, p. 37; il tema è uno dei Leitmotiv della ricostruzione di Meldolesi.
(8) La prima traduzione italiana di Stanislavskij arrivò nel 1956, da Laterza, grazie a Gerardo Guerrieri. Per Bragaglia, Grassi si riferisce al progetto di una Antologia di Pulcinella (vedi RB 2/12, dove si trovano anche altri interessanti progetti: uno tra tutti, Lo spettacolo sportivo, RB 2/12, n. 3); Bragaglia raccolse i suoi studi con il titolo Pulcinella, Casini, Roma, 1953.
(9) “Grassi lavora anche per la casa editrice Poligono, e a Gianni Brera dà l’incarico di preparare un volume su Molière. Brera, che è partigiano garibaldino, ha nello zaino, in montagna, L’Avaro, Il Tartufo e Il Misantropo, che traduce tra un’azione e l’altra. La prefazione riuscirà a scriverla soltanto dopo il 25 aprile” (Grassi, Quarant’anni, p. 120); il volume uscì per Il Poligono nel 1947.
Le recensioni di ateatro: La pecora nera di Ascanio Celestini
L'elogio funebre del manicomio elettrico
di Valeria Ravera

Foto M. Iacovelli-F.Zayed/Spot the Difference.
“Io sono morto quest’anno”: si apre così La pecora nera - Elogio funebre del manicomio elettrico, il nuovo spettacolo di Ascanio Celestini. Queste parole – leitmotiv ripetuto più volte e richiamato da una grande scritta rossa su un pannello bianco – conducono immediatamente all’oggi perché, a differenza dei precedenti lavori dell’autore e attore romano, La pecora nera è declinato in buona parte al presente. In scena le lancette della macchina del tempo oscillano infatti tra gli anni Sessanta – i mitici, i favolosi, l’età dell’oro in cui tutto sembrava possibile e Gino Paoli cantava Sapore di sale – e i giorni nostri.
È negli anni Sessanta che Nicola passa la sua infanzia. Non è però un’infanzia favolosa e all’insegna del benessere, ma un percorso a ostacoli, una lotta con la povertà e l’emarginazione cominciata in famiglia grazie a un padre che non lo ha nemmeno registrato all’anagrafe, e proseguita sui banchi di scuola, dove si sente ripetere dalla maestra “sei il peggiore della classe, la mela marcia, la pecora nera”. Così, per uno scherzo del destino ma soprattutto per la cecità crudele delle istituzioni, la piccola pecora nera finirà in manicomio e ci resterà per trentacinque anni.
Ritroviamo Nicola alle prese con le meraviglie del consumismo del terzo millennio durante l’unica occasione di confronto con il mondo esterno che ha: la visita settimanale al supermercato, accompagnato dalla suora che lo segue in istituto da quand’era bambino. Lì rivede il suo primo e unico amore, Marinella, che da piccolo aveva conquistato mangiando un ragno vivo, per perderla immediatamente cedendo all’impulso di sbugiardarla. Ora vorrebbe riprovarci, ma i loro mondi non possono incontrarsi, se non una volta alla settimana, per lo spazio di una spesa: lui è rinchiuso in manicomio, lei nel supermercato dove non solo lavora ma vive, senza mai uscire.
Per La pecora nera Celestini ha scelto come terreno d’indagine la realtà manicomiale, raccogliendo in tre anni di ricerche le testimonianze di pazienti, infermieri, operatori, medici in diverse città italiane. Ne è scaturito un lavoro stratificato e multiforme in cui, ancora una volta, i piani drammaturgici si intrecciano, talvolta in maniera vorticosa, per ricomporsi mirabilmente nel finale. Con il suo eloquio torrenziale e sferzante, Celestini racconta il manicomio nella sua realtà di istituzione che opera un processo di omologazione appiattendo l’identità dei singoli sino a privarli della loro dignità e a farli scomparire. Dirompente e calzante è il parallelo con il supermercato, paese dei balocchi illuminato dai neon, luogo in cui ci si smarrisce bombardati da continue sollecitazioni al consumo, sempre a rischio di annegare in un lago di Nelsen piatti o di soccombere sotto una valanga di biscotti Ringo.
Su una scena sempre essenziale (una sedia, un paralume con un lungo stelo, un manichino di donna vestito di un sobrio abito nero, una sporta per la spesa traboccante di prodotti) ma meno spoglia di quelle dei suoi precedenti lavori, ancora una volta Celestini costruisce una galleria di personaggi a tutto tondo, ritraendoli con il consueto amore. A nessuno di loro, sia pure insulso e sgradevole, è negato un briciolo di umanità, un lampo di luce che lo presenti in una prospettiva inedita e inattesa. Ne è un esempio Pancotti Maurizio, il bambino più sciocco, presuntuoso e insopportabile della classe, che in qualche maniera si riscatta con una morte da piccolo eroe disgraziato, incapace com’è di scavalcare un cancello perché troppo grasso, asmatico e col soffio al cuore.
In questo viaggio nel disagio mentale, le bussole di Celestini sono l’ironia e la poesia, strumenti essenziali per mantenere sempre un tocco lieve. Ascanio va dritto al cuore raccontando la santità dei matti, la loro testa abbagliata perennemente da luci accecanti o immersa nel buio più nero, la paura che non li abbandona mai, finché non arrivano gli psicofarmaci a spegnere le luci o l’elettroshock a portare via il buio. Poi punta al riso con tanti spunti surreali: i marziani che assoldano le prostitute perché lecchino gli uomini e scoprano se sono buoni o cattivi, il papa polacco che resuscita e dice che Dio non esiste né tanto meno l’inferno e il paradiso, quindi i preti si ritrovano disoccupati e le chiese diventano parcheggi… È la voce registrata di una delle persone intervistate durante il lavoro di ricerca per la preparazione dello spettacolo a riportare prepotentemente alla realtà nel finale, rendendo lampante la sofferenza di chi ha vissuto l’esperienza del manicomio sulla propria pelle: non c’è consolazione per chi è stato internato a vita.
Le recensioni di ateatro: Come uccidere causando inutili sofferenze con Daniele Luttazzi
Monologo scritto e interpretato da Daniele Luttazzi
di Sara Ficocelli

Parlare di Luttazzi con parole semplici è veramente difficile. Nel suo caso non ci si può fermare ad un punto di vista, occorre mettere in discussione la propria capacità di giudicare. E persino di ridere. Perché, ovviamente, si ride, si ride e si ride da pazzi, ma sempre di un riso amaro, che talvolta somiglia ad un ghigno nervoso. Arrabbiato. Primi vagiti del conflitto iracheno: il governo italiano spedisce Daniele Luttazzi, Aida Jespica, Manuela Arcuri, Raoul Bova e Giancarlo Giannini in terra di guerra, a far compagnia ai soldati. Una brigata degna del miglior Stefano Benni, composta dalla crema dello spaghetti-vips. Scesi dall’aereo, i nostri si danno subito da fare per rallegrare l’esercito, tra balletti improbabili e, neanche a dirlo, esilaranti filippiche tenute dallo stesso Daniele. Che non risparmia nessuno. Trattando il pubblico alla stregua di uno stupido battaglione di pace, parla incessantemente per due ore tirando fuori il meglio di sé. E il peggio della società italiana. Non siamo ai livelli di Beppe Grillo, nel senso che non ci troviamo di fronte a un testo documentato, sull’onda del giornalismo d’inchiesta. No. Luttazzi dissacra, rivolta come calzini sfilacciati i tabù più inconfessabili e imbarazzanti, facendo perdere alle parole e ai gesti il loro significato originario.
Non approfondisce, non gli interessa: preferisce buttare lì decine di input, preferisce una platea divertita e disposta, semmai, a raccogliere ed elaborare. L’universo del pudore e della decenza viene risucchiato dallo sguardo allucinato di questo piccolo uomo in camicia bianca, magrolino, più simile ad un cartone animato che allo show man tanto temuto da Berlusconi. L’oscenità verbale prende il sopravvento in continuazione, costringendo lo spettatore a scendere a patti con la vergogna, ridendoci su. Un riferimento al sesso di qui, un’offesa al politico di là, tra una frecciata alla chiesa e un’altra all’intellettuale di turno. Fino a centrare l’obiettivo, che è quello di spogliare la realtà da ogni ipocrisia. Dopo aver accettato lo scandalo di una guerra inutile, siamo ancora capaci di vergognarci di qualcosa? Luttazzi sembra chiedere proprio questo al pubblico, schiaffeggiando luoghi comuni e falsi moralismi con la rabbia di chi più di una volta è stato imbavagliato.
Di Berlusconi non parla molto, forse perché siamo in tempi di par condicio, chissà. Certo è che sparare a zero sulla condizione dei soldati in Iraq è un modo altrettanto efficace per consumare le redini al Cavaliere. Daniele Luttazzi nasce a Santarcangelo di Romagna (RN) il 26 gennaio 1961, dove si laurea in medicina con una tesi sulla eziopatogenesi immunitaria della gastrite atrofica(!!). Nel frattempo collabora come vignettista per la rivista Tango. Il successo arriva con il concorso per giovani comici "Zanzara d'oro", che conta tra la giuria personaggi come Garinei, Dapporto, Arbore e la Wertmuller. L'incontro con questi mostri sacri dello show business gli procura la partecipazione ad un altro concorso, che questa volta lo vede vincitore. Arbore gli proporrà poi di partecipare al programma "Doc", con Gegè Telesforo e Gianna Nannini: la strada giusta è stata imbroccata. Sono gli albori di una comicità cerebrale e fredda, fondata sull'accanimento contro tutto e tutti, ma soprattutto contro chi proprio non gli piace. Una scelta che porterà con sé censure, citazioni per danni e cause miliardarie. E' questo un altro aspetto per cui il comico satirico è famoso. La consacrazione definitiva arriva nel 2001 con “Satyricon", talk show di Rai2 in onda in seconda serata. La trasmissione gli causa grossi problemi di censura e lo allontana dal piccolo schermo. E’ l’inizio del Luttazzi ancora più pericoloso e ronzante, proprio come la “zanzara d’oro” del primo concorso a cui partecipò.
In scena domenica 19 febbraio al Teatro Politeama di Cascina (Pi), Fondazione Sipario Toscana-Lacittadelteatro
Adelaide Ristori a cento anni dalla morte
Un convegno a Cividale del Friuli
di Angela Felice

“Giù il cappello, Giorgio. Qui è nata tua madre”. Stando a Orio Vergani, testimone oculare dei fatti in quel di Cividale, a pronunciare quelle imperiose parole, degne di un album di frasi celebri per i posteri, fu Adelaide Ristori, che l’11 dicembre 1879 tornò in visita ufficiale nella città del Natisone, per ricevere l’omaggio della comunità e portarvi in dono un suo busto di marmo, poi andato perduto.
E infatti in quella casa al numero civico 284 dell’allora Contrada S.Tomaso, indicata con tanta autorevolezza al figlio (poi pittore non spregevole di sensibilità liberty), la Ristori aveva visto la luce in un gelido inverno friulano, alle due di notte del 29 gennaio 1822. E sempre a Cividale, il 31 gennaio, era stata battezzata dal parroco Niccolò Tiossi nella vicina Chiesa di S. Silvestro, avendo per padrino e madrina gente oscura del posto, rispettivamente il sig. Matteo Turrini e tale Teresa Duttig, di mestiere “pistora”, cioè panettiera.
Di umili origini, del resto, era allora la piccola Adelaide, primogenita di due comici di terz’ordine, Maria Maddalena Pomatelli, di Ferrara, e Antonio Ristori, di Capodistria, che in quel freddo 1822 erano in forza della Compagnia Cavicchi, una di quelle “familiari”, si diceva, per etichettare le zone basse del teatro di giro.
Figlia d’arte, ma da sottoscala dello spettacolo, la Ristori era prevedibilmente avviata a calcare le orme dei genitori, nel misero e faticoso nomadismo di una scena perennemente in viaggio, da una piazza all’altra, baule al seguito, con allestimenti si può immaginare quanto accurati, approfonditi e artisticamente decorosi. A tre mesi era già sul palco, quando ci fu bisogno di un bambino in fasce per colorire la farsa “I regali del Capo d’anno”. E poi, a tre anni, eccola di nuovo nella parte di un fanciulletto nel dramma di ambientazione medioevale “Bianca e Ferdinando”. Precoce bambina prodigio e perciò beniamina del pubblico, sarebbe potuta avanzare poco più in là, se non fossero intervenute quelle doti di energia, ambizione, volontà e, naturalmente, talento che fanno sempre la differenza e che, nel suo caso, ne invertirono il destino e la innalzarono a “gloria” indiscussa del teatro italiano di prosa, in particolare tragico.
E dunque quello “scappellarsi” intimato nel 1879 a Cividale era parte di un trionfo pubblico più che dovuto. Adelaide Ristori era ormai marchesa e blasonata, sposa dal 1848 di Giuliano Capranica del Grillo, una delle famiglie romane di più antica nobiltà, che invano aveva osteggiato quelle nozze con l’attrice. Ma, al di là di quell’ascesa sociale, o insieme ad essa, la Ristori poteva vantare ben altri titoli di merito. Il capolavoro assoluto della sua vita era consistito tutto nella battaglia artistica, condotta con instancabile tenacia e con successo indiscusso per legittimare il lavoro dell’attore, ridargli dignità estetica e morale, sollevarlo dal sospetto corrente di essere solo lo strumento di un intrattenimento più o meno raffazzonato, e a conti fatti non proprio necessario. Battaglia non facile, la sua, se nel primo Ottocento, quando lei aveva iniziato, la concorrenza da battere veniva anche dalla supremazia riconosciuta del teatro lirico, come scuola dei sentimenti superiore per principio e laboratorio primo di modelli e valori di comportamento.
Ma evidentemente la giovane Adelaide doveva avere le idee chiare, tali da farle preferire il sacrificio dello studio ai facili luccichii della carriera rapida, che le si spalancava davanti grazie a un talento e a un poderoso physique du rôle, ben presto rivelati e sviluppati. Nel 1837, perciò, rinunciò ai ruoli di “prima donna” per cui veniva già cercata e invece scelse la gavetta del tirocinio severo con la Compagnia Reale Sarda, una di quelle formazioni “stanziali”, cosiddette “privilegiate”, volute dalla politica culturale delle corti italiane e tese alla ricerca del rigore e del decoro artistici e morali.
In seguito, forte di una solida consapevolezza tecnica e professionale, allevata dal magistero d’attrice della maestra Carlotta Marchionni, rinvigorita anche dalla sferzata di energia che lo sconquasso del 1848 portò agli attori della sua generazione, la Ristori tornò alle scene nel ’53 da protagonista autorevole e gran dama. Selezionò un repertorio di regine del passato e di eroine classiche, Maria Stuarda, Maria Antonietta, Fedra, Mirra, Lady Macbeth, tutte donne giganti, tanto potenti nel comando quanto umane nel dolore e nel pentimento, studiate con cura minuziosa nello scavo interiore e rese in una accurata partitura di sfumature a contrasto tra la parola e la controscena del gesto. Le vestì di abiti meravigliosi, decisivi in una scena che puntava anche sul ruolo del costume fastoso come elemento di informazione visiva. Su queste donne “mondiali”, nel presupposto dell’universalità delle loro passioni, costruì il programma esportabile per pionieristiche e fortunate tournèe internazionali, a partire da una prima uscita a Parigi nel ’55, dove fu anche in missione diplomatica per conto di Cavour e della causa dell’indipendenza italiana. E allora con l’alfieriana Mirra stravinse il confronto con la rivale francese Rachel, attrice tragica di controllo diderotiano a cui lei contrappose la sua più calda maestosità.

Adelaide Ristori in Medea.
E poi, ormai “divina”, ricca e autonoma, al punto da fondare nel ’56 con il marito una Compagnia tutta sua, sempre preceduta da un’abile strategia promozionale, puntò nel ‘57 su Londra, dove portò per prima un “Macbeth” in italiano. Poi vennero le capitali europee, Pietroburgo e gli Stati Uniti (vi si recò in ben quattro tournée), fino al vero tour de force del giro del mondo nel 1874-76, per terra e per mare, dall’America Latina al Messico, da New York all’Australia: un’impresa senza precedenti, 20 mesi e 12 giorni per 312 rappresentazioni, una recita ogni due giorni. Quel virtuosismo toccò il suo acme nel 1982, quando a Londra ricomparve di nuovo con “Macbeth”, sbilanciato naturalmente tutto a vantaggio della dark Lady, ma questa volta recitò in inglese, lingua ignota e completamente mandata a memoria senza suggeritore, che lei ben presto, sull’esempio della Marchionni, aveva abolito perché non ne venisse compromessa la naturalezza dell’interpretazione.
Nel 1886, fu infine il ritiro dalle scene. Per la Ristori, elevata intanto a dama di corte della regina Margherita -lei che nel corso della carriera era entrata in familiarità con le teste coronate di mezza Europa- , quello fu il tempo delle memorie, consegnate nel 1987 alla scrittura di un prezioso libro di “Ricordi e Studi artistici”. Fu anche il tempo di una vecchiaia da mito monumentale, tanto che all’ottantesimo compleanno ricevette in casa la visita, inaspettata, del re Vittorio Emanuele III, notoriamente poco incline a questo genere di omaggi. E infine, quando scomparve il 9 ottobre 1906, l’orazione funebre concludeva col dire che la sua morte era “un lutto per Roma e l’intera nazione”.
Ma il mondo avevo ormai preso da tempo altre vie di inquietudine. La scena si era aperta all’entieroismo del quotidiano e delle sue patologie. Sul palco non trionfavano più grandi attori, ma attori grandi, di nuovo esecutori al servizio dei testi e degli autori, rinati già dall’epoca del verismo.
Si chiamavano Virginia Marini, Ermete Novelli, Eleonora Duse, Ermete Zacconi, protagonisti di una nuova arte scenica che la Ristori non poteva capire e tanto meno approvare. Nel 1899 la giudicò una maniera “nevrotica, falsa e acrobatica”. Eppure erano tutti figli suoi, usciti per interpretare la modernità da quell’orgoglio d’attore professionale e artisticamente creatore che lei per prima aveva incarnato e che aveva contribuito a nobilitare. E dunque, aveva avuto ragione lei. Chapeau, appunto.
Convegno Nazionale di Studi
Cividale del Friuli
Chiesa di S.Maria del Battuti
Sabato 25 marzo 2006
Ore 10.00-13.00 / 16.00-19.00
Davvero di prestigio nazionale il Convegno di Studi che il 25 marzo 2006, dalle ore 10 alle 13 con ripresa pomeridiana dalle ore 16.00, a Cividale del Friuli (Udine), presso la restaurata Chiesa di Santa Maria dei Battuti, indagherà la personalità e il genio artistico di Adelaide Ristori, grande attrice tragica dell’Ottocento teatrale italiano, a cento anni dalla morte.
L’iniziativa, firmata da Angela Felice, con il sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia e Provincia di Udine, oltre che con il patrocinio dell’Ente Teatrale Italiano e dell’Università degli Studi di Udine, è promossa dal Comune di Cividale del Friuli, dove la Ristori vide la luce nel 1822 da una famiglia di modesti comici di terz’ordine.
Cividalese per caso, dunque, e prevedibilmente avviata a un destino di povero nomadismo, la Ristori finì invece per dominare la scena del suo tempo, legittimando con vigore il prestigio sociale e artistico del mestiere d’attore e battendo con energia la concorrenza del teatro lirico, come anche i pregiudizi correnti sulla sciatteria del teatro di giro. Una carriera autorevole, la sua, che la incoronò infine a “mito” e a donna di teatro a tutto tondo: non solo interprete del grande repertorio di regine e eroine classiche, ma anche capocomica, amministratrice, ambasciatrice appassionata della causa e della cultura italiane e -ancora- abile stratega di fortunate, e pionieristiche, tournée internazionali.
Sono le tante facce di una esaltante avventura umana e teatrale, nel contesto della scena dell’Ottocento, di cui spetterà al prestigioso gruppo dei relatori del Convegno cividalese analizzare e interpretare il significato e i caratteri: Paolo Puppa, per gli “splendori e miserie di un’attrice da legittimare”; Teresa Viziano, per il risvolto anche risorgimentale di quella esperienza; Franco Perrelli e Marisa Sestito, per il carattere delle tournée della Ristori, rispettivamente, in Scandinavia e in Inghilterra; Laura Mariani, per un confronto in chiaroscuro tra Adelaide Ristori e Giacinta Pezzana, modelli d’attrice in conflitto; Maria Ida Biggi, per l’analisi di scene e costumi.
Claudio Meldolesi, infine, coordina e conclude i lavori, che saranno impreziositi in apertura anche da un rapido schizzo sulla Cividale ottocentesca. E’ un omaggio non di circostanza a una piccola città defilata, ma di tutto rispetto per il teatro italiano, se –oltre alla Ristori- ha dato i natali alla colorita tribù dei Podrecca-Vergani.
Info, Cividale del Friuli, Biblioteca Civica, tel. 0432-710510, E-mail biblioteca@cividale.net.
PROGRAMMA
Ore 10.00 – 13.00
Mauro Pascolini – Università di Udine
Borgo, paese, città: antiche identità e nuove vocazioni di Cividale nell’Ottocento
Paolo Puppa – Università di Venezia
Adelaide Ristori: splendori e miserie di un’attrice da legittimare
Teresa Viziano – Civico MuseoBiblioteca dell’Attore di Genova
Adelaide Ristori: da figlia d’arte a simbolo dell’Italia Unita
Ore 16.00 – 19.00
Franco Perrelli – Dams Università di Torino
Herman Bang e Adelaide Ristori
Laura Mariani – Università di Cassino
Adelaide Ristori rivista da Giacinta Pezzana: modelli d’attrice in conflitto
Maria Ida Biggi – Università di Venezia
Gli scenografi di Adelaide Ristori
Marisa Sestito – Università di Udine
La giustizia poetica di Lady Adelaide
Claudio Meldolesi – Dams Università di Bologna
Coordinamento e conclusioni
Adelaide Ristori
1906-2006 – a cento anni dalla morte
Convegno Nazionale di Studi – Cividale del Friuli, 25 marzo 2006
Città di Cividale del Friuli - Assessorato alla Cultura
con il sostegno di
Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia - Assessorato alla Cultura
Provincia di Udine - Assessorato alla Cultura
con il patrocinio di
Ente Teatrale Italiano
Università degli Studi di Udine
progetto e coordinamento
Angela Felice
Harold Pinter alla X Edizione del Premio Europa per il Teatro
A Torino dall'8 al 12 marzo
di Ufficio Stampa
Dall’8 al 12 marzo 2006 si svolgerà a Torino la X Edizione del Premio Europa per il Teatro, il più alto riconoscimento europeo assegnato al lavoro teatrale. La manifestazione, sostenuta ed ospitata quest’anno dalla Città di Torino in collaborazione con la Fondazione del Teatro Stabile di Torino, è stata calendarizzata in coincidenza con il programma speciale per la Cultura realizzato in occasione delle Olimpiadi Invernali.
Il Premio Europa per il Teatro, nato nel 1986 come programma pilota della Commissione Europea e riconosciuto dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo quale unico italiano tra gli organismi “di interesse culturale europeo”, ha come enti associati e sostenitori l'Union des Théâtres de l'Europe e la Convention Théâtrale Européenne; altri organismi associati sono l'Association Internationale des Critiques de Théâtre e l'Instituto lnternacional del Teatro del Mediterraneo.
La manifestazione dedica ai premiati, nell’arco di quattro giorni, convegni, incontri, anteprime spettacoli, letture, video e pubblicazioni;
un appuntamento che richiama gente di teatro da tutto il mondo: artisti, uomini di cultura, critici, giornalisti delle più importanti testate di tutti i paesi, docenti, direttori di teatri e di Festival.
La giuria internazionale del Premio Europa per il Teatro ha assegnato il riconoscimento per la X Edizione ad Harold Pinter, drammaturgo, regista, poeta e sceneggiatore inglese. L’autore, che ha appena ricevuto il Premio Nobel per la Letteratura, ha confermato la sua presenza alla manifestazione. Nel corso della mattinata dell’11 marzo, al Teatro Carignano, si terrà l’Incontro con Harold Pinter intervistato da Michael Billington (biografo di Pinter e Critico di “The Guardian”). Inoltre è prevista la presenza del Commissario Europeo per la Cultura Ján Figel’.
Il premio, in precedenza è stato assegnato a: Ariane Mnouchkine e il Théâtre du Soleil, Peter Brook, Giorgio Strehler, Heiner Müller, Robert Wilson, Luca Ronconi, Pina Bausch, Lev Dodin e Michel Piccoli.
Sarà inoltre organizzato un Convegno su Pinter a cura di Michael Billington in collaborazione con Gianfranco Capitta e verranno presentati: The new world order di Pinter con la regia di Roger Planchon spettacolo creato appositamente per il Premio Europa dal regista francese e lo spettacolo Pinter’s plays, poetry & prose con la regia di Alan Stanford prodotto dal Gate Theatre di Dublino.
L’VIII Premio Europa Nuove Realtà Teatrali è stato assegnato a Oskaras Korsunovas (regista lituano di Vilnius) e a Josef Nadj (coreografo e regista del Centre Chorégraphique National d'Orléans). Proprio Korsunovas, nel settembre scorso, ha presentato al Teatro Carignano di Torino, per la Stagione Internazionale del TST, lo spettacolo Romeo ir Džuljeta.
In precedenza questo riconoscimento era stato assegnato a: Anatolij Vasil’ev, Giorgio Barberio Corsetti, Comediants, Eimuntas Nekrosius, Théâtre de Complicité, Carte Blanche-Compagnia della Fortezza,
Christoph Marthaler; il Royal Court Theatre di Londra per la scoperta e
promozione di giovani autori, il Theatergroep Hollandia, Thomas Ostermeier, Socìetas Raffaello Sanzio, Heiner Goebbels, Alain Platel.
Sono previsti incontri con la Critica e il pubblico dedicati a Josef Nadj e Oskaras Korsunovas. Saranno inoltre presentati: due spettacoli di Korsunovas (Playing the Victim - un testo sul terrorismo internazionale scritto da due giovanissimi fratelli, Oleg e Vladimir Presnyakov, oggi tra i più popolari autori russi - e Il Maestro e Margherita di Michail Bulgakov), un Duo tratto da Canard Pékinois, regia di Josef Nadj e l’anteprima del film Journal d’un inconnu, Portrait de Josef Nadj.
In occasione delle Olimpiadi della Cultura, Luca Ronconi, vincitore del VI Premio Europa per il Teatro, mette in scena per il Teatro Stabile di Torino cinque spettacoli per il progetto Domani. Le ultime repliche di queste produzioni faranno parte della sezione Ritorni del Premio Europa. Per questa sezione, sono in programma incontri con alcuni premiati delle precedenti edizioni, in particolare con Luca Ronconi, Lev Dodin a cura di Franco Quadri, con Ariane Mnouchkine a cura di Georges Banu.
Nell’incontro con Lev Dodin sarà presentato il volume bilingue degli atti dell’VIII Premio Europa per il Teatro: Lev Dodin, Le creuset d'un théâtre nécessaire/The melting pot of essential theatre. Si segnalano, inoltre: l’incontro sul tema The End of the Criticism? organizzato per il 22° Congresso dell’Association Internationale des Critiques de Théâtre e la loro Assemblea Generale, che ritorna in Italia dopo 20 anni in occasione del Premio Europa; l’Assemblea Generale de l’Union des Théâtres de l’Europe; la riunione della Convention Théâtrale Européenne e la riunione dell’Instituto Internacional del Teatro del Mediterraneo.
Chiuderà l’intera manifestazione la Cerimonia ufficiale di consegna dei premi che si terrà domenica 12 marzo 2006, alle ore 21.00, al Teatro Carignano di Torino. La serata si concluderà con la presentazione dello spettacolo del Gate Theatre di Dublino.
Carla Galliano/Margherita Fusi
PREMIO EUROPA PER IL TEATRO - X EDIZIONE
Torino, 8 -12 marzo 2006
X Premio Europa per il Teatro a:
Harold Pinter
VIII Premio Europa Nuove Realtà Teatrali a:
Josef Nadj, Oskaras Korsunovas
I Ritorni:
Luca Ronconi
Programma preliminare aggiornato al 27 febbraio 2006
mercoledì 8 marzo 2006
Lumiq Studios, ore 20.00
Troilo e Cressida
di William Shakespeare
regia Luca Ronconi
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri, ore 20.45
Il silenzio dei comunisti
di Vittorio Foa, Miriam Mafai e Alfredo Reichlin
regia Luca Ronconi
Teatro Vittoria, ore 21.30
Biblioetica. Dizionario per l’uso
di Gilberto Corbellini, Pino Donghi e Armando Massarenti
regia Luca Ronconi
giovedì 9 marzo 2006
Teatro Gobetti, ore 9.00
Apertura lavori
Premio Europa per il Teatro
A seguire
XXII Congresso AICT/Association Internationale des Critiques de Théâtre:
La fine della Critica?
ore 15.00
Incontro con Luca Ronconi
a cura di Franco Quadri
Casa Teatro Ragazzi e Giovani, ore 17.30
Il Maestro e Margherita
di Michail Bulgakov
regia Oskaras Korsunovas
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri, ore 20.45
Il silenzio dei comunisti
di Vittorio Foa, Miriam Mafai e Alfredo Reichlin
regia Luca Ronconi
Lumiq Studios, ore 21.30
Lo specchio del Diavolo
di Giorgio Ruffolo
regia Luca Ronconi
Teatro Vittoria, ore 21.30
Biblioetica. Dizionario per l’uso
di Gilberto Corbellini, Pino Donghi e Armando Massarenti
regia Luca Ronconi
venerdì 10 marzo 2006
Teatro Gobetti, ore 9.00
Symposium: Pinter: Passion, Poetry and Politics
relazioni, comunicazioni e testimonianze sul lavoro di Harold Pinter
a cura di Michael Billington in collaborazione
con Gianfranco Capitta
a seguire
Oskaras Korsunovas
incontri con la critica e il pubblico
conduce di Leonidas Donskis
Teatro Gobetti, ore 18.00
The New World Order
di Harold Pinter
regia Roger Planchon
Lumiq Studios, ore 20.00
Troilo e Cressida
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri, ore 20.45
Il silenzio dei comunisti
Teatro Vittoria, ore 21.30
Biblioetica. Dizionario per l’uso
sabato 11 marzo 2006
Teatro Carignano, ore 9.00
Symposium: Pinter: Passion, Poetry and Politics
relazioni, comunicazioni e testimonianze sul lavoro di Harold Pinter
a seguire
Incontro con Harold Pinter
conduce Michael Billington
Teatro Gobetti, ore 15.00
Incontro con Lev Dodin
conduce Franco Quadri
Casa Teatro Ragazzi e Giovani, ore 17.00
Playing the Victim
di Oleg e Vladimir Presnyakov
nuova creazione di Oskaras Korsunovas
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri, ore 20.45
Il silenzio dei comunisti
Teatro Gobetti, ore 22.00
The New World Order
domenica 12 marzo 2006
Teatro Gobetti, ore 9.00
Josef Nadj
incontri con la critica e il pubblico
conduce Jean-Marc Adolphe
a seguire
Journal d’un inconnu
Portrait de Josef Nadj (Film) Preview
a seguire
Duo
estratto da Canard Pékinois
regia di Josef Nadj
ore 15.30
Ariane Mnouchkine
incontro
conduce Georges Banu
a seguire
Symposium: Pinter: Passion, Poetry and Politics
relazioni, comunicazioni e testimonianze sul lavoro di Harold Pinter
Teatro Carignano, ore 21.00
Cerimonia di assegnazione premi
Pinter Plays, Poetry & Prose
regia Alan Stanford
Gate Theatre - Dublino
Corso di Alta Formazione sul Teatro di Figura
Le iscrizioni aperte fino al 15 marzo
di Atelier Teatro di Figura di Cervia
Corso di Alta Formazione sul Teatro di Figura promosso dall'Università di Parma
(con il coinvolgimento dell'Atelier delle Figure di Cervia)
Si aggiunge, all'attività dell' Atelier delle Figure di Cervia, che da 4 anni tiene corsi di formazione professionale per giovani aspiranti burattinai, una iniziativa di grande prestigio.
Il Dipartimento dei Beni Culturali e dello Spettacolo dell'Università di Parma ha organizzato il Corso di Alta Formazione continua e permanente integrata in "Teatro di Figura e nuove professionalità", diretto dal Professor Luigi Allegri, uno dei massimi esperti dell'evoluzione del Teatro in Europa, nonchè apprezzato ricercatore dei linguaggi del Teatro di Figura.
I Corsi di Alta Formazione sono iniziative che l'Università rivolge a ex allievi o comunque a laureati e diplomati, che hanno già iniziato un percorso lavorativo e che vogliono aggiornarsi in alcune discipline o approfondire e variare la loro cultura professionale.
Il Corso, che coinvolge anche l'Atelier delle Figure/Scuola per Burattinai di Cervia, è il primo di questo genere in Italia promosso dall'Università che accenda e punti il riflettore sul Teatro di Figura a tutto campo, dai suoi fondamenti teorici ai suoi linguaggi e discipline, dal problema dell'apprendimento alla valutazione estetica, dall'economia del settore al marketing e alla organizzazione. I docenti, di varia provenienza, copriranno un'area vasta e interessante di competenze.
Il Corso tocca campi relativamente "nuovi" di applicazione del Teatro di Figura: dalla produzione degli spettacoli, alla scuola, alla disabilità fisica e mentale, all'animazione commerciale e turistica, alla televisione.
La durata prevista è di 200 ore (di cui 100 di lezioni e laboratori e 100 di studio individuale).
I periodi di impegno sono concentrati: un week end lungo a Parma, alla fine di aprile; una settimana durante il Festival "Arrivano dal Mare!" (la prima settimana di maggio); un'altra settimana entro la fine di giugno, sempre a Cervia.
I costi che l'Università propone ai partecipanti sono ridottissimi: dei 2000 euro richiesti, infatti, 1400 vengono rimborsati da borse di studio della Regione Emilia Romagna e del Fondo Sociale Europeo.
Chi voglia iscriversi al Corso ha tempo fino al 15 marzo.
Per ulteriori informazioni o per iscriversi on-line, si può visualizzare il Bando del Corso nel sito dell'Università http://www.unipr.it/ (tel 0521/281248) oppure al Centro Teatro di Figura di Cervia http://www.arrivanodalmare.it/ (tel 0544 971958)
"Dionisi" cercano azionisti per nuova produzione
Una buona pratica? Una pratica praticabile?
di Renata Ciaravino, Valeria Talenti e tutti i dionisi
Uno studio di Opera Notte, il rumore che fa la città di notte” di Renata Ciaravino
e il progetto di produzione sarà presentato il 19 marzo a Milano, Fabbrica del Vapore.
COMPAGNIE DI PRODUZIONE:
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE, GLI ANELLI DEBOLI DELLA CATENA.
”Al di sopra del cartellone, al di sopra dei lavori presentati e della loro realizzazione, al di sopra dei particolari che logicamente incontreranno la futile discussione, veniteci sempre incontro in questo nostro diuturno atto d'amore per il teatro, siateci amici con i vostri consigli, col vostro plauso e con il vostro appunto, con la vostra partecipazione.”
Paolo Grassi
Gli ultimi anni di vita del Teatro di Prosa italiano hanno dimostrato la sostanziale incapacità o impossibilità da parte delle strutture teatrali italiane di sostenere dal punto di vista produttivo e distributivo spettacoli di nuove compagnie teatrali, intendendo per nuove tutte quelle realtà non riconosciute dal Ministero che rischiano molto spesso di cadere nel dimenticatoio, nonostante portino avanti, spesso in modo autonomo, spettacoli e progetti culturali di notevole interesse.
L'auto imprenditorialità delle nuove compagnie teatrali italiane, non è rigorosa perché difficilmente riesce ad inserirsi in un mercato reale, e risulta spesso fine a se stessa, piccola, ridotta ad una dimensione locale.
La Compagnia Teatrale Dionisi, propone per questo motivo una nuova via di produzione, una nuova possibilità per far nascere uno spettacolo e per consentirgli di avere vita anche dopo il debutto, di vivere delle proprie repliche, partendo proprio dai punti deboli della catena, la produzione e la distribuzione.
L’IDEA di produzione
Opera Notte, il rumore che fa la città di notte è il prossimo testo di Renata Ciaravino, nuova idea di allestimento della Compagnia Teatrale Dionisi.
Il testo in forma di studio, è stato presentato alla prima edizione del Premio Dante Cappelletti, ricevendo una menzione speciale per la drammaturgia.
La produzione dello spettacolo non è mai stata affrontata, per le solite problematiche legate alla disponibilità economica, nella visione che nessun teatro ha disponibilità di investimento sufficiente per rendere possibile un lavoro di allestimento di due mesi con attori e musicisti.
A questo punto però, anziché fare la solita piccola produzione che farà una piccola tournèe, abbiamo pensato di provare a ragionare su altre possibilità: è vero che nessun teatro avrà mai un'alta disponibilità, ma è possibile che trenta teatri ne abbiano poca; e allora ragioniamo su quello che realmente c'è.
L'idea è quella di coinvolgere il numero maggiore di situazioni teatrali e musicali, che diventino direttamente cooproduttori e azionisti dello spettacolo con un minimo investimento.
Comprando una o più repliche dello spettacolo il teatro stabile di innovazione, il teatro comunale, il Comune o la rassegna, diventerà automaticamente cooproduttore e azionista dello spettacolo, pagando il cachet dello spettacolo maggiorato di una percentuale "x" che servirà per la produzione.
In questo modo sarà possibile produrre lo spettacolo e nello stesso tempo garantirne la circuitazione. Questa idea di produzione presuppone ovviamente, una parte di "rischio imprenditoriale" per i soggetti che decidano di diventare azionisti dello spettacolo, comprando delle repliche ancora prima che lo spettacolo sia pronto e sostenendo un progetto a scatola chiusa, basando la scelta esclusivamente sul valore culturale del progetto.
Sappiamo però che nello stesso modo, anche le produzioni che presuppongono investimento di un solo soggetto sono a rischio, ma non per questo non si fanno. La rete produttiva e distributiva che dovrebbe esistere tra gli enti, in questo caso viene avviata da una compagnia, da chi produce e ha come unica finalità la produzione; creare una rete di sostenitori è forse un nuovo modo di dare significato agli enti stessi.
Al Cooproduttore
Nelle cooproduzioni classiche, i soggetti partecipanti si dividono i borderaux delle repliche. In questa tipologia di coproduzione risulta difficile, se non in eventuali casi particolari su lunghe teniture, per cui i soggetti partecipanti sono da considerarsi più azionisti che veri e propri cooproduttori.
Lo spettacolo verrà promosso e pubblicizzato, facendo apparire su tutti i materiali i nomi (dove è possibile anche i logo) di tutti i cooproduttori.
Il progetto verrà seguito in tutte le sue fasi da un ufficio stampa per promuovere lo spettacolo, ma soprattutto la tipologia di produzione. Considerando il tema dello spettacolo, stiamo cercando di coinvolgere dei media partner che possano amplificare l'idea del progetto.
La comunicazione vorremmo che fosse più vicina all'amplificazione mediatica della musica: Opera Notte è uno spettacolo, ma anche un concerto.
Il progetto è ancora in via di definizione. Il 19 marzo, in occasione della personale sulla Compagnia Dionisi alla Fabbrica del Vapore per la rassegna Vapori Zerosei, la compagnia presenterà un ulteriore studio dello spettacolo, con nuove parti di testo e nuovi personaggi, rispetto alla prima versione presentata in precedenti occasioni. In quella serata la compagnia presenterà il progetto produttivo in compagnia dei primi sostenitori del progetto.
Maggiori informazioni contattando la compagnia: Alessandra Maculan
www.dionisicompagniateatrale.it; alessandra@dionisicompagniateatrale.it
Da una mail di Franco D'Ippolito su Opera Notte
"Carissimi,
ieri sera ho visto un primo studio di circa 20 minuti (in occasione del Scena Prima Fringe Festival al Verdi di Milano) della nuova produzione della Compagnia Dionisi e mi ha colpito molto. Per la qualità straordinaria del testo (una conferma del valore di Renata Ciaravino), per la capacità di trattare microstorie con leggerezza, eleganza, ironia e forza critica, per la bravura (anche questa una conferma) delle attrici, per il possibile buon esito di pubblico che si intravede. La struttura dello spettacolo è nella cifra delle Dionisi, fra continui salti ritmici e poetici (ma, rispetto a Disco 80, con un 'corpo' più solido e strutturato)."
Franco
QUALCHE NOTA SUL PROGETTO ARTISTICO
Abbiamo dovuto cominciare ad ardere per pensare "opera notte". Per scriverlo e farlo, dobbiamo esplodere come ragni traverso le stelle. Come in un rave o dentro una poesia. Senza paura. Come accogliere un proiettile che trapassa, ma non uccide. Non puoi fare altro purtroppo quando parli dell'ombra (la notte) e quando parli alle persone, non puoi fare altro quando progetti la tua individuazione dentro un'opera rock. E' un testo sulla notte. Ma è anche un¹idea viscerale di teatro, un pop raffinato, declinato con parole contemporanee per contemporanei. Un'ascesa, un sacrificio, una scopata, qualcosa che puoi capire, qualcosa che puoi condividere, qualcosa dentro cui puoi piangere. Ricapitolare nell'atto della rappresentazione le vite che hai vissuto di notte, nell'ombra, quelle che hai incrociato, quelle che vorresti vivere e non puoi più perché deprivato di coraggio, quelle che non possono più tornare".
(to be continued)
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
Studio Azzurro manda Galileo all'inferno
Il debutto del nuovo lavoro a Norimberga
di Studio Azzurro
STUDIO AZZURRO
GALILEO ALL'INFERNO
cosmodramma
Spettacolo di danza e video in 5 piattaforme interattive
Progetto scenico e multimediale: Studio Azzurro
Regia: Paolo Rosa
Coreografia: Daniela Kurz
Drammaturgia: Paolo Rosa ed Andrea Balzola
Testi: Andrea Balzola
Luci e fotografia: Fabio Cirifino
Scenografia e Costumi: Frank Albert
Sistemi Interattivi: Marco Barsottini e Lorenzo Sarti
Musica originale: Tommaso Leddi
Montaggio: Antonio Augugliaro
Operatore: Rocco Cirifino
Grafica: Daniele de Palma
Computer hardware e software: Alberto Massagli, Emanuele Siboni.
Tracking software: Alessandro Valli
Assistenti: Paola Tognazzi, Mahnas Esmaili, Luigi Boccadamo, Federico Perrone.
Produzione esecutiva: Paola Tognazzi
Relazioni pubbliche: Delphine Tonglet
Coordinamento progetto: Reiner Bumke, 235 Media, Meike Ludwig.
Danzatori in scena: 7 ballerini del corpo di ballo “Staatstheater Nuremberg”
Danzatori nel video: Corinna Azzi, Andrea Valfre', Valter Esposito, Simone Magnani, Fabio Ratti, Salvatore Giacomia, Antonella Marra.
Prodotto da Open Haus Norimberga e Studio Azzurro

Galileo all'Inferno: il viaggio immaginario di uno scienziato
(Testo introduttivo allo spettacolo, a cura di Andrea Balzola)
Questo spettacolo, che si ispira a Galileo Galilei, nasce dalla collaborazione artistica tra il Balletto di Norimberga e lo Studio Azzurro di Milano.
La vita dello scienziato italiano Galileo Galilei (1564-1642) attraversa il tempo come una stella cometa, è emblematica del complesso rapporto tra ricerca scientifica e fede religiosa, tra libertà di pensiero e convenzioni culturali, tra invenzione tecnologica e sviluppo della conoscenza. Galileo detesta l’astrazione e l’arroganza dei dogmi accademici e metafisici, ama l’esperienza diretta del fare come un’artista, scopre i segreti della fisica immergendosi nella sperimentazione, creandosi nuovi strumenti di misurazione, non inventa il cannocchiale ma lo punta per primo con tanto accanimento sul cielo, fino a diventare cieco, scoprendo e dimostrando che l’eretico Copernico aveva ragione: la terra non è al centro dell’universo, la luna e gli altri pianeti non sono sfere immobili e cristalline ma sono masse viventi, mobili e mutanti, il fango è per lui più nobile del diamante perché è fonte di vita. La sua opera diventa simbolo di come il pensiero di un uomo possa esplorare l’ignoto aprendo nuove prospettive per l’umanità, a suo rischio e pericolo, ostinato a prezzo anche della vita e degli affetti. Quando abiura lo fa per paura e per stanchezza o per poter continuare la sua ricerca, affidandosi al giudizio dei posteri?
Pubblica le sue opere in italiano invece che nel latino canonico, perché crede nella condivisione e nella divulgazione del sapere, la sua opera più importante (Sui due massimi sistemi tolemaico e copernicano) è scritta in forma di dialogo come un testo teatrale, Tommaso Campanella la definisce infatti una “commedia filosofica”, argomenta le proprie idee facendo parlare il proprio alter ego con 2 interlocutori e così “mette in scena” per la prima volta il pensiero scientifico, come un regista-drammaturgo dei concetti. L’idea di teatralizzare Galileo non viene quindi da Brecht ma da Galileo stesso. Ma come sintetizzare la complessità del personaggio e delle sue idee in una visione simbolica, veloce, fatta da corpi in movimento, immagini videoproiettate e ambienti interattivi?
C’è anche, nel densissimo percorso di questo fondatore del metodo sperimentale e della scienza moderna, un sorprendente, e poco noto, tentativo di coniugare il rigore matematico con l’immaginazione poetica e artistica. Infatti, nelle DUE LEZIONI ALL'ACCADEMIA FIORENTINA CIRCA LA FIGURA, SITO E GRANDEZZA DELL'INFERNO DI DANTE, del 1588, Galilei ripercorre passo per passo il viaggio dantesco all’inferno cercando, sulla base dei “divini” versi e a commento di due teorie contrapposte di matematici fiorentini dell’epoca, di dare una descrizione razionale, matematica e geometrica dei gironi infernali e dei demoni che li abitano, calcolando misure e proporzioni di quei luoghi, dei giganti e infine dello stesso Lucifero. Così Galileo inaugura un'inedita dialettica tra scienza e fantasia, tra tecnica ed arte, tra matematica e poesia.
"Se è stata cosa difficile e mirabile .... l'aver potuto gli uomini per lunghe osservazioni, con vigilie continue, per perigliose navigazioni, misurare e determinare gl'intervalli de i cieli, i moti veloci ed i tardi e le loro proporzioni, le grandezze delle stelle, non meno delle vicine che delle lontane ancora, i siti della terra e de i mari, cose che, o in tutto o nella maggior parte, sotto il senso ci caggiono; quanto più maravigliosa deviamo noi stimare l'investigazione e descrizione del sito e figura dell'Inferno, il quale, sepolto nelle viscere della terra, nascoso a tutti i sensi, è da nessuno per niuna esperienza conosciuto (...) ché dal mancamento dell'altrui relazione viene sommamente accresciuta la difficultà della sua descrizione. Per lo che era necessario, allo spiegamento di questo infernal teatro, corografo ed architetto di più sublime giudizio, quale finalmente è stato il nostro Dante...”
Qui Galileo applica idealmente (e paradossalmente) il suo metodo scientifico e i suoi calcoli matematici all’”infernal teatro” di cui Dante è stato “architetto e coreografo”. E di qui, da questo intreccio tra arte e scienza, lo spettacolo prende spunto per realizzare un viaggio simbolico con i linguaggi contemporanei della danza e delle immagini interattive. L’uso dei dispositivi interattivi consente ai danzatori di trasformare la scena in tempo reale con i loro movimenti, superando la tradizionale separazione tra corpo e scenografia, e si connette profondamente col principio di Galileo di una tecnologia che può estendere la dimensione percettiva dell’uomo, addirittura fino al punto di misurare un luogo "fantastico" e puramente immaginario come l'inferno di Dante. Lo spettacolo non è quindi un ritratto biografico, ma un itinerario visionario di Galileo all’Inferno, raccontato con i “moti dei corpi” coreografati da Daniela Kurz, con le proiezioni mutanti e interattive di Studio Azzurro, con frammenti verbali elaborati da Andrea Balzola da documenti e scritti galileiani, tutto musicato da Tommaso Leddi.
La scena è concepita come un organismo metamorfico, dove, in un progressivo passaggio tra macrocosmo e microcosmo, i corpi dei danzatori sono come emanazioni del pensiero di Galileo e interagiscono con le videoproiezioni, disegnando una “cosmogonia antropomorfa”.
Galileo inizia il suo viaggio dall’osservazione dell’universo, in cui gli astri danzano in moti celesti e ruota un globo terrestre composto di corpi umani; focalizza il luogo dove Dante colloca l’Inferno (vicino a Gerusalemme), entra nell’anfiteatro infernale attraverso l’ombelico di Lucifero. Misura l’inferno attraverso i movimenti dei danzatori; alle soglie della discesa tra i dannati subisce il giudizio della Chiesa del passato e del presente attraverso le voci di alcuni papi, rompe la grande vetrata del dogma e naufraga nel buio travolto da tempeste, piogge e paludi di fango. Entra su un “tapis roulant” nella Città di Dite e percorre i gironi infernali, costellati di esplosioni come gli inferni terrestri della nostra epoca. Fumi offuscano la vista e scoprono un occhio gigantesco come una Luna, quello di Galileo, che diventa cieco. Nel buio della cecità (caratteristica dei veggenti per gli antichi) lo sguardo muta natura, si rivolge all’interno: un sistema a infrarossi rivela un nuovo universo, interiore, quello del corpo umano radiografato dalle moderne tecnologie della medicina (radiografie, ecografie, etc). Da qui una lentissima zoommata in fuori svela che questo territorio non e’ altro che un corpo gigantesco rannicchiato su se stesso simile alle immagini iniziali, ma costruito con lo sguardo delle nuove tecnologie. E’ una nuova immagine del Lucifero dantesco attorno al quale altri corpi, forse angeli forse uomini, orbitano come satelliti.
La capacità e il coraggio di Galileo di “guardare lontano”, interrogando le leggi della Natura e il mistero dell’Universo con l’esperienza e l’osservazione diretta, potenziando con l’invenzione di nuovi strumenti tecnici le facoltà umane e quindi finalizzando l’innovazione tecnologica al progresso della conoscenza, non segnano soltanto la nascita della scienza moderna e del suo metodo sperimentale, ma generano anche una nuova visione dell’uomo. Un uomo che il cattolico Galileo non voleva sostituire a Dio, ma che stimolava ad assumersi pienamente, nella meraviglia e nella sofferenza, la responsabilità della sua presenza al mondo e la ricerca di una risposta (anche se mai certa e compiuta) ai misteri dell’esistenza. Lo sguardo umano che si sofferma e studiare la natura e l’universo scopre in essi anche lo specchio macrocosmico della condizione umana. E la conoscenza, come qualcuno più tardi avrebbe suggerito, non serve soltanto a descrivere il mondo, ma anche a trasformarlo.
Il fulcro dello spettacolo diventa questo rapporto indissolubile tra conoscenza del mondo ed evoluzione dell’uomo, che si configura nell’intreccio dinamico tra corpo reale e scena virtuale (videoproiezioni interattive), frutto di un percorso che caratterizza la ventennale ricerca espressiva di Studio Azzurro nelle arti visive e nel teatro e che ha visto già una precedente collaborazione con Daniela Kurz (Wor mochte Wohl Kaspar Hauser, 2000).
Nella nostra epoca le innovazioni tecnologiche, e in particolare la rivoluzione digitale, hanno generato profonde trasformazioni nella percezione della realtà e nell’immaginario collettivo, coniugandosi con la ricerca scientifica sono arrivate a intervenire sugli equilibri dell’ecosistema e sui fondamenti della biologia umana, e stanno quindi ridisegnando l’identità stessa dell’uomo e della natura. Raccontare in modo contemporaneo significa anche appropriarsi di queste tecnologie per esplorare nuovi territori evolutivi e le nuove problematiche scientifiche, filosofiche ed etiche che essi suscitano, superando le frontiere tra i linguaggi. Anche questo è un modo per accogliere, attualizzare e rilanciare il messaggio galileiano, che supera le frontiere del tempo per affermare l’inesauribilità dello spirito di ricerca umana, sempre conteso tra esperienza e desiderio, tra astrazione e contatto, tra visione e verifica nella realtà, fra arte e scienza.

