Due incontri per un teatro che cambia
di Franco D'Ippolito, Mimma Gallina e Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and2
Le Buone Pratiche 2.1. Il teatro come servizio pubblico e come valore: lo spettacolo dal vivo tra economia, politica e cultura
Mira, Villa dei Leoni, 11-12 novembre 2005
di Franco D'Ippolito, Mimma Gallina e Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and3
Le Buone Pratiche 2.2. La questione meridionale nel teatro
Dicembre 2005
di Franco D'Ippolito, Mimma Gallina e Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and4
Diario dai festival
Gli spettacoli dell'estate 2005 e il loro pubblico
di Franco D'Ippolito
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and6
C'è chi si vuole impegnare e chi si accontenta di vedere il mondo dalla parte di Zelig
Resistenti di Roberta Biagiarelli a Festambiente 2005
di Anna Maria Monteverdi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and7
La prigione dell'autore in crisi
Una intervista ad Armando Punzo su Appunti per un film
di Andrea Lanini
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and8
Nel paradiso delle marionette
Il festival “Marionette e burattini nelle Valli del Natisone”
di Fernando Marchiori
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and9
Il corpo all'attacco
Dalla Biennale Danza 2005
di Fernando Marchiori
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and11
La rinascita della tragedia?
Dionysus Since 69. Greek Tragedy at the Dawn of the Third Millennium, a cura di Edith Hall, Fiona Macintosh e Amanda Wringley
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and12
La voce artaudiana di Diamanda Gàlas
Defixiones, Will And Testament (Mute 2003)
di Nevio Gàmbula
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and13
Dal punto di vista dell'ombra
El Eco de la Sombra del Teatro de los Sentidos di Enrique Vargas
di Enia Daniela Idda
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and15
Enrique Vargas alla Città del Teatro di Cascina
Il progetto
di La Città del Teatro di Cascina
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and16
Il teatro è sogno (ma anche come metterlo in pratica)
La prefazione a Il teatro possibile di Mimma Gallina
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and25
Integrazione tecnoespressiva e métissage artistico nel teatro di Robert Lepage
Dal volume a cura di M.M.Gazzano che contiene gli atti del convegno su Cinema e intermedialità
di Anna Maria Monteverdi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and50
Orizzonti di uno sguardo antro-po-etico
Su 'U Gioia di Mauro Aprile
di Andrea Balzola
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and51
Una lettera ad Andrea Balzola
Ancora su 'U Gioia di Mauro Aprile
di Fernando Mastropasqua
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and52
Mahmud Darwish in tournée italiana con Sandro Lombardi
Dall8 al 18 settembre
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and80
Le Buone Pratiche 2
Due incontri per un teatro che cambia
di Franco D'Ippolito, Mimma Gallina e Oliviero Ponte di Pino
Dopo il grande successo dell’incontro sulle Buone pratiche 1, che nel novembre 2004 ha visto a Milano la partecipazione di oltre 400 tra artisti, operatori, studiosi, studenti, critici, ci è sembrato opportuno dare un seguito a quella Ottima Pratica, con due iniziative complementari, una al Nord e una al Sud.
Si parte dunque per Le Buone Pratiche 2. Due incontri per un teatro che cambia.
Perché nel nostro teatro stanno davvero cambiando molte cose, e molte altre devono cambiare. Sono dunque necessari nuovi strumenti e nuove idee. Molto spesso però le necessità impellenti del presente ci impediscono di vedere oltre il nostro interesse immediato e particolare.
Ci sembra perciò utile e indispensabile riprendere a riflettere sulle ragioni di fondo del fare teatro, e sul rapporto tra lo spettacolo dal vivo da un lato e, dall’altro, l’economia (mercato e sponsor compresi), la politica (sovvenzioni comprese), la geografia e la geopolitica (dalle sfide della globalizzazione alla scala europea, dalla regionalizzazione delle competenze dello spettacolo al rapporto con gli enti locali), le altre arti e forme di comunicazione (a cominciare dai nuovi media).
Abbiamo deciso di articolare la seconda sessione delle Buone Pratiche in due incontri.
Le Buone Pratiche 2.1 – di carattere più generale – si terrà il 13 e 14 novembre alla Villa dei Leoni di Mira, grazie all’ospitalità del Comune di Mira, e avrà per tema Il teatro come servizio pubblico e come valore: lo spettacolo dal vivo tra economia, politica e cultura.
Le Buone Pratiche 2.2 si terrà invece tra dicembre 2005 e gennaio 2006 (stiamo ancora definendo la località) e avrà per tema La questione meridionale.
Le caratteristiche degli incontri restano quelle della prima tornata delle Buone pratiche: assoluta indipendenza e libertà, autogestione e trasparenza, partecipazione gratuita, diffusione delle relazioni (sempre gratuita) sul sito www.ateatro.it, discussione aperta sia nel corso dell’incontro sia nei forum Fare un teatro di guerra? NTVI.
Stiamo iniziando a raccogliere le adesioni all’indirizzo info@ateatro.it. Nelle prossime settimane, sempre attraverso il sito www.ateatro.it, forniremo le necessarie informazioni logistico-organizzative e vi terremo aggiornati sulle varie fasi della preparazione dell’iniziativa (insomma, come l’altra volta).
Le Buone Pratiche 2, così come l’incontro precedente, vuole dunque offrire un’occasione per il teatro di riflettere sul proprio ruolo, sulla propria situazione e sulla propria evoluzione; e cerca di fornire agli artisti, agli studiosi e agli operatori pubblici e a privati una serie di strumenti di informazione, formazione e analisi.
Qui di seguito i documenti preparatori dei due incontri.
Le Buone Pratiche 2.1. Il teatro come servizio pubblico e come valore: lo spettacolo dal vivo tra economia, politica e cultura
Mira, Villa dei Leoni, 13-14 novembre 2005
di Franco D'Ippolito, Mimma Gallina e Oliviero Ponte di Pino
Il teatro – e in generale la cultura – può ancora essere considerato ancora un “servizio pubblico”? Con quali modalità e criteri questa categoria può continuare a governare i rapporti tra la scena e la politica?
In altri termini, perché andiamo a teatro? Qual è oggi il “valore” del teatro? Con quali modalità questo “valore” può costituire un criterio per determinare il sostegno pubblico e privato al teatro?
Nel corso degli ultimi decenni il teatro in Italia, come in tutti i paesi europei, ha beneficiato di un fondamentale sostegno pubblico, sia dal governo centrale sia dagli enti locali, in varie forme e con motivazioni articolate anche se non sempre espresse con chiarezza.
Molto meno sostanzioso è stato finora nel nostro paese l’intervento dei privati: ed è curioso (e significativo) che nel quadro del loro impegno culturale le fondazioni bancarie e le industrie private abbiamo finora trascurato nella sostanza il teatro.
Ferma restando l’opportunità e la necessità di un finanziamento pubblico al teatro, ci pare che oggi vadano riconsiderate e ritrovate le ragioni profonde del sostegno allo spettacolo dal vivo da parte del pubblico e dei privati, e dunque vadano riequilibrati i criteri e le modalità di assegnazione dei finanziamenti.
Sono infatti in corso diversi cambiamenti di ampio respiro che è inutile e sciocco ignorare.
E’ possibile indicare, in maniera molto generica e come primo spunto di riflessione, alcuni snodi fondamentali:
- la ridefinizione del ruolo del teatro (e in generale dei valori umanistici) all’interno del sistema culturale e nella mediasfera, anche in considerazione dell’impatto di nuovi media;
- la ricerca di forme espressive, ma anche produttive e organizzative, che superino le barriere tra i diversi generi e le diverse arti, imponendo una riflessione di carattere generale sullo statuto del teatro;
- di conseguenza, una diversa frammentazione del pubblico del teatro e dello spettacolo dal vivo, che suggerisce anche diversi metodi di contatto e di coinvolgimento, sia sul versante della promozione sia su quello delle modalità di fruizione dell’evento da parte dello spettatore;
- il ripensamento del welfare e del concetto stesso di servizio pubblico, che investe anche il sostegno alla cultura, in un quadro che vede una generale diminuzione delle risorse pubbliche;
- le recenti acquisizioni nel campo dell’economia della cultura, che impongono una revisione dei criteri di gestione delle imprese culturali;
- l’impatto della globalizzazione su un versante della cultura legato a un aspetto per sua natura “locale” (per lingua, tradizioni, destinatari) come il teatro;
- in Italia, il passaggio di una serie di competenze in materia di spettacolo dallo Stato alle regioni, e dunque la ridefinizione del rapporto tra governo centrale ed enti locali; e in prospettiva la spinta verso un riequilibro territoriale delle attività di spettacolo dal vivo, e relative sovvenzioni;
- sul versante europeo, dopo un decennio di tentativi non del tutto riusciti (sia sul fronte dei grandi festival-vetrina della cultura europea sia sul versante della formazione), si avverte la necessità di una politica convinta e incisiva a favore della cultura, con reperimento e riequilibrio delle risorse destinate al settore, e si avverte di conseguenza la necessità di definire nuovi criteri di distribuzione delle medesime.
In questo scenario, la nozione di “servizio pubblico” può essere ancora un’utile bussola, ma probabilmente non è più sufficiente. Alcuni artisti e studiosi propongono di affiancare o sostituire questo tradizionale approccio con un altro, che ponga al centro della riflessione e della valutazione il concetto di “valore”.
Un primo problema è che il termine “valore” ha significati e implicazioni diverse a seconda degli ambiti in cui viene usato, anche rispetto al teatro.
In ambito economico, il valore indica la redditività di un investimento.
In ambito politico, il termine si riferisce a quell’insieme di idealità, punti di riferimento collettivi, aspirazioni morali, progettualità condivisi da una società.
In ambito artistico, il “valore” misura l’eccellenza estetica delle opere.
Come è evidente, le implicazioni in questi tre ambiti del termine “valore”, anche applicato al teatro (e in genere allo spettacolo dal vivo), sono diverse e non sempre necessariamente convergenti.
A Mira cercheremo di capire se questi tre approcci sono validi e fecondi, e se nel loro insieme possono offrire elementi e metodi che possano tradursi in metodi di valutazione dell’investimento in cultura; e se e come possono integrarsi all’idea di cultura come “servizio pubblico”.
Per raggiungere questi obiettivi, non vogliamo coinvolgere solo teatranti, operatori e studiosi (e in generale persone interessate primariamente allo specifico teatrale), ma anche personalità della cultura, della politica, dell’economia e in generale della società che possano dare un costruttivo contributo alla discussione. Perché, ne siamo convinti, i problemi del teatro non riguardano solo il teatro e i teatranti, ma l’intera società. Non si tratta solo di questioni tecniche, che gli addetti ai lavori e gli esperti possono risolvere in separata sede, ma di problemi che investono l’intero ambito sociale e culturale e che dunque riguardano tutti noi.
Le Buone Pratiche 2.2. La questione meridionale nel teatro
Dicembre 2005
di Franco D'Ippolito, Mimma Gallina e Oliviero Ponte di Pino
La questione meridionale del teatro sta nel divario nord-sud dei finanziamenti pubblici alla produzione ed alla distribuzione, delle sale agibili, del numero delle recite programmate, ma non solo. Sta anche nella difficoltà di sviluppare politiche attive di contrasto delle povertà materiali (attraverso l’occupazione diretta ed il vasto indotto che produce) ed immateriali (che attengono alla qualità della vita delle comunità ed al capitale civico dei territori), ma non solo. Sta nella specificità del “pensiero meridiano” e nelle punte d’eccellenza e nei modelli organizzativi ed artistici che funzionano, ma non solo. Sta pure nella condizione di solitudine della passione dei talenti che nessuna legge o regolamento potrà misurare ma che senza quei riferimenti normativi certi continuerà a produrre l’individualismo delle azioni e dei pensieri. E forse sta in altro ancora, nella necessità di un’utopia, di cui il teatro e gli uomini non possono fare a meno.
Noi siamo convinti che dal Sud possa venire una nuova percezione della necessità del teatro e perciò vogliamo far seguire alla riflessione veneta la “presa in diretta” della situazione teatrale meridionale, laddove inizia ad avere visibilità nazionale il talento e la capacità di nuovi soggetti che reclamano l’urgenza di un cambiamento concreto del sistema, per continuare il proprio percorso artistico ed organizzativo. Un passaggio questo già sperimentato nel primo incontro milanese, dai pensieri alle pratiche, perché ciò che ci interessa è quanto si può fare, quanto si può far vivere e crescere di quello che siamo capaci di immaginare.
Vorremmo affidare ad un sociologo la riflessione sulla società civile meridionale e sul rapporto con la sua cultura mediterranea: a cosa può servire il teatro nel superamento della questione meridionale come “palla al piede” del sistema Italia? E poi chiedere al mondo dell’impresa privata quale grado di consapevolezza abbia raggiunto l’imprenditoria privata nel considerare lo sviluppo civile parte irrinunciabile ed imprescindibile dello sviluppo economico del territorio e come, perché, quanto il mondo dell’impresa voglia e possa investire promozionalmente in cultura. Con un economista della cultura vorremmo esaminare i dati statistici del “sotto la media” delle produzioni, delle recite, delle sale teatrali, degli spettatori, delle risorse pubbliche e private del teatro meridionale per poi provocare un confronto fra il teatro che si fa al nord ed il teatro che si fa al sud attraverso la vis polemica di due critici. Uno spazio importante vorremmo dare alle pratiche teatrali meridionali, da quelle svolte negli anni passati a quelle più recenti, attraverso l’analisi delle luci e delle ombre dell’intervento delle isituzioni e degli Enti Locali, del ruolo svolto nel bene e nel male dai circuiti regionali e della capacità a volte scarsa dei teatri e delle compagnie di fare rete, di lavorare insieme. Tra le pratiche da sperimentare con maggiore convinzione proveremo a chiedere ad un critico dell’arte come il teatro possa partecipare dell’aumento dei flussi turistici al sud legati ai Beni culturali. Contiamo anche di riuscire a coinvolgere le regioni meridionali per una riflessione trasversale sulle politiche locali teatrali, sui nuovi assetti Stato/Regioni che stentano a definirsi per le difficoltà di condivisione degli strumenti normativi fra politica e teatro, magari avviando proprio dal sud e con le nuove regioni meridionali una prima ricomposizione degli obiettivi strategici (come ripartire il FUS, a chi e perché, ambito nazionale e rilevanza regionale, solo per fare qualche esempio). Ci piacerebbe che l’incontro meridionale fosse anche capace, con il contributo di tutti i partecipanti, di immaginare un’utopia per il Sud, un pensiero alto non misurabile, che accompagnasse le cose concrete che si possono fare e che si debbono fare e che possa restituire alle donne ed agli uomini meridionali il “sogno del bello”.
Diario dai festival
Gli spettacoli dell'estate 2005 e il loro pubblico
di Franco D'Ippolito
La riflessione che ha attraversato tanti operatori teatrali nelle settimane di festival estivi si è concentrata, anche con qualche spunto autocritico, sulla “questione del pubblico”. Non che negli anni scorsi questo tema sia stato assente o trascurato (anzi, ha caratterizzato le più incisive pratiche di molti stabili di innovazione e segnato le più feconde esperienze del Progetto Aree Disagiate), ma non è mai stato posto con tanta convinzione (magari dovuta forse ad una evidente costrizione) al centro delle analisi della crisi, né è mai stato indicato con tanta consapevolezza fra le principali possibili soluzioni all’immobilismo del sistema teatrale italiano, che ha scavato nell’ultimo decennio un fossato sempre più largo fra le generazioni ed i generi, con qualche stretto ed isolato ponte levatoio praticabile a pochi.
Se punto focale dei dibattiti diventa così il pubblico (o meglio i pubblici) dello spettacolo dal vivo, si può provare a ri-pensare molte delle analisi finora fatte ed a ri-definire alcuni principi fondamentali nel rapporto artisti/spettatori, progetti artistici/progetti organizzativi, sistema teatrale/sistema politico, a cominciare dalla delicata questione dei finanziamenti pubblici al teatro. Proviamo a ribaltare il pensiero guida della politica culturale delle sovvenzioni dalla difesa della libertà degli artisti (sacrosanta quando non diventa giustificazione per sopravvivere acriticamente) a quello della libertà dei pubblici (non subendone passivamente la domanda quanto piuttosto generandola). E poi a correlare anche ai pubblici le finalità del finanziamento pubblico, ribadendo in funzione dei pubblici il diritto della cultura e del teatro ad attingere alla fiscalità generale per la propria crescita (e non solo per la propria sopravvivenza!). Se lo spettacolo (insieme alla letteratura ed all’arte) è elemento ineliminabile del processo educativo e ciò che spinge il fruitore delle attività culturali è il desiderio/bisogno di accrescere il proprio stock di conoscenze, come possiamo sostenere che quanto oggi la stragrande maggioranza dei teatri propone vada in quella direzione e non, piuttosto, nella più sicura ed improduttiva offerta del “già conosciuto”? Il problema sta nella carenza di stimoli per il pubblico e per i creatori che si sono seduti sulle rendite di posizione con un eccesso di ripiegamento su di sé.
Ho fatto un tour fra alcuni festival estivi. A cominciare da Napoli con Teatri di Napoli 2005 incontri di teatro contemporaneo e teatro per le nuove generazioni, che si è svolto dal 16 al 19 giugno in alcune strutture della periferia: Teatro Aria Nord di Piscinola (affidata in convenzione a dal Comune a Liberascena ensemble), la palestra Scialoja a San Giovanni a Teduccio (affidata a Libera Mente ed a I Teatrini), il Museo di San Martino, il Chiostro di San Gregorio Armeno, il Teatro Le Nuvole Edenlandia oltre alle due sale del Teatro Nuovo. Questa seconda edizione ha confermato la vitalità del teatro napoletano ed il grande interesse ed affetto che circonda l’esperienza dei Teatri di Napoli (di cui si è parlato nelle Buone Pratiche 2004). La formula del festival prevede la presentazione da parte delle compagnie aderenti al progetto (Crasc, La Riggiola, Scena Mobile, Libera Mente, I Teatrini, Rossotiziano, Le Nuvole e Liberascena ensemble) delle loro ultime produzioni unitamente ad uno spettacolo indicato da ciascuna di esse nel pieno rispetto delle autonomie di ognuno. Le scelte di ospitalità quest’anno hanno privilegiato anche, in chiave serenamente polemica, alcuni soggetti che sono stati penalizzati, in alcuni casi arbitrariamente, dalla Commissione Prosa per le sovvenzioni 2004 (vale soltanto la pena di ricordare che le decisioni del Ministero sono state prese a novembre 2004 quando nessuno era più in grado di porre rimedio a tagli o azzeramenti), mentre non erano ancora note le decisioni per il 2005 (che hanno portato un ulteriore taglio medio del 4% spalmato su più o meno tutti).
Nello spettacolo di burattini napoletani dal titolo Se77e, ispirato al Settimo sigillo di Bergman, il sorprendente Gaspare Nasuto affronta con coraggio il tema bergmaniano della morte attraverso un Pulcinella che si interroga con intelligenza, grazia, ironia tutta napoletana sul senso della vita, pronto a dare una rivincita alla morte. E’ una guarattella per certi aspetti inquietante, che restituisce contemporaneità ad una delle più tradizionali forme di teatro popolare. Liberascena Ensemble ha presentato Museum, il progetto di Renato Carpentieri ambientato nelle sale del Museo di San Martino: nove performances affidate agli attori della compagnia su nuove drammaturgie fra cui La sala del pallone aerostatico ispirata a Nadar (uno dei più grandi fotografi dell’Ottocento) interpretato da Lello Serao, il debole omaggio a Heiner Müller de La sala delle macerie e l’intenso La sala dell’ultimo convito, un omaggio a Socrate e Diotima dai Dialoghi di Platone affidato al sempre umanissimo Renato Carpentieri (ideatore dell’intero progetto) e alla brava Patrizia De Martino. Molto bello lo spettacolo del Centro Diaghilev nella Sala Assoli del Teatro Nuovo su un testo di Mariano Dammacco, Assedio con Christian Di Domenico e Saba Salvemini per la regia di Simona Gonella: il pelide Achille è l’Eroe eccellente, metafora contemporanea dell’uomo di fronte alle costrizioni dei ruoli, e grazie ad una regia rigorosa che si mette al servizio dei bravissimi attori lo spettacolo restituisce con forza la poesia ed i paradossi della scrittura di Dammacco.
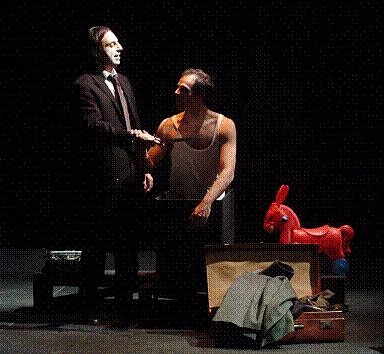
Christian Di Domenico e Saba Salvemini
ASSEDIO di Mariano Dammacco - regia di Simona Gonella
Tra gli altri spettacoli visti, Clinch con Stefano Jotti, uno sguardo dentro il mondo della boxe attraverso un pugile suonato forse un po’ troppo solo nella drammaturgia di Francesco Pititto e nella regia dello stesso Jotti, e Mac e Beth di e con Alberto Astori e Paola Tintinelli, uno studio forte e a tratti di qualche impatto, liberamente tratto dal Macbeth, dove la storia di un pallido delinquente e di una trapezista imperfetta scorre tra belle invenzioni sceniche e qualche forzatura di ritmo e di toni. Un ultimo accenno a Nessuna omelia, scritto, diretto ed interpretato da Gaetano Colella e Gianfranco Berardi (che due settimane dopo avrebbero vinto il Premio Scenario 2005 con un progetto che abbiamo poi visto a Volterra): questo spettacolo narra di un armistizio che dovrà mettere fine ad una guerra che si protrae da diversi anni e che fintanto non sarà firmato costringerà due capi di stato in una stanza, anche la notte di Natale. Una buona prova dei due attori su un interessante impianto drammaturgico con qualche ingenuità di regia che giustamente segna i primi lavori di questi due attori-drammaturghi pugliesi.
Armunia Festival Costa degli Etruschi rappresenta il luogo in cui è ancora possibile ritrovare quella saggia follia di cui sentiamo tutti la mancanza in un panorama teatrale innocuo, chiuso, incapace di provocare reazioni, positive o negative che siano. Grazie a Massimo Paganelli al Castello Pasquini di Castiglioncello si riesce sempre ad entusiasmarsi per qualche spettacolo o ad incazzarsi per la inutilità di qualcun altro, ma personalmente ricevo sempre la sensazione che il nostro teatro è ancora vivo, nella confusione di proposte che si accavallano dis-organizzativamente tra la Sala del Camino, l’Anfiteatro, la Tensostruttura di sopra e quella di sotto. Peccato, come dice Paganelli e come amaramente condivido, che tutto, il bello ed il brutto, resti poi lì, nelle sere toscane d’estate, e non riesce a vivere come potrebbe, come dovrebbe, negli spazi delle stagioni invernali d’Italia. A che serve allora rischiare continuamente per cercare quanto ancora di intensamente vivo c’è nel teatro italiano, investire danaro pubblico (e in questo caso davvero di investimento si deve parlare) se poi dei tanti spettacoli promossi attraverso residenze o coproduzioni o più semplicemente ospitalità che danno visibilità, quasi nessuno “parte” da Castiglioncello e quasi tutti si limitano ad “arrivare” là, senza speranza di proseguire. L’incredibile situazione del mercato italiano, tra circuiti pubblici timorosi di promuovere il ricambio degli artisti e del pubblico e teatri municipali arroccati sui propri stanchi abbonamenti, non riesce a cogliere le occasioni che la follia responsabile dei Paganelli gli offrono, pagando di persona il rischio dell’insuccesso.
Per fortuna Armunia esiste e consente il debutto di Cesso dentro, novità di Renato Gabrielli con Massimiliamo Speziani e la intensa regia di Sabrina Sinatti, uno spettacolo in cui, come raramente accade ormai, si incontrano in scena la forza del testo, la straordinaria bravura dell’attore, mai troppo “fuori” come pure il personaggio indurrebbe, ed il talento di una giovane regista che costruisce una trama visiva tra l’immaginario e il reale con grande equilibrio, raccordando le due parti in cui si articola il testo in un tutt’uno godibile e credibile. Ho visto per il terzo anno consecutivo lo spettacolo di Roberto Abbiati: dopo Moby Dick e Giraffe, questo artigiano dell’immaginario teatrale ha lavorato stavolta con Leonardo Capuano (un altro degli attori italiani che vengono tenuti inspiegabilmente da parte) su un’idea piccola ottenendo un grande risultato. Pasticceri – Io e mio fratello Roberto potrebbe sembrare uno spettacolo di teatro e cibo, ma non lo è, perché qui è la storia di due fratelli, una sorta di Cyrano e Cristiano che aspettano la loro Rossana, a dettare i ritmi drammaturgici e di regia, mentre soltanto le azioni che compiono ci immergono nei profumi della crema pasticciera o nelle visioni della panna che monta. E’ una storia dolce (in tutti i sensi) e melanconica, ironica e poetica, ma la voglia di far assaggiare le torte preparate in scena non giustifica il buttar via frettolosamente e semplicemente il finale. Vincenzo Pirrotta ha conquistato il pubblico del festival con la forza brutale del suo “cunto” ne Il tesoro della Zisa, mentre stranamente inquietante (a parte la melassa dei video) è stato Haikus della danzatrice portoghese Sonia Baptista, sospesa fra intriganti invenzioni minimaliste. Ho assistito, infine, ad una prova (a tre giorni dal debutto nazionale) de I Costruttori di Imperi di Boris Vian per la regia di Davide Iodice con Alessandro Benvenuti. In tre giorni gli spettacoli maturano, sedimentano poetiche e interpretazioni; quel che si può dire è che Iodice sfrantuma a suo modo il complicato testo di Vian forzandolo nelle solitudini di un perso Cruche e di uno Padre a cui Alessandro Benvenuti dà grande intensità e incantata sospensione dei sentimenti. Le repliche sapranno sciogliere alcuni irrigidimenti della regia, che si rivelano nei tecnicismi di alcuni attori.

PASTICCERI io e mio fratello Roberto
di e con Roberto Abbiati e Leonardo Captano (foto di Furio Detti)
Il Filo d’Arianna è il festival che il TIB da undici anni organizza a Belluno con l’intelligente e tenace direzione artistica di Daniela Nicosia, in una città che, sarà perché contornata dalle cime alpine, sembra una meravigliosa oasi di tranquillità e concretezza. Quest’anno, dal 28 giugno al 3 luglio, si è articolato in due progetti, uno dedicato a Pasolini ed uno a Museum di Renato Carpentieri (che abbiamo già incrociato al festival de I Teatri di Napoli 2005). Italia mia della Compagnia Babbaluck ha un inizio dello spettacolo che coinvolge assai di più dello svolgimento e poi si conclude con una immagine forte della banalizzazione dello spettacolare contemporaneo; da Museum l’ispirata Ismene con Patrizia De Martino in una cornice affascinante per semplicità e poesia resa ancora più emozionante dalla bella interpretazione dell’attrice napoletana. Molto interessante la serie di proiezioni pasoliniane in collaborazione con Riccione TTV precedute dalle riflessioni sempre puntuali di Massimo Marino. Una nota a parte merita lo spettacolo itinerante negli spazi nascosti del Teatro Comunale, Polvere, drammaturgia e regia di Daniela Nicosia: di che strana materia è fatto il teatro, di polvere che si alza e si trascina fra le parole dei tragici greci e del grande bardo fino a posarsi sul palcoscenico, dove in uno dei momenti più emozionanti del percorso gi spettatori sono portati a guardare il teatro dall’altra parte, da quella dove si rinnova la magia del raccontare per finzioni troppo vere per non crederci.

Susanna Cro (Fedra)
POLVERE ovvero La Storia del Teatro drammaturgia e regia di Daniela Nicosia
Sabato 1° luglio il festival ha ospitato un incontro dal titolo L’effimero che permane che è stato un importante momento di riflessione e di confronto tra artisti, critici ed operatori sul “teatro della periferia”. Partendo dall’esperienza del TIB (che gestisce il Teatro Comunale di Belluno e che, giova ricordarlo, non ha inspiegabilmente alcuna sovvenzione ministeriale), Daniela Nicosia ha ribadito come fuori dai grandi centri, il teatro in provincia abbia saputo ridisegnare la geografia di ampie zone del nostro paese puntando sulle professionalità artistiche ed organizzative (capaci di sollecitare un bisogno di teatro) e sulla passione (perché fare teatro è un atto necessario). Quello che va assolutamente modificato è il rapporto fra la critica e la provincia, fra le istituzioni nazionali e le periferie del sistema. Sia i critici che il Ministero devono attrezzarsi per riuscire a “leggere” i territori teatrali, nella loro diversità ma anche nelle loro grandi potenzialità di pubblico e di artisti, i primi ritornando ad essere testimoni indagatori del sistema teatrale ed il secondo adottando normative meno conservatrici e inventando parametri di valutazione più aperti al nuovo, al non misurabile. Si è proposto il riconoscimento degli “enti teatrali territoriali” riferiti appunto a tutti quei soggetti produttivi e di programmazione che svolgono un lavoro di radicamento nel territorio e di promozione del pubblico, valorizzando le esperienze di rete che si sono affermate negli ultimi anni. Lello Serao (Liberascena Ensemble) ha fatto scandalosamente appello alla “onestà” degli operatori, alla moralità dei comportamenti nei confronti delle altre compagnie e delle istituzioni locali, regionali e nazionali: la difesa corporative delle posizioni non paga e sta da anni colpevolmente immobilizzando il sistema. Alla critica anche Serao ha chiesto maggiore apertura e libertà di giudizio, senza necessità di “scrivere bigliettini da visita per il Ministero”. La mancanza di certezze, della certezza del diritto, è stata denunciata da Stefano Pasquini (Teatro delle Ariette) insieme all’arbitrarietà con cui il Ministero utilizza le norme in vigore, decretando o negando riconoscimenti e sovvenzioni indipendentemente dai risultati dell’attività. Paolo Aniello (Presidente Tedarco) ha sostenuto che “il pensiero della politica è il pensiero degli operatori” sollecitando l’assunzione di maggiori responsabilità nei processi innovativi da parte di chi riveste responsabilità artistiche ed organizzative, Cristina Palumbo (Associazione Echidna) ha chiesto agli operatori di “smetterla di fare i committenti della politica di destra o di sinistra” mentre Andrea Porcheddu ha cercato di spostare il punto di vista stimolando con l’esempio delle Olimpiadi di Torino un approccio al sistema teatro come “sistema lavoro”, poiché stiamo attraversando una crisi di modello piuttosto che di sistema, perché il sistema cultura, a differenza di quello industriale (Fiat, Alitalia) e di quello finanziario (Parmalat, Cirio) tira ancora (gli Uffizi non sono in crisi!). Tesi difficile da sostenere se confrontata con i dati (della BorsaTeatro) delle repliche degli spettacoli prodotti nella scorsa stagione 2004/05 per i quali più della metà degli spettacoli non ha raggiunto le 30 repliche.
Non vi è dubbio che bisogna cambiare le regole del finanziamento pubblico allo spettacolo, ma da solo, e soprattutto in mancanza di un pensiero nuovo questo non basterà. L’incontro di Belluno ha segnato con vigore l’urgenza di costruire un nuovo sistema teatrale plurale, fondato sulla diversità dei soggetti (per storia, per dimensioni, per capacità), ma tutti con pari dignità rispetto alla critica ed alle istituzioni e tutti valutati in funzione dei risultati che producono. I dati del decennio 1990-2000 denotano la persistente debolezza strutturale della domanda di spettacolo, come se in un campo da baseball mancasse il ricevitore: è inutile giocare, non si va a punto. Il tema centrale degli anni che stiamo per affrontare sarà la formazione di un pubblico interessato. Poiché mi sembra azzardato e poco conveniente chiedere una nuova classificazione di soggetti nelle normative regionali e statali (dovremmo invece cercare di semplificare), piuttosto che invocare il riconoscimento di nuovi “enti teatrali territoriali” bisognerebbe davvero avere la forza ed il coraggio di ri-pensare le diversità (dei grandi centri e dei territori periferici, dell’innovazione e della tradizione, del teatro pubblico e del teatro privato) e di riordinare la scala delle priorità (in primo piano i risultati nella promozione di nuovo pubblico e nuovi artisti, sullo sfondo i criteri economicistici e quantitativi che oggi impropriamente governano imprese ed istituzioni culturali).
A Brescia da ormai cinque anni si svolge la Festa internazionale del Circo Contemporaneo ideata e diretta da Gigi Cristoforetti e promossa dal Comune. Ciò che più colpisce è la straordinaria partecipazione di pubblico, dei tanti pubblici: dagli operatori che si chiedono ogni volta perché il nuovo circo resti fuori dalle programmazioni dei loro teatri (ma poi continuano a presentare i soliti spettacoli per il solito pubblico), al pubblico del teatro che finalmente ritrova stimoli ed emozioni così scarse nelle loro stagioni tradizionali, al nuovo pubblico che si diverte, si fa coinvolgere, si appassiona allo spettacolo dal vivo. Sarà la magia dello chapiteau, sicuramente spazio comune ed identitario per eccellenza, ovvero la apparente semplicità del linguaggio degli artisti del nuovo circo, ma l’applauso finale di tutti agli spettacoli a cui ho assistito era gioioso, liberatorio, soddisfatto dell’esperienza collettiva vissuta davanti all’acrobata Eric Lecomte con il suo 9.81, ai giovani danzatori-giocolieri de Le Parti Pris de choses o allo straordinario Anatomie Anomalie della compagnia Anomalie presentato al Teatro Sociale per i danni subiti dallo chapiteau grande a causa del nubifragio abbattutosi su Brescia la sera precedente.
Sabato 2 luglio si è svolto un incontro, il secondo, per la definizione di un progetto coraggioso ed ambizioso, Apripista 06, a cui hanno partecipato operatori di tutti Italia, (Roberto Ricco del Kismet di Bari, Alessandro Serena di Pantakin di Venezia, Silvano Sbarbati del Teatro delle Muse di Ancona, Dino Somagrossi del Festival di Dro, Umberto Angelini del Festival L’Uovo di Milano, Franco Ungano di Koreja di Lecce, Beno Mazzone del Teatro Libero di Palermo, Giulia Basel del Florian di Pescara, Antonio Geroni del Centro Documentazione Arti Circensi) insieme allo stesso Cristoforetti ed al direttore dell’ETI Marco Giorgetti, che ha ribadito il “nuovo corso” dell’ente per il coordinamento organico delle diversità dei territori e dei soggetti in un rinnovato (recuperato) spirito di servizio. Il progetto intende realizzare quattro mesi di tournée (autunno/inverno 2006/07) di uno spettacolo di nuovo circo affidato alla regia di un importante regista teatrale europeo, sollecitando Enti Locali, teatri e compagnie presenti sul territorio a sperimentare modelli trasversali di collaborazione. Ogni città ospiterà per minimo una settimana due chapiteau (uno grande - quattro antenne - ed uno più piccolo - due antenne) in cui saranno programmati lo spettacolo in tournée e diverse attività formative o performative di circo, di teatro, di danza, di musica, declinate secondo l’identità di ciascun luogo e dei partner coinvolti. Si cercherà così di rinnovare in altre città il successo “popolare” della Festa bresciana, colmando la distanza, che si sta aggravando, fra proposte di spettacolo e pubblico, recuperando il ritardo delle programmazioni teatrali italiane rispetto alla diffusione del circo contemporaneo e rinforzando o addirittura promuovendo reti di nuova distribuzione (i circuiti regionali resteranno a guardare?). Dalle dichiarazioni d’intenti bisognerà ora passare alla realizzazione concreta di accordi e convenzioni, calendari e budgets, programmi e promozione, cioè la fase in cui più difficile è mettere insieme i teatranti, ma la speranza è che la forza del progetto e l’entusiasmo dei promotori riesca finalmente a rinnovare i processi di distribuzione/programmazione del sistema teatrale italiano.

Compagnie Anomalie ANATOMIE ANOMALIE
Messa in scena e scenografia: Martin Zimmermann
Il Sud dei festival sta proponendo da qualche anno un appuntamento che sta crescendo per importanza e qualità delle proposte: il Festival internazionale di Andria Castel dei Mondi, legato ad uno dei luoghi più affascinanti e meravigliosi del mondo, il federiciano Castel del Monte, a pianta ottagonale con otto torri ottogonali. Questa edizione è stata l’ultima del triennio affidato alla direzione di Pamela Villoresi e Mimma Gallina, sviluppatosi sotto il titolo Geografie immaginarie tra “Europa e vecchi mondi” (2003), “Vie di fuga e mondi nuovi” (2004) fino a “Città ideale, città globale” (2005). Il bilancio non può che essere positivo, vista l’accresciuta visibilità del festival, l’interesse che ha conquistato fra gli operatori ed il crescente rapporto con il mondo della produzione teatrale pugliese. Credo sia questo il punto più delicato dello sviluppo futuro, poiché proprio uno spazio “franco” come quello di un festival – per definizione “concentrato” di tempi, di luoghi, di idee - può sperimentarsi il confronto fra le proposte di largo respiro internazionale e la capacità di un territorio di esprimere le proprie tensioni, le proprie capacità artistiche ed organizzative.
Quest’anno Castel dei Mondi è stato anche ribalta del teatro pugliese, ha promosso un bando per la produzione di un nuovo progetto teatrale presentato da giovani compagnie meridionali (vinto da Roberto Corradino con La commedia al sangue liberamente ispirato a Di questa vita menzognera di Giuseppe Montesano) e per la prima volta ha trovato la collaborazione del circuito regionale del Teatro Pubblico Pugliese. Ma il rischio del futuro per il teatro pugliese sta nella partecipazione al festival fine a sé stessa, se non riuscirà a far partire proprio dalle giornate andriesi un nuovo orgoglio (non localistico, né protezionistico) del lavoro culturale e teatrale. Da anni si richiamano i successi di pubblico e di critica degli spettacoli di alcune compagnie pugliesi e si iniziano a raccogliere i frutti istituzionali (più a livello nazionale che regionale, invero) di questa nuova visibilità; ciò che stenta a radicarsi ed a farsi normalità è il rapporto con la Regione e con gli Enti Locali, ma anche una nuova consapevolezza di sistema (potremmo dire di concorrenza solidale) fra le compagnie ed i teatri pugliesi. Castel dei Mondi potrebbe divenire laboratorio di attenzione per le relazioni fra istituzioni, enti ed operatori teatrali, favorire collaborazioni trasversali produttive e di programmazione. Peccato che non si sia riusciti ad organizzare un incontro delle compagnie pugliesi a conclusione del triennio del duo Villoresi-Gallina, perché ho l’impressione che motivi inconfessati abbiano impedito di cogliere un’importante occasione di confronto interno al sistema teatrale e fra questo e le Pubbliche Amministrazioni, sfruttando l’importante apertura della direzione del festival nei confronti del teatro pugliese. Se, come c’è da augurarsi, il Comune di Andria confermerà la stessa direzione artistica per un altro triennio, speriamo che si crei tra il festival ed il teatro pugliese un rapporto profondo, capace di lasciare il segno anche dopo le settimane estive all’ombra di Federico II.
Koreja ha presentato ad Andria Il pasto della tarantola, ormai quasi un cult, che attraverso postazioni in cuffia promuove la degustazione guidata di prodotti tipici della tradizione salentina accompagnata da interventi multimediali di due attrici. Nello scenario unico di Castel del Monte (peccato che per motivi logistico-ambientali non sia possibile avere il profilo del castello sullo sfondo, sarebbe davvero magico) Giovanni Sollima e l’Orchestra della Provincia di Bari (bell’esempio di collaborazione con le Amministrazioni e di sostegno agli organismi produttivi pugliesi) ha donato ai numerosi spettatori una serata di grandissima intensità musicale proponendo alcune fra le sue più belle composizioni (da Songs from the Divine Comedy al Federico II del Viaggio in Italia, a Spasimo). Ancora teatro pugliese con Accadueò del Teatro Minimo, una delle realtà più interessanti e significative del fermento che in questi ultimi anni ha segnato il panorama regionale: lo spettacolo segna un ulteriore importante passo in avanti nel lavoro d’attore di Michele Sinisi (che dovrebbe misurarsi presto con un grande testo) ed in quello di drammaturgo di Michele Santeramo. Il Kismet ha presentato in anteprima la drammaturgia di Mariano Dammacco (che cura anche la regia) da Alberto Savinio La nostra anima, che rivela le qualità d’attrice di Monica Contini, fuori dagli stereotipi del teatro ragazzi cui è sempre stata più o meno legata. Il lavoro di Dammacco, più nella riduzione drammaturgia che in una regia ancora un po’ ingombra di riferimenti non sempre giustificati, riesce in più momenti a restituire con intelligenza ed ironia il mondo visionario e variegato di Savinio.

Monica Contini
LA NOSTRA ANIMA testo e regia di Mariano Dammacco
L’ultimo festival frequentato è stato VolterraTeatro del Nuovo Mondo 05, dove non sono riuscito a vedere il lavoro di Armando Punzo, direttore artistico del festival, con la Compagnia della Fortezza (Appunti per un film), né la serata conclusiva (P. P. Pasolini ovvero Elogio al disimpegno). Volterra è il luogo “comune” dove operatori e pubblico si incontrano per verificare - i primi - e conoscere - i secondi - le idee nuove che percorrono i territori del teatro e quelli limitrofi, senza quasi soluzione di continuità, ma con attento interesse reciproco. Nelle due sole giornate trascorse a Volterra ho ritrovato quella vivacità di partecipazione e commistione di linguaggi che dovrebbero essere l’elemento irrinunciabile di ogni appuntamento che si proponesse di interrogare il presente e scrutare il futuro del teatro (lungi dalle beghe più o meno politiche, più o meno private che stanno svilendo la capacità di attrazione e la forza innovatrice di Santarcangelo dei Teatri, dove si spera si arrivi presto ad un azzeramento delle cariche e dei ruoli per il rilancio del festival). All’arrivo in città sono stato accolto dalla carica “eversiva” di Alessandro Benvenuti (lasciato qualche settimane prima a Castiglioncello nel ruolo del Padre nei Costruttori di imperi) con la Banda Improvvisa in uno concerto-spettacolo travolgente dal titolo Benvenuti… in banda!, ovvero come si prepara (sotto il cielo d’estate) con un attore che vuol essere cantante uno spettacolo di poesia e musica e una banda musicale che suona il mondo”. E il titolo è tutto vero, perché le stonature di Benvenuti nelle canzoni di Paolo Conte, di Francesco De Gregari, di Rino Gaetano, di Giorgio Gaber lasciano immaginare il mondo di tutti noi, dietro la nostra banda, alle prese con la nostra capacità di trasognare.

LA MANO di Luca Doninelli con Ermanna Montanari
regia di Marco Martinelli (foto di Enrico Fedrigoli)
Il Teatro delle Ariette ha riproposto nel Parco di San Pietro il progetto di Paola Berselli e Stefano Pasquini coprodotto con Santarcangelo 2004 L’estate. Fine, spettacolo che alterna momenti di festa popolare (il ballo e poi la abituale cena stavolta a base di riso, cipolle e salsicce) a grandi emozioni collettive (le domande del poeta friulano, lo straziante liscio solitario sulle note di Romagna mia, il desolante imboccamento del vecchio contadino costretto sulla sedia a rotelle). Al Teatro Persio Flacco il Teatro delle Albe ha presentato l’ultimo lavoro di Marco Martinelli, La mano. De profundis rock su testo di Luca Doninelli e la grandissima interpretazione di Ermanna Montanari. Bellissimo il disegno luci di Vincent Longuemare (gotico, per le sue continue variazioni di colori e di tagli e lo sfondo che muta rimandando ora alle cattedrali del nord ora alle discoteche più hard) sull’impianto scenico di Edoardo Sanchi e la regia del suono di Luigi Ceccarelli (calibratissima anche se un po’ a tratti ridondante). Lo spettacolo ruota intorno al diario di Isis, sorella e suora non accettata da nessun convento di uno dei più grandi chitarristi della storia del rock, quel Jerry Geramia Olsen che si troncò la mano sinistra con una scure per diventare più grande di sé stesso. E’ un lavoro collettivo, di continui sfalsamenti fra regia, suono e luci in cui la Montanari domina con la sua voce, a volte riuscendo ad oscurare tutto intorno a sé, lasciandoci in sua meravigliosa balìa.
La Generazione Scenario 2005 rappresenta il risultato di lunghe selezioni territoriali, di due tappe intermedie e della finale a Santarcargelo. La sensazione ricevuta vedendo a Volterra i due spettacoli segnalati ’O Mare di Taverna Est e DAMM Teatro di Napoli e soprattutto 11/10 in apnea di Teatro Sotterraneo di Firenze è di una edizione di passaggio, dopo le rivelazioni degli ultimi anni, che segna l’incertezza e la confusione nelle nuove generazioni teatrali, alla riconquista della parola ma senza riuscire a fare i conti fino in fondo con la drammaturgia e le tecniche d’attore e di regia da cui non si può prescindere quando si rappresenta un testo. Il lavoro dei giovani attori di Napoli, ma di nazionalità diverse, con una bella storia attraversata dalla vitalità della musica di strada ha sicuramente più forza e più teatralità dell’incerto e confuso lavoro fiorentino.Convince e sorprende per intensità e rigore il vincitore del Premio Scenario Il deficiente di Gianfranco Bernardi e Gaetano Coltella accompagnati in scena da due attori pugliesi fra i più interessanti degli ultimi anni, Angela Iurilli e Pietro Minniti. Lo spettacolo è capace, pur nella versione del frammento di venti minuti (come nel regolamento del premio), di suscitare emozioni e di confermare la necessità di fare teatro del Sud, di affidare al teatro le tensioni e le passioni della società mediterranea, crocevia di ogni tempo nel dialogo fra civiltà.
Ma di questo parleremo nell’incontro delle Buone Pratiche 2 sulla “Questione meridionale teatrale” a novembre.
P.S. Non ho visto ovviamente tutti gli spettacoli presentati a Napoli, Castiglioncello, Belluno, Brescia, Andria e Volterra e fra quelli che ho visto non ho ritenuto interessante citarne alcuni.
C'è chi si vuole impegnare e chi si accontenta di vedere il mondo dalla parte di Zelig
Resistenti di Roberta Biagiarelli a Festambiente 2005
di Anna Maria Monteverdi
Resistenti
Un racconto di Francesco Niccolini e Roberta Biagiarelli
con Roberta Biagirelli
consulenza storica: Franco Sprega
musiche di Andrea Soffientino
Luci: Giovanni Garbo
Festambiente è un appuntamento immancabile non solo per chi è ambientalista convinto; è un modo per conoscere realtà e associazioni in Italia che si occupano di tutto ciò che è salvaguardia e educazione ambientale, sviluppo sostenibile. Che passa anche attraverso l’informazione sul risparmio energetico, sui progetti sulla biodiversità, sulla bioagricoltura, su Chernobyl (il prossimo anno sono vent’anni dallo scoppio della centrale nucleare in Bielorussia), sui risultati di Goletta Verde. Appuntamento quest'anno a Rispescia vicino al Parco naturale della Maremma con la musica (Roy Paci, Lindo Ferretti, Elisa), con il cinema, con la letteratura e anche con il teatro grazie alla sezione “Clorofilla” che ha ospitato progetti aventi tematiche di impegno civile. Hanno partecipato Andrea Cosentino, Francesco Niccolini e Roberta Biagiarelli dell'associazione Babelia.
Roberta Biagiarelli ha presentato a Festambiente Resistenti, leva militare '926 dopo che lo spettacolo ha avuto alcune presentazioni (a Inequilibrio di Castiglioncello) ancora in forma di work in progress. Come sempre la Biagiarelli si lega a tematiche che affrontano capitoli irrisolti e drammatici della nostra storia contemporanea: il massacro di Srebrenica, lo scoppio della centrale nucleare di Chernobyl e le conseguenze devastanti per la popolazione e la natura e ora la memoria della seconda guerra mondiale; in questi anni ha viaggiato in Kossovo e nella Bosnia Erzegovnia; ha fatto più di 200 repliche di A come Srebrenica e ha portato lo spettacolo a Sarajevo e a Tuzla in lingua slava; dopo lo spettacolo mette in vendita le sopracalze di lana, comode e caldissime fatte dalle vedove musulmane di Srebrenica a cui va il ricavato. Altre volte sono i cachet degli spettacoli a essere devoluti a progetti sanitari importanti come il mantenimento di un ambulatorio pediatrico gratuito attivato dall'Associazione Macondo 3.
Il teatro di Fiorenzuola diretto con grinta e determinazione dalla giovane Paola Pedrazzini le ha commissionato quest'anno uno spettacolo sulla Resistenza partigiana nei luoghi tra Parma, Piacenza e Fiorenzuola. Una commissione importante che ha significato per la Biagiarelli entrare nelle storie e nei luoghi di chi ormai ha più di ottantenni e che nel corso del sia pur breve tragitto per la definizione dello spettacolo, purtroppo l’ha lasciata. Roberta si è fatta affiancare dallo storico Franco Sprega che gli ha aperto un mondo: quello dello Stalin, della Pierina e del Molinari. Poi ha voluto che le loro storie fossero scritte da una penna pulita e essenziale come quella di Francesco Niccolini che ha fornito il quadro temporale e la cornice storica.
A Festambiente Resistenti è accolto nello spazio (non mi piace dire location) adeguato: l‘uliveto al calar della sera. Una staffetta partigiana vestita con un impermiabile bianco, fucile in mano, capelli raccolti e sguardo sospetto ci conduce con passo deciso tra i campi dove seduti su panche di legno, ascoltiamo quello che ha a dire la Roberta che ci dice che ha avuto bisogno del Franco ma poi dopo un po’ diventa l’Eligio che fu risparmiato ma gli hanno ammazzato il padre quando lo hanno liberato, e dopo anche la Pierina, che aveva una bella bicicletta e delle belle gambe. Roberta li ha conosciuti tutti quelli di cui parla: la Pierina (“Stella”) oggi vive sola in una casa popolare, una stanza, fa ottant’anni l’8 settembre e si accende una sigaretta con il mozzicone dell’altra. Ha la voce roca proprio come fa la Roberta nello spettacolo e quando le hanno portato a casa sua la foto che la ritraeva diciassettenne con i capelli alla Ava Gardner fiera accanto alla sua bicicletta, ha detto: “Ma son me? Son proprio me!” Pierina non lo sapeva che era entrata nella Storia. Quella Storia fatta da chi ha liberato l’Italia: dall'anarchico Ezio Franchi reduce dalla guerra di Spagna, da Don Giovanni Bruschi, dal “Gioia”, dallo “Stalin” che più comunista di così si muore. Dunque anche da lei che portava ai partigiani cibo e armi pedalando per 100 km e una volta l'hanno anche messa dentro. Gente passata allla Resistenza per convinzione o per caso. Disertori dell’esercito classe '25 e '26 che anziché andare a combattere per la Repubblica di Salò sono andati tra le montagne. Lo spettacolo racconta del partigiano Giovanni Molinari (il Piccoli), comunistaccio che imbrattava la faccia del Duce sui manifesti in Piazza e aveva fondato col fratello la prima colonna partigiana là sull’Appennino tra la Liguria e l’Emilia. Colonna comunista. Ma qualcuno ne stava mettendo in piedi un'altra, il sardo cattolico Fausto Cossu. Sono i partigiani bianchi. E per non lasciare dubbi su chi bisognava seguire, aveva ucciso proprio il Molinari. Ancora adesso la prima domenica di settembre il paese ricorda in Piazza il Molinari ucciso né da fascisti italiani né da fascisti tedeschi ma da italiani partigiani. Figure di giovani e giovanissimi, uomini e donne ritratti a tutto tondo, con le loro inflessioni, i loro tic, le loro esclamazioni in dialetto, le paure dopo aver aderito alla Resistenza non senza esitazioni. “M’è bela capì?” dice lo Stalin.
Lo spettacolo cerca di far stare queste storie di uomini non illustri -come avrebbe detto Pontiggia- dentro tutta la Storia del Ventennio, dell'Italia in guerra, in un equilibrio drammaticamente instabile tra fratellanze e diserzioni, rastrellamenti, eccidi, torture e grandi atti di eroismo. Per il sogno della libertà.
Quale è stata la metodologia che avete usato per raccogliere e poi raccontare queste storie?
Ci siamo basati sull'oralità, sui racconti di chi è stato testimone. Gente che sta scomparendo, persone io dico, che sono ormai di “cartavelina”, trasparenti, uomini e donne che faticano molto a ricordarsi le date ma si prendono tutto il tempo, e poi te le dicono esatte. Entrare in contatto con loro, avere la loro fiducia è stato fondamentale. Ci vuole fiducia per consegnare a qualcuno la propria memoria; quindi abbiamo fatto un percorso di avvicinamento e poi dalla Storia siamo passati alla drammaturgia. Alla “parola per essere detta”. Dalla storia delle persone qualsiasi a una memoria sentita come qualcosa da comunicare per la collettività.
I luoghi del racconto non sono però “i vostri luoghi”.
Un profondo senso del dovere permea il progetto: quel territorio che decidi di raccontare lo devi conoscere bene, devi percorrere le valli, i luoghi storici. Devi prendere confidenza con la sua geografia e il suo parlato. Raccontiamo di questo ventaglio di valli tra Pama a Stradella fino a Fiorenzuola. Abbiamo fatto anche ricerche all’Anpi di Piacenza, abbiamo visto le foto, abbiamo ascoltato le testimonianze, la voce diretta di chi è stato testimone e che presto non ci sarà più. Il sentimento comune che passa attraverso l’umanità che ho incontrato è che loro hanno dato tutto, è stata dura ma è stato anche bello; poi sono tornati alle loro vite, alle loro case e si sono sentiti traditi da chi poi ha fatto la politica, si sono sentiti manipolati. I sopravvissuti ti ricordano gli amici perduti e il rispetto che dobbiamo avere verso i caduti.
Rispetto a "A come Srebrenica" che tipo di esperienza è stata?
Un'esperienza bella, strana; in queste tragedie che mi è capitato di affrontate da Srebrenica a Chernobyl, capisci che le vittime che periscono, cadono per darci una prospettiva, un domani, un progetto, hanno un dolore che è comune, come dire, che è simile in tutti. Nelle storie dei partigiani ho trovato i racconti della Aleksevic, dei profughi; questo dolore comune, c’è la tragedia comune e la resistenza che è la speranza. Il mio lavoro poi guarda all’umanità, vai a sondare dei territori che per riflesso, rimbalzo, fanno da compendio l’uno con l'altro, rileggi diversamente il tuo lavoro di ieri alla luce di quello che scopri oggi. Un giorno ascoltando un partigiano mi sembrava di sentire un profugo di dieci anni fa in Bosnia.
Parlami di questo tuo impegno oltre il teatro.
Franco Sprega che è uno storico dunque esterno al teatro, scevro, completamente avulso dal mondo teatrale, alla fine della prima dello spettacolo a Carpaneto al momento del dibattito ha detto: “La Roberta ha fatto una cosa bella, è venuta con me da loro, e poi è andata a trovarli anche dopo, si è ricordata di loro, ha telefonato a tutti, ha costruito con loro un rapporto; se questo è il teatro allora è interessante”. Per me questo deve essere il valore del teatro. Finito il lavoro ti deve rimanere qualcosa. Tu fai sacrifici, ascolti storie drammatiche ma poi devi andare avanti, oltre, non c'è solo lo spettacolo, non puoi fermarti, devi fare uno scambio. Uno scambio che è necessario io dico, per non morire. In effetti io mi appassiono, torno là sui luoghi di questi drammi, e loro i bosniaci, mi vengono a trovare nelle Marche; si aspettano da te delle cose, ti vivono come un tramite e non puoi tradirli..
La Storia di Resistenti è quella di un mondo che ancora c’è bisogno di raccontare. Non si tratta di fare memoria. Questa è una moda, non mi interessa, tutti possono farlo perché è politicamente corretto. Io voglio fare un teatro dove mi pongo come narratrice: racconto queste storie vere ma attraverso una finzione che è quella del teatro. L’attore da solo in scena che parla non mi interessa, bisogna restituire al teatro il suo naturale artificio.
Dopo Srebrenica un viaggio per il decennale per girare un documentario
Abbiamo partecipato alle commemorazioni, alcuni di noi hanno preso parte alla marcia di vari giorni da Tuzla a Srebrenica, facendo il percorso inverso dei musulmani che scappavano dall'eccidio
Il documentario parte dal testo di Srebrenica per arrivare al decennale del massacro e dare maggiore fruibilità allo spettacolo. E' come il teatro può diventare altro, diventare film appunto, Luca Rastrello è venuto con noi a Potociari dove c'è il memoriale, allestito nel luogo dove sono sepolti dei musulmani riesumati dalle fosse comuni, siamo andati al campo sportivo dove c’era il campo di concentramento, alla sede dei soldati dell’Onu, luogo emblematico perché ci sono ancora tracce dei passaggi dei Caschi blu che hanno avuto responsabilità nel massacro: loro sono stati lì con obbligo di non intervenire. Ci sono oscenità disegnate sui muri, attacchi orrendi e violenti scritti contro la popolazione. Questa struttura diventerà un museo di tutti i caduti di Srebrenica. Abbiamo scelto delle aree, della fabbriche, dei luoghi all'aperto e abbiamo ambientato là dei pezzi dello spettacolo come fosse un film. Una fiction del teatro. Questo costituisce la parte narrativa dello spettacolo; abbiamo poi aggiunto interviste a gente in quel pezzo della Bosnia Erzegovnia. Il titolo dovrebbe essere Srebrenica: dieci anni dopo oppure Voci dall’oblio.
Abbiamo raccontato la storia di qualcuno che è tornato, come Dule, un ristoratore che ha aperto un albergo e ristorante, quella dell’allenatore di calcio e dell’imam di Srebrenica; abbiamo raccontato cosa accade in città, una mostra d’arte, quel minimo di cose che ripartono con molta difficoltà di vita quotidiana: ogni organizzazione non governativa qua inizia progetti ma le condizioni sono difficili e spesso rinunciano. Una cosa che colpisce è che i giovani non ci sono quasi più.
Questi progetti teatrali di Babelia occupano spesso posti insoliti, Festival della letteratura, sedi di Associazioni o ambiti comunque poco frequentati dagli addetti ai lavori teatrali. E' questa la vostra fortuna, uscire dal circuito ormai semideserto della ricerca vera e propria?
I luoghi di cui tu parli possono dare una misura alla gente di come uno spettacolo può fare da catalizzatore di un pubblico trasversale, diverso; se il pubblico teatrale non esiste più, allora bisogna creare un altro pubblico. Un pubblico che potenzialmente c’è; la gente ha casomai un preconcetto rispetto al teatro: spesso si sente inadeguato; ma è l’argomento che muove la gente, è il tema. Nell’associazionismo il pubblico esiste ed è numeroso, va solo ricomposto. Il teatro che c'è intorno certamente non aiuta, è fatto come un ipermercato per cui nel tuo piccolo cerchi di fare una politica di tutt'altro genere. A volte bisogna sgusciare fuori per sopravvivere. A come Srebrenica ci ha aperto un mondo di associazionismo trasversale legato ai Balcani che non conoscevo: Casa per la pace, Le donne in nero, Macondo 3. Trasversale, ma molto frequentato.
Del resto, c'è chi si vuole impegnare o chi vuole vedere il mondo dalla parte di Zelig.
La prigione dell'autore in crisi
Una intervista ad Armando Punzo su Appunti per un film
di Andrea Lanini
Come può un autore raccontare il mondo reale? Che strategie si possono ancora sperimentare per parlare di ciò che i nostri sensi ci fanno provare, venendo a contatto con la vita? Esiste il modo di farlo evitando di ripetere ciò che già è stato detto e tentato? Armando Punzo dice che quando un autore comincia a farsi queste domande di frequente, significa che i suoi piedi iniziano a camminare su un territorio pericoloso, al limite dell’afasia, o della pagina bianca.
Evidentemente, in questo caso può cominciare una crisi: crisi creativa, ma anche impasse che nasce dallo smarrimento della propria coscienza di artista, della percezione del proprio ruolo o della propria utilità. Che cosa succede, in questo caso? Come indagare questi territori misteriosi, confinanti da un lato con la chiara consapevolezza del proprio stallo creativo e dall’altro con un bisogno di raccontare, di fare partecipi gli altri che non cessa di essere irrinunciabile, irrimediabilmente urgente?

Appunti per un film, l’ultima produzione della Compagnia della Fortezza (lo spettacolo – evento clou di Volterrateatro 2005 - è stato presentato dal 25 al 28 luglio al Carcere di Volterra), è un viaggio all’interno di questi territori, un sentiero che si dipana inseguendo i pensieri di un Autore che sta lavorando alla sceneggiatura del suo prossimo film, e nelle cui idee tutto finisce per galleggiare: il pubblico della Fortezza e i detenuti-attori, gli oggetti teatrali che danno vita a questo camaleontico gioco di scatole cinesi e lo stesso Punzo, portavoce ed ennesima emanazione della fantasia di un Autore-demiurgo attorno al quale chiunque entri in contatto con lo spettacolo finisce per orbitare, diventando – consapevolmente o meno – una parte di un meccanismo dai contorni sfuggenti e necessariamente non delimitabili, così come impossibile da circoscrivere è il pensiero di chi tutto questo immagina.
Si può dire che in questo spettacolo niente è reale e nulla è, in sostanza, ciò che dovrebbe essere: tutto è in preda a una sorta di liturgia dissacrante che pare obbedire a un principio pirandelliano di sdoppiamento esponenziale dell’io (non a caso Luigi Pirandello diventa una delle incarnazioni del pensiero dell’Autore, finendo inevitabilmente, come Don Chisciotte, per materializzarsi tra il pubblico), di sovrapposizione di coscienze infinitamente diverse che, in nome della propria alterità, finiscono per riconoscersi e conciliarsi: il flusso della vita vera si stempera sempre in quello di una vita immaginata dall’esterno, guidata da un burattinaio invisibile i cui intimi tentativi creativi animano ciò che ci appare visibile. In questo spettacolo non esiste un pubblico: anche gli spettatori che entrano nel carcere, che assistono ai richiami delle sensazioni pittoriche ricreate nel cortile per l’ora d’aria, alle suggestioni provenienti da Fellini e Truffaut, ai “colpi di Realtà” che i detenuti-attori mettono in scena, fanno parte di un piano; esistono in quanto pensati, e sono lì per dare vita a un’idea di pubblico, a un pubblico probabile che non può e non deve mancare. Eppure, tra le ombre di quella che sembra essere diventata una sorta di caverna platonica, dove tutti, alternativamente, recitano sia la parte di chi sta all’interno sia di chi sta al di là del muro, si riconoscono dettagli chiari dell’autobiografia della Compagnia della Fortezza, della sua vera storia. Come può non essere vera la ricostruzione del viaggio del terrore compiuto dagli scafisti in gommone, o la claustrofobica scena della rivolta dei detenuti, vissuta dal pubblico-comparsa attraverso un inedito e toccante punto di vista posto all’interno delle celle? Quelle voci, quelle grida sanno di vita scorsa davvero sulla pelle di chi la mette in scena. Certo, in parte si tratta di verità vera: ma basta davvero far raccontare a qualcuno una parte della sua vita per raccontare la vita? Si può dire che sia un tentativo, una strada che l’Autore prova a imboccare: ma basta questo? Non ci sono risposte, ma solo serie di tentativi: tutto fa parte di un piano del quale si raccolgono (con riprese vere, con vere telecamere, contraltare mediatico della finta troupe che nel pensiero dell’Autore deve catturare gli spunti per la sua sceneggiatura) tracce, sfumature, ipotesi.
Forse per racchiudere la realtà in una sceneggiatura bisogna fare così: dipingere colpi di realtà che possano dar vita ad un immenso affresco che racconti tutto, che spieghi tutto. E’stato questo il sogno-utopia di tanti autori che – come dice Armando Punzo – con la loro opera hanno voluto “acciuffare il reale”, imprigionandolo in architetture immense: le pagine di Proust, i progetti mai realizzati di Pasolini inseguono questa chimerica tensione; nello spettacolo vive anche parte del loro spirito, di quella utopia letteraria.
In Appunti per un film, work in progress che sembra divertirsi a nascondere tra le sue ramificazioni la propria spinta evolutiva e che, teoricamente, potrebbe anche essere “in progress” per sempre ed essere destinato dal suo Autore a rimanere eternamente aperto, come una dissonanza che non troverà mai una sua risoluzione, l’aspetto frammentario e segmentato della struttura partecipa di questo tipo di ricerca. I vari brandelli di realtà catturati da questo ingranaggio che sembra creato per non avere controllo sono specchi deformanti che potrebbero essere la cosa più vicina al vero ma anche quella più lontana.
Seguendo i flussi di coscienza dell’Autore, si assiste a una metamorfosi inquieta delle sue visioni, delle sue percezioni di una possibile narrazione: se il mondo non può essere raccontato da un autore attraverso squarci di verità, forse è perché, in fondo, non esiste alcun autore. Esiste solo la vita che deve essere vissuta, o il mondo che va avanti anche se nessuno lo pensa. L’Autore riflette allora sul proprio annientamento, e immagina la sua morte: noi, pubblico-comparsa che ha il privilegio di essere spettatore dei suoi pensieri, vediamo il suo funerale, e prendiamo parte al corteo funebre che riprende, in tonalità minore, il passaggio onirico dai toni chiaroscurali che apre la rappresentazione. Può finire tutto così? La vera soluzione è la scomparsa di chi, per un momento, sembrava avere regole da dettare? Forse.

Il balletto di Don Chisciotte, il suo muoversi come strattonato da un inesperto e nervoso burattinaio, sembra voler ricordare che in questo gioco regna l’indecisione: la sua danza caricaturale manifesta una perdita di ruolo, una mancanza di collocazione all’interno di una struttura in cui tutto deve essere al suo posto. L’Autore non sa pensare il destino di Don Chisciotte esattamente come non sa sistemare se stesso e le sue idee. E forse l’insegnamento di questa tormentata ricerca è proprio nella consapevolezza dell’inutilità della ricerca stessa: capire che la cosa più saggia è lasciare che “alla fine, tutto finisca in ballo”, cercare di seguire la melodia anziché tentare di comporla. Vivere, insomma. Magari arriverà un tempo in cui tutte le sensazioni e le immagini, i tentativi e i frammenti raccolti avranno una loro definitiva collocazione (Armando Punzo, per scaramanzia, preferisce non fissare date precise: dice semplicemente “tra qualche anno, forse tre”) in un vero film. Solo allora ci sarà un vero pubblico che assisterà al racconto iniziato questa estate a Volterra.

Appunti per un film è pensato come emanazione del pensiero di un Autore che non vedremo mai, e che siamo destinati a conoscere solo attraverso il suo lavoro, la sua sceneggiatura: ma quanto ti assomiglia, quanto di te c’è in lui?
In lui c’è parte della mia biografia, ma non sono io. E questo non perché io non possa essere un autore in crisi, ma perché drammaturgicamente sarebbe poco interessante. Il fatto che, durante lo spettacolo, cominciamo a interrogare il pubblico serve anche ad allontanare l’idea che l’Autore sia io: mi è sembrato molto più interessante prendere delle persone dal pubblico e chiedere loro di interpretare la sua parte, per vedere che cosa sarebbe successo. Tutto quello che abbiamo fatto in Appunti per un film è stato un raccogliere materiale che ci servirà ad andare avanti in questa sceneggiatura. Fondamentalmente abbiamo continuato a lavorare anche durante le varie repliche: ad un certo punto del lavoro era necessaria la presenza del pubblico; bisognava immaginare che ci fosse un pubblico grazie ad un tot di comparse incaricate di recitare la parte degli spettatori, per un lavoro che viene scritto in quel momento, e soprattutto pensato da un Autore in quel momento. Un Autore che non sono io, anche se abbiamo dei tratti in comune: si immagina che lui faccia anche un percorso dentro di sé, per capire le sue origini e da dove viene il fatto che nella sua vita abbia deciso di fare l’artista. Per questo aspetto ho fatto intervenire la mia autobiografia, ed è in quest’ottica che si spiega la partecipazione di mia madre: la scena di cui lei è protagonista è un lavoro su un addio, su un distacco di un ragazzo dalla propria famiglia. In questa scena lei interpreta se stessa, e la situazione riflette – anche se non nei particolari – un momento della mia vita.
Raramente la struttura carceraria è entrata all’interno dei vostri spettacoli come in quest’ultimo: una delle soluzioni pensate dall’Autore porta il pubblico all’interno delle celle, a contatto con una situazione emotivamente molto toccante. Parlaci di questa scelta…
E’vero, negli spettacoli precedenti il carcere è sempre stato tenuto fuori dal nostro lavoro. Nell’inizio di Marat Sade, la produzione del ’93, c’era qualcosa di simile, ma si tratta di due situazioni molto diverse. E’importante sottolineare che la scena nelle celle non è servita per far vedere il carcere, ma per raccontare una possibile storia. Quella rivolta è uno dei tentativi fatti dall’Autore: bisogna immaginare la situazione in cui c’è un autore che cerca di raccontare la realtà, di mostrare qualcosa di vero, di definitivo. Potrebbe pensare di fare un viaggio in India, o nei Quartieri Spagnoli a Napoli: in quel caso il pubblico non avrebbe visto alcun carcere. Avrebbe potuto scegliere di andare in un carcere brasiliano – un posto dove le carceri sono veramente l’inferno dell’inferno –, per cercare di raccontare la realtà. E’in quest’ottica che va vista la parte di spettacolo in cui il Carcere ha un ruolo importante. Fino ad oggi lo avevamo nascosto, lasciato da parte: negli spettacoli precedenti non mi interessava mostrarlo. Questa volta compare semplicemente perché attraverso di lui si attua una delle possibilità che l’Autore tenta per portare avanti il suo progetto.
Lo spettacolo è ricco di momenti che appartengono alla storia della Compagnia della Fortezza, di citazioni del vostro vissuto: si ha l’impressione che uno dei fattori determinanti di Appunti per un film sia il desiderio di fissare un momento, di tracciare una sorta di “bilancio emotivo” della vostra stessa memoria…
Per lo spettacolo abbiamo usato molto la nostra autobiografia, la nostra storia privata, la mia e quella di tutto il gruppo. L’abbiamo fatto per trovare una partenza per scrivere. Quando tu scrivi un libro, un film, da cosa puoi partire? Parti sempre da te stesso. Noi stiamo lavorando su di noi: nello spettacolo c’è molto materiale che viene da noi, per poi staccarsi e diventare materiale per raccontare il mondo, materiale a disposizione di altri. L’episodio del gommone, i problemi con gli attrezzisti o con la costumista, provengono dalla nostra realtà quotidiana.
L’episodio degli scafisti col gommone è un altro momento molto toccante, in cui la rappresentazione entra potentemente in simbiosi con il vissuto dei detenuti-attori. Ad un tratto però arriva l’apertura inaspettata verso una soluzione ironica della scena: avete anche giocato, con la vostra biografia…
Sì, in certi casi abbiamo giocato con questi particolari biografici. Quando uno degli scafisti dice di essere arrivato in Italia in aereo, in realtà, e non in gommone, crea uno sfasamento comico. Ci sono sempre tanti livelli nello spettacolo proprio perché la realtà non è poi così semplice. Le persone vogliono sempre essere rassicurate, e si rassicurano pensando che ciò che vedono corrisponde in tutto a ciò che è successo. Ma la realtà, invece, è difficilmente rassicurante. La situazione del gommone è vera: è vera per molti di loro, per molti altri, ed è vera tutti i giorni in tv, nella vita reale. Il problema del nostro Autore è proprio questo: come fare a raccontare la realtà? E’possibile? O magari è possibile solo raccontare un piccolo frammento per poi perdersi di fronte alla vita intera? Lui sta vivendo questa situazione. Questi che abbiamo raccontato sono “blocchi di realtà”, infatti li abbiamo chiamati “Realismo 1”, “Realismo 2” ecc. Anche il momento in cui il pubblico viene portato in quella che presto si trasforma in una sorta di arena riflette una cosa vera, e cioè il momento in cui ci trovavamo per discutere (parlo di 5-6 mesi fa) su come avremmo messo in piedi lo spettacolo. Discutevamo tra di noi. Ci sono state discussioni vere sull’America e sul mondo islamico, confronti anche molto accesi. La molla che muoveva quelle discussioni è la stessa che abbiamo proposto nell’arena, ed è anche la stessa che si trova nella vita reale. Il timore che la gente aveva al momento di dover esprimere la propria opinione è quello stesso timore che fa sì che spesso stiamo zitti nella vita reale. A me sembra una sorta di mancanza di abitudine a confrontarsi, a scambiare idee. Se ci pensi, è una cosa terribile, che non aiuta. Credo che la difficoltà che si crea in quel confronto teatrale rifletta molto da vicino ciò che succede fuori. Questo Autore si è immaginato che anche la strada dei talk-show è percorribile, quella dove si decide di mettersi di fronte e di parlare: perché non è detto che i talk-show siano per forza quelli televisivi; quelli sono una deformazione, una degenerazione che rende manipolata e calcolata quella che resta una possibilità importante dell’essere umano, quella cioè di mettersi insieme e parlare per cercare di capire qualcosa. La scena dell’arena, in questo senso, vuole essere anche una parodia e una critica nei confronti di quella degenerazione.
L’impasse che si crea all’interno dell’arena viene vissuto dal pubblico in maniera molto forte: i vari livelli del gioco messo in piedi dall’Autore sembrano scatenare un cortocircuito dal quale sembra difficile uscire. Sembra che lo stallo e l’inquetudine che emergono tra il pubblico divengano non solo paradigma ed emanazione della crisi dell’Autore, ma anche del teatro, dell’uomo, del mondo… Fino a che punto si tratta di un impasse voluto, di un effetto controllato?
L’impasse c’è sempre stata, ma non si tratta di qualcosa di cercato, di teatrale: potrebbe anche non esserci. Fin dall’inizio eravamo consapevoli che molto probabilmente si sarebbe potuta verificare una situazione difficile: si è trattato di un rischio preventivato ma assolutamente interessante da provare. E’vero che poi, oltre al livello della parodia della tv, c’è anche un parallelismo tra la crisi del pubblico e quella dell’Autore: ma quella del pubblico, per l’Autore, è solo una messa in scena… l’unico ad essere veramente in crisi è lui.
Nel paradiso delle marionette
Il festival “Marionette e burattini nelle Valli del Natisone”
di Fernando Marchiori
A parlarne si ha quasi timore di rompere l’incantesimo, ma non si può fare a meno di segnalare la magia di un festival che ogni estate trasforma un lembo estremo del Friuli ai confini con la Slovenia in un palcoscenico naturale dove burattini e marionette, sagome e ombre fanno incontrare i pochi abitanti di paesini abbarbicati alle rocce o distesi su imprevisti pianori con un pubblico di infaticabili appassionati del teatro di figura, di escursionisti solitari e soprattutto di bambini e famiglie.

Dal 1994, prima come settore “Marionette” del “Mittelfest” poi in forma autonoma, il festival “Marionette e burattini nelle Valli del Natisone” sparpaglia le sue proposte internazionali (oltre che dall’Italia gli artisti provengono soprattutto da Slovenia, Croazia, Austria e dai Paesi dell’Europa centrale e orientale) in fienili, piazzette, sagrati, sotto una pergola o dentro una legnaia. Qualche panca, le sedie portate fuori dalle case e la sorpresa degli spettatori che salgono anche con la pioggia, che non mancano un appuntamento, che ritornano anno dopo anno.
Si arriva inerpicandosi per stradine nei boschi, lungo il fiume, attraversando minuscoli borghi silenziosi nel verde, fermi in un tempo altro che il teatro ha saputo riconoscere e rispettare. È la Slavia italiana, manciate di case intorno a campanili che sbucano tra il verde folto, “le felci come un viso che si impara dietro il muro del paese”, ha scritto il poeta di Nimis Mario Benedetti (Umana gloria, Mondadori 2004). I suggestivi toponimi hanno suggerito a Carlo Podrecca – linguista e padre del grande Vittorio, nato in queste valli – fantasiose escursioni etimologiche e negli accostamenti sonori di Alfonso Cipolla, curatore del bel volume Marionette Burattini nelle Valli del Natisone – Oltre i confini di un festival (pubblicato dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia) “diventano quasi una formula arcaica per varcare una soglia aperta sull’immaginazione”:
Merso, Mersino, Biacis, Postregna,
Pulfero, Drenchia, Savogna, Stregna,
Cras, Masarolis, Rodda, Crostù,
Oborza, Togliano, Terpenica, Dus.
Cialla, Clastra, Clenia, Cosizza,
Picig, Paciuch, Cepletischis, Podpolizza,
Plataz, Podlach, Picon, Postacco,
Tribil, Zamir, Seuza, Grimacco.

Questi luoghi, e altri dispersi anche oltre confine, non solo hanno accolto con favore gli insoliti pellegrinaggi al seguito di fantocci e teste di legno, offrendo ospitalità a un festival itinerante che ha nella discrezione il suo carattere migliore, ma si sono decisamente appropriati della manifestazione fin dalle sue prime edizioni, come racconta il direttore Roberto Piaggio. L’erba appena tagliata sul prato o il pane e salame offerto alla fine di uno spettacolo sono per i paesi delle valli un modo per vivere il festival da protagonisti, “per mettere in mostra se stessi col pretesto dei burattini”, scrive Cipolla. La complicità tra residenti, artisti e spettatori consente di risolvere problemi tecnici e imprevisti meteorologici. Ricordano gli organizzatori che a Pulfero una volta, sotto un improvviso temporale, pubblico e compagnia trovarono rifugio in un ristorante e lo spettacolo andò in scena nella sala da pranzo, spostando tavoli e clienti. Un’altra volta a Topolò si fece uno spettacolo dentro una stanza al pianterreno con gli spettatori che guardavano dalle finestre con gli ombrelli aperti.
Radicamento e vocazione transfrontaliera, informalità e competenza non si escludono dunque in questa realtà unica nel panorama dei festival teatrali, dove l’ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito (quest’anno erano ben 42) e il premio all’opera migliore (la Marionetta d’oro) viene assegnato secondo il giudizio espresso dal pubblico, oltre che da una commissione di esperti.

Paolo Papparotto con La casa stregata è il vincitore dell’edizione 2005. Il burattinaio di Treviso ha messo in scena a Stregna un’ulteriore versione della favola veneta nota come Giovannin senza paura (o Butta butta). Pantalone speculatore immobiliare ha comprato a prezzo stracciato una casa stregata. A combattere i fantasmi manda però Arlecchino e Brighella, pronti all’avventura in cambio di un pollastro. Papparotto prosegue dunque il suo lavoro di recupero al linguaggio burattinesco della grande tradizione delle maschere veneziane, con le quali ha già affrontato Goldoni, Gozzi, Ruzante. Ma nelle Valli del Natisone è tornata quest’anno anche la tradizione toscana con La storia di Baccellino della compagnia Pupi di Stac e quella napoletana con le guarattelle di Michele Roscica (Le farse di Pulcinella); sono passate le teste di legno di Michele Polo (Dighe de sì, testo e regia di Gigio Brunello) e la bella storia di Jacopo e i pirati mammalucchi messa in scena da Ortoteatro di Pordenone; dalla Slovenia sono arrivati Carta sasso forbici della compagnia Papilu Gledalisce e La casa della tartaruga Morgan del Teatro Matita; dalla Croazia l’Accademia di Osijek con Il pupazzo-uomo o l’uomo-pupazzo.
Forse l’appuntamento più suggestivo si è rivelato però quello articolato in quattro tempi, per quattro pomeriggi, dentro la grotta affrescata di San Giovanni d’Antro. In macchina fino al paesino omonimo, poi a piedi lungo una mulattiera, infine la salita di un centinaio di gradini nella roccia che portano all’eremo. Qui un pubblico attentissimo ha seguito La storia di Guerrino detto il Meschino che Giovanni Moretti ha raccontato utilizzando vecchi copioni ottocenteschi e del primo Novecento, alcuni anche materialmente sfogliati in scena, e muovendosi tra le marionette e i burattini storici per i quali quei copioni furono scritti. Conservati nell’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare di Torino, i fantocci sono stati rianimati insieme ai fondali originali. In alcuni casi si trattava di materiali appartenuti alle stesse compagnie proprietarie dei copioni (Aimino, Cuccoli, Lupi). Naturalmente non siamo di fronte a un’operazione archeologica. Moretti è cultore da quasi mezzo secolo di una materia che nelle sue mani e nella sua voce diventa commossa presenza di un mondo perduto e sempre ritrovato. Solo a soffiarne via la polvere, queste marionette regalano bagliori di passioni eterne, frammenti di storie entrate nel canone occidentale. Ma la polvere torna a posarsi sul Meschino e sul bel volto di Alcina, come sul Tannhäuser di Wagner che esce gracchiando dal grammofono. Non era il mondo cavalleresco che stavamo guardando, ma l’immagine di esso che l’Ottocento ci ha lasciato. Non era uno spettacolo di burattini e marionette, ma l’evocazione di un modo di concepire il teatro e il gesto di trasmetterne la memoria. “È successo proprio così, vero? È tutto giusto?”, chiede Moretti alla bambina in prima fila che ha seguito tutte le puntate e conosce il Meschino per averlo incontrato in un suo libretto colorato. “Sì, è proprio così”, risponde la piccola spettatrice.
Il corpo all'attacco
Dalla Biennale Danza 2005
di Fernando Marchiori
Più che nelle due precedenti edizioni, dirette rispettivamente da Frédéric Flamand e da Karole Armitage, la Biennale Danza ha trovato nel tema scelto quest’anno da Ismael Ivo – Body attack – un filo conduttore e un motivo di riflessione che, aldilà della discontinuità degli esiti spettacolari, ha spostato il fulcro del giovane festival veneziano dalla ricerca autoreferenziale e dai pretesi universalismi (Abcd, la grammatica universale del corpo, era il titolo l’anno scorso) a un confronto con questioni all’altezza di un presente che non lascia indifferente neanche la danza. Corpo attaccato, che attaccca, che è parte in gioco. In tempi in cui i corpi si fanno saltare in aria, vengono venduti e violati, clonati, dematerializzati nei monitor, essi non smettono di “pensare”, sentire, reagire, ricordare.
Ecco allora danzatori e coreografi interrogarsi, verificando a un tempo la tenuta formale e la precisione semantica del loro linguaggio, sulle possibilità di espressione nel corpo scenico di questa intelligenza differente. Per esempio cogliendo i frammenti di vita di sei performer iraniane chiuse per tutto lo spettacolo dentro delle tende, come accade in Letters from Tentland.

Sono le piccole tende che in Iran si trovano ovunque, ai bordi delle strade, sulle spiagge, nelle città: abitazioni, riparo per il tempo libero, separè per le donne – tenda, per estensione, indica in alcuni paesi musulmani la donna col burqa. È l’idea della coreografa berlinese Helena Walden, che quelle tende ha fatto girare e saltare in scena, trasformandole in pupazzi, in foglie portate dal vento, in buste di lettere che non riusciremo a leggere. A meno di non raggiungere sul palco le sei ragazze alla fine dello spettacolo per prendere insieme un tè e vedere come si vive dentro il mondo a parte di Tentland (nome che sostituisce Teheran, per evitare la censura). Sono state invitate a farlo solo le donne tra il pubblico. E in centinaia, rispondendo all’appello, hanno iniziato quello scambio vero, quel contatto diretto che era senz’altro l’obiettivo dello spettacolo.
Più duro il lavoro di Ismael Ivo, che ha composto la sua coreografia su Eréndira di Gabriel García Marquez, storia di una ragazza costretta dalla nonna a prostituirsi. Con un gruppo di danzatori eterogeneo per formazione e per capacità, ma ugualmente coeso dal fitto disegno registico, e un’attrice brasiliana dalla presenza possente (Cleide Eunice Queiroz), Ivo ha attualizzato la pièce, moltiplicando la figura della protagonista e facendone una delle tante persone che scompaiono nelle città del mondo, una ragazza venduta, resa schiava del lavoro, della droga, del sesso.

Spiega il coreografo che “il circo viaggiante del personaggio della nonna disegnato da García Marquez è la processione della Persona non grata, o il terzo mondo svantaggiato, pieno di debiti, con l’anima in vendita”. L’energia di giovani corpi si scarica in un bordello sudamericano fatto di tralicci e nicchie, di teche che lasciano vedere amplessi e disperazione. Di grande forza soprattutto le prove di Pan Sun Kim e di Pichet Klunchum. A effetto la scena dello stupro, con il corpo di Eréndira segnato col rossetto nella bocca e nelle mani del partner che le danza intorno in una convulsione di membra. A questi giovani artisti Ivo ha chiesto come sempre di danzare il personaggio e allo stesso tempo “di esercitare la libertà di avere un’opinione su di esso”. Per fare ciò, i danzatori hanno trascorso un periodo nei quartieri popolari di São Paulo, tra le baracche delle vere Eréndire di oggi. Se ne vede qualche frammento nelle immagini proiettate verso la fine dello spettacolo, che è una particolare declinazione di teatro danza (Ivo, che è stato riconfermato alla direzione della Biennale Danza, lavora da molto tempo in Germania). Si conferma, insomma, il marcato impegno politico del coreografo e danzatore brasiliano: contro il razzismo, l’oppressione, le ingiustizie sociali. E insieme l’apertura al grande tema antropologico dell’altro ma affrontato, ancora una volta con le risorse interpretative dell’esperienza diretta, che passa appunto attraverso il corpo. Traducendo in performance i concetti di antropofagia e di cannibalismo culturale (in voga a Säo Paulo a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta), Ivo ha sviluppato negli anni una figura base della sua danza, e un’idea attiva in molti suoi spettacoli: “Mangiare le parole e trasformale in movimento”, come spiega lui stesso nell’intensa conversazione raccolta da Johannes Odenthal e pubblicata in un bel volumetto della collana “danceforword” (curata per l’editrice L’Epos di Palermo da Susanne Franco). Fagocitare le altre culture, assumere l’altro nel proprio corpo. Una pratica della trasformazione più che di meticciato: anche questo è il corpo.
La Compagnie Marie Chouinard ha presentato invece in prima assoluta Body remix Goldberg variations. La formazione canadese ha mostrato come si possa danzare l’interno del corpo, auscultarlo amplificandone il respiro e i gemiti (tutto lo spazio scenico è amplificato, e addirittura una danzatrice tiene per un’intera scena un microfono in bocca), oppure percorrerne le pieghe per cercare di rivelare lo scorrimento interno, viscerale del movimento. Sono soprattutto la forzatura, l’ostacolo, la protesi a rendere più visibile (più “esterno”) l’impulso, l’origine del movimento. Seguendo (lasciandosi seguire) il partner, assecondando i suoi spasmi o servendo il suo passaggio aereo, imbracato a un cavo di carrucola, si danza il corpo altrui, l’altro corpo. Esasperando l’idea di limite si cercano le condizioni che risveglino l’intelligenza segreta del corpo nell’inventare alternative, nel praticare soluzioni diverse. Sezionando e ricomponendo i movimenti si creano ibridi dalla funzionalità ridotta, artificiali ripartizioni di gravità, figure teriomorfe di sorprendente eleganza. I passi lunghi delle danzatrici con una sola scarpetta su cui puntare l’andatura sbilenca, le evoluzioni su una gamba e due stampelle, le due danzatrici siamesi che avanzano come un solo volatile, la gamba destra dell’una legata alla gamba sinistra dell’altra. Stampelle, aste, corde, girelli, imbracature, costringono e liberano a un tempo le evoluzioni dei dieci danzatori che rispondono con millimetrica precisione al rigore compositivo della Chouinard. Le restrizioni sembrano potenziare la scrittura corporea alla stregua del lipogramma (la soppressione di una lettera) nelle sperimentazioni letterarie praticate da Georges Perec.

Così la Chouinard riesce a trasformare impedimenti e mutilazioni, protesi o costrizioni in elementi generativi di inedite grammatiche corporee, ed è a tratti stranamente emozionante il volteggio con le grucce sulle Variazioni Goldberg interpretate da Glenn Gould, per quanto masticate (distorte, campionate) nel remix operato da Louis Dufort. Quando la voce del pianista doppia, sporcandolo, il contrappunto bachiano, manca forse un’equivalente drammaticità che rompa e renda più viva, più umana, la precisa, calibratissima, levigata ma fredda partitura coreografica. O il distacco è un modo per far passare senza moralismi la mancanza, lo sfregio, la differenza, la disabilità, la menomazione?
La rinascita della tragedia?
Dionysus Since 69. Greek Tragedy at the Dawn of the Third Millennium, a cura di Edith Hall, Fiona Macintosh e Amanda Wringley
di Oliviero Ponte di Pino
Era il 1968. In un garage di New York un gruppo di giovani
attori diretti da Richard Schechner portò in scena un allestimento
innovativo e provocatorio di un testo vecchio di duemilacinquecento anni,
Le Baccanti di Euripide. Lo spettacolo debuttò il 6 giugno. La sera
prima era stato assassinato Robert Kennedy, gli americani combattevano in
Vietnam. A San Francisco si radunavano i Figli dei Fiori, da qualche
settimana Parigi era infiammata da una rivolta studentesca che si sarebbe
diffusa nel mondo intero. Alla fine dell’anno una capsula spaziale con un
nome mitologico, Apollo 9, sarebbe partita per compiere la prima orbita
intorno alla Luna.
Quello spettacolo fu uno scandalo, fin dalla chiara
allusione sessuale del titolo, Dionysus in 69, un successo
replicato per un anno e mezzo (e un work in progress in continua
evoluzione), una messinscena destinata a segnare la storia del teatro di
quegli anni. Di più, quell’allestimento avrebbe anticipato una ripresa
d’interesse per la tragedia greca a cavallo di due millenni, tanto da
fornire oggi, trentacinque anni più tardi, lo spunto – grazie alle cure di
Edith Hall, Fiona Macintosh e Amanda Wringley – per un volume di quasi 500
pagine sui moderni allestimenti della tragedia greca, Dionysus Since
69. Greek Tragedy at the Dawn of the Third Millennium, ovvero
Dioniso dopo il 69. La tragedia greca all’alba del terzo millennio
(Oxford University Press, 2004).

La locandina di I gladiatori dell'anno 3000 (1977), regia di Allan Arkush e Henry Suso.
“La crisi
della società americana che stava dividendo i falchi dalle colombe, i
giovani dai vecchi, i cappelloni da queli con i capelli corti, i profeti
della liberazione sessuale e psichica dai moralisti conservatori, trovò
un’espressione teatrale eccitante e lucida nell’esplosione dionisiaca che
aveva luogo ogni notte nel Performing Garage, un ampio spazio nel downtown
di New York.” (p. 1)

La locandina di Totò contro Maciste (1961), regia di Fernando Cerchio.
Da allora (senza però dimenticare
un precedente come l’Antigone di Brecht nella traduzione di Judith
Malina, che il Living Theatre aveva presentato nel 1967), le
rappresentazioni delle tragedie greche – che prima di allora si erano rare
ed episodiche - si sarebbero moltiplicate sui palcoscenici di tutto il
mondo: secondo le tre curatrici, “sono più numerose le tragedie greche
portate in scena in questi trent’anni che in tutte le altre epoche della
storia, dai tempi dell’antichità greco-romana” (p. 2).

La locandina di L'ira di Achille (1962), regia di Marino Girolami.
Negli ultimi
trent’anni, nei cinque continenti e in centinaia di lingue, con obiettivi
e stili diversissimi, tra un Dioniso con i dreadlock e un Giasone
irrimediabilmente gay, un Filottete con l’Aids e una Clitemnestra en
travesti che sgozza il suo Agamennone nella vasca da bagno,
“il mondo mitico, disfunzionale,
conflittuale descritto dai drammi archetipici di Eschilo, Sofocle ed
Euripide è diventato uno dei principali prismi estetici e culturali in cui
il mondo reale, disfunzionale, conflittuale della fine del
Ventesimo e dell’inizio del Ventunesimo secolo ha cercato di vedere
riflessa la propria immagine.” (ibid.)

La locandina di Il colosso di Rodi (1961), regia di Sergio Leone.
Insomma, la domanda che sottende Dionysus Since
69 è “perché la tragedia greca ha avuto tanto successo in
questi decenni?” (p. 5)
Partendo da una minuziosa ricostruzione della
messinscena di Schechner, affidata a una testimone di quello
spettacolo-evento, Froma I. Zeitlin, il volume cerca di analizzare i
motivi di questo recupero, con una ricognizione ad ampio raggio che si
appoggia al lavoro svolto negli ultimi anni dall’Archive of Performances on
Greek and Roman Drama di Oxford. Nell’impostazione del volume, i
filoni lungo i quali si articolano le moderne letture dei testi di
Eschilo, Sofocle ed Euripide coincidono dunque con le ragioni della loro
attualità e le esplicitano. Dionysus Since 69 è così scandito in
quattro grandi aree di ricerca, “quattro ampie categorie (che sono
tuttavia strettamente intrecciate): sociali, politiche, teatrali e
mentali” (p. 9).

La locandina di La regina delle Amazzoni (1960), regia di Vittorio Sala.
Il primo blocco riguarda Dioniso e la guerra dei
sessi: “‘il personale è politico’ (…) potrebbe essere una delle
possibili descrizioni della tragedia greca, dove vicende individuali,
intime, domestiche di conflitti sessuali, parentali e di potere vengono
narrate nella prospettiva collettiva, comune, politica della società in
cui vive la famiglia tragica” (p. 10).

La locandina di Le guerriere dal seno nudo. Le amazzoni di Terence Young (1974), regia di Terence Young.
Ecco dunque – dopo la ricostruzione
dello spettacolo di Schechner - due saggi che contrappongono
l’esplorazione della femminilità attraverso le moderne incarnazioni delle
“Bad Girls” attiche (a cura di Helen Foley) alla riflessione critica
sull’immagine maschile (l’“Ercole decostruito” di Kathleen Riley).

La locandina di Xena and Hercules (1998), regia di Lynne Naylor.
A
seguire, il Dioniso politico: “la tragedia greca è nata in una fase
di transizione politica, ovvero con l’emergere dei primi segni di una
rivoluzione democratica nell’Atene della fine del Sesto secolo (…) La fine
del Ventesimo secolo ha risvegliato il suo impatto politico” (p. 18).

La locandina di Spartacus (1961), regia di Stanley Kubrick.
In
questa chiave Oliver Taplin, partendo dalla situazione emblematica
dell’Irlanda del Nord, si concentra sulla riscrittura del Filottete
da parte di Seamus Heaney, The Cure at Troy. Edith Hall misura
il rapporto con l’attualità geopolitica dei Persiani di Peter
Sellars (1993) (secondo il quale la tragedia greca ci permette di dire
quello che altrimenti sarebbe indicibile, di rappresentare
l’irrappresentabile), e del Prometeo di Tony Harrison (1998).

La locandina di Edipo Re (1967), regia di Pier Paolo Pasolini.
Pantelis Michelakis traccia una rapida panoramica sulla cinematografia, a
cominciare ovviamente da Edipo Re (1967) e Medea (1969) di un apripista come Pasolini, ma arriva fino al
Teatro di guerra di Martone (1998) – senza naturalmente dimenticare
il documentario che il giovanissimo Brian De Palma dedicò proprio al
Dionysus in 69 di Schechner.
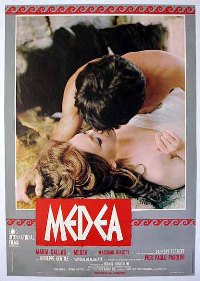
La locandina di Medea (1969), regia di Pier Paolo Pasolini.
Lorna Hardwick affronta il nodo
dell’anti- e post-colonialismo, con particolare attenzione alle
reinvenzioni caraibiche di Derek Walcott e alle esperienze africane:
“la tragedia greca si è rivelata un terreno
fertile per esplorare le differenze culturali (…) in tutte le tragedie
greche s’incontrano, in pratica, personaggi che vengono dai diversi stati
della Grecia – tebani, ateniesi, argivi, tessali, cretesi – ma è anche
sorprendente che la metà circa di questi testi mostrino dei greci che
interagiscono con individui o gruppi (spesso il coro) di etnie e lingue
diverse.” (p. 23)

La locandina di Maciste nell'inferno di Gengis Kahn (1964), regia di Domenico Paolella.
La terza sezione è dedicata
all’estetica della performance. Del resto il confronto con la tragedia
greca – ovvero con l’origine del teatro – è alla radice di alcune delle
moderne rivoluzioni teatrali. In un momento in cui si rifiutava il “teatro
di parola” per ritrovare sulla scena la forza espressiva e comunicativa,
il ritorno all’origine era un passaggio pressoché obbligato: esemplare, in
questo senso, un unicum come l’Antikenprojekt nelle due serate di
Peter Stein e Klaus Michael Grüber alla Schaubühne di Berlino nel 1972, di
cui parla Erika Fischer-Lichte. Si esplora in primo luogo il recupero
della maschera: se ne occupa David Wiles; mentre la riflessione sul coro,
un problema altrettanto e forse ancor più centrale nelle messinscene
moderne, è confinata alla riflessione di Erika Fischer-Lichte sulle regie
di Einar Schleef.

La locandina di La vendetta di Ercole (1960), regia di Vittorio Cottafavi.
Al centro dell’analisi di Katharine Worth c’è invece
l’influenza della tragedia greca sulla drammaturgia contemporanea, a
cominciare da Beckett, ma con un risvolto interessante: per molti registi,
tra cui Tadashi Suzuki e JoAnn Akalaitis, proprio Beckett è stata la
chiave per arrivare – dopo – alla tragedia greca. L’uso che la
musica contemporanea, in particolare il teatro lirico, ha fatto dei miti
greci è invece oggetto della compilazione di Peter Brown.

La locandina di Ercole e la regina di Lidia (1959), regia di Piero Francisci.
Infine, gli
aspetti psicologico-mentali, affrontatati da Fiona Macintosh (con
un’analisi dell’Edipo anti-freudiano di Steven Berkoff in Alla
greca), Erika Fischer-Lichte e Timberlake Wertenbaker.
“Il nostro inconscio è nascosto, i greci lo sapevano e
hanno fatto teatro proprio con la parte nascosta di noi stessi (…) il
recente successo della tragedia greca non dipende da particolari
evoluzioni della società o politica o del teatro della fine del Ventesimo
secolo; dipende invece dalle ‘parti nascoste di noi stessi’, dalle
evoluzioni psicologiche, intellettuali ed emotive della coscienza alla
fine del Ventesimo secolo.” (p. 36)

La locandina di Saffo, Venere di Lesbo (1960), regia di Piero Francisci.
Non è un caso che,
dopo Freud e Jung, molti teorici del post-moderno (Derrida, Foucault,
Barthes, Lyotard, Jameson, ma anche teoriche del femminismo come Kate
Millet e Germaine Greer, cui andrebbero aggiunti almeno i Deleuze e
Guattari dell’Anti-Edipo) abbiano trovato nella tragedia greca
materiali, suggestioni e metafore. Del resto, la riflessione sulla
distruzione (o l’indebolimento) della soggettività e sull’instabilità
della coscienza individuale trova nei personaggi tragici ampie e variegate
esemplificazioni.

La locandina di Elena di Troia (1955), regia di Robert Wise.
Di più, pensando alla parabola di molte eroine
tragiche, la drammaturga Timberlake Wertenbaker fa notare una differenza
sottile ma fondamentale rispetto ai maschi:
“gli uomini affermano di arrivare alla consapevolezza di
sé, di capire perché hanno fatto quello che hanno fatto, di aver appreso
da questa esperienza, e di essere in grado di compiere azioni fondate su
una ragione che nasce dall’esperienza. Le donne, per esempio Ecuba,
si
sentono prima di
conoscersi, e agiscono senza fare appello a una consapevolezza di sé – né
mentre agiscono né a posteriori.” (p. 45)

La locandina di La guerra di Troia (1961), regia di Giorgio Ferroni.
In un’epoca
in cui le certezze della ragione illuministica vacillano, minate dagli
orrori della storia, queste figure femminili “non ci insegnano a Conoscere
Noi Stessi, ma ad essere umili di fronte all’Inconoscibile, come è giusto”
(ibid.).
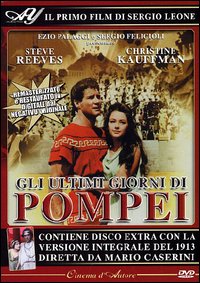
La locandina di Gli ultimi giorni di Pompei (1959), regia di Mario Bonnard.
Di fronte a un’impresa di questo genere, che
raccoglie le voci di una dozzina di studiosi di area angloamericana e
tedesca, non si può certo pretendere la completezza, anche perché la
quantità di informazioni contenuta nel volume resta in ogni caso notevole.
Sarebbe fin troppo facile notare quanto siano scarsi, per esempio, i
riferimenti alle stagioni di teatro classico di Segesta e Siracusa (con
l’INDA, fin dagli anni Trenta) ed Epidauro (anche se è interessante
l’accenno di David Wiles alla pionieristica attività di Eva
Palmer-Sikelianos a Delfi alla fine degli anni Venti).

La locandina di La caduta dell'impero romano ((1964), regia di Anthony Mann.
Nella teatrografia
finale, compilata da Amanda Wringley, manca per esempio qualunque accenno
alle memorabili Troiane di Thierry Salmon, e allo stesso modo viene
appena citata un’altra messinscena in greco antico, quella
dell’Orestea del rumeno Andrei Serban. Allo stesso modo, per
limitarsi alle vicende italiane, Massimo Castri (con il suo lavoro di
ampio respiro sul ciclo di Eracle) non è presente neppure nell’indice dei
nomi; e di Luca Ronconi non si cita l’epocale Orestea – si
ricordano piuttosto la sua Fedra da Seneca e, in una nota, la
censura berlusconiana alla scenografia delle Rane a Siracusa. Ma
quello del “chi c’è e chi manca” è un gioco troppo banale, e in definitiva
inutile.
Il vero nodo è invece un altro: come si legge
nell’introduzione, “l’aspetto più significativo di questa impresa consiste
nel disegnare i rapporti con i programmi sociali, estetici ed
intellettuali dei registi e con le società in cui operano” (p. 5).
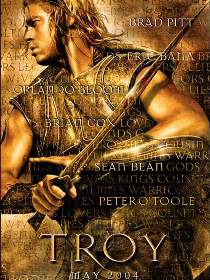
La locandina di Troy (2004), regia di Wolfgang Petersen.
Insomma, si tratta di trovare le chiavi in base alle quali possiamo
affermare che i greci sono nostri contemporanei - per parafrasare il
titolo della celebre raccolta di saggi shakespeariani di Jan Kott, che
alla tragedia greca sulla stessa falsariga ha poi dedicato un altro libro
fortunato, Mangiare dio.
Pochi anni prima che andasse in scena
Dionusus in 69 di Schechner, George Steiner aveva pubblicato
Morte della tragedia (seguito qualche anno dopo da Le
Antigoni, rivisitazione delle diverse e contrastanti letture del testo
di Sofocle attraverso i secoli, fino allo spettacolo del Living Theatre:
un saggio che ha segnato la storiografia dello spettacolo, e di cui questo
stesso volume è obliquamente debitore). Tesi di fondo della carrellata di
Steiner attraverso duemilacinquecento anni di drammaturgia era che il
senso tragico dei greci fosse per noi moderni irrimediabilmente perduto,
irrecuperabile.
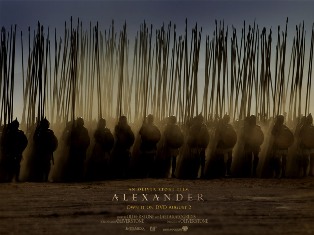
La locandina di Alexander (2004), regia di Oliver Stone.
La domanda che i brillanti e informati saggi di
Dionysus Since 69 non si fanno – e forse non possono farsi, ma
sfiorano continuamente – è proprio questa: al di là delle mille possibili
attualizzazioni e interpretazioni, contaminazioni e parodie, al di là
dell’uso di un patrimonio condiviso di trame e di personaggi, in questi
ultimi decenni è stato in qualche modo possibile trascendere il dramma
(ovvero il discendente depotenziato della tragedia), e invece recuperare e
trasmettere sulla scena contemporanea l’autentico senso tragico? E se
questo è accaduto, se questo può accadere, che cosa nella nostra
sensibilità e visione del mondo ci accomuna agli antichi greci e ci rende
diversi dai nostri immediati predecessori?

La locandina di Ulisse (1954), regia di Mario Camerini.
Altrimenti la tragedia greca si
riduce a un repertorio di classici, più o meno belli, più o meno
inoffensivi, da usare come pretesti per obiettivi e scopi totalmente
“nostri”, attuali, utilitaristici (che poi si tratti di obiettivi politici
o turistici, a questi punto poco importa). Una risposta, da intrecciare
magari con il declino della soggettività cui si accennava, viene forse
suggerita verso la fine dell’introduzione:
“dipingendo un universo retto da una moltitudine di
divinità pagane in cui oggi nessuno crede più, la tragedia greca può
offrire uno spazio importante, libero dalle specificità culturali del
presente, per riflettere su questioni metafisiche e (nel senso più ampio
del termine) teologiche – le domande tragiche ‘cruciali’ del bene e del
male, il ruolo dell’umanità nell’universo e il suo rapporto con le forze
inconoscibili che lo plasmano – soprattutto nel mondo attuale,
frammentato, multiculturale (e, almeno in Europa occidentale,
post-cristiano).” (p. 45)
Come se, archiviata la morte
di Dio, lo spirito tragico potesse in qualche modo tornare a soffiare.

La locandina di Hercules (1997), regia di John Musker e Ron Clements.
Tuttavia un interrogativo del genere non può essere l’argomento per
una raccolta panoramica di saggi di studiosi di teatro. Dovrebbe piuttosto
essere il tema del libro di un filosofo. Anche se proprio questo è il nodo
intorno a cui lavora un altro dei gruppi che questo Dionysus Since
69 non cita, la Societas Raffaello Sanzio, che nel corso degli anni ha
condotto una ossessiva e coerente riflessione sul tema dell’impossibilità
del tragico, dal Gilgamesh alla fondamentale Orestea, dalla
Genesi alla Tragedia endogonidia.

La locandina di Ulisse contro Ercole (1963), regia di Mario Caiano.
Altri saggi recenti affrontano, da angolature e con
ambizioni diverse, temi analoghi.
I testi di una pioniera del
settore, Marianne McDonald, L’arte vivente della tragedia greca
(traduzione di Francesca Albini, con il saggio L’arte vivente della
tragedia greca in Italia di Umberto Albini, Le Monnier Università,
Firenze, 2004, 248 pp., 17,50 euro), lo fa in maniera più spigliata, visto
anche l’obiettivo del volume: “una breve introduzione che fornisca una
visione d’insieme bilanciata, in cui siano affrontate adeguatamente sia la
rappresentazione sia l’analisi filologica”. Il saggio comprende dunque una
serie di schede sui tre tragici greci e su ciascuno dei loro testi, con un
breve riassunto e alcuni appunti sulle messinscene moderne principali
(integrate per quanto riguarda l’Italia nell’appendice di Umberto Albini).
Dello stesso Albini, che all’attualità dei tragici greci e di
Aristofane ha dedicato numerosi saggi, si veda anche il recente Maschere
impure, ovvero, come recita il sottotitolo, Spettri, assassini,
amori e mierie nei drammi greci (Garzanti Libri, Milano, 2005, 194 pp,
13 euro).

La locandina di Gli invincibili fratelli Maciste (1965), regia di Roberto Mauri.
La voce artaudiana di Diamanda Gàlas
Defixiones, Will And Testament (Mute 2003)
di Nevio Gàmbula
“L’autocoscienza critica vera e propria della voce rock va ricercata soprattutto nella parodia, o nella vociaccia di Captain Beefheart, che dà al linguaggio della vita vera e del desiderio, senza complimenti, il timbro del lupo mannaro.”
Umberto Fiori

Al di là del mero consumo, o dell’arte come sistema edificante o terapeutico, esiste, per così dire, una comunità “sperimentale” che ha sempre inteso la poesia come possesso di strumenti di parola: al di là, dunque, di una serie di malintesi socialmente indotti, del tipo, per intenderci, quello che vuole il poeta “ispirato” e tutto dedito ad una attività spontanea e incontrollata, esiste una comunità per cui la poesia è costruzione (e costrizione) formale, una organizzazione di ritmi che si scontra con l’abbrutimento che la parola subisce in una comunicazione standardizzata: il poeta inventa tecniche e strumenti di intervento sulla materia (la parola) per resistere al suo scadimento, per esplorare la possibilità di nuovi accostamenti, di aprire sentieri nuovi: al di là della mediocrità, dell’irrilevanza, della frustrazione. La poesia reagisce alla glorificazione del banale.
Ora, uno degli impulsi primari del poeta – e dell’artista in generale – è quello di «essere diverso». Qualora non ricada nell’arte pura o in forme di ascetismo o di distacco dal mondo, questo desiderio di «essere altrove» indica una forma di malessere nei confronti di un sistema sociale e culturale che fa della omologazione una delle istanze principali. L’artista oppone resistenza proprio a quel “controllo” che vuole interdire il pieno sviluppo della libertà umana. Se nello spettacolo diffuso è veicolata una coscienza deformata (della realtà e di sé stessa), l’artista tenta, con la sua opera, di emanciparsi. Lo fa, per così dire, oggettivamente, ossia costruendo strutture che minano dall’interno i codici della banalizzazione e dell’immediatezza su cui si regge il consumo distratto dell’arte odierna; l’economia è spiazzata esaltando, nel processo compositivo, l’elemento libidico e il desiderio (la «mancanza») esplode in «dissonanze, stridori, silenzi, davvero esagerati, brutti». Liberando la musica dalla linearità e dalla «dittatura della tonalità», ad esempio, l’atonalità e il dodecafonismo mostrano come «nessuno dei suoni può essere privilegiato»; e quando questo percorso di libertà si fa ordine e sistema “serio”, irrompe, a spiazzare di nuovo il tutto, e liberare di nuovo i suoni, la musica aleatoria di Cage. È l’opera che trascende sé stessa, che oltrepassa i confini del costituito mettendo in gioco un grande amore per la materia, esaltandola sino al punto in cui il troppo amore la fa esplodere.
Qui non c’è bisogno di lavorare sul “significato”; è il “significante” che, avvolto da un abbraccio stritolante, si trasforma non solo in prodotto artistico pregevole, ma anche in «effetto liberatore», proprio perché riesce a sottrarsi alle trame limitanti delle convenzioni. Tanto per restare in ambito musicale, l’importanza di Schönberg non risiede nei contenuti, invero alquanto risibili, del testo poetico usato per Pierrot Lunaire, quanto piuttosto nella sua capacità di inventare un modo (della “forma”) che, come giustamente sottolinea Adorno, riesce «a portare alla superficie tutto ciò che si vorrebbe dimenticare»; così come l’importanza degli Henry Cow non è nella ingenuità dei testi che compaiono nelle loro composizioni, ma nella capacità di fare interagire il rock con il free-jazz e con l’atonalismo, creando delle partiture che hanno spiazzato completamente le abitudini d’ascolto contribuendo, con altri (essenzialmente Frank Zappa, la cosidetta “scuola di Canterbury” e i primi Velvet Underground), a indirizzare il gusto dell’ascoltatore di rock verso una complessità emancipante.
Il vasto intreccio tra le condizioni di un’epoca e la costruzione di strutture artistiche ha invero fatto sorgere un’altra prospettiva, una tendenza per certi versi distante da quella appena delineata; ovvero c’è anche chi tenta di emancipare se stesso e la propria opera ponendosi totalmente al di là dell’orizzonte di senso imposto, tenendo vivo e aperto l’esercizio della critica dei significati, e spesso facendo di questa volontà l’impulso primario al lavoro artistico. Esistono opere, insomma, che considerano l’intreccio tra forma e contenuto a partire dalla volontà di configurare prima di tutto una “polemica” nei confronti del mondo. Brecht e Artaud, ad esempio; o, per restare alla musica, Canto sospeso di Luigi Nono o Passaggio di Berio o l’eccelsa macchina maccheronica degli Stormy Six. Opere, insomma, dove la rottura del significante è agita su impulso della critica del significato, entrambi presi nella loro dialettica e inscindibilità. Allora, quel desiderio di alterità rispetto al «canto della merce e delle sue virtù» (questa è diventata l’arte di consumo e la cultura) è la linfa vitale di un lavoro il cui risultato sarà la produzione di inquietudine e di dubbio, di riapertura del sogni di liberazione, di messa in crisi della coscienza manipolata e assoggettata alle rappresentazioni dominanti.
Diamanda Gàlas, cantante e compositrice greco-americana, è uno degli artisti contemporanei che più lucidamente si pone secondo questa ottica. Tutta la sua opera, infatti, passa i limiti della mera dimensione musicale e certifica la possibilità, per la voce, di misurarsi con soluzioni formali «salutarmene eversive». Mi riferisco al suo ultimo lavoro, il doppio CD Defixiones, Will And Testament (Mute 2003), che è dedicato al tema dello sterminio degli armeni e della minoranza anatolica ad opera dei turchi nei primi anni del Novecento.

Mischiando sapientemente canto dissonante a recitazione fortemente ritmica, la Galàs costruisce, con la sua splendida voce, una grande allegoria «straziata dal dolore», stordente, tesa sino allo spasimo, mettendo l’ascoltatore di fronte ad un’opera fatta di litanie lancinanti, di sofismi vocali irriverenti, di granulazioni vibranti, dove lo scarto dalle norme del “bel canto” si delinea, al contempo, come trasgressione dell’ascolto stucchevole e come critica del mondo. Defixiones è un vortice tempestoso di vocalità, travolgente. È un’opera sgradevole, scomoda, fin anche esagerata. La Galàs non smette di interrogare lo spazio creativo della voce e di spingerla sino ai limiti del possibile, proponendola nella sua essenza esorbitante, eccedente, così potentemente sovvertitrice della forma-canzone. Controllando rigorosamente l’emissione, e carica di ferocia fonetica, sostenuta ora da percussioni ipnotiche ora da suoni elettronici ora da un pianoforte che sembra aver smarrito la partitura, narra storie di sterminio, di morte, di disagio per oppressioni secolari. Una poesia vocale che disintegra ogni ascolto neutralizzante.
Al di là di ogni tentativo di sospendersi dal tempo, la mediazione che la Galàs costituisce nella relazione tra il segno verbale (la parola come portatrice di significato) e la voce non ambisce a occultare il referente, come avviene nelle pur splendide sperimentazioni astratte di Joan La Barbara. Esaltando le potenzialità di significazione della voce, l’operazione della Galàs mantiene una certa concettualizzazione e la struttura vocale mira ad affermare anche la sua funzione “comunicativa”. Di fatto, la sua voce si inserisce nel circuito cantante-ascoltatore con la potenza di una “idea” che è immediatamente disturbo, intoppo, spiazzamento. Operando all’interno del meccanismo percettivo su cui si fonda l’atto dell’ascoltare, la Galàs, con le sue istanze radicali, riesce a fratturarlo, a “uscire dal seminato”, senza cadere nell’esaltazione di una vocalità “pura”, innamorata di sé stessa, sentimentalmente legata a una idea di “fuga dalla storia”. Delicata, intensa, severa, aberrante, sincopata, anche delirante, fenomenale con la sua capacità di estendersi per ben tre ottave e mezzo, sempre debordante, la voce di Diamanda Galàs è tra le migliori che la storia della musica abbia mai conosciuto.
Fin dagli esordi come cantante, insieme al Living Theatre con cui si esibiva nei manicomi, la Galàs ha messo in evidenza una modalità vocale fragorosa, in cui la parola è trattata come nel più esagitato teatrino espressionista, con passaggi bruschi di tonalità, e resa timbricamente terrificante e opprimente, come a voler significare nient’altro che la sofferenza del corpo piegato ad un presente di tragedia. Tra sovraincisioni e inserti cacofonici di elettronica, tra pronunce strascicate e ritmi vertiginosi, la voce della Galàs smerda una volta per tutte la figura (e la funzione) della cantante lirica: il “bel canto” è travolto da scoppi di grida, da angoscianti vocalizzi, da strappi, da ferite, passando in rassegna tutto il repertorio delle possibilità vocali. Ogni gesto vocale, anche il più ardito, scorre, nella Galàs, con una semplicità sconvolgente, e non c’è vagito o grido o nota tenuta su un fiato inesauribile che non sia capace di farsi immediatamente senso. Ogni fonema emesso rimanda a un numero imprecisato di “vittime del progresso”. C’è infatti, nel suo eccesso vocale, tutto il grido del mondo, dai malati di AIDS al sangue versato sotto la dittatura dei Colonnelli in Grecia, dai corpi oppressi dalla religione ai sacrificati in nome della merce.
E’ proprio nel punto in cui il dolore dell’Altro è colto in tutta la sua intensità che la voce della Galàs si fa gestualità critica, comportamento sovversivo. Il dolore diventa tangibile e la voce indica il modo di resistervi: uscire dalla secche del costituito, per porsi definitivamente nei pressi della vita e della morte, propiziando una musica che significa qualcosa. Prometeo e Medea convivono nella sua voce: il corpo smembrato del ladro di fuoco e il pianto di vendetta della madre assassina. Una voce, per dirla con Artaud, «eccitata, violenta, seduttrice, ma ripugnante». Quando recita i versi di Adonis, per esempio nel pezzo The desert, sempre da Defixiones, riesce a realizzare quanto Artaud aveva solo teorizzato: mettere in atto una partitura di ritmi e di modulazioni di frequenza che sia percepibile come «discorso polemico».
Un tale uso delle variazioni vocaliche serve alla Gàlas per far risaltare la criticità della sua opera, mostrando come effettivamente la voce possa presentarsi con “dentro” dei significati, in certi passaggi, in quelli dove risalta la voce slegata da ogni elemento verbale, non riferibili quindi al sistema-lingua, ma ugualmente portatrice di significanza. Se poi, come fa, la Galàs non disdegna il rapporto con la parola, allora è evidente l’intento di aggredire il significante per prendere di mira i significati sociali che sottendono un uso tranquillizzante della voce. Il significante è motivato dalla volontà di fare risaltare una doppia contraddizione: l’oppressione secolare subita dalle minoranze è simile e per certi versi coincide con l’oppressione che costringe la vocalità entro canoni rigidi, entro quella stessa “consuetudine” che – come giustamente diceva Demetrio Stratos – isola il cantante «nel recinto di determinate strutture» limitandone fortemente l’espressività.
Ecco allora che la grandezza della Galàs sta proprio nella sua capacità di perseguire una «appassionata radiografia dei suoni» senza per questo rinunciare all’esposizione di un pensiero (poetico) altamente critico; e difatti i rumori vocali che produce esprimono un pensiero disposto a irradiare conflitto: non c’è dialogo con il potere che non sia anche aggressione; non c’è sottolineatura del massacro che non sia, malgrado la crudezza, canto erotizzante; non c’è pratica vocale che non sia anche irrisione; e difatti la sua voce granitica è subito, al contempo, incontro & oltraggio. Rifiuta ogni “dolce melodia” per fare risaltare una fisicità bestiale, allucinata, disperata, ma razionalmente mondana, non celebrativa, ma cinicamente reattiva e senza esitazioni contro. Voce riluttante a farsi complice di una formazione sociale che fa della propria barbarie materia da rotocalco, Diamanda Galàs è una delle poche cantanti (insieme alla meno conosciuta Maja Ratkje, compositrice e performer islandese che compone opere per elettronica e voce di una radicalità stupefacente) che sia riuscita a disfarsi del bel canto. Pur attraversandolo, ossia non disdegnando di cantare frammenti di stili consacrati, dal gregoriano al melodramma, da Wagner al canto da muezzin, sino a litanie religiose, gospel spiritual e blues, addirittura rock (eccellenti le “canzoni” realizzate insieme all’ex bassista dei Led Zeppelin, John Paul Jones, nel disco The Sporting Life del 1994), il grottesco “blasfemo” della Galàs presenta il suo delirio invasato, per evolversi poi in una forma libera da ogni costrizione convenzionale e dare forma ad un canto polemico e dissacrante.
Dal punto di vista dell'ombra
El Eco de la Sombra del Teatro de los Sentidos di Enrique Vargas
di Enia Daniela Idda
C’erano una volta un cerchio di pietre erette e una manciata di eruditi studiosi al centro di questo che esponevano con fare gentile l’esito della loro ricerca circa il fine di questo cerchio, operavano per chiarire il mistero con ingenua precisione. Per tutti essere lì non costituiva una novità, avevano ben studiato l’allineamento con gli astri e il sorgere del sole, ma, credo, nessuno avesse sostato lì con un occhio forgiato dall’esperienza. Il dibattito si faceva sempre più ricco, le opinioni sempre più contrastanti, a un tratto la disputa divenne silenziosa, gli occhi di ciascuno dondolavano alla ricerca di una verità dallo sguardo degli interlocutori a quello delle grosse pietre. In tutti si impresse nel volto una sola domanda non enunciabile: “Ma come avranno fatto a spostarle? Sono enormi, davvero enormi!”
Credo che accada qualcosa di simile davanti a un allestimento di Enrique Vargas e dei suoi attori-drammaturghi-tecnici-scenografi-guide del Teatro de los Sentidos. Entrando nella dimensione poetica della loro opera, che è paradossalmente percepita come reale, metaspaziale, la mente analitica cerca invano di circoscriverla ad un solo punto di vista, cerca una funzione per carpirne un solo senso, un messaggio. Alla pari dei cerchi delle pietre erette, che certo non venivano edificati con tanta fatica per una sola funzione, così le architetture viventi del Teatro de los Sentidos sono veri e propri vissuti percettivi a tutto tondo, inganni emotivi.
E' un percorso di esperienza consapevole che determina un cambiamento. Entrare nel percorso sensoriale costituisce un atto di volontà, l'uscita conferma la trasformazione avvenuta: qualcosa nel corpo è davvero cambiato, persino l’odore, il respiro. Non risulta possibile la comprensione del suo postulato attraverso la ricerca di un unico fine, equivale a perdere la traccia del labirinto, o peggio, il labirinto stesso.
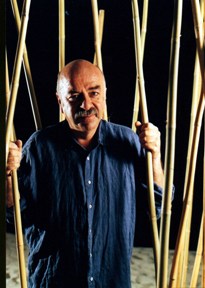
Enrique Vargas è nato a Manizales, in Colombia, nel 1940, studia a Bogotà regia, recitazione e drammaturgia alla Scuola Nazionale D'Arte Drammatica e in seguito, trasferitosi in Michigan (U.S.A.), si dedica allo studio dell'antropologia teatrale. Drammaturgo stabile del famoso Teatro La Mama di New York, diviene successivamente direttore e drammaturgo del Gut Theatre ad East Harlem. Alcuni tra i componenti del gruppo del Teatro de los Sentidos lo accompagnano dalle prime opere realizzate in Colombia.
Le opere di Enrique Vargas sono difficilmente collocabili nell'ambito teatrale stretto poiché molti tra i parametri del teatro per antonomasia vengono ribaltati, per primo la funzione dell'attore che perde l'identità recitante per divenire parte di un tutto, parte vivente di un costrutto percettivo. La "maraviglia", lo stupore, è la tacita asserzione che tesse il filo d'intesa tra l'opera e un fruitore attivo, facendo leva su un linguaggio simbolico e archetipico, per il quale la metafora non è una figura retorica ma un'alchimia.
Gli spazi che ospitano il visitatore o viaggiatore o viandante sono spazi onirici eppure materici, dove la propulsione evocativa è data dal profumo, dai suoni, dal buio e dalla luce, dal tatto, dal gusto. In questi spazi,l'incontro con gli abitanti-attori, avviene in un tempo sospeso, vero o falso, realtà o apparizione non hanno più motivo di distinguersi.

L'ultima opera, El Eco de la Sombra, tratta da un racconto di Hans Christian Andersen intitolato L'ombra, ripete la struttura labirintica delle opere precedenti (come Oraculos, El hilo de Ariadna), in cui un solo spettatore per volta entra all'interno del percorso, facilitando così la perdita dell'identificazione nella collettività in favore di una disposizione all'introspezione e a una relazione intima con le proposte incontrate nel percorso.
La funzione narrativa, come nelle precedenti opere, viene sviluppata nella conseguenzialità degli spazi che suscitano nello spettatore differenti stati d'animo. Esiste una vera e propria drammaturgia sensoriale in cui il ritmo conduce e determina la riuscita dell'esperienza.
Le fasi attraversate possono essere a grandi linee raggruppate in una gradualità di percorso che rimandano allo schema ricavato da Joseph Campbell analizzando "il viaggio dell'eroe" (nel testo L'eroe dai mille volti): la chiamata, il distacco dal mondo conosciuto, l'incontro con il proprio sé, il disorientamento, la perdita del sé, le prove poste dai guardiani del nuovo mondo, il nuovo sé, la conquista dell’altra sponda, il mistero svelato, il ritorno.

E’ un teatro arcaico, iniziatico, che poggia la sua motivazione su necessità attuali, una fra queste mi sembra essere l'ordito di un insieme aperto: offrire esperienza reale di un mito.
Credo non si possa dire di più, chi ha visto un'opera del Teatro de los Sentidos si lega intimamente all'opera stessa, non svelandone il mistero, a maggior ragione se il percorso viene fatto in compagnia dello sguardo della propria ombra.
Può invece essere utile un accenno, a posteriori, alla curiosa rilettura del testo L'ombra di H. C. Andersen che il Teatro de los Sentidos propone, infatti alcune varianti o accenti rivelano in modo emblematico,a mio vedere, possibili chiavi di lettura dell'intera poetica di Vargas e compagni. L'ombra che per Andersen diviene punitiva per Vargas è invece catalizzatrice di trasformazione.
Il "filosofo del nord", andato ad abitare al sud, desidera poter vedere chi abita l'appartamento della sua dirimpettaia, che presume essere una donna,poichè mai potè vederla,solo ammirò la bellezza dei fiori sul balcone. Il desiderio si spinge oltre, stimolando nel protagonista un'immaginario poetico, di certo non filosofico, che lo induce a chiedere in intimità alla propria ombra di staccarsi per lasciarsi scivolare sulla parete della casa di fronte ed entrare a vedere quella meraviglia, questo accadrà determinando la lenta fine del protagonista, fine che per altro ricorda le atmosfere schnitzeleriane del delirio psichico. Enrique Vargas, che non è un uomo del nord, interpreta in chiave nettamente differente da Andersen questo delicato passaggio: nell'anteprima per soli operatori presentata a Barcellona, l'ombra spariva risucchiata e un ambiguo personaggio, che pareva muoversi tra una bisca clandestina e un interrogatorio delle forze pubbliche, rilanciava la possibilità di riavere la propria ombra giocandosela a tris o simili... chiaramente non vi è possibilità di riscatto, ma questo espediente permette di attraversare un travaglio di coscienza fino a rinnovare, ripartorire, la nuova ombra e vivere ciò che segue. E questo non sarebbe possibile senza il lavoro dei bravissimi artisti che collaborano con Enrique Vargas: senza le loro mani e la loro fervida intuizione niente di così prezioso potrebbe accadere. Non è un linguaggio facile quello dell’evocazione metaforica, è un linguaggio che si va perdendo e lascia bricioline nel sentiero che gli uccelli del bosco presto dovranno mangiare; è una formazione in cui non bisogna acquisire ma sottrarre, togliere tutto cio’ che offusca la capacità creativa, lo stupore del pensiero magico.
In sintonia con la risonanza evocativa che lega pensiero a pensiero nell'atmosfera che gravita intorno al genio di Enrique Vargas e agli artisti che con lui lavorano, concludo con tre citazioni che possono gettare altra luce ancora sull'"ombra" di Vargas:
"Anch'io ho pensato un modello di città da cui deduco tutte le altre [...] E' una città fatta solo di eccezioni, preclusioni, contraddizioni, incongruenze, controsensi. Se una città così è quanto c'è di più improbabile, diminuendo il numero degli elementi abnormi si accrescono le probabilità che la città ci sia veramente. Dunque basta che io sottragga eccezioni al mio modello, e in qualsiasi ordine proceda arriverò a trovarmi una delle città che, pur sempre in via d'eccezione, esistono. Ma non posso spingere la mia operazione oltre un certo limite: otterrei delle città troppo verosimili per essere vere."
(Italo Calvino, Le città invisibili, Einaudi, 1972)
"[...]con una costruzione di carte, una sopra l'altra [...] si potrà imprigionare,come in una stanza, la prima ombra. E allora questa ombra imprigionata non si chiamerà più ombra, poichè l'ombra in senso volgare è una proiezione. Fino ad oggi l'ombra non è stata che una proiezione, quindi negativa col fatto costruttivo, un ampliamento. Mentre la prigionia di un'ombra diventa un'immagine costruttiva; meglio, rientra nell'immagine come fatto costruttivo."
(Arturo Martini, Colloqui sulla scultura, 1944-1945, Canova, 1997)
"Abbiamo ancora questo corpo fisico e se apparteniamo solo a Ermes non sentiamo più gli altri dèi. Non più Afrodite né Era, non più Apollo né Muse. Non ci accorgiamo più di nient'altro, assorbiti dalla nostra comunicazione elettronica.[...] Ma non ne sono troppo preoccupato. I sensi, i sensi umani, la sensualità, possono salvarci da moltissimi problemi."
(James Hillman, L'anima del mondo, conversazione con Silvia Ronchey, Rizzoli, 1999)
Enrique Vargas alla Città del Teatro di Cascina
Il progetto
di La Città del Teatro di Cascina

IL PROGETTO
La Città del Teatro a Cascina - Pisa presenta in prima esclusiva italiana dal 15 al 20 Settembre 2005 la creazione commissionata dalla Fondazione Hans Christian Andersen 2005 al regista colombiano Enrique Vargas e alla sua compagnia internazionale residente in Spagna, il Teatro de Los Sentidos.
L’evento spettacolare debutterà nel mese di Maggio a Barcellona per essere presentato durante l’intero mese di Agosto alla Kanonhallen di Copenhagen nel programma del festival Kopenhageh International Theatre (KIT). Da Copenhagen la compagnia si trasferirà direttamente in Italia per le rappresentazioni alla Città del Teatro a Cascina – Pisa.
Enrique Vargas e il Teatro de Los Sentidos hanno ricevuto di recente il Premio Max ‘Nuove Tendenze’. Il Premio Max è il più prestigioso riconoscimento teatrale annuale conferito in Spagna.
Enrique Vargas e il Teatro de Los Sentidos sono stati accolti in passato con unanime consenso di critica e pubblico nei maggiori festival e capitali europee.
Enrique Vargas e il Teatro de Los Sentidos sono stati scelti dalla Fondazione Hans Christian Andersen 2005 assieme al regista canadese Robert Lepage, al italo-danese Eugenio Barba, a Frank Castorf direttore della Volksbühen di Berlino, e al regista cino-americano Chen-Shi-Zheng con il Lincoln Center di New York per ripercorrere il mondo fantastico di Hans Christian Andersen. Nella produzione di Chen-Shi-Zheng sono protagonisti Blair Brown (vista in ‘Dogville’ di Lars Von Trier) e Mia Maestro (la fidanzata di Che Guevara in ‘I Diari della motocicletta’). Lo spettacolo di Chen-Shi-Zheng sarà in scena a Copenhagen in contemporanea con quello del Teatro de los Sentidos.
La Città del Teatro di Cascina è un progetto artistico che ha sede in un singolare complesso edilizio di oltre 5000 metri quadri completamente dedicati al teatro, alle arti dello spettacolo, alla formazione, alla ricerca e alla produzione artistica e culturale.
Collaborando come partner italiano alla presentazione di questo evento, la Città del Teatro intende dare un impulso internazionale alla sua vocazione artistica nel campo dell’innovazione e della produzione di teatro contemporaneo di qualità.
L’IDEA
Il progetto Andersen Odyssey - Travelling Europe with Hans Christian Andersen è focalizzato sul carattere europeo dell’opera di H.C. Andersen in occasione delle celebrazioni del bicentenario della nascita dell’autore nel 2005.
H.C. Andersen infatti ha viaggiato a lungo nel continente europeo traendo ispirazione per le sue opere dalla cultura e dall’arte delle persone incontrate nel suo percorso. Il viaggio diventa quindi per Andersen metafora della sua crescita umana e spirituale. I suoi personaggi sfuggono a confini sociali riferiti a contesti locali specifici e assumono contorni universali tanto da rendere l’opera di Andersen una delle più tradotte in tutto il mondo.
Il tema del viaggio tra le culture europee trova il suo naturale sviluppo nel progetto Andersen Odyssey - Travelling Europe with Hans Christian Andersen anche attraverso una tournée in tre paesi dell’Unione con la previsione di realizzare ulteriori rappresentazioni per l’anno 2006 in altri paesi, con il fondamentale supporto della rete di Ambassadors creata dalla Fondazione HCA 2005 di Copenhagen. Questa rete promuove le celebrazioni del bicentenario della nascita di Andersen in tutto il mondo e vede membri operanti in molti paesi quali (Australia, Belgium, Brazil, Chile, China, Denmark, Great Britain, Italy, Ireland, Latvia, Mexico, Netherland, Singapore, Spain, Switzerland, USA) ed è in continua espansione specialmente in quelli di nuova adesione all’Unione Europea.
Attraverso la costruzione di un labirinto, come luogo della ricerca di significati possibili e luogo della scoperta o della ri-scoperta del valore/senso delle cose, si andrà ad approfondire e valorizzare uno degli aspetti più significativi dell’opera di Andersen.
Egli fu infatti capace di superare schemi e frontiere attraverso il racconto fiabesco, andando a “lacerare il mondo visibile e raccontare il rimosso attraverso trame visionarie ed aggraziatissimi tocchi di poesia” come cita Vincenzo Cerami nell’introduzione al libro di Bruno Berni, traduttore italiano delle fiabe di Andersen..
L’idea si sostanzia in una collaborazione artistica tra la Fondazione H.C. Andersen (Danimarca), il Teatro de Los Sentidos (Spagna) e La Città del Teatro (Italia), attraverso l’allestimento di una rappresentazione, realizzata costruendo un labirinto, all’interno del quale le persone saranno invitate ad entrare e vivere un’esperienza di tipo sensoriale. L’evento, dal titolo Asombra, partirà con una prima tappa di dimostrazione a maggio del 2005, nella città di Barcellona (Spagna), da poco sede del Teatro de Los Sentidos – una sorta di anteprima per ospiti ed amici – proseguirà nella città di Copenaghen (Danimarca) ad agosto 2005, vero e proprio debutto internazionale, per approdare a La Città del Teatro (Italia) a settembre 2005.
In particolare, il consolidamento del rapporto con il Teatro de Los Sentidos, che ha permesso di sostenere il progetto, è il risultato di una naturale contaminazione che La Città del Teatro ha contratto nell’incontro con il percorso di ricerca del drammaturgo colombiano Enrique Vargas.
La ricerca di Vargas riguarda vari ambiti: le arti visive, la drammaturgia ma soprattutto, l’antropologia.
Vargas ha lavorato a lungo in Colombia con la popolazione Indios (documentazione delle feste paesane) e presso l’Università di Bogotà. Per 10 anni ha lavorato negli Stati Uniti, a New York (quartieri disagiati, ghetto neri, minoranze in aree a degrado urbano), ha collaborato, a Los Angeles, con il movimento Agit Prop ed il Teatro Campesino.
A partire dagli anni ’90, l’opera di Vargas inizia a circolare attraverso i più importanti festival europei: Francia, Inghilterra, Danimarca. E’ proprio in Danimarca che nasce il sodalizio tra Vargas e l’allora Direttore del Festival di Aarhus ed attuale presidente della Fondazione Andersen, Lars Seeberg.
Quando Seeberg viene investito della presidenza della Fondazione Andersen per il progetto HCA 2005, riprende contatto con alcuni degli artisti incontrati nel corso della sua esperienza professionale, artisti capaci di esplorare e interpretare l’opera di Andersen. Tra questi figura Enrique Vargas.
La compagnia formata per la nuova creazione è composta da attori e tecnici provenienti da tutta Europa ed oltre (Italia, Spagna, Francia, Danimarca e Sud America) come fossero frammenti dei personaggi di Andersen a rappresentare le molteplici influenze accolte nel corso dei numerosi viaggi all’estero lontano dalla natale Danimarca. E’ importante sottolineare il carattere interculturale della creazione, sostenuto dal fatto che la rappresentazione è concepita attraverso il linguaggio dei sensi (verrà strutturato un vero e proprio labirinto sensoriale nel quale attori e pubblico si muoveranno armonicamente) e non è pensato sui canoni del linguaggio verbale: non esistono barriere linguistiche, né ostacoli culturali e razionali.
Caratteristica peculiare del lavoro di Vargas è creare le condizioni per un’esperienza individuale: lo spettatore/viaggiatore si muove nello spazio del labirinto ed incontra l’attore/abitante. Nella poetica del Teatro de los Sentidos si incontrano parole come funzione in luogo di rappresentazione, viaggiatore come caratteristica dello spettatore e abitante per connotare l’attore. L’ideazione scenografica - segno drammaturgico e non decor – concepita e strutturata sotto forma di labirinto, concede l’accesso ad un numero limitato di persone (ogni funzione consente il passaggio di un massimo di 50 spettatori): l’originalità di una creazione artistica così pensata, non compromette la particolarità dell’esperienza ed è capace di determinare effetti di grande impatto emotivo. E’ ormai noto che chi vive l’esperienza labirintica di Vargas ne esce trasformato, e questa trasformazione è capace di innescare una contaminazione a catena che determina una moltiplicazione fisiologica dei beneficiari ultimi dell’esperienza.
I promotori del progetto hanno iniziato a lavorare allo sviluppo dell’iniziativa a partire dal 2003 avviando un percorso di ricerca e preparazione sotto la direzione di Enrique Vargas fatto di momenti di ricerca, incontri con artisti, studiosi, di laboratori che hanno coinvolto attori e registi provenienti da vari paesi europei.
L’obiettivo del progetto è di dimostrare che, le differenti nazionalità, lingue e culture sono elementi di ricchezza che possono creare territori fertili per l’emancipazione degli individui e della civiltà, lavorando insieme abitanti e viaggiatori alla scoperta di canali di comunicazione attraverso l’espressione artistica.
Le attività si inseriranno nel calendario di eventi che la Fondazione HCA sta realizzando e realizzerà per le celebrazioni del 2005 (see Annex xx). Sono previsti progetti che spaziano in tutte le forme di espressione artistica, dalle più tradizionali alle più innovative, e che già coinvolgono, al momento, 35 diversi paesi making the bicentennial one of the largest cultural projects in the world. Tra questi paesi, in relazione agli obiettivi del Programma Cultura 2000, sono da citare Latvia, Estonia, Lithuania. La Fondazione HCA ha individuato infine tra i suoi key markets prioritari di riferimento Czech Republic, Romania.
LE SUGGESTIONI ARTISTICHE
Perché Andersen ? Cosa ha da dirci oggi ?
Il mondo in cui viviamo oggi ci insegna, più che mai, di accettare come reale quello che vediamo.
La prima e più importante conseguenza di questo fatto è che tutti i nostri sforzi ed i nostri tentativi tentano di manipolare quello che vediamo , in modo tale da manipolare la realtà. Di fatto abbiamo preso come valore delle cose la loro immagine.
Il processo attraverso il quale siamo spinti a prendere per reale l’aspetto esterno delle cose, progressivamente inaridisce ed annulla lo spirito e l’essenza delle cose, negando il loro significato intrinseco.
Quindi inevitabilmente quello che noi facciamo sotto questa spinta é manipolare.
D’altra parte cosa accade se, per un momento, noi non accettiamo di comportarci così e tentiamo invece, in silenzio, di guardare dietro la loro superficie esterna ? Quello che accade è che noi cominciamo a scoprire che il mondo non è solo quello che vediamo dal di fuori , ma è animato da una forza interna. E scopriamo anche che quello che conta è il movimento da dentro a fuori, dall’interno all’esterno.
Andersen ha tentato di comunicarci questo movimento , questo respiro che anima tutte le cose dal dentro , dal loro cuore. Egli ha dato voce agli oggetti più derelitti per mostrarci la loro anima , il loro spirito , dando un senso a quello che apparentemente sembravano non avere.
Animare gli oggetti, recuperando il loro senso, e riconciliandoli con il loro mistero è il lavoro di un poeta ed Andersen lo era senza dubbio. Andersen ci fa ricordare sempre questa verità.
Il lavoro che Enrique Vargas e il Teatro de los Sentidos farà, con i propri mezzi ed il proprio linguaggio, è la costruzione di un contenitore che ci permetterà di congiungerci con il poeta nel suo viaggio verso il valore del mistero.
LA COLLABORAZIONE TRA LA CITTA’ DEL TEATRO E IL TEATRO DE LOS SENTIDOS
Nel novembre 2003 Enrique Vargas ha tenuto un laboratorio presso la nostra Città del Teatro. L’intento era quello di conoscere un uomo e il suo lavoro, cercando insieme i punti di contatto che ci legano e che ci conducono verso l’attivazione di una pratica individuale, di tipo ‘fisiologico’ o ‘magico’, sulle modalità del perdersi, superando progressivamente i sentimenti razionali fino a raggiungere una modalità del sentire nuova, di tipo percettivo emozionale.
Il lavoro che la direzione artistica de La Città del Teatro sta conducendo è un indagine profonda sul ‘significato’ che la sacralità del lavoro determina. Sacralità del lavoro che determina e giustifica l’irrazionalità delle improvvisazioni, esperienze dalle quali emerge una memoria delle ombre che vivono nello spazio di verità irreali della scena e che segnano una frattura rispetto alla convenzionalità dei comportamenti e dei sentimenti abituali; la sacralità è indispensabile affinché si determini: una mutazione della propria fisiologia psicocorporea, la riattivazione della sensitività, il superamento del sentimento razionale, la ricerca di un’emozionalità inattesa e sorprendente, l’eliminazione degli automatismi, la riappropriazione degli istinti primari.
Così ha preso corpo l’idea di indagare in maniera più approfondita il lavoro che Enrique Vargas conduce da anni.
Lo abbiamo invitato ad unirsi a noi in Metamorfosi Festival a giugno 2003 e a tracciare le prime linee di lavoro che costituiranno, ce lo auguriamo, il progetto sul quale riverseremo le nostre energie nel settembre 2005, in coproduzione con la Fondazione Andersen di Copenaghen e altri enti ed istituzioni che hanno già dichiarato il loro interesse al progetto, in occasione del bicentenario della nascita di Andersen.
IL TEATRO DE LOS SENTIDOS
Il Teatro de los Sentidos è una compagnia diretta dal drammaturgo e antropologo colombiano, Enrique Vargas è formata da persone provenienti da 12 nazionalità diverse (Colombia, Cile, Francia, Germania, Olanda, Spagna, Venezuela…).
Sotto la direzione di Vargas, il Teatro de los Sentidos, indaga la drammaturgia del Linguaggio Sensoriale avvalendosi di codici o linguaggi (tattile, uditivo, percettivo…) che troveremo in maggiore o minore grado in tutti i suoi spettacoli.
Il risultato di questa ricerca ha dato frutto alla trilogia Sotto il segno del Labirinto, le cui opere, El hilo de Arianna, Oraculos (Mercat de les Flors 2002) e La memoria del vino, hanno come proposta scenica il labirinto.
“Oraculos ti fa sentire come se avessi ricevuto un preziosissimo regalo, ma nello stesso tempo si tratta di una cosa talmente fragile che tradurla in parole, corre il pericolo di disperdersi…” TheTimes. UK.
Enrique Vargas si stabilisce a New York come drammaturgo stabile del Teatro La Mama. Più tardi sarà al Gut Theatre (Est Harlem).
Successivamente realizza studi sull’animazione di oggetti al Teatro Centrale di Praga.
A partire dal 1974 inizia la sua ricerca sulla relazione tra “Teatro - I Riti - Miti” nelle Comunità Indigene della Regione Amazzonica della Colombia, dando vita al Taller de Investigacion de la Imagen Sensorial, quello che oggi è il Teatro de los Sentidos.
“…ha un punto di contatto con l’emozione del carrozzone della festa che Tadeusz Cantor esigeva per l’arte teatrale…”
El Pais. Espana
ENRIQUE VARGAS
Il drammaturgo colombiano Enrique Vargas svolge una attività di ricerca, creazione e formazione che comprende laboratori, seminari e messe in scena sulla Drammaturgia dell’Immagine Sensoriale.
Le sue ricerche si sono concentrate principalmente sulla relazione tra ‘Mito, Rito e Gioco’ in contesti labirintici basati sul linguaggio dell’Oscurità, del Silenzio e della Solitudine.
L’Oscurità decodifica il corpo: le mani vedono, la narice evoca, le orecchie sentono il silenzio. Il viaggiatore torna alle sue origini: annusa, tocca, percepisce come se fosse la prima volta.
La ricerca di un linguaggio sensoriale risponde alla necessità di recuperare il corpo come fonte di conoscenza e di piacere.
Nelle opere di Enrique Vargas si creano le condizioni necessarie per ascoltare e parlare in questo linguaggio inesprimibile in parole.
Molte delle sue “costruzioni sceniche” sono state realizzate a partire dalle rappresentazioni tradizionali nelle comunità indigene, nelle strade di Harlem a New York o nei riti misterici mediterranei.
Dal ’55 al ’69 segue la Escuela Nacional de Arte Dramàtica a Santafe de Bogotà; dal ’60 al ’65 Antropologia all’Università del Michigan; dal ’65 al ’69 è drammaturgo stabile al Teatro La Mama di New York; dal ’69 al ’72 direttore e drammaturgo del Gut Theatre ad East Harlem; dal ’72 al ’75 drammaturgia di animazione dell’oggetto al Teatro Centrale di Praga; dal ’75 al ’96 professore del Taller de Investigacion de la Imagen Drammatica all’Universitad Nacional de Santafe de Bogotà.
Alcuni premi: Primo Premio Expo 67, Quebec, Canada; Premio Nazionale di Drammaturgia, Colombia 1988; Primo Premio Salon Nacional de Artes Plasticas, Colombia 1992; Premio Tucan de Oro, Festival di Teatro di Cadice, Spagna 1993.
Pubblicazioni per il quotidiano “El Espectador” e per la Universitad Nacional de Colombia dal 1986 al 1993. Ha pubblicato i saggi: Rito, Mito y Juego, Tiempos de Metafora, Imagen sensorial e investigacion y la busqueda de lo no dicho.
Negli ultimi anni Vargas ha realizzato la trilogia “Sotto il segno del labirinto” che, oltre a Oracoli, comprende gli spettacoli Il filo di Arianna e La fiera del Tempo vivo.
Il filo di Arianna: lo spettatore/viaggiatore scopre, come Teseo, che il Minotauro non è il suo nemico né sta fuori della sua pelle. L’avventura per gli incroci del labirinto è intima e personale. “La miglior maniera di viaggiare è perdersi”.
La fiera del tempo vivo è ispirata al Carnevale. La Mucca Pazza della Fiera tradizionale colombiana rimpiazza il Minotauro mitico del Filo di Arianna; la luce si sostituisce all’oscurità, il frastuono al silenzio, il debordare carnevalesco dei saltimbanchi e dei ciarlatani alla solitudine. “Per non confondere l’entrata con l’uscita né la morte con l’atto di morire”.
Oracoli rappresenta un vero e proprio sconfinamento nei campi più estremi della ricerca teatrale e parateatrale. Nell’epoca della realtà virtuale i labirinti sensoriali rappresentano una vera e propria controtendenza, sono un’immersione totale in un mondo arcaico che esalta tutte le percezioni umane (vista, tatto, olfatto, udito) connettendole con il piano psicoemotivo. Orcacoli è molto più di uno spettacolo, è la combinazione alchemica tra casualità, fortuna e filosofia, rappresenta la possibilità di vivere un teatro che nega se stesso per sciogliersi nella partecipazione attiva dello spettatore e nella possibilità di scoprire quanto può essere affascinante “guardarsi dentro”.
Oracoli è una creazione sulle relazione tra la Domanda e il Mistero, un percorso di avvicinamento, un gioco per seguire l’ascolto dei misteri vivi nella profondità del sogno e nella premonizione.
Una delle ultime creazioni di Enrique Vargas è La memoria del vino. La ricerca affonda le proprie radici nel confronto tra l’uomo razionale e l’uomo istintivo, dove il primo deve scomparire per consentire la rinascita dell’altro, dove luce e oscurità sono parte dello stesso universo e prevalgono a secondo del nostro sentire, del nostro stare all’interno della vita.
Memoria del vino si inserisce in un progetto di largo respiro che comprende altre due opere precedenti: Oracoli e Il Filo di Arianna, spettacoli labirintici e individuali nei quali il viaggiatore cercava una propria strada verso l’intimità e la profondità delle proprie sensazioni, quasi a riconoscersi nell’oscurità e nella solitudine di tracciati intricati come le spire del cervello umano. La metafora di questo percorso è il cammino dell’uva. Dove termina il cammino del grano proposto da Oracoli inizia quello dell’uva. Se il grano è crescita, terra, organicità, l’uva è aria, fermentazione, confine sottile tra realtà e finzione, solitudine e convivialità, ebbrezza e saggezza. L’uva è un salto nel vuoto, nella possibile follia liberatrice e propiziatoria di nuove e antiche libertà; l’uva è la strada che ci conduce alla bevanda degli dei, all’ambrosia della conoscenza che purifica e non corrode, che inneggia alla vita e rifugge la morte dei sensi.
ESTRATTO RASSEGNA STAMPA (SUL TEATRO LOS SENTIDOS)
Oracoli sulla stampa
Che cos’è? Cyberspazio? Il sogno di un pazzo? Paradiso? Inferno? Niente parole, solo movimenti, sorrisi, e sguardi amichevoli. Allora non può essere l’inferno!… Il viaggio continua – da sola cammino nel grano, sulla terra e sulla sabbia, tra specchi, attraverso ponti. Chiudo gli occhi, li apro, agisco, annuso, ascolto, sento, vedo – e sono… E’ quasi impossibile descriverlo. Tu devi cercare te stesso. E’ come un mondo di meraviglie, solo meglio.
Camilla Kjarsgaard, Berlingske Tidende
Tutti i sensi vengono stimolati, Oracoli ci fa sentire come se avessimo ricevuto un regalo prezioso ma molto fragile, quasi che parlarne potrebbe farlo scomparire.
The Times
Le tue percezioni sono intensificate in un processo molto più efficace di qualsiasi droga.
Liberation
Non avevo mai avuto un’esperienza come questa…Non esagero dicendo che è più di un “lavoro d’arte”. Mi sono sentito come se stessi assistendo alla nascita di un miracolo.
Epifanias Magazine
…una specie di sensazione come essere in uno di quei sogni che uno fa appena prima di svegliarsi – in quello strano stato tra veglia e sonno in cui si è ancora coscienti di questo. Uno di quei sogni che sono strani e un po’ agitati ma allo stesso tempo misteriosamente piacevoli – che fa sì che si desideri sognare ancora…E una paura iniziale è rapidamente placata da mani che ti aiutano e che sembrano apparire dal nulla, generando benevolmente, e movendo anche emozioni o felicità in modo strano, movendole spiritualmente(…) Quando mi sono trovata intrappolata in una sala di specchi senza uscite, ho immediatamente colto un’apparizione fugace di facce sconosciute riflesse in uno specchio. Non potevo riconoscermi.
Anne Marit Waade, Professore al Centro per gli Studi Estetici Interdisciplinari dell’Università di Arhus
Memoria del vino sulla stampa
C’è qualcosa di sovversivo nel teatro di Enrique Vargas. Qualcosa cioè che si manifesta con la spinta di un momento innovatore, nel porsi al centro di un’esperienza dell’essere. Fin quasi a richiamare il primato della vita su ciò che vorrebbe cristallizzare l’esistente. Dietro i suoi giochi c’è l’ignoto, c’è il mistero dell’incontro. E c’è l’evocazione di qualcosa che resta nei desideri, perché il teatro non può darlo. Fuori, passato lo spaesamento, si tratta di viverlo.
Gianni Manzella, Il Manifesto
Un’atmosfera da fiera sudamericana, giganti e nani, giostre, lucine e teatrini, zingare che ti leggono la mano, case per il disordine dei sensi, jube-box di cartone da cui sensuali labbra cantano al prezzo di un acino d’uva. Fellini riscritto da Gabriel Garcia Marquez. Ma questo carnevale non si svolge di fronte a noi spettatori: ci siamo dentro.
Massimo Marino, Hystrio
Che gran baldoria, corpo di Bacco! Chi va con Dioniso impara a bisbocciare. Ci si sente leggeri come cirri e un po’ si rischia la cirrosi, a seguire a piedi nudi gli scatenati attori del Teatro de Los Sentidos in questo nuovo labirinto predisposto da Vargas e intitolato alla Memoria del vino. Persino lo spettatore più malmostoso finirà per arrendersi al mosto, all’odore acidulo degli acini pigiati in un’improvvisa vendemmia. Impasterà piedi e mani in quella poltiglia fermentante da cui viene spremuta la bevanda di Bacco; seguirà incantato attrici-sirene o attori-Minotauri, dopo che i bastoni d’un gigantesco shangai avranno divinato le sorti, tenendo qui la funzione che in Oracoli avevano i tarocchi.
Roberto Barbolini, Panorama
Il teatro è sogno (ma anche come metterlo in pratica)
La prefazione a Il teatro possibile di Mimma Gallina
di Oliviero Ponte di Pino
Quella che segue è la prefazione a Il teatro possibile. Linee organizzative e tendenze del teatro italiano di Mimma Gallina, FrancoAngeli, Milano, 2005, 380 pp., 28,00 euro, in libreria da settembre 2005.
Il volume verrà presentato a Milano, alla Civica Scuola d'Arte Drammatica, via Salasco, il 29 settembre alle ore 18. Accorrete numerosi...
A mio padre
Quanti possono essere oggi in Italia i professionisti fattivamente interessati alla fusione tra aziende in ambito teatrale, e dunque motivati ad acquistare un volume che affronti l’argomento nei suoi aspetti pratici? Se fosse questa la ragione per comprare Il teatro possibile, con ogni probabilità questo libro troverebbe una ventina di acquirenti o poco più, che oltretutto farebbero molto prima a chiamare direttamente l’autrice: nel mondo teatrale la conoscono tutti, recuperare il suo numero di telefono o la sua mail è fin troppo facile, e oltretutto con il passare degli anni lei si è fatta sempre più prodiga di informazioni e di aiuto.
Insomma, Il teatro possibile di Mimma Gallina non è e non può essere solo un manuale di organizzazione teatrale o di economia dello spettacolo, o un breviario per affrontare e risolvere qualche problema pratico nell’attività organizzativa, anche se distribuisce pagina dopo pagina indicazioni operative, notizie, dati, considerazioni, consigli. Se però guardiamo meglio al capitolo che questo libro dedica al misterioso e raro fenomeno delle “fusioni teatrali”, scopriamo che in realtà mentre parla di un problema di portata assai limitata (quante sono oggi le imprese teatrali che davvero potrebbero o dovrebbero praticare una fusione?), Mimma Gallina intreccia una serie di sguardi ricchissima e complessa.
C’è in primo luogo un aspetto storico, a sua volta declinato secondo scansioni diverse. Il richiamo folgorante alla “grande storia” del teatro, con il riferimento alle compagnie di Molière, ci ricorda acutamente che la pratica teatrale attuale può servire a illuminare la storia del teatro, e viceversa. Il racconto di due fusioni effettivamente realizzate nel recente passato, quella dei Teatri Uniti a Napoli e quella dei Teatridithalia a Milano, dunque due eventi che un qualche significato nella storia del nostro teatro l’hanno avuto (anche se nessuno ne aveva mai effettivamente valutato il peso con questa attenzione), intreccia elementi che riguardano l’economia aziendale e la poetica delle compagnie, nei loro rapporti reciproci, soppesando intenzioni e risultati. Una storia più piccola, contingente, ma per noi determinante, dà un ulteriore taglio interpretativo: è la successione delle circolari ministeriali che governano da sessant’anni il nostro teatro, o meglio la vivisezione di un loro comma fugace e in apparenza trascurabile.
Così, quando arriva ad affrontare l’attualità, lo scenario generale è ampiamente delineato. E nel censire le fusioni effettivamente concluse negli ultimi anni, può mettere in gioco anche fattori giuridico-amministrativi, economici, sociologici, di organizzazione aziendale e gestione del personale, di marketing, – sempre ricordando però la specificità e la prevalenza dell’aspetto artistico.
Questo approccio multidisciplinare discende dalla “prospettiva organizzativa” adottata da Mimma Gallina e già sistematizzata nel volume Organizzare teatro e può dare un’idea della ricchezza di contenuti e di problematiche di un libro che è più libri insieme, all’interno però di un forte disegno unitario, oltre che di una robusta impostazione e idealità.
Per quanto riguarda la struttura, Il teatro possibile è un libro composito. La prima parte è un viaggio nelle capitali teatrali italiane, quella decina di città dove si concentra buona parte dell’attività produttiva e del mercato. In Italia un teatro nazionale non è mai riuscito a nascere, anche per questa fortunata sovrabbondanza di articolazioni e di tradizioni. Tuttavia l’analisi non è rivolta alle glorie del passato, da Pulcinella e Arlecchino ai teatri stabili, quanto piuttosto allo snodo di questi anni e al prossimo futuro: è la fotografia di una situazione in rapido movimento, di cui non è facile prevedere gli sviluppi. Con questa vera e proprio inchiesta, Mimma Gallina si allontana dagli schemi consolidati: insomma, non vuole certo ratificare il “sistema teatrale italiano” così come si era andato configurando in questi decenni e di cui lei stessa è stata protagonista. Va piuttosto a cercare i segnali di trasformazione e novità: ed è uno sforzo notevole, perché è molto più facile continuare a ragionare all’interno di schemi collaudati – e magari sanciti da un quadro legislativo-burocratico consolidato nei decenni – piuttosto che arrischiare sul nuovo.
Il secondo “libro nel libro”, dopo questa significativa aperture sulla realtà, riguarda l’analisi – un commento filologico - delle “ultime edizioni” della circolare annuale (o dei decreti pseudotriennali) che regolano il nostro teatro. Al di là delle conclusioni cui giunge questa puntigliosa radiografia, è chiaro che all’autrice sta a cuore soprattutto, ancora una volta, il metodo di analisi. Per gli addetti ai lavori questa circolare e le assegnazioni del FUS ministeriale sono ovviamente un elemento determinante, l’architrave dell’intera attività della stagione. Dunque quello che monopolizza l’attenzione dei teatranti è ovviamente il proprio particulare: le opportunità offerte dalla normativa e le sue richieste, la somma di sovvenzioni di cui disporre, e magari il confronto con le realtà più vicine (e perciò quelle direttamente concorrenti nella lotta per la sopravvivenza, in un ambiente dove le risorse sono cronicamente scarse e per di più in ulteriore drastica riduzione). Questa lettura in soggettiva è per gli operatori una tentazione fortissima, inevitabile. Oltretutto in un sistema regolato in sostanza da un autogoverno corporativo (attraverso le diverse categorie rappresentate nell’AGIS) e poi corretto da vari meccanismi clientelari e di sottogoverno (o peggio), diventa spesso difficile cogliere un disegno generale, un progetto politico esplicito o implicito. Invece, al di là della apparente casualità di scelte contingenti e di un procedere burocratico e in apparenza neutro, una lettura informata (e magari a tratti maliziosa) fa emergere una linea precisa, perseguìta con maggiore o minore consapevolezza dai politici e dagli alti burocrati, con la complicità di esperti e di addetti ai lavori, ma che determina l’evoluzione dell’intero sistema con sorprendente coerenza (persino nelle apparenti incoerenze). Non è un caso che questo meccanismo di controllo tenda a nascondersi dietro un velo impenetrabile: nel chiuso di uffici e commissioni, vengono prese decisioni politiche che hanno effetti ampi e profondi, ma di fatto senza alcun reale dibattito, solo contrattazione tra alcuni maggiorenti. La fitta cortina che nasconde questa procedura rende di fatto impossibile ogni discussione e verifica, fino alla scandalosa decisione di non divulgare le assegnazione del FUS per il 2004, in nome di una malintesa difesa della privacy. Senza trasparenza, la democrazia perde significato: comprendere i meccanismi del potere e i suoi effetti è il primo necessario passo verso una autentica procedura democratica.
Altri capitoli di questo libro potrebbero costituire ricerche autonome, dal reportage sull’attività spettacolare dei centri sociali di Roma e Milano (ma accoppiato a una radiografia dei loro conti economici) al censimento dei circuiti regionali, che chiude un po’ il cerchio e il viaggio iniziato dalle aree metropolitane: perché i circuiti portano il teatro nei centri medi e piccoli, le centinaia di piazze da “una replica e via” che danno al teatro italiano la sua peculiarità.
Mimma Gallina traccia dunque un percorso che va dalle massime istituzioni teatrali ai borghi della provincia con i loro teatrini da poco restaurati, dai corridoi del Ministero ai disastrati capannoni che raccolgono ed esprimono il disagio giovanile. Il teatro possibile ci porta là dove si decide la politica dell’intero sistema e si distribuiscono le risorse, ma esplora anche l’area di una marginalità che vuole vivere di fatto al di fuori della legge e dei regolamenti burocratici. Segue questo itinerario senza una gerarchia precostituita: non parte dal vertice per arrivare alla base, dal centro per arrivare alle periferie (o viceversa, che sarebbe la stessa cosa), ma va a verificare di volta in volta i fronti del cambiamento ai diversi livelli. Perché il tema centrale, la grande domanda del libro, è la possibile evoluzione del teatro italiano: quali sono le sue potenzialità, e quali sono le capacità delle istituzioni di cogliere e valorizzare queste spinte innovative.
Il teatro possibile è molti libri insieme anche per altri motivi. Per esempio vi si stratificano le diverse fasi e i successivi saperi accumulati dall’organizzazione teatrale in Italia.
L’organizzatore teatrale è una figura insieme antichissima e moderna. Ovviamente impresari e organizzatori esistono da sempre, anche se le loro funzioni potevano essere diversamente distribuite all’interno di un teatro o di una compagnia, e non perfettamente definite da un mansionario. Per fermarsi a epoche recenti, capocomici come Eduardo o Dario Fo sono stati anche straordinari organizzatori: o meglio, sono stati artisti creativi anche a livello organizzativo. Basti pensare all’abilità con cui Eduardo - ai tempi del fascismo e dunque in una situazione culturale e politica per lui difficilissima – modulava nelle sue tournée il rapporto tra i testi in italiano e i testi in napoletano del suo repertorio; o alla creazione di un circuito autonomo da parte di Dario Fo e Franca Rame dopo la cacciata da Canzonissima e l’uscita dal circuito dei teatri “borghesi”. Quella dei capocomici era una competenza conquistata sul campo, oltre che il frutto di una tradizione e una sapienza secolari, che risalgono fino ai tempi dei Comici dell’Arte.
Con il dopoguerra, nel momento in cui l’intervento pubblico in teatro è diventato determinante, sia sul versante artistico sia su quello economico, la figura e il ruolo dell’organizzatore è cambiata. O meglio, è nata una diversa figura di organizzatore, che non risponde più solo alle necessità della propria impresa, ma che deve confrontarsi in maniera diversa con la “funzione pubblica” del teatro, nei due sensi del termine: sul versante della progettualità (e dunque sul senso del proprio fare teatro rivolto a una collettività) e nel rapporto con le istituzioni (e dunque con i funzionari che a vari livelli interagiscono con i teatranti). E’ la generazione di operatori che si è affermata sulla scia di Paolo Grassi e dell’esperienza del Piccolo Teatro, e di cui faceva parte anche Giorgio Guazzotti, che di Mimma è stato amico e maestro: anche questa generazione, che ha vissuto la meravigliosa necessità di inventare un teatro diverso e nuovo, si è sostanzialmente formata sul campo, forgiata da battaglie culturali e politiche interne ed esterne al palcoscenico. Proprio Giorgio Guazzotti ha sentito, a un certo punto del proprio percorso, la necessità di formare i quadri organizzativi in grado di gestire e plasmare questo sistema emergente, offrendo loro le competenze e le informazioni necessarie. E’ nato così – ancora negli anni Settanta – il primo corso per organizzatori teatrali italiano, in quella che all’epoca si chiamava ancora “Scuola del Piccolo Teatro” e che sarebbe poi diventata la “Civica Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi”.
Mimma Gallina è stata una delle prime allieve di questi nuovi corsi (io, che sono arrivato poco dopo, oltre che di Guazzotti sono stato anche uno dei primi studenti di Mimma, che aveva subito conquistato il grado di docente). Appartiene dunque a una generazione per la quale l’organizzazione non è solo un sapere di cui appropriarsi attraverso l’esperienza diretta e i consigli dei più esperti, quanto una professionalità che si acquisisce attraverso un preciso percorso formativo e un curriculum di studi: non si tratta più di un accumulo empirico di problemi e soluzioni, ma di un insieme di competenze multidisciplinare e di un metodo di lavoro. Parallelamente al definirsi e al moltiplicarsi di corsi di questo genere (che ora hanno invaso università e master), hanno iniziato ad approfondirsi (in Italia con qualche ritardo rispetto al mondo anglosassone e alla Francia) tutta una serie di studi e ricerche che riguardano l’economia e la sociologia della cultura. Gli strumenti di analisi e le metodologie di lavoro sono andate affinandosi e sistematizzandosi, quasi aspirando a una scientificità in precedenza impensabile. Di questo corpus ancora un po’ sgangherato, Mimma è andata appropriandosi in questi decenni, inseguendo una curiosità attenta e onnivora, ampliando e definendo i confini della disciplina e cercando di darle un po’ d’ordine: non è un caso, va notato, che il suo lavoro si sia concentrato sul teatro, tenendo ben presenti le sue specificità e peculiarità, mentre in genere altri studi privilegiavano un più generico approccio all’economia e all’organizzazione dello spettacolo dal vivo (comprendendo dunque anche forme come il teatro lirico e i concerti, con tradizioni e problematiche molto diverse).
In questo libro, queste tre età – se vogliamo chiamarle così - dell’organizzazione teatrale si compenetrano e si completano. In primo luogo c’è una profonda padronanza dei modi di funzionamento del teatro, una conoscenza di prima mano, affinata in anni di lavoro, prima con le responsabilità ai vertici del Gruppo della Rocca e poi con la direzione – prima donna in Italia – di un teatro stabile, quello del Friuli-Venezia Giulia, poi con la creazione di un prestigioso festival internazionale come il Mittelfest, e ancora come mille collaborazioni e consulenze a compagnie, teatri e rassegne. Annotazioni come quelle sui differenti cachet degli spettacoli nelle piccole e nelle grandi piazze possono essere il frutto solo di una conoscenza di prima mano dei rapporti tra teatri (e/o circuiti) e compagnie (e/o agenzie).
Emerge poi tutta la competenza maturata in decenni di rapporti con le istituzioni ai diversi livelli dell’amministrazione, l’abilità di destreggiarsi nei meandri della burocrazia ministeriale, regionale, comunale, assessorile, eccetera eccetera, unita alla capacità di cogliere il segno e l’effetto politico di ogni decisione, e dunque di interpretare e valutare – per esempio – leggi, circolari e regolamenti in perenne evoluzione. E c’è soprattutto, ancorata nelle effervescenti stagioni dell’immediato dopoguerra e degli anni Settanta, quella spinta ideale al rinnovamento, quella tensione alla dignità e alla diffusione di un teatro d’arte che sia anche un teatro civile, e la consapevolezza della necessità di disegnare, attraverso il proprio lavoro e le proprie scelte, un diverso sistema teatrale. A ispirare Il teatro possibile non sono solo i criteri di una corretta gestione economico-finanziaria, un uso razionale e magari creativo delle (scarse) risorse, una razionalizzazione del sistema, insomma l’adeguamento ai presunti diktat del mercato, quando prima di tutto l’idea di un teatro di qualità – nel suo valore estetico e nel suo rapporto con il pubblico - che va difesa e diffusa.
Si sviluppa infine l’uso di competenze che lo studio dell’economia della cultura di questi anni ha progressivamente affinato e che lei stessa ha collaudato in decenni di insegnamento. Un approccio insomma meno casuale, più sistematico, ai problemi del teatro. E, va sottolineato ancora una volta, multidisciplinare: non è un caso che molte parti di questo libro siano il frutto di collaborazioni e di incontri, sia sul versante pratico sia su quello teorico.
Oltre che i diversi saperi dell’organizzazione teatrale, questo libro ne intreccia anche le diverse funzioni. Parte con l’analisi dei problemi specifici, con una molteplicità di strumenti e tecniche. In secondo luogo fa appello alla capacità di inserirli nel loro contesto culturale, politico, normativo e di mercato. Terzo, una volta individuate le possibili soluzioni, affina gli strumenti organizzativi, di marketing, economici e giuridici necessari per raggiungere gli obiettivi prefissi. Infine, e soprattutto, fa appello a una “immaginazione organizzativa” che inventi soluzioni innovative e creative. Perché è inutile ricordare che molte grandi invenzioni teatrali sono anche, insieme, indissolubilmente, soluzioni organizzative inedite (e in questo libro ce ne sono diverse, alcune ricordate altre magari suggerite). Perché a questo punto è inutile ricordare che anche quello dell’organizzatore (dal direttore organizzativo all’ultimo dei suoi collaboratori) dev’essere un ruolo creativo.
Affiora anche, in questo Teatro possibile, una ulteriore ambizione, che trascende i tradizionali obiettivi di un bravo organizzatore. Pur affrontando e analizzando una serie di situazioni e problemi precisi, non nasconde mai il suo vero obiettivo. Perché l’oggetto del libro è il sistema teatrale italiano nel suo complesso, e l’ambizione inconfessata di Mimma Gallina è quella di contribuire in maniera costruttiva alla sua riforma. Il teatro italiano sta attraversando uno dei ricorrenti momenti di crisi: insufficiente ricambio generazionale e di linguaggi, risorse sempre più scarse, incapacità dei poteri politici di offrire finalmente un quadro di riferimento normativo e legislativo credibile. Ma in questa crisi è possibile anche cogliere una serie di opportunità. L’incontro milanese delle Buone Pratiche, nel novembre 2004 (a cui Il teatro possibile dedica un denso capitolo), è stato un tentativo di mappare alcune di queste opportunità, al di fuori di pregiudizi e luoghi comuni. Al di là dei singoli esempi di Buone Pratiche – tutti ovviamente discutibili – c’è forse una lezione che si può trarre da quella esperienza e da questo libro: in questo scenario non possono esistere certezze, né da parti di chi il teatro lo fa né da parte di chi il teatro lo organizza, lo osserva e lo regola. O meglio, di chi il teatro lo vuole e deve regolare, considerato l’attuale passaggio di consegne tra Stato e Regioni, qui peraltro ampiamente discusso.
Mimma Gallina ci dimostra che è diventato impossibile accostarsi ai problemi attuali della scena partendo da partiti presi ideologici o estetici, oppure dall’attuale quadro normativo-legislativo (o, peggio ancora, da quelle rendite di posizione che ingessano i nostri palcoscenici). Dunque è necessario mettersi davvero a guardare quello che sta succedendo, al centro e ancora di più nelle mille periferie, per capire quali possano essere le strade del rinnovamento. Forse, va aggiunto, al momento non è immaginabile una soluzione di sistema, che possa ricondurre a un quadro unitario tutte queste spinte. Perciò qualunque progetto normativo o legislativo deve essere aperto e flessibile. Irrigidire la molteplicità e la ricchezza di realtà ed esperienze che emerge da questo viaggio nel teatro italiano all’interno di categorie codificate, significa togliergli l’ossigeno: rischiamo di amputargli quella costante capacità di reinventarsi, di proiettarsi ogni volta verso un teatro che ancora non esiste. Quel teatro che qualche ingenuo visionario può solo immaginare e sognare e poi – con ostinata disperazione, con feroce necessità – far vivere e crescere.
Milano, 1°-14 aprile 2005
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
Integrazione tecnoespressiva e métissage artistico nel teatro di Robert Lepage
Dal volume a cura di M.M.Gazzano che contiene gli atti del convegno su Cinema e intermedialità
di Anna Maria Monteverdi

LA SCENA MULTIMEDIALE DI LEPAGE
La scena di Robert Lepage, attore, regista teatrale cinematografico e d'opera, creatore di scenografie multimediali per concerti rock (1), è costellata da una vera polifonia di linguaggi e di immagini (fotografiche, video e in grafica 3D). L'effetto di ombre nel suo teatro è combinato variamente con le proiezioni video in diretta, tecniche che insieme creano un gioco e uno scambio ininterrotto tra la parte frontale e quella retrostante la scena, entrambe spazio d'azione live sia dell'attore che della macchina. Per questo motivo Iréne Perelli-Contos e Chantal Hébert affermano che il “medium di Robert Lepage è l'immagine" (2), mentre Ludovic Fouquet sostiene che nei suoi spettacoli Lepage fa della scena “una piazza forte dell'immagine” (3).
La sua originale drammaturgia gioca su più livelli narrativi: in un’architettura stratificata fatta di trame visionarie si intrecciano storie di esplorazioni simboliche, di perdite e di riconciliazioni; vicende lontane nel tempo e nello spazio si incastrano come scatole cinesi offrendo sguardi speculari, percorsi obliqui di memoria, investigazioni introspettive che relazionano la Storia al quotidiano. La scena - un vero trionfo di mechané e techne antica, commista a tematiche e tecniche postmoderne di appropriazione e citazione dai linguaggi della comunicazione mass mediatica - in costante divenire per mezzo del movimento e della luce come nell’utopia craighiana, diventa “maschera” per l’attore, ovvero corpo espanso e insieme luogo metamorfico dell’essere che si rivela, in ultima analisi, multiforme e illuminante macchina della verità.
Nel lavoro artistico di Lepage dove “non è il teatro che si meccanizza ma è la macchina che si teatralizza” (4), la tecnica è metafora di una condizione esistenziale di mutabilità perenne, di un processo di memoria e di conoscenza (dell’Io, della Storia), di un nuovo sguardo inteso come illuminante esperienza interiore; la scena è concepita come materia viva e palpabile, suscettibile di innumerevoli trasformazioni, pulsante all’unisono con il corpo dell’attore del quale è suo naturale riflesso, articolazione, appendice. Le tecnologie dell'immagine diventano metaforiche lenti addizionali per vedere il piccolissimo o ingigantire, oppure costituiscono uno specchio interiore. Producono una sorta di occhio supplementare, una protesi che ci protegge, ci fortifica e contemporaneamente ci permette di "vedere oltre", oltre la visione binoculare umana. Producono una visione stereoscopica o addirittura a raggi X (come in Elseneur, spettacolo definito dallo stesso Lepage un encefalogramma del protagonista Amleto, ovvero “una timida esplorazione dei meandri dei suoi pensieri” (5)).
Il procedimento di racconto per immagini è evidente soprattutto in Les aiguilles et l'opium (1990). Un senso di angoscia esistenziale, di impossibilità di fuga pervade lo spettacolo che parla attraverso le figure di Jean Cocteau e Miles Davis, di dipendenze (dalla droga e dall'amore). Su un pannello-lavagna rivestito di spandex sopra il quale l'attore si muove e danza appeso con un cavo all'alto del proscenio, vengono proiettate immagini che creano lo “sfondo” drammaturgicamente adeguato: il vortice dei Rotorelief di Marcel Duchamp (o la spirale nella scena dell'Ermafrodita in Le sang d'un poète di Cocteau, 1930) (6), che crea l'illusione di un uomo risucchiato dentro le sue spirali. Di particolare intensità le immagini proiettate sullo schermo di piccoli oggetti posti su una lavagna luminosa (due tazzine di caffé a tradurre sinteticamente un incontro al bar; una piantina di Parigi, delle chiavi) o l'ombra dell'uomo che offre il suo minuscolo braccio alla gigantesca siringa (azione composta da oggetti collocati in realtà a distanza: la siringa posta su una lavagna luminosa e l'uomo posto dietro lo schermo-lavagna). L'effetto di composizione dell'immagine e di “incrostazione” (ovvero “intarsio” tra ombre di oggetti di dimensioni diverse ma senza un vero lumakey) tra corpo reale e immagine in proiezione è senz'altro la caratteristica di questo spettacolo. L'uso della tecnologia delle immagini come metafora della memoria è esemplificato in Les sept branches de la rivière Ota, spettacolo, commissionato dal governo giapponese tra le attività di commemorazione del cinquantesimo anniversario della bomba atomica su Hiroshima. La tecnologia video - che nello spettacolo racconta attraverso immagini in movimento le storie orientali e occidentali che cominciano o finiscono a Hiroshima – associata all'antica tradizione del teatro d'ombre, diventa metafora stessa del processo di memorazione. Così Perelli-Contos e Hébert accostano questo teatro all'effetto fotografico:
“Queste ombre, queste immagini al negativo, latenti, si rivelano in scena grazie ai particolari procedimenti di scrittura scenica che muta, in questo spettacolo, in una vera foto-grafia. Scritture di luce che, attraverso flash (istantanei) e flashback (ricordi), stampano la vita di metà secolo, proiettandola sulla scena e sugli schermi sotto forma di biografia originale, fatta di fotografie. Di ombre e di riflessi".(7)
La scena, strutturata come una tradizionale casa giapponese, bassa e lunga, opaca e trasparente, diventa una lastra “fotosensibile”, o piuttosto un muto teatro d'ombre. (8)
Il cinema è un riferimento fondamentale per Robert Lepage, il quale spesso ha dichiarato che la cultura audiovisiva, cinematografica e televisiva ha da sempre influenzato il suo teatro portandolo a "réinventer le vocabulaire narratif". In quanto canadese, anzi in quanto québecois:
“In Québec non c'è tradizione letteraria. Il nostro Molière è ancora in vita, ha cinquant'anni e si chiama Michel Tremblay. La tradizione letteraria non è presente come in Europa. La nostra tecnica di scrittura deriva effettivamente dalla televisione o dal cinema. Il teatro non è ufficializzato dalla scrittura: non si parla di scrittura teatrale ma piuttosto di uno spazio di scrittura cinematografica affiliata al teatro. Per quanto mi riguarda trovo la scrittura cinematografica più teatrale del teatro, risponde veramente alle regole della tragedia greca: le sceneggiature sono strutturate, sono dei sistemi shakespeariani. Mi stupisco dunque molto che la gente di teatro rifiuti questa scrittura. Con lo zapping, ciascuno può seguire una storia senza che venga raccontata in maniera lineare. Davanti al suo televisore uno spettatore può guardare contemporaneamente il calcio e un dibattito. E finisce per trovare il filo di ciò che guarda. E' come a teatro, è in grado di trovare il filo tutto da solo, sa che questo è un flashback (...) Troppa gente considera il teatro qualcosa di superato.” (9)
Più che usare immagini cinematografiche, Lepage struttura la scena stessa come un grande schermo (i sette pannelli che compongono la casa giapponese in Les sept branches de la rivière Ota, il muro in Le polygraphe, la parete scorrevole in La face cachée de la lune, l'enorme cornice televisiva in Apasionada). La trama è spesso suddivisa in sequenze e "quadri" che ritagliano e isolano la scena letteralmente "incorniciandola", ricreando vere e proprie inquadrature e movimenti della macchina da presa, mentre la storia procede attraverso originali raccordi imitando le modalità e le tecniche del film secondo un procedimento narrativo non lineare, con distorsioni temporali in forma di analessi (flashback) e prolessi (flashforward), che mettono in crisi la cronologia stessa del racconto (10).
La citazione al cinema è presente anche nella finzione teatrale: in Les sept branches de la rivière Ota un'équipe di cineasti americani sta filmando un documentario su Hiroshima; in Les aiguilles et l'opium il protagonista è a Parigi per un lavoro di postproduzione di un film; in Le polygraphe la protagonista è un'attrice che dopo molti provini, è stata scelta per girare un film. L'universo teatrale di Lepage è inoltre costellato di scritte proiettate in scena che segnalano la separazione da una sequenza all'altra oppure servono a dare indicazioni di luogo e di tempo, o a indicare i “credits” come i titoli di coda dei film.
LE POLYGRAPHE O LA RICERCA DELLA VERITA'
Le polygraphe, spettacolo creato con un lungo work-in-progress nel 1987-88 (ma con una prima ufficiale a Londra nel febbraio 1989) ed interpretato inizialmente dallo stesso Lepage insieme con l'attrice Marie Brassard (che fu anche co-autrice del testo) e con Pierre-Philippe Guay, ha avuto nel 1996 una versione giapponese e nel 2000 una versione italiana (11). Da una tragica vicenda autobiografica (l'omicidio di un' amica nel 1980 all'epoca in cui Lepage frequentava il Conservatoire d'Art Dramatique di Québec) il regista trae gli elementi per un allestimento che gioca a confondere teatro e cinema, il racconto teatrale con la suspense del thriller e del film poliziesco (con echi da certa filmografia hitchcockiana) e con le tecniche cinematografiche. Il tema dello spettacolo, ambientato in parte a Québec e Montréal e in parte a Berlino il cui Muro è una simbolica presenza (soprattutto a partire dal 1989, anno della sua caduta) ma anche pratica parete di proiezione (12), è la verità. O meglio, la ricerca di una verità che, simile a una Matrioska, come si racconta nello spettacolo, sembra contenerne molte altre. Una donna è stata uccisa in circostanze misteriose e alcune persone a lei vicine vengono sospettate (13); tra di esse il suo ragazzo, François, uno studente di scienze politiche di venticinque anni che sta svolgendo una ricerca sul muro di Berlino. Dopo sei anni un regista decide di farne un film e per il ruolo della vittima sceglie una giovane attrice, Lucie, che abita porta a porta con François, il maggior sospettato dell'omicidio e sottoposto alla macchina della verità (poligraphe in francese). Questi, poiché non era mai stato informato dal medico Christof circa il risultato del test in quanto omicidio non risolto, cade in uno stato di angoscia e di ossessione che lo porta ad atti estremi di autodistruzione. Lucie (attrice teatrale dilettante alle prese con l'emblematico monologo amletico) conosce anche il criminologo incaricato delle indagini nel Metro di Montréal casualmente perché entrambi assistono al suicidio di un ragazzo, e in seguito hanno una relazione. Christof le rivela l'esito della macchina della verità; Lucie, a conoscenza dell'innocenza di François non potrà però rivelargliela. La vicenda termina con il suicidio di François sotto un metrp. Sesso, sangue e morte sono strettamente collegati nello spettacolo, in un contrasto che ricorda le vicende e l'atmosfera che animeranno, sette anni dopo Les sept branches de la riviére Ota: la morte e la devastazione della bomba atomica si mescolano alla sensualità e all'invito alla "rigenerazione". Come afferma lo stesso Lepage:
"In Le Polygraphe la morte è un importante tema costantemente legato alla sessualità. Uno dei personaggi è un medico legale. Mentre seziona un cadavere, spiega come è fatta la carne, come circola il sangue, come funzionano o non funzionano più i vari organi. I dettagli sono insignificanti. Ciò che è importante è che egli ha entrambe le mani immerse fisicamente in un corpo. Quando vuoi far risaltare il giallo in un quadro usi il nero. Quando vuoi esaltare un tema musicale usi il contrappunto. Lo stesso vale per i temi di un dramma. Se vuoi rivelare la vita e vuoi che gli istinti sopravvivano e si riproducano, spesso devi avvicinarti ad essi attraverso la morte" (14).
I rapporti, con risvolti sessuali espliciti, tra Christof, Lucie e François il principale indiziato, sono alla base dello spettacolo suddiviso in ventidue brevi sequenze frammentate con soluzioni di vera “cineficazione” (15): dissolvenze, flashback, primi piani, proiezioni, slow motion, accelerazioni, alternate scenes, con richiami espliciti al linguaggio cinematografico e alle convenzioni che regolano la comunicazione audiovisiva. La narrazione, costituita da una successione di quadri (alcuni dei quali esclusivamente visivi) solo apparentemente slegati tra loro e aventi continui spostamenti di tempi e di luoghi, mette il pubblico teatrale nella condizione di dover indagarne il senso, ricostruendo l'enigmatica vicenda: la macchina da presa - come ricordava André Bazin a proposito dei film di Cocteau - è lo spettatore (16).
Con Le Polygraphe si preannuncia l'interesse di Lepage verso una scena “integrata”, che attinga con grande disinvoltura al linguaggio e alla cultura dei vari media, dal cinema alla televisione. Questo libero e spregiudicato uso dei linguaggi in scena non significa però confusione tra le diverse arti, come precisa Lepage:
“Il cinema, anche quello visto su grande schermo e in Dolby stereo, non potrà mai dare quello che dà il teatro. Non lo dico perché sono un purista. Lo dico perché il cinema è un'esperienza individuale mentre il teatro è un'esperienza collettiva” (17).
Gli oggetti e lo spazio
Pochi oggetti concreti "a funzionamento simbolico", richiamano immediatamente - tra tensione verso il realismo e gusto metafisico - una storia drammatica di incomunicabilità, di solitudini, di drammatiche esplorazioni interiori, di silenzi, violenze, separazioni e morti: il muro, lo scheletro, lo specchio.

Le proiezioni di diapositive e l'aggiunta di pochi altri oggetti di arredo (un rubinetto, un tavolo) permettono di trasformare il muro in stazione del metro, interno di discoteca, ristorante e appartamento; l'immagine fotografica è anche usata per evocare lo spettro della morte: nella scena iniziale al corpo di Lucie si sovrappone in proiezione l'immagine spettrale di uno scheletro che ha il suo corrispettivo nella scena finale: il corpo nudo di François diventa uno scheletro con un eguale gioco di specchi e di proiezioni. Lo scheletro come presenza funesta anticipatrice di eventi tragici (come nella scena della Danse macabre di Saint-Saens presente ne La règle du jeu di Jean Renoir, 1939) non può che richiamare sia le iconografie delle medioevali danze macabri o i Trionfi della Morte che raccontano - come ricorda M. L. Testi Cristiani - "l'umana Commedia o la moralité", che le pitture surrealiste di Dalì e gli inquientanti manichini dei quadri metafisici di De Chirico. Come nel surrealismo e nella metafisica lo scheletro funziona quale dépaysage, oggetto insolito ed estraneo alla generale collocazione della storia inserito per associazione illogica e psichica, a metà strada tra visionarietà onirica e proiezione inconscia dei personaggi. Proprio il quadro metafisico Piazza d'Italia (1913) di De Chirico presenta un lungo portico lungo l'asse prospettico centrale e soprattutto, in posizione avanzata rispetto ad esso e completamente frontale a tagliare la metà del quadro, un lungo muro di mattoni che può vagamente ricordare l'ambientazione scelta per Le polygraphe (18). Il muro permette lo svolgimento di azioni davanti e dietro di esso, stabilendo così, anche una distanza fisica tra gli eventi spazialmente distanti, narrati. Tale procedimento verrà perfezionato proprio ne Les sept branches de la rivière Ota in cui è usata dagli attori tutta la profondità del palco grazie all'espediente della presenza di una parete orizzontale divisoria fatta di schermi trasparenti - a ricordare la facciata di una casa giapponese. Questi attraverso l'uso particolare di luci e proiezioni di video e di ombre permettono una narrazione che disloca eventi temporalmente e spazialmente lontanissimi tra loro (dal 1945 al 1985 e dall'Oriente all'Occidente) in luoghi diversi della scena ma tutti raccolti, esattamente come in Le Polygraphe, intorno a un unico ambiente avente una forte pregnanza simbolica. Scheletro e muro, inoltre sono strettamente collegati insieme nel racconto teatrale: così come l'innalzamento del muro di Berlino nel 1961 che delimitava il confine tra Est e Ovest ha significato la morte per centinaia di persone che dalla Repubblica democratica volevano entrare nella Repubblica federale, così il cadavere sezionato prelude a quel suicidio finale la cui motivazione sarà proprio la consapevolezza da parte di François di una prigionia all'interno di un muro di silenzio, associato all'impossibilità di comunicare la propria innocenza.
Lo specchio è, inoltre, una costante presenza negli spettacoli di Lepage: solitamente simbolo nel suo teatro, di un necessario percorso di indagine autoanalitica dei protagonisti generato da una frattura o una perdita (19), in questo caso diventa porta verso un altro mondo (come nel film di Jean Cocteau Le sang du poète, 1930) e oggetto di scambio fra la realtà e il mondo interiore. Lo specchio - oggetto orfico per eccellenza - registra, secondo una famosa frase di Cocteau che è anche presente nella conversazione tra Lucie e Christof al ristorante, "la mort au travail":
"Les miroirs sont le portes par lesquelles la mort vient et va. Du rest, regardez-vous toute votre vie dans une glace et vous verrez la mort travailler comme les abeilles dans une ruche de verre." (20)

Cinema o teatro?
Nella prima scena denominata Il filtro (Québec, 1983) abbiamo una simultaneità di situazioni: sulla destra il criminologo Christof Haussmann legge un rapporto di autopsia di un cadavere servendosi per indicare le ferite sulla vittima, di uno scheletro in posizione fetale. Sulla sinistra François Tremblay illustra ai suoi compagni universitari una relazione sul muro di Berlino. La connessione tra i due discorsi è evidente: il taglio sul corpo ha inferto un blocco al passaggio del sangue ossigenato, il muro di Berlino ha impedito la libera circolazione di persone e di idee. Si parla di un omicidio e contemporaneamente della Storia. La metafora anatomica e il procedimento di montaggio parallelo (alla Griffith) o anche l'effetto a "doppia finestra" video contigua e comunicante, che prevede un passaggio di parole e intrecci di frasi tra i due personaggi, fanno slittare continuamente il discorso dal teatro al cinema alla denuncia politica e sociale. Il muro di Berlino (che nella scena 7 arriverà letteralmente a sanguinare perché "...la Storia è scritta con il sangue") ha inciso profondamente sul corpo della collettività abitante la zona Ovest così come profonda è la ferita da arma di taglio del cadavere sottoposto all'autopsia del criminologo tedesco:
François: ....I sovietici, da parte loro, hanno costruito un muro di più di quaranta chilometri che l'ha tagliata in due.
Christof: L'avevano tagliata alla mano sinistra, al braccio destro, colpita alla cassa toracica con un proiettile perforandole il polmone e si può supporre che il colpo fatale sia stato inferto qui
François e Christof: ...In pieno cuore
François....della città
Christof....tra la quinta e la sesta costola
François: Il muro della vergogna, come lo chiamano i tedeschi dell'Ovest, venne eretto allo scopo di bloccare....
François e Christof....l'emorragia....
François...di berlinesi...
Christof....che è seguita
François..passando da Est a Ovest...
Christof: ...è stata occasionata dal sezionamento del setto.
L'incipit che simula il montaggio parallelo con conseguente ritmo sostenuto, risponde anche alla classica funzione di tale procedimento nei film, ovvero di presentazione sintetica al pubblico dei personaggi e delle vicende della storia. In questo caso il montaggio parallelo prelude anche all'intreccio drammaturgicamente significante tra muro e cadavere, le cui immagini diventano un vero leit motiv visivo, facendo precipitare il racconto continuamente dal piano realistico a quello simbolico e viceversa.
Lo stesso espediente della contemporanea doppia colonna narrativa (il cui corrispondente filmico è appunto, il montaggio parallelo) viene riproposta nella scena 19: durante il trasloco Lucie trova una cintura borchiata: François dice di usarla per alcune pratiche omosessuali sadiche. Dietro il muro grazie a uno specchio appare Christof che sta parlando a una conferenza sugli effetti devastanti provocati dalla macchina della verità: mentre spiega i danni permanenti che può causare psicologicamente a una persona che si dichiara innocente, François descrive a Lucie come si stringono con forza i lacci e come si benda la persona per renderla maggiormente vulnerabile, racconto che lo riporta con la memoria all'episodio della macchina della verità, in un vortice di ricordi in soggettiva, violenti e drammatici, in bilico tra innocenza e colpevolezza, tra verità e menzogna:
Christof: In primo luogo, la macchina della verità registra la minima variazione della velocità e del palpito del cuore, indicando anche, con un disegno nel grafico, se c'è un aumento, oppure nel caso di certe persone, una diminuzione della pressione arteriosa.
François: Stringo un poco
Christof: La respirazione del soggetto interrogato offre un'altra lettura delle modificazioni fisiche provocate dai nervi. L'apparecchio poi controlla il livello di sudore della persona interrogata. La macchina della verità può rivelare la minima variazione dello stato fisico e psichico prodotta durante l'interrogatorio
François: (Benda gli occhi di Lucie) Così hai realmente la sensazione di essere vulnerabile...
Nella scena 4 (François; interno, notte) François, cameriere in un ristorante di Montréal, apparecchia, sparecchia e dialoga con clienti immaginari a velocità sostenuta in una specie di accelerazione mediatica e recita con la stessa accelerazione il testo della scena successiva. Con una frequenza ossessiva fanno poi la loro comparsa nella mente di François, come un incubo incancellabile, l'immagine del lie-detector e la voce del criminologo che gli rivolge la solita domanda:
“François mi sente?...Ma non può vedermi vero? François stiamo per procedere a un test... Siamo o no in Canada? Siamo o no in estate? Lei ha assassinato o no Marie-Claude Légarè?”.
In questo caso si unisce anche il motivo del flashback diegetico che, più che far tornare indietro il racconto, crea una pausa sostenuta la cui funzione è quella di focalizzare l'attenzione sulla psicologia del personaggio.
Nella Scena 5 (Audizione, interno, giorno) Lucie fa il provino per un film; le viene chiesto di improvvisare una scena drammatica. Nella scena successiva (Metrò, Interno notte) Lucie assiste al suicidio di un ragazzo e in stato di choc, viene soccorsa dal crominologo Christof. Alla fine della scena Lucie è ancora dentro la sala cinematografica per il provino. La scena del metro non è altro dunque, che un flashback che Lucie ha richiamato alla sua mente volontariamente (quasi stanislawskianamente) per ritrovarsi in una condizione emotiva drammatica come richiestole per il provino ed essere così più realistica nella sua interpretazione. Nella scena 13 (La ferita; interno, notte) Lucie e Christof sono a tavola al ristorante serviti da François quando in un'azione esasperatamente rallentata quasi come un fermo fotogramma, viene accidentalmente rovesciato sulla tovaglia il vino rosso che sembra ricoprirsi di sangue e richiama l'omicidio in cui a vario titolo tutti e tre sono coinvolti e introduce con un climax estremamente significativo, la tensione tipica del thriller cinematografico. Lo slow motion che produce un effetto di estensione temporale, enfatizza infatti un evento diegetico di breve durata per creare un crescente effetto di suspense.
Se Le Polygraphe è costruito interamente attraverso una sequenza a episodi con “effetto cinema”, appropriandosi dello “spazio-tempo filmico” ed in base ad un ordine del racconto non lineare, ricco di passaggi al passato, il finale addirittura arriva a “mostrare” al pubblico teatrale i personaggi non solo frontalmente ma da punti di vista insoliti, con una visione dall'alto, per esempio, come se si trattasse di un movimento della macchina da presa rispetto al soggetto, giocando sullo spostamento radicale verso il linguaggio cinematografico (e che ancora una volta ricorda Le sang d'une poète di Cocteau, scena "La leçon de vol, la petit fille au mur").

Gli attori, per mostrare questo insolito punto di vista, sono atleticamente posizionati in maniera da stare in bilico sul muro in posizione antigravitazionale, mentre nella scena 16 si ripropone una sorta di coreografia come riassunto visivo in forma di corti flash, ovvero in avanzamento veloce (il line up). In questo scorrere finale della vicenda, i personaggi si muovono velocemente con gesti essenziali e sono completamente nudi (è la resa davvero letterale della ricerca della “nuda verità”).
Le polygraphe, thriller metafisico, corre sul filo di un doppio cammino di verità: mentre si cerca il vero assassino attraverso vari indizi, ricostruendo ciò che accadde grazie alla macchina della verità, si rivela che il cinema è illusione (Lucie usa un liquido irritante per piangere sul set). Se la verità passa per una menzogna (l'innocente François sottoposto al lie-detector alla fine non è più sicuro di essere tale), la finzione cinematografica gioca ad apparire terribilmente reale (“A volte bisogna soffrire quando vuoi far sembrare che stai davvero soffrendo”). Come il bisturi seziona il corpo dell'assassinata per scoprirne la causa della morte, così l'occhio della cinepresa incombe minaccioso sull'attrice, rovesciando inaspettatamente la vicenda tragica e la rappresentazione del dolore (è cinéma-verité o la realtà?) e giocando un macabro gioco la cui posta è la vita stessa: “Il regista mi pare un po' insistente, voglio dire, con l'occhio della sua camera... Oggi abbiamo girato una scena in soggettiva, sa, come se si vedesse l'azione attraverso gli occhi di un assassino che guarda la sua vittima attraverso un lampo di luce. Ma durante la ripresa (...) avevo l'impressione di essere guardata (...) Mi è sembrato di essere fatta a pezzi (...). Sì... sai com'è... un piano della bocca che urla, primo piano del coltello nella schiena, la mano che gratta il pavimento". Se la reazione spontanea dell'indiziato è secondo la polizia, la prova dell'innocenza e la macchina l'unico strumento in grado di registrare le alterazioni di emozioni e di afferrare quindi, la verità al di là e oltre ogni simulazione, lo spettacolo afferma con decisione il contrario: l'impossibilità di approdare ad una verità unica e definitiva che appare al contrario sempre più inafferrabile. La presenza di Amleto interpretato da Lucie sul palcoscenico, contribuisce a fornire la visione di una gravosa e sofferta ricerca interiore: le storie di tutti i personaggi, dal criminologo Christof a Lucie Champagne a François nello spettacolo non sono altro che le storie degli Amleti che hanno gettato uno sguardo sulle cose del mondo, ne hanno visto l'orrore e sono stati colpiti da un dolore insopportabile (21). In questo senso è esemplare la scena 2 completamente muta e ambientata all'istituto medico-legale: di fronte alla macchina della verità Christof, tormentato da apocalittici dubbi di innocenza e colpevolezza, sta maneggiando un teschio. Queste le indicazioni del copione:
"Christof sta terminando la redazione di un rapporto sopra un test del poligrafo.
Chiude il detector, sistema le sue carte, tira fuori di tasca una sigaretta e l'accende, poi sempre dalla tasca cava una lettera che rilegge con emozione, si direbbe per la centesima volta. Prima di uscire, dopo aver indossato il cappotto incrocia lo scheletro che ora è in piedi e ne prende con dolcezza la testa in mano, imitando inconsapevolmente la posizione tipo di Amleto".
Le Polygraphe (di cui Lepage firma anche una regia cinematografica nel 1996 tiepidamente accolta dalla critica (22) ) condivide con Le Confessionnal (suo successivo film ispirato esplicitamente a I Confess di Hitchcock) il tema della ricerca di una verità che attraversa labirinticamente meandri nascosti della vita dei personaggi mettendone in luce drammi interiori inespressi o rimossi e relazioni irrisolte.

"Il cinema per Lepage è un medium estremamente personale, dove l'esperienza soggettiva è parte del suo inconscio e può essere materializzato e mostrato attraverso immagini ‘cinematiche’. Ciascuno dei film di Lepage ha a che fare con la ricerca personale dei personaggi principali, che sono di fatto ossessioni dello stesso Lepage: scoprire qualcosa del loro ‘sé’ che è collegato con il processo della memoria: Da dove provengo? Chi sono? Dove sto andando?" (23)
NOTE
(1) Vedi A.M.Monteverdi, Il teatro di Robert Lepage, Pisa, Bfs, 2004, La tecnologia è la reinvenzione del fuoco in E.Quinz (a cura di) Digital performance, Paris, Anomos, 2002; Attore-specchio-macchina, in A. M. Monteverdi, O.Ponte di Pino, Il meglio di ateatro, Milano, Il principe costante, 2004; A.M.Monteverdi, La scena trasformista di Lepage in “Teatro e storia” n.25, 2005.
(2) "E' chiaro che la pertinenza dell'immagine come medium risiede meno nella sua capacità di rappresentazione che nei suoi effetti metaforici sullo sguardo, incitando lo spettatore a vedere ‘altrimenti’ e più lontano di quanto l'occhio non veda. Se in generale ‘i media sono cambiati e hanno cambiato la nostra maniera di pensare, sia sul piano della forma che del contenuto’ quello che l'immagine teatrale sta cambiando in quanto medium, è in modo particolare, la nostra maniera secolare di vedere, interrogando e esplorando in scena quello sguardo nuovo che la nostra epoca posa sul mondo". I. Perelli-Contos, C. Hébert, L'oeuvre de R. Lepage, cit., p. 277. La frase tra virgolette è di Robert Lepage ed è tratta da I. Perelli-Contos, C. Hébert, La tempête Robert Lepage, cit., p. 64.
(3) L. Fouquet, Clins d'oeil cinématographiques dans le théâtre de R. Lepage, "Jeu”, n. 88, 1998.
(4) Irène Perelli-Contos e Chantal Hébert si sono soffermate a lungo sull’uso metaforico delle tecnologie nel nuovo “teatro immagine” secondo Lepage. Rimandiamo senz’altro all’importante saggio (riferito in particolare agli spettacoli Circulation e Les sept branches de la rivière Ota) L’écran de la pensée ou les écrans dans le théatre de Robert Lepage, in B. Picon-Vallin (a cura di), Les écrans sur la scène, Lausanne, L’Age d’Homme, 1998.
(5) Nota di Robert Lepage allo spettacolo Elseneur, datata settembre 1995 e consultabile al sito http://www.cicv.fr/reseau/epidemic/geo/art/lepage/prj/els.html
(6) Il riferimento visivo immediato è alle semisfere rotanti di Anemic cinema (1925-1926, 7', 35mm), film muto realizzato da Marcel Duchamp in collaborazione con Man Ray. Rosalind Krauss ne dà una interpretazione psicoanalitica freudiana che assocerebbe all'ambito proprio della visione-percezione-illusione ottica dei dischi, l'attività libidica dell'inconscio: la sfera sarebbe assimilabile alla mammella, alla cavità uterina e alluderebbe alla penetrazione sessuale (lo stesso Duchamp definiva erotica la visione del film). R. Krauss, Marcel Duchamp, Oltre la retina: ricerche visive e tematica psicoanalitica a proposito del corpo che guarda, “Flash art”, n. 190, 1995, p. 76.
(7) I. Perelli-Contos, C. Hébert, L'écran de la pensée ou les écrans dans le théâtre de Robert Lepage, cit., p. 187.
(8) Il teatro delle ombre muto veniva ampiamente utilizzato per gli apparati dei Sacri Misteri. Sul tema vedi M. Rak, L'arte dei fuochi, comunicazione al convegno "Bernini e l'universo barocco" (Roma, gennaio 1981). Nel saggio dedicato alle marionette e ai pupi (Il teatro meccanico, "Quaderni di teatro", n.13, 1981, pp. 46-59).
(9) P. Hivernat, V. Klein, Histoire paralléles. Entretien avec R. Lepage, “Les Inrockuptibles”, n.77, nov. 1996.
(10) Cfr: L. Fouquet, Clins d'oeil cinématographiques dans le théâtre de R. Lepage, "Jeu", n. 88, 1998, p. 139.
(11) Le Polygraphe con Stefania Rocca, Nestor Saied e Giorgio Pasotti. Produzione Segnali (Roma), Centro Servizi Spettacoli (Udine), Ex Machina (Canada), Mercat de les flors (Spagna). Traduzione di F.Quadri. Cfr: C. Ziraldo, Lepage's Polygraphe in Italy, “Canadian Theatre Review”, n. 105, 2001, pp. 16-19. Inoltre la raccolta di recensioni su “Il Patalogo” n. 23, 2000.
(12) Il riferimento visivo del muro ci riporta senz'altro a quel muro a gradoni che divide le due Germanie nello spettacolo di R. Wilson, Death, Destruction and Detroit (D.D.& D.), 1979.
(13) R. Lepage, M. Brassard, Le Polygraphe, “Canadian Theatre Review”, n. 64, 1990 (testo integrale dello spettacolo); Polygraph, Methuen, London, 1997. Le polygraphe (La macchina della verità), trad. di F. Quadri, manoscritto inedito, 2000.
(14) R. Lepage in R. Charest, Connecting flights, New York, TCG, 1999, p. 86-87.
(15) Adotto da Mario Verdone il termine “cineficazione” con cui lo studioso definisce l'assimilazione linguistica da parte del teatro di principi propriamente cinematografici. Verdone ne parla in riferimento alle regie piscatoriane, al teatro sintetico futurista e al Fregoligraph di Leopoldo Fregoli. M. Verdone, Teatro e cinema: interazioni in AA.VV, Il teatro nella società dello spettacolo, a cura di C. Vicentini, Bologna, Il Mulino, 1983.
(16) A.Bazin, Che cosa è il cinema, Milano, Garzanti, 1999, p.159-160. Per Bazin Cocteau è stato il regista che più di ogni altro ha mantenuto il carattere teatrale nella sua opera cinematografica attraverso alcuni espedienti come quello appunto, della "macchina da presa soggettiva".
(17) P. Lefebvre, New filters for creation. Interview with R. Lepage, “Canadian Theatre Review”, n. 52, 1987, p. 32.
(18) L'indicazione di "thriller metafisico" per Le Polygraphe è dello stesso regista che non specifica però se il termine vada solo a indicare genericamente un intreccio enigmatico che si avvicina all'onirico nella perdita della trama logica della realtà oppure nello specifico, se sia da riferirsi alla particolare qualità di non sense e di "rivelazione" propria dell'estetica e della pittura metafisica. Vedi: R.De Fusco, Storia dell'arte contemporanea, Bari, Laterza, 1989.
(19) Vedi A.M.Monteverdi, Attore, specchio, macchina in A.M.Monteverdi, Il teatro di R. Lepage, cit.
(20) J. Cocteau cit. in L. Schifano, Autoportaits orphiques in Cocteau-Catalogo della mostra Jean Cocteau, sur le fil du siècle (Parigi, Centre Pompidou, 2003-2004).
(21) Su Amleto, maschera del dolore e della follia, vedi F. Mastropasqua, Accerchiando Amleto, in Id, Metamorfosi del teatro, Napoli, Esi, 1998.
(22) Sul film Le Polygraphe vedi A. Dundjerovic, Le Polygraphe: what is truth? In ID The cinema of Robert Lepage. The poetcis of memory, Londra, Wallflower press, 2003.
(23) A. Dundjerovic, Cinema as medium for remembrance, in Id, cit, p.20
Orizzonti di uno sguardo antro-po-etico
Su 'U Gioia di Mauro Aprile
di Andrea Balzola
Il film di Mauro Aprile 'U gioia è stato presentato su ateatro 83.

‘U Gioia è un reportage di un’ora realizzato da Mauro Aprile Zanetti nel 2002 sulle celebrazioni della settimana Santa, dalla deposizione del Cristo dalla croce fino alla sua Resurrezione, e in particolare della processione dell’Addolorata, che si svolge a Scicli in Sicilia. Testo e pretesto di un racconto assai più ampio. Com’è noto, la Sicilia vive ancora con grande intensità e partecipazione collettiva gli appuntamenti liturgici, che si riproducono con varianti specifiche in quasi ogni paese dell’isola. Sono occasioni di feste e processioni che coinvolgono sia nei preparativi sia nella loro realizzazione la maggioranza della popolazione ed esaltano una vocazione antica alla rappresentazione, sacra, perché religiosa, ma sacra anche perché indispensabile allo spirito della sicilianità (con tutte le sue radici greche).
Non a caso il giovane autore del filmato s’interroga innanzi tutto su questa “sicilianità”, cercando citazioni poetiche o letterarie che ne evochino il mistero, affidando a un pittore un commento pantomimico o facendo parlare gli abitanti di Scicli (filmati in primo piano con una luce molto contrastata che ne fa delle maschere), soprattutto i macellai che per tradizione e fortissima metafora hanno l’arduo compito di condurre la pesantissima statua in processione. Il filmato inizia con immagini d’acqua e la voce di un narratore che racconta di un’isola mitica, di cannibali, l’”isola dell’insonnia”, affascinante e terribile, dove tutto è riconducibile a tre cose: nascita, copula e morte. E poi appare la maschera, quella degli dèi e degli immortali, quella della finzione, del sogno, appunto della rappresentazione che sconfigge lo “scandalo della morte”, che viene mostrata e indossata nei Misteri per iniziare l’adepto alla vera vita, oltre la morte, perché situata nell’eterno ritorno del rito. Ecco il siciliano, attore tragico, pupo e paladino che indossa la maschera per diventare sognatore a occhi aperti, cioè insonne nel teatro della Morte, e dalla dialettica tra sacro e profano egli distilla la sintesi del teatro, che è rito profano e metafora mistica, perché il teatro nasce dall’amore e dal tradimento degli dèi.
La Resurrezione di Cristo diventa allora il momento della Metamorfosi dell’intera comunità, la ricomposizione dei brandelli che da Osiride a Dioniso testimoniavano nel mito l’uccisione del Fanciullo Divino e ne preludevano la rinascita come immortale. Si riaccende la luce nel tempio, la carne risorge e si muove, esce all’aperto tra la sua gente a testimoniare che la morte è il grande inganno nel teatro della realtà.
Allora come raccontare in immagini e suoni tutto questo? E’ possibile “documentare” l’evento e insieme l’archetipo che lo sottende, l’anima che lo muove, le ombre e le contraddizioni che lo attraversano?
Werner Herzog, uno dei più straordinari (letteralmente: oltre l’ordinario) autori cinematografici che si siano dedicati anche alla ripresa di eventi, personaggi, luoghi reali, si proclamava “becchino del cosiddetto cinema-verità”, cioè di quel cinema documentaristico (divenuto poi modello di quello televisivo) che si teorizzava e pretendeva fedele alla realtà, specchio del mondo. La realtà è improbabile, ricordava Borges, e perciò imprendibile, irriproducibile perché – suggerisce Herzog – molto più complessa della sua evidenza, la realtà è appunto “maschera”. Allora come far vedere qualcosa oltre la maschera? Mediante un’altra maschera: una “visione” poetica o drammatica che forza la realtà e ne induce epifanie, trovando delle immagini chiave che pur essendo prese dalla realtà vanno oltre essa (come l’immagine di uno scimpanzé che fuma una sigaretta in gabbia e che diventa l’immagine ultima del ritratto di un sanguinario dittatore africano rinchiuso in carcere e impazzito (Echi da un paese oscuro)), o modi antinaturalistici di riprendere e rimontare sequenze di realtà (come l’esasperazione al ralenti di un salto con gli sci che diventa così esperienza estatica di un volo oltre le possibilità umane (L’estasi dell’intagliatore di legno Steiner), oppure la ripresa aerea del deserto iracheno con i pozzi di petrolio ancora in fiamme e le tracce della prima guerra del Golfo, dove non ci sono più tracce umane, e tutto pare paesaggio dell’apocalisse al suono di un requiem…(Apocalisse nel deserto)).
Si tratta di cogliere gli strati della realtà e sintetizzare in un’immagine o una sequenza d’immagini la verità di quell’evento, un evento può infatti essere ripreso e fotografato mille volte da mille angolazioni ma soltanto una (o poche inquadrature con un montaggio efficace) sarà capace di rivelarne pienamente il contenuto simbolico (rivelando quindi la verità che quella realtà sottende), ma per fissarlo in immagine bisogna prima “vederlo” (talvolta basta una frazione di secondo), intuirne il valore e il climax drammatico e forzare la realtà ad esprimerlo, come accade nelle fotografie di Cartier-Bresson. Questa è la differenza fondamentale tra uno sguardo che riproduce e uno sguardo che rivela.
Orson Welles, uno degli artisti sperimentatori delle strutture narrative della comunicazione (fu il primo a trasformare un racconto fantastico – La guerra dei mondi di Wells – in una falsa notizia radiofonica che sconvolse l’America), nel suo testamento cinematografico F come Falso (un falso documentario su una falsa biografia di un noto falsario di quadri) spiega come “gli artisti siano dei falsari che attraverso la menzogna si avvicinano un po’ alla verità”. Questo accade quando la finzione artistica si coniuga alla capacità di osservare la realtà (il termine latino observare ha il doppio significato etimologico di guardare e di aderire, uno sguardo che quindi non si limita a percepire o esplorare ma che si posa e si sofferma sul suo oggetto, che vi aderisce e che lo interroga) e diventa prefigurazione e sintesi di essa, uno strumento poetico per interpretare la complessità del reale e svelarne, attraverso la sua messa in scena, gli aspetti di verità. Verità che, com’è noto (un po’ meno noto risulta, ma per “opportunità” di mestiere, agli operatori mediatici), non può essere colta che indirettamente – attraverso le sue maschere – e per via indiziaria.
Anche Jean Rouch, uno dei padri del documentario antropologico, s’immergeva esistenzialmente nel contesto che voleva esplorare, ne individuava temi, situazioni e personaggi chiave e “sceneggiava” il documentario con gli elementi che aveva selezionato di quella realtà, anche elementi interiori, come i sogni dei protagonisti. La realtà riprodotta è, per dirla con Barthes, uno sguardo “ovvio”, mentre la realtà “rappresentata” è uno sguardo “ottuso” (nel senso di aperto, come l’angolo ottuso), per cogliere la maschera rappresentativa della realtà bisogna che ci sia una “regia dello sguardo” (una definizione molto efficace che Liborio Termine aveva proposto nel suo libro La scrittura fotografica).
Dovendo perciò pensare a una nuova definizione del documentario antropologico che, come nel filmato ‘U Gioia, tenti la perigliosa sintesi di osservazione e finzione poetica, di riproduzione e di rivelazione, di regia dello sguardo e forzatura drammatica del reale, di intuito metaforico e di furtiva velocità (quella di Hermes, non a caso protettore di viaggiatori, artisti, maghi e ladri), ma anche di trasparenza e responsabilità etiche, proporrei il termine “antropoetico” sintesi possibile di uno sguardo antropologico, di una visione poetica e di una responsabilità etica.
Il documentario “antropoetico” non è solo la “realtà rubata dagli agguati del cinema” come teorizzava Zavattini, non è la riproduzione fiction di una situazione o vicenda reale interpretata dagli stessi protagonisti reali (il primo fu Flaherty, fino all’attuale volgarizzazione della TV-realtà con i poliziotti, i carcerati, i pensionati, etc che interpretano se stessi), non è la creazione di un contesto artificiale con personaggi “reali” (come i finti reality-show alla Grande Fratello), non è il “montaggio proibito” che impedisce la manipolazione della realtà attraverso il montaggio, non è l’occultamento delle strutture narrative all’interno di una ripresa apparentemente descrittiva (tipico caso dei documentari sulla vita degli animali), non è’ una raccolta “oggettiva” di testimonianze.
E’, piuttosto, immersione in un frammento di realtà con una chiave interpretativa forte, esplicita, poetica o mitologica (quest’ultima è stata scelta da Pasolini per i suoi documentari e appunti per film da farsi), o, in altri termini, una “messa in scena” (e una “messa in inquadratura”) che “costringe” la realtà all’epifania, alla rivelazione della sua complessità e quindi degli aspetti di verità che in essa baluginano. Una realtà che indossa la maschera per iniziare gli spettatori-adepti (non x vocazioni esoteriche ma per capacità di attenzione e ascolto) al viaggio nei suoi misteri.
Una lettera ad Andrea Balzola
Ancora su 'U Gioia di Mauro Aprile
di Fernando Mastropasqua
Caro Andrea,
del tuo interessante intervento sul film ‘U Gioia di Mauro Aprile ho apprezzato in particolar modo l’espressione “sguardo antropoetico”. Ed è seguendo le direzioni verso cui spinge la tua definizione che aggiungo, per quel che valgono, alcune mie considerazioni.
Aprile ha rivolto lo sguardo a un particolare avvenimento, che accade e riaccade nel suo paese, ma, invece di considerarlo nella sua circoscritta realtà, lo ha dilatato inconsuetamente fino a comprendere l’orizzonte di gran parte dell’avanguardia artistica del Novecento. Ha inserito citazioni per affermare che molti sono i luoghi in cui il senso nascosto dell’evento si ripete o si completa, ma pinocchiescamente rovescia a volte la gravità in beffa: nel mentre infonde un altrove nel Gioia immediatamente lo risputa per farne ponte verso altro. Quanto più la citazione può apparire appropriata, Bufalino per esempio, tanto più essa deflagra verso altri mondi, apparentemente incoerenti a uno sguardo superficiale, e se ne ammanta per restituire una visione, mai pensata, pertinente alla realtà contingente, appena sconfessata, in un continuo e vertiginoso détournement situazionista. Chi accusasse questo film di non documentare la festa, avrebbe ragione, e insieme torto, perché la verità della festa non sta nel suo apparire ma nel suo scomparire verso un’altra resurrezione. Quale modo migliore di parlare della Pasqua? Giocare fra il basso e l’alto non è cosa nuova nella nostra cultura, ma il senso nuovo che sperimenta Aprile è dovuto al contesto (la festa - il Gioia) rispetto al tempo presente che la statua del Cristo in bilico attraversa in perenne tentazione di caduta, cui fa da contrappeso la titanica volontà di stravolgerla in trionfale raddrizzamento. Gioia contro Fatica, che non è diversa da quella quotidiana, la vita faticata, e, per i macellai, la morte faticata, il massacro di innocenti animali per garantire una fettina di proteine nel piatto dei ricchi. Se questo è legittimo, perché non dovrebbe esserlo anche la carneficina di altri innocenti per garantire nelle automobiline della giostra dei ricchi un pieno di benzina? Se posso approfittare del gioco delle citazioni per avanzarne una fuori d’opera, mi viene in mente il racconto di Isaac Singer Lo scannatore rituale, in cui il rabbino addetto alla macellazione arriva a tal punto di orrore per il proprio “sacro” ufficio, “Quando si scanna una creatura, si scanna Dio”, che maledice il dio che reclama tale scempio e si suicida.
Contro la smania, che ha colpito anche alcuni promettenti registi, di aderire alla diffusa dottrina che ogni zolla è una cultura, che ogni pur vaga rimembranza di dialetto è alterità in abbandono, devastazione di anime (ma non sono bastati Vitelloni e Basilischi?), Aprile apre un diverso sguardo sull’altro confinato nella sua festa paesana, rompendo il chiuso orizzonte del folklore per parlare di dolore, ferocia, estasi, teatro, rigenerazione, al di là della gabbia dell’opera d’arte, della poesia autografa, della perversa idea dell’unicità del genio. Una intera collettività inconsapevole di ciò che fa, tranne che di esistere per quello che fa, può dire: Io sono Shakespeare, ma senza snobistica ironia. Perché non è vero che ogni zolla è una cultura ma la cultura è in ogni zolla, in ogni piccolo grande pensiero che attraversa obliquamente la nostra mente rischiando di perdere l’equilibrio e di cadere in oblio se una qualche fatalità (la fatica di chi non rinuncia, di chi accetta la vita faticata, poeta o macellaio che sia) non intervenga ad impedirlo, a sostenere quell’oscillante pensiero perché riprenda la sua folle corsa obliqua. Ed all’arte pertiene la fatica di sostenere il peso di quel vertiginoso masso in caduta e di farlo ogni volta riemergere e risalire fino alla sommità da cui è precipitato. Sarebbe bene togliere le firme dai capi di moda ma anche dalle opere d’arte. Poeta è colui che si confonde con gli anonimi uccèri (i macellai che portano il Gioia in spalla) e impedisce il tracollo di quella gioia traballante che ci sovrasta e ci dà senso. E nel farlo perde il nome. Una presenza inattuale, dato che oggi, tra i molti macabri aneddoti che costellano la nostra insensata esistenza, annebbiata da sbornie televisive più che da estasi, si può, pagando profumatamente, vendere il proprio nome perché sia inserito da Stephen King in un romanzo dove un personaggio subirà il mercantesco battesimo; ed è il Gioia un’opera inattuale, che contrasta con rigore la deriva cui siamo destinati, l’omologia universale, consenziente - come pietoso tiranno - a che sia accordato a tutti gli universalmente uguali di rivendicare il proprio assoluto per radici effimere che non affondano neanche un millimetro sotto la terra che incuranti quei cloni calpestano. Così graziose quanto sconsiderate ragazzine ballano tarante nel Salento dimenticando il dolore, la violenza, la rabbia, la sessualità, i desideri repressi, il fetore delle loro sgraziate bisnonne. Radici nella sabbia!
‘U Gioia che parla del dolore non alimenta infettate radici locali: Scicli è un crogiolo di forme e di voci. Sono quelle stesse che hanno dato dignità a quel secolo di orrori, preparatore di futuri orrori, che è stato il Novecento, Scicli è l’universo mondo. Aprile scongiura gli equivoci a cui ha dato luogo la ricerca popolare dagli anni’50 in poi, solleva la festa oltre il confine della tradizione folklorica, non la recinge nel cantone di espressione di ceti incolti cui non sarà mai riconosciuto lo status di poesia, né la esalta come autentica voce del popolo che racconta una visione alternativa del vivere sociale come tanti ricercatori negli anni ’70 hanno creduto, ma la pone nello stesso vortice che ha prodotto il pensiero più libero e rivoluzionario dell’arte, da Benjamin a Nietzsche, da Bacon a Bene, da Deleuze a Debord. Un urlo che è anche una malattia, una insania che non ha mai cambiato il mondo, che è incurabile quanto impotente. Di tale insania ha tutti i pregi, ma anche i difetti, vive negli stessi limiti che profetizza il muto Grido di Munch. Per questo, Andrea, la tua definizione risulta tanto calzante: uno sguardo antropoetico perché ha coscienza della finitezza dell’uomo e della infinitezza del suo dolore.
Mahmud Darwish in tournée italiana con Sandro Lombardi
Dall8 al 18 settembre
di Redazione ateatro
Dall'8 al 18 settembre il poeta palestinese Mahmud Darwish sarà in Italia per presentare il suo poema Murale (trad. italiana Fawzi Al Delmi, Epoché, 2005 Milano).
Darwish - affiancato da Sandro Lombardi - leggerà il suo poema in alcuni dei principali teatri italiani:
- 8 settembre, Teatro Bibbiena, Mantova (durante la prossima edizione del Festivaletteratura)
- 13 settembre, Teatro Storchi di Modena
- 14 settembre, Teatro della Pergola, Firenze
- 17 e 18 settembre, Teatro Garibaldi, Palermo
La lettura teatrale, in arabo e italiano, sarà a cura di Federico Tiezzi.
Mahmud Darwish
MURALE (incipit)
Trad. di Fawzi Al Delmi
Edizioni Epoché 2005
Ecco il tuo nome,
disse una donna,
e scomparve nel cunicolo sinuoso…
Vedo il cielo laggiù, a portata di mano,
e l’ala di una colomba bianca mi porta
a un’altra infanzia. Non sogno
di sognare. Ogni cosa è reale.
So che abbandono me stesso…
E m’involo. Sarò ciò che diventerò
Nell’ultimo firmamento. E ogni cosa è bianca,
il mare sospeso sul tetto di una bianca nube
e bianco il nulla nel cielo bianco dell’assoluto.
Sono e non sono stato. E sono solo, sul limitare
di questa bianca eternità. Giunto prima della mia ora,
non un angelo è apparso per dirmi:
“Che cos’hai fatto, laggiù, sulla terra?”.
E non ho udito l’esultanza dei giusti,
né il lamento dei peccatori. Sono solo, nel biancore,
solo…
Nulla mi addolora alla soglia della resurrezione,
non il tempo né i sentimenti.
Non sento la leggerezza delle cose né il peso
dei tormenti. Non trovo a chi domandare:
dov’è, ora, il mio dove? Dov’è la città
dei morti e io, dove sono? Non c’è il nulla,
qui, nel non-qui… nel non-tempo,
e non c’è esistenza.
Come se fossi già morto prima d’ora…
So cos’è questa visione, so che
sto andando verso l’ignoto. Forse
in qualche luogo continuo a esser vivo
e so ciò che voglio.
Un giorno sarò ciò che voglio.
Mahmud Darwish

Mahmud Darwish è indubbiamente uno dei più rappresentativi poeti palestinesi del nostro tempo, la voce più importante nella lotta per l’indipendenza palestinese. Da oltre quarant’anni i suoi versi ritraggono profondamente la tragica esperienza della Palestina. Mahmud Darwish nasce a Birwa, un villaggio della Galilea (Palestina), dove trascorre l’infanzia fino al 1948, data in cui la famiglia è costretta all’esilio in Libano. Quando un anno dopo i genitori tentano di tornare in patria, constatano che il loro villaggio è stato raso al suolo e rimpiazzato da una colonia ebraica. Allora raggiungono Dayral-Assad, dove vivranno in semi-clandestinità. A causa delle sue poesie, Darwish sarà imprigionato cinque volte tra il 1961 e il 1967. Lavora come giornalista a Haifa, poi si esilia in Libano dal 1971 al 1982 e infine raggiunge Tunisi. È stato detenuto nelle carceri israeliane, e molte volte costretto agli arresti domiciliari, a causa dei suoi scritti e della sua attività patriottica. Per questi motivi non ha potuto frequentare l’Università. Nel 1970 inizia così a studiare a Mosca, e da qui, nel 1971, si trasferisce al Cairo. Mahmud Darwish è stato a capo del Centro di ricerca Palestinese, editore del giornale Palestinian Affaire Magazine, direttore dell’Associazione degli Scrittori e Giornalisti Palestinesi, fondatore del giornale dell’Associazione, Al Karmil Magazine e, più tardi, membro della Commissione Esecutiva dell’OLP, da cui si è dimesso nel 1993. Nel 1996, dopo 26 anni di esilio, è tornato in Palestina e si è stabilito a Ramallah.
Bibliografia Sintetica
Memoria per l’oblio, Jouvence, 1996
Perché hai lasciato il cavallo alla sua solitudine, San Marco de’ Giustiniani, 2001
Murale, Epoché, in libreria a settembre 2005


