L'editoriale di ateatro 73
E se ci dessimo alle buone pratiche?
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and1
Le Buone Pratiche il 6 novembre a Milano
Una banca delle idee per il teatro italiano: perché ci dovete essere (e come fare per esserci)
di Franco D'Ippolito, Mimma Gallina e Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and2
Gli Stabili danno i numeri
In margine al Libro Bianco presentato a Genova
di Franco D'Ippolito
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and4
Verso le buone pratiche?
L'intervento all'incontro di Napoli
di Adriano Gallina
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and5
La festa e l'utopia
Diario dal Festival d'Avignon (parte prima)
di Erica Magris
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and9
Il teatro e lo «Spirito della terra»
Un festival etno-ecologico per scoprire la Siberia e le periferie del teatro russo
di Mimma Gallina
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and10
The Grammelot Professor
Il teatro epico di Dario Fo e Franca Rame nelle classi di italiano in Nord America
di Walter Valeri [Harvard University]
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and40
Le recensioni di "ateatro": IX Crescita per la Tragedia Endogonidia di Romeo Castellucci
Per Uovo performing arts festival
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and50
A Torino la terza edizione del Malafestival
Il programma
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and73
Al Pacino è Shylock nel film di Michael Radford
Alla Biennale di Venezia e nel Bardofilm database
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and81
Italy for Rwanda 1994-2004
Un progetto per capire, per non dimenticare
La tournée italiana di Rwanda 94, lo spettacolo di Jacques Delcuvellerie
di Italy for Rwanda
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and82
Il Festival del Ticino si apre ai nuovi progetti
Nasce la sezione "Lavori in corso"
di Festival del Ticino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and83
Il nuovo numero di "Prove di drammaturgia"
Il teatro di narrazione: una nuova performance epica?
di Redazione "Prove di drammaturgia"
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and83
La quinta edizione dei Teatri delle diversità
A Cartoceto il 9 e 10 ottobre
di Teatri delle diversità
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and85
E' scomparso Giovanni Raboni
Poeta, scrittore, critico e autore teatrale
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and86
Maria Giovanna Elmi sarà il nuovo presidente dello Stabile del Friuli-Venezia Giulia
La nomina di competenza del Comune
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and87
Nasce IRIS, l'associazione sud-europea per la creazione contemporanea
Raccoglie 55 teatri e festival di Francia, Italia, Spagna e Portogallo
di IRIS
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and88
Il forum IETM a Milano dal 17 al 21 novembre
ateatro parteciperà al forum
di IETM
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and89
Fritz Kater autore tedesco dell´anno per il 2004
Secondo il referendum di «Theater Heute»
di Charlotte Menin
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and90
Ancora polemiche per lo Stabile del Veneto
I Ds divisi sulla proroga del mandato a De Fusco
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and91
|
L'editoriale di ateatro 73
E se ci dessimo alle buone pratiche?
di Redazione ateatro |
Attesa, attesissima, arriva la convocazione per le Buone Pratiche. Ci vedremo il 6 novembre alla Civica Scuola d’Arte Drammatica di Milano per una giornata che si preannuncia intensa e interessante (ci sarà persino il buffet...).
In ateatro73 trovate tutte le informazioni necessarie: contiamo naturalmente sul vostro contributo e sulla vostra partecipazione. Se non siamo stati chiari, se avete qualche dubbio, se volete darci qualche consiglio, siamo a vostra disposizione.
Nel numero ci sono anche alcuni spunti di riflessione che possono essere utili nella preparazione dell’incontro.
Ma in questo ateatro73 si parla anche d’altro, di molto altro. Per esempio due strepitose ateatro girls ci raccontano i loro festival estivi: Erica Magris è andata a gironzolare nel padre di tutti i festival, quello di Avignone, e ci ha regalato il suo diario; più esotica, Mimma «Strogoff» Gallina si è spinta fino al cuore della Siberia, là dove nessuno di noi si era mai sognato di avventurarsi, per il festival etno-etnologico di Abakan.
Dagli Stati Uniti, Walter Valeri ci raccontano che laggiù usano i testi di Dario Fo per insegnare l’italiano.
E ancora notizie notizie notizie, spesso gustose e golose.
|
Le Buone Pratiche il 6 novembre a Milano
Una banca delle idee per il teatro italiano: perché ci dovete essere (e come fare per esserci)
di Franco D'Ippolito, Mimma Gallina e Oliviero Ponte di Pino |

Ideazione e (dis)organizzazione Franco D'Ippolito, Mimma Gallina e Oliviero Ponte di Pino
Sabato 6 novembre
Milano, Civica Scuola d'Arte Drammatica «Paolo Grassi»
via Salasco 4
dalle 10 alle 18.30
PREMESSA: ISTRUZIONI PER L’USO
L’incontro si terrà in dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.
Verrà articolato in sessioni, condotte da un moderatore, con brevi relazioni (max 10 minuti, con rigido rispetto dei tempi) che illustrino le Buone Pratiche.
Abbiamo previsto un «coffee break» e un «lunch break» sul posto (l'iniziativa è autofinanziata: portate qualche euro, per favore, altrimenti niente caffè né focaccine al prosciutto...).
Se venite verso le 9,30 vi guardate meglio i documenti preparatori, che verranno esposti il loco.
Ringraziamo di tutto cuore la Civica Scuola d'Arte Drammatica «Paolo Grassi» per l'ospitalità.
LE BUONE PRATICHE
In ateatro71 abbiamo lanciato l'iniziativa «Le Buone Pratiche. Una banca delle idee per il teatro italiano». L'iniziativa si muove nella scia degli incontri Nuovo Teatro Vecchie Istituzioni e ne riprende alcuni aspetti.
Ci sono stati parecchi riscontri al nostro documento, abbiamo lavorato e ora passiamo alla fase esecutiva.
Che cosa intendiamo per Buona Pratica?
Per noi una Buona Pratica è una iniziativa o un metodo di lavoro che considerate efficace e utile (o che ha avuto successo in passato) e che pensate possa e debba essere riprodotto da altri;
oppure un progetto che vi sembra possa essere utile ad altre realtà che operano nel campo del teatro (per esempio società di servizi o reti).
Insomma, non si tratta di dire: «Guarda come sono stato bravo a fare questa cosa» (siete tutti bravissimi, lo sappiamo), ma: «Adesso ti spiego come ho fatto questa cosa bella & utile che ho imparato a fare io, così lo potrai fare anche tu, a casa tua (e magari potremo farla insieme)».
Non si tratta di illustrare i vostri progetti (interessantissimi, ne siamo sicuri), ma di dire: «Ho fatto» (o anche «Ho in mente di fare») «questa cosa con te e per te/per noi. Ti spiego qual è l'obiettivo del progetto, come funziona e perché deve interessare anche te».
Come procediamo per illustrare con chiarezza le nostre Buone Pratiche?
L'incontro è ovviamente aperto a tutti. Quello che invece chiediamo a chi voglia presentare una relazione (insomma, a chi voglia raccontarci la sua Buona Pratica) è di inviare all'indirizzo mail info@ateatro.it entro il 25 ottobre prossimo una breve scheda (circa 4000 battute) che illustri - appunto - la vostra Buona Pratica: in che cosa consiste, perché è utile, quali sono gli elementi «riproducibili» - e magari quelli da non riprodurre.
Ci interessa sapere in cosa consiste, ma soprattutto il metodo, le forme di finanziamento: insomma vi chiediamo di essere molto concreti, magari facendo anche qualche cifra.
Quando parliamo di «Banca delle Idee», sappiamo che possono esserci idee, anche molto buone, che non è stato possibile realizzare. Non vi chiediamo di raccontare i sogni nel cassetto, ma SE avete dei progetti concretamente strutturati (scopo, metodo, finanziamenti), che ritenete utile condividere, o che forse qualcuno o voi stessi potreste realizzare altrove, mandateceli pure!
L'insieme di queste schede confluirà nella Banca delle Idee, consultabile da tutti sul sito www.ateatro.it
Vorremmo che l'incontro fosse davvero utile. Per questo abbiamo pensato a una giornata intera di lavoro, con una griglia tematica di riferimento, per sollecitare il vostro apporto.
I temi che abbiamo individuato saranno precisati meglio da relazioni introduttive (non troppo prolisse!), anche alla luce dei materiali pervenuti e da qualche intervento che ci riserviamo noi stessi di sollecitare.
Sollecitiamo anche la presenza di OSSERVATORI: artisti, autori, critici, rappresentanti istituzionali, direttori di teatri, festival, circuiti (alcuni ci hanno già garantito che ci saranno).
Per ora (ma non escludiamo che le vostre proposte disarticolino un po' lo schema), riteniamo di poter raccogliere le Buone Pratiche (e le idee e i progetti) secondo i seguenti nuclei tematici. Le esemplificazioni riguardano pratiche/interventi che ci sono già state segnalate o che abbiamo sollecitato. Ma attenzione! questo non vuol dire che siano le più importanti (o le sole).
1. MODELLI DI PRODUZIONE, DI SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE, DI GESTIONE DELLE IMPRESE TEATRALI
Si è parlato molto di razionalizzazioni e fusioni, che sono tra l’altro incoraggiate dalle recenti normative. Ma ci sono fusioni - temporanee o definitive - davvero riuscite?
Rimescolare le carte nella formazione delle compagnie integrando personalità e artisti diversi (per stile, generazione etc.) può essere una buona pratica: come nasce e può essere gestita?
Parliamo dell'efficacia dei «bandi» e delle diverse forme di selezione dei giovani e delle nuove realtà - dopo anni di verifiche - e del sostegno produttivo attraverso l’esame di «corti» (il metodo usato per esempio dal Premio Scenario) o «progetti».
Ma siamo certi che su questo argomento ci sono molte pratiche da raccontare.
2. MODELLI DI DISTRIBUZIONE, DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE DEGLI SPAZI
Si tende a ignorare, a livello nazionale il funzionamento di alcuni «microcircuiti» e di qualche teatro comunale che si è «reinventato».
Sarà utile analizzare lo spazio, la funzione e i modi di fare teatro nei Centri Sociali: ci sono ricerche e progetti concreti.
Ci interessa capire come all'interno di realtà istituzionali (Stabili, circuiti) può esserci davvero spazio per un teatro giovane, per un rinnovamento del linguaggio teatrale e per il ricambio generazionale.
Nella periferia delle grandi città - da Milano a Napoli - si stanno creando di fatto reti di teatri, con progetti di programmazione: analizziamo in concreto l'avvio di queste esperienze.
Ma ancora: ci sono esperienze funzionanti (esportabili) di gestione comuni di spazi? pratiche di «residenza» da cui si possa imparare?
3. MODELLI E TECNICHE DI FINANZIAMENTO E DI AUTOFINANZIAMENTO
Funziona l'«azionariato popolare» lanciato per finanziare alcune produzioni?
Acquistare il proprio teatro/spazio: come autofinanziarsi, quali vantaggi può portare.
Ma su questo tema ci interessano anche pratiche molto specifiche: avete scoperto una tecnica miracolosa per convincere gli sponsor? Riuscite a finanziare una sala teatrale (o un festival) con altre pratiche? Gestione di bar e locali, corsi e seminari, noleggi di materiale o di spazi possono tappare qualche buco: ma con quali regole e in che rapporto con l’attività «creativa»?
4. ASSOCIAZIONI DI COMPAGNIE, RETI E SERVIZI COMUNI
Area 06 a Roma, Faq a Milano: in cosa consistono queste associazioni tra compagnie? Hanno funzionato? Il modello è migliorabile ed esportabile?
E’ possibile pensare a società di servizi (e centri di servizi) che possano diminuire i costi di alcune funzioni (per esempio ufficio stampa, fornitura materiali tecnici o servizi)?
C'è qualche idea per razionalizzare e rendere più economico l'uso delle sale prove? O per mettere in comune attrezzature nei periodi fermi?
Ma in questi mesi sono state lanciate altre forme di associazione, come l’Associazione Luz (sul versante della produzione cinematografica) e Iris (sul versante delle relazioni internazionali).
5. NONSOLOTEATRO: IL CONFRONTO E LA CONTAMINAZIONE
Che rapporto può esistere tra il teatro e la radio e la televisione? Internet e i nuovi canali tematici possono offrire una nuova opportunità?
E’ possibile pensare a sale polivalenti in cui il teatro sia solo una parte dell’offerta (accanto a musica, cinema, eccetera).
E’ possibile che il teatro «invada» in qualche modo gli spazi museali - magari evidenziando il rapporto con le arti visive?
6. TUTTO QUELLO CHE MANCA
Certamente ci direte che abbiamo dimenticato molte cose fondamentali, importantissime: per esempio la FORMAZIONE, gli SCAMBI INTERNAZIONALI, il SUD e le AREE DISAGIATE, la PROMOZIONE e il MARKETING, l’INFORMAZIONE e la CRITICA, il RAPPORTO CON GLI ENTI LOCALI...
Non ce li siamo dimenticati! Ci interessano tutte le Buone Pratiche (nell'accezione di cui sopra) ci interessa. Dunque ne avete in mente qualcuna, fatecelo sapere.
IL PROGRAMMA DELL’INCONTRO
Prima dell'incontro contiamo di mettere sul sito www.ateatro.it un programma articolato, con l'elenco degli interventi e i nomi degli osservatori che ci hanno garantito la loro presenza.
Potete (dovete...) anche segnalare la vostra adesione e partecipazione utilizzando il forum Nuovo Teatro Vecchie Istituzioni.
Come sempre attendiamo idee, suggerimenti, obiezioni, consigli, sconsigli (il sito e i forum sono a dispo). Se volete approfondire, nell'archivio di ateatro, trovate altro materiali, riflessioni, relazioni, e quant'altro.
E aggiorneremo via via il sito con ulteriori informazioni, materiali e contributi alla discussione.
|
Gli Stabili danno i numeri
In margine al Libro Bianco presentato a Genova
di Franco D'Ippolito |
In attesa di futuri approfondimenti qualititativi e di contestualizzazioni critiche, che vadano aldilà dei pur utili e importanti dati quantitativi del Libro Bianco dei Teatri Stabili Pubblici (presentato a Genova dal Presidente dell’Antad Luca De Fusco lo scorso 21 settembre), alcune riflessioni si impongono. La dimostrazione data "di essere quantitativamente la spina dorsale del teatro italiano" richiede un approfondimento critico di cui non vi è ancora traccia nelle dichiarazioni di De Fusco: può bastare fare tutta quell’attività, avere tutti quei teatri, dare occupazione a tutti quei lavoratori per motivare e sostanziare il ruolo "pubblico" dei 16 Stabili italiani a cui sono destinate (in proporzione al numero dei soggetti) le maggiori risorse statali, regionali e degli Enti Locali, in termini di strutture e di finanziamenti? Ci saremmo anche attesi, avendo scelto di pubblicare un "libro bianco" (dal Dizionario dell’Enciclopedia di Repubblica: "raccolta di documenti e testimonianze per denunciare all’opinione pubblica un grave problema sociale…"), una qualche autocritica per gli errori e i ritardi, artistici e organizzativi accumulati soprattutto negli ultimi difficili anni del teatro italiano e che i più sinceri hanno più volte pubblicamente riconosciuto (per esempio con un po’ di coraggio si sarebbe potuto affrontare dall’interno il delicatissimo tema del rapporto fra rappresentanze politiche dei Consigli di Amministrazione e responsabilità di gestione delle direzioni, di cui le cronache degli anni anni hanno testimoniato le anomalie).
Il "libro bianco" è costituito da 49 pagine di nomi e numeri (riferiti all’attività 2003) privi di alcun commento. Alcuni numeri mi hanno comunque colpito.
GLI SPETTATORI: complessivamente alle recite di proprie produzioni partecipa il 52,5% del totale degli spettatori nei 77 teatri e spazi gestiti dagli Stabili pubblici. Il dato appare subito nel suo valore complessivo importante e significativo, salvo poi riscontrare che nella metà degli stabili che si collocano al di sotto di quella media vi sono quasi tutti gli stabili più importanti: Piccolo di Milano (32,7%), Teatro Stabile di Torino (35,7%), Stabile del Veneto (39%), Teatro di Roma e Metastasio di Prato (44%), Centro Teatrale Bresciano e Emilia Romagna Teatro (44,5%), Stabile dell’Umbria (45%). Infine una vera e propria curiosità: perché il Piccolo ed il Biondo forniscono ancora dati quantitativi sull’affluenza del pubblico nelle proprie sale nel 2003 "approssimativi"?
I LAVORATORI: fra registi e collaboratori artistici del regista, attori, tecnici ed impiegati gli Stabili pubblici impegnano 3.492 lavoratori dello spettacolo per 263.651 giornate lavorative complessive. Mi ha colpito il dato "astratto" (ma significativo credo) di una media di 75,5 giornate per unità lavorativa, scarsi tre mesi di lavoro (al netto del 10% dei lavoratori fissi, la media scende a soli due mesi di lavoro). Dai dati "astratti" della media delle giornate lavorative che i singoli Teatri Stabili hanno dichiarato nel 2003, possiamo rilevare come la forbice relativa alla stabilità media dei lavoratori sia amplissima, dalle 27 giornate (un mese di lavoro) del Metastasio di Prato alle 136 giornate (cinque mesi di lavoro) dello Stabile di Genova. Sempre nel dettaglio dei dati forniti da ogni Stabile, mi sembra anomalo e degno di riflessione critica quello relativo al numero di impiegati fissi e stagionali dello Stabile del Veneto, ben 85 su 156 lavoratori complessivamente impegnati nel 2003 (il 54,5%), a fronte di un rapporto che in tutti gli altri teatri stabili va dal 4% sul totale dei lavoratori dello Stabile di Bolzano al 30% dello Stabile d’Abruzzo. Qualche perplessità inoltre suscita il dato relativo al numero di giornate lavorative globali del Centro Teatrale Bresciano (4.266) e del Teatro Metastasio di Prato (4.060): la normativa ministeriale vigente dispone per i Teatri stabili ad iniziativa pubblica la effettuazione annua di almeno cinquemila giornate lavorative (art 11 DM 27.02.2003): si tratta di un erronea indicazione del "libro bianco"? Così come erronea potrebbe essere anche l’indicazione del numero di recite di produzione programmate nel 2003 dallo Stabile del Veneto (126) a fronte dello stesso articolo della normativa ministeriale che ne prevede almeno centotrenta.
Fra curiosità e riflessioni riponiamo il "libro bianco" tra i fogli statistici e aspettiamo che la Commissione ministeriale decida a fine settembre quanti dei soldi spesi in questi 9 mesi e di quelli impegnati contrattualmente nei 3 mesi che restano del 2004, sulla base di un progetto preventivo presentato a settembre 2003, troveranno copertura nella sovvenzione ministeriale. Un modo migliore per non entrare nel merito dei progetti presentati e mettere ancor di più in braghe di tela il teatro italiano non potevano inventarselo.
|
Verso le buone pratiche?
L'intervento all'incontro di Napoli
di Adriano Gallina |
Devo dire che mi ha molto stimolato l’intervento di Franco D’Ippolito. Noi in questi giorni abbiamo avuto occasione di chiacchierare un po’ ma non avevamo concordato in maniera dettagliata i nostri interventi. Devo dire che – ma non ne dubitavo – da un lato apprezzo molto la concordanza della stragrande maggioranza delle cose che ha detto con quelle che andrò dicendo; in secondo luogo Franco mi pare finire – ovviamente con alcune sovrapposizioni – dove in qualche maniera inizia il mio tema, il mio intervento.
Devo fare alcune premesse, che mi sembrano importanti. La prima è sottolineare nuovamente la natura di questo incontro, già evidenziata da Lello Serao ma che mi pare necessaria: non si tratta cioè di un convegno nel quale vengono esposte delle "tesi congressuali". Semplicemente sono stati chiamati degli organizzatori a formulare idee e riflessioni da leggere, lo devo dire con molta chiarezza, in chiave largamente dubitativa e quindi realmente aperte al dibattito; spesso anzi – è questa un’altra caratteristica che ritengo fondamentale dell’incontro – anche avanzate in maniera piuttosto "brutale": per una volta forse abbiamo la possibilità di non trovarci in un contesto di difesa corporativa di un esistente a-priori da sostenere e giustificare di fronte all’istituzione, ma di poter realmente mettere in gioco pratiche e dubbi di un mondo che – se pure nominalmente condivide una koiné generale o generica – è nella realtà dei fatti molto più frammentato e frastagliato al proprio interno di quanto non amiamo pensare o far pensare. Nelle nostre chiacchiere di corridoio in queste situazioni la reale unità del nostro mondo spesso mostra il metallo che sta sotto la vernice della facciata: credo di conseguenza siano questi i contesti in cui le cose si possono dire con una certa franchezza della quale mi scuso all’inizio ma che ritengo sia fondamentalmente doverosa.
Il tema che mi è stato assegnato e che mi interessava di più affrontare è il tema del mercato per il nuovo teatro, laddove per "nuovo teatro" – in linea con le denominazioni ministeriali che rischiano di diventare in realtà delle prescrizioni ministeriali – faccio riferimento al settore dell’innovazione teatrale e quindi genericamente all’area del teatro ragazzi e del teatro di ricerca e sperimentazione: sapendo che gran parte di quanto dirò – anche se io provengo e lavoro nell’ambito del teatro ragazzi – è in larga misura forse più applicabile al settore del teatro di ricerca (nel quale da qualche anno opero in maniera più continuativa in termini di programmazione) perché ritengo che, sia pure con questa koinè che ho esplicitato all’inizio, esistano fondamentali differenze storiche fra i due settori, di collegamento con il pubblico e con l’ente locale, che non possono essere assolutamente essere poste fra parentesi all’insegna di una generica univocità artistica, di modi di produzione, di metodologie o di orientamenti culturali. Nel senso che indiscutibilmente, sia pure in una fase caratterizzata da una notevole contrazione e flessione, il teatro ragazzi ha di fronte a sé una dimensione di mercato più consistente di quanto non avvenga tendenzialmente per quella che genericamente possiamo chiamare "ricerca". Diciamo quindi che le cose che dirò in linea di massima non saranno differenziate, nel senso che non introdurrò ogni volta le determinazioni d’oggetto, ma saranno più marcatamente riferite al teatro di ricerca.
Un’altra premessa fondamentale che vorrei fare è la seguente. Uno degli argomenti che inevitabilmente affronterò anch’io - e che però mi pare monopolizzino in maniera ossessiva e a volte quasi condizionante le nostre possibilità di immaginazione artistica ed organizzativa – è il tema dell’interlocuzione con il soggetto istituzionale a tutti i livelli: che sia il Ministero, che siano le Regioni, che sia l’ETI che siano gli Enti Locali territoriali, il problema in tutti questi casi è sempre quello della relazione di un mondo, una classe di operatori ed imprese, con un interlocutore istituzionale. Esiste però un altro ambito di discorso, che io ritengo essenziale e che a volte nella difficile relazione di dialogo o di conflitto che c’è per esempio fra le compagnie e le stabilità acquista una primaria importanza: quello della reale pratica organizzativa del nostro mondo, delle scelte e dei percorsi economici, vocazionali reali e concreti. Un tema che non ha un’importanza minore: anzi in molti casi io credo possa essere nel suo effettivo farsi, nella sua effettiva prassi, un elemento fondamentale anche per porsi in maniera più significativa in relazione con l’interlocutore istituzionale.
Il versante della politica – i temi dell’allocazione delle risorse, la vertenza sul valore reale del FUS, tutto l’ambito del complesso, confuso e cristallizzato passaggio Stato/Regioni – è evidentemente essenziale ed è quello, dicevo, che assorbe la gran parte del nostro tempo e del nostro interesse. La mia sensazione è oggi – e in questo mi allineo con l’area degli economisti più disincantati, non necessariamente a matrice neoliberista anzi molto spesso di scuola keynesiana – che il dato che dobbiamo avere ben presente (ed è il motivo per cui il tema del mercato acquista oggi un’importanza centrale) è che è totalmente inutile credere o sperare che nuove amministrazioni più illuminate di quella che sta demolendo questo paese possano in qualche maniera invertire in tempi rapidi, o anche sulla durata medio-lunga, l’andamento del FUS ed in generale dei finanziamenti sullo spettacolo. Cioè il quadro è questo, fondamentalmente, la coperta è questa. Il problema non è quindi continuamente e parossisticamente chiedere l’estensione di questa coperta, in una sorta di ecumenismo che non vede la realtà dei fatti, ma semmai porre continuamente – l’hanno detto Franco con riferimento all’ETI e Lello in relazione ai circuiti – il problema politico dell’allocazione delle risorse, cioè di come le risorse vengono ripartite e di cosa si intende per contribuzione alle attività culturali ed in particolare al teatro. Il problema della "coperta corta" implica un orientamento politico più generale relativo alle visioni alternative del sistema del Welfare e alla sua considerazione. In questo io ritengo che – nonostante le irritazioni che pare abbia suscitato a Bologna – sia un nostro potenziale alleato il Prof. Trimarchi (che io ritengo attualmente una delle teste più lucide, e certamente più dei teatranti, rispetto alle visioni sulle prospettive possibili di sviluppo del nostro mondo) nel suo sostenere il fatto che il teatro, la contribuzione al teatro, possa essere considerata come una necessità per il reale progresso del paese, per il futuro del paese. Il fatto quindi che la spesa per il teatro non venga considerata appunto come una spesa ma come un reale investimento che prima o poi torna.
Da questo punto di vista – ce lo siamo detto e ripetuto rispetto all’ETI e ai circuiti – la questione consiste nel porre continuamente al centro dei nostri discorsi, quasi a norma fondamentale dalla quale discendano le nostre pratiche (e io credo in fondo anche le nostre scelte politiche in senso più generale), il tema della ratio, del senso e della funzionalizzazione dell’intervento pubblico sul teatro. Finché ci limiteremo al contrario a giustificare investimenti a pioggia senza entrare in valutazioni che inevitabilmente condurranno il conflitto all’interno del nostro stesso mondo, ed in particolare dell’AGIS, noi non faremo politica per l’innovazione teatrale. Fin quando noi ammetteremo pacificamente - dimenticandoci per esempio di ciò che fu il progetto "Aree disagiate" – che l’ETI possa oggi definire programmi di sostegno al "teatro privato di qualità" e nel contempo esaurire le sue risorse nel progetto francese o nella gestione diretta dei suoi teatri senza assolvere minimamente alle funzioni ad esso istituzionalmente definite(1), noi non faremo attività politica ma ci limiteremo solamente ogni volta, in maniera un po’ corporativa e francamente inutile, a sostenere nei fatti una "notte in cui tutte le vacche sono nere". Dobbiamo cioè iniziare, in maniera molto rigorosa e anche brutale, a definire i contorni del nostro mondo e a sottolineare il fatto che il teatro non è uno ma è molti, che il teatro d’innovazione è "altro" rispetto a molto altro teatro (non si tratta qui – non necessariamente - di determinazioni qualitative, ma di rischio e di valenza culturale).
Porre quindi in continuazione il problema della logica dell’intervento pubblico: con intransigenza, ma anche con la disponibilità - nel momento in cui si chiede equità e rigore nell'applicazione delle regole e dei parametri - a mettere in gioco la qualità in un contesto in cui il sistema deve essere rivisto, per riporre al centro dell'osservazione pubblica anche le rendite di posizione sedimentate e consolidate. (2) Io credo cioè che il sistema possa essere sbloccato e disingessato solamente se noi siamo disposti di principio - a periodi triennali, o anche sul medio/lungo periodo - a sottoporci (domani c’è uno spettacolo su Kant, quindi consentitemi la citazione) ad una sorta di "critica della ragione", di "tribunale della ragione", e a mettere in discussione le nostre qualità, i nostri numeri e le nostre rendite di posizione. Se così non è, il sistema è bloccato strutturalmente, non c'è possibilità di cambiamento. Le variazioni possono andare solo nella direzione di un impossibile allargamento della coperta: e se le nostre rendite di posizione sono ingiustificabili sul versante della qualità e del reale lavoro (e io ritengo che molto spesso purtroppo questo sia, anche all'interno dell’innovazione come giustamente diceva Franco) noi saremo complici di un ingessamento e di una mancanza di prospettive che alla fine opererà anche contro noi stessi.
Vorrei aggiungere altre due o tre premesse sgradevoli. Detto questo, e detto che l'istanza fondamentale è quella di porre al centro della riflessione e della pratica politica - dell'interlocuzione anche territoriale con gli enti locali, con le regioni - il tema del senso dell'investimento pubblico, esistono però alcune osservazioni che a mio avviso dobbiamo tener presente e che devono costituire una sorta di esame di realtà anche per noi.
Io non credo che questo tema possa essere facilmente recepito: il problema dell’interlocuzione istituzionale è essenzialmente quello della "sordità" dell'ascoltatore, cioè del suo orientamento politico complessivo; della necessità "conservativa", in larga misura persino giustificabile, del mondo della politica – di qualunque parte – di non creare terremoti all'interno dei sistemi che gestisce, di mantenere quanto più possibile lo status quo anche a costo della conservazione di grandi sovrastrutture di iniquità. E questo non avverrà facilmente a meno che il mondo del teatro d'arte non riesca a trovare interlocutori reali che ne riconoscano, condividano e comprendano l'importanza: in quel palazzo lì, cioè nel palazzo e nei palazzi della politica.
Ma devo aggiungere subito, in secondo luogo, che non credo però che questo riconoscimento sia automaticamente implicito in questa o in quella parte politica. (3) Non lo è: questa o quella parte politica può avere orientamenti differenti rispetto ad una visione complessiva del welfare, cioè della spesa in generale per il pubblico ed in particolare per la cultura, ma non nel merito delle attività teatrali. Un qualunque interlocutore politico che non sia strettamente competente di teatro, per quanto aperto alla cultura in senso generico, non riuscirà mai a discriminare fra il nuovo teatro, il teatro privato di intrattenimento, il teatro ragazzi (normalmente considerato puro servizio funzionalizzato allo svago dei bambini) ecc.
Non illudiamoci, dunque, che tutto questo possa avvenire nel momento in cui ci fosse un - tanto auspicato per altri versi - cambiamento di direzione politica.
Il terzo punto - sgradevolissimo, ma necessario da affrontare una buona volta – è che io ritengo impossibile e sempre più evidentemente inutile pensare che una significativa vertenza in queste direzioni che sto cercando di definire, di individuare, possa nascere o essere condotta dall'interno dell'A.G.I.S. Cioè l'A.G.I.S. non è più il palazzo deputato alla vertenza per il teatro d'arte. L'AGIS in quanto tale può fare genericamente le vertenze che chiamo "à la Francesconi" (4) : noi non possiamo pensare di poter marciare su una linea di difesa del teatro d’arte insieme alle stesse persone che quel teatro, nella prassi quotidiana e al di là della genericità delle richieste e delle petizioni di principio sull'investimento pubblico, ostacolano e avversano quotidianamente.
Infine - pongo la questione in forma dubitativa, ma ritengo che in un contesto di grande franchezza, quale questo, vada comunque posta - io non credo più che una prospettiva genericamente corporativa o di settore, basata su una specie di autoreferenzialità autoinclusiva del nostro mondo (5) sia sensata: non è più sensata. Abbiamo all'interno del nostro mondo così auto-definito una quantità di dislivelli e di disomogeneità qualitative talmente clamorosa che la vecchia formula, che tante volte ci siamo ripetuti, della "quantità che riflette la qualità" o dei "parametri quantitativi indice dei parametri qualitativi" deve essere ampiamente relativizzata: ancor più nel momento in cui poi, nelle nostre litanie di corridoio, quello stesso mondo che noi in teoria dovremmo andare a difendere sindacalmente di fronte alle istituzioni lo definiamo fra noi "imbarazzante", "scandaloso", "filodrammatico" e chi più ne ha più ne metta. E questo valga – è un dato di questi giorni - anche (e ancor più) di fronte a compagnie finanziatissime e con numeri certo "sospetti" ma più che decorosi, almeno formalmente.
E allora, anche in relazione alla questione AGIS che ho posto in precedenza: io credo che se – non necessariamente in termini formalizzati – non facciamo un serio esame della possibilità di individuare fra noi delle affinità, delle forme di "scelta tra affini"; se non riusciamo ad introdurre delle forme di selezione e riconoscimento fondate strutturalmente (perché rimane vera a priori la domanda "chi selezionerà i selezionatori?") sull'assunzione della parzialità del giudizio estetico ed artistico (in base alla quale ci si sceglie fra simili, che si riuniscono non per categoria ma per riconoscimento), io temo che quando un giorno andremo dalle istituzioni a chiedere di assistere ai nostri spettacoli rischieremo degli autogol clamorosi. Mettiamocelo in testa, lo diceva giustamente anche Franco: non possiamo continuare a difendere - anche internamente al settore dell'innovazione - tutti in maniera indifferenziata. Ed esistono valutazioni che non si riflettono e non sono inquadrabili nelle analisi quantitative ma che sono giustificabili solo in chiave qualitativa (6) : io credo che quest’approccio sia molto difficile da sostenere e da portare avanti, ma credo altresì che sia sempre più necessario. Perché la questione investe anche il senso profondo del nostro lavoro. Difendere a-priori una categoria, sostenerne acriticamente una qualità che è tale solamente nelle dichiarazioni di principio e nei sempre più rari nuclei di reale eccellenza del nostro mondo, rischia di vanificare anche profondamente il senso culturale del nostro lavoro.
Pongo tutto questo in chiave problematica: ma io non credo che noi potremo andare sensatamente dalle istituzioni a rivendicare un qualsivoglia primato di eccellenza, o una qualsivoglia patente di innovazione, finché andremo avanti con questo modello acritico in base al quale – direbbe Secchioni - "spuntano a grappoli i poeti".
Quest’ultima annotazione mi consente di uscire dall'ambito della politica in senso ampio e di entrare un po’ più nel merito del tema del mercato.
In questa prospettiva, relativa all'orientamento sul Welfare ed in generale al FUS, il mercato acquista una primaria importanza perché diventa l'unica sorgente di autonomia possibile delle imprese. Un mercato che ha, è stato evidenziato a più riprese, delle dinamiche di sclerotizzazione assolutamente clamorose e che è in larga misura ingessato e che però è strutturalmente costituito sul giro. Non esiste un sistema di stabilità in Italia. E anche laddove le stabilità, come evidenziava Franco, hanno "fatto sistema" (in particolare nel caso delle stabilità pubbliche ma io credo anche in buona misura nel caso delle stabilità private), si tratta comunque di una sorta di sistema entropizzato, che mantiene le energie all'interno del proprio circuito economico in un circolo vizioso di circuitazione.
Il mercato però come dicevamo rappresenta una possibilità di autonomia delle imprese e di emancipazione dai tanti meccanismi di dipendenza dal sistema del finanziamento pubblico. Anche in questo mi viene in soccorso Trimarchi, nelle pagine in cui mostra i possibili elementi di relatività del vecchio "Teorema di Baumol" secondo cui in un mercato a stagnazione strutturale quale è quello dello spettacolo dal vivo la necessità dell'intervento pubblico è ineludibile. In realtà esiste, è visibile, l'esperienza virtuosa di tante compagnie, di tante strutture che non vivono di sovvenzioni statali e che riescono comunque a mantenere equilibri di bilancio ed economie non quantitativamente stratosferiche in valore assoluto ma caratterizzate da una sanissima composizione interna: ad evidenziare che probabilmente scelte economicamente, organizzativamente e produttivamente giocate su un mix essenziale fra scelta d'arte e razionalità è probabilmente possibile.
Il che non esclude, ovviamente, tutto ciò che ho detto prima, cioè che il fondamento di larga parte del nostro lavoro politico deve essere la vertenza per il riconoscimento del teatro d'arte: ma in un contesto di difficilissima interlocuzione ed incisività su quel versante allora bisogna capire cosa sia possibile fare su questo secondo versante, quello dell’autonomia. E qui il tema non è più quello della politica istituzionale ma quello delle "buone pratiche" di cui parlava Franco, cioè della prassi organizzativa e di come il nostro mondo - in particolare attraverso le stabilità di innovazione che pure avevano la funzione di diventare la "dorsale" del teatro di innovazione italiano - non sia riuscito in realtà in alcun modo, secondo il mio parere, a diventare sistema, a realizzare esattamente questo tipo di funzione. (7)
Nate con l'intento di costituire l’ossatura della circuitazione a livello nazionale, le stabilità della ricerca non hanno creato sul fronte della produzione, se non in alcuni casi sporadici, nessuno snodo di eccellenza, vanificando in larga misura la possibilità di fare sistema al proprio interno. (8)
Se sul fronte produttivo il dato è questo, sul fronte organizzativo c'era forse la possibilità - che è stata totalmente disattesa - di andare realmente a creare un sistema di rete fra poli di programmazione. Non è stato fatto. Questo è evidentissimo: è evidente nell'ambito del teatro ragazzi, che pure aveva un maggior attivismo maggiore per quanto riguardava le stabilità, ed è sempre più evidente – e con sempre maggiore accelerazione anche nell'ambito della ricerca - il fatto che le compagnie stanno imparando a costruirsi reti possibili da sole. Questo quadro di stabilità diffusa è un quadro che non nasce perché le compagnie "ce l'hanno su con i centri", come spesso sembra dai nostri discorsi, ma perché i centri hanno lasciato, in questa ipotetica rete, tante e tali maglie vuote di possibilità di intervento, di declinazione coerente delle proprie vocazioni e di lavoro reale sul territorio che le compagnie per forza di cose hanno dovuto assumere il compito di assolvere funzioni di servizio, spesso addirittura socio-assistenziale-ricreativo-culturale in senso generico sui propri territori. (9)
E questo è il quadro che noi abbiamo di fronte adesso, che sta crescendo sempre di più e che va a denotare un sistema che in realtà è strutturato a maglie molto più fitte di quanto pensiamo, perché i bacini di programmazione curati dalle compagnie in relazione con l'ente locale sono tantissimi.
Ma il problema non è solo questo. Il problema consiste - nell'ambito di una valutazione del mercato – nel cercare di capire come questo "sistema", in realtà, così com’è strutturato in quanto tale non sia un sistema. Non lo è in senso "moriniano" (10) , non c'è interrelazione fra gli elementi o i poli: si tratta fondamentalmente di un aggregato non-organizzato, sostanzialmente privo di reali flussi operativi o comunicazionali.
Elementi di sistema divengono invece possibili, secondo me, nel momento in cui vengano praticate politiche volte al tentativo di trasformare questo quadro in un reale circuito alternativo. Pratiche che stavano per altro all'origine del movimento del decentramento degli anni ‘70 che – ovviamente con tutte le dovute differenze – nasceva in un contesto simile, con un ente locale che evidentemente rispondeva molto di più alle sollecitazioni culturali ma con una altrettanto forte necessità di costruirsi il proprio mercato e andarlo a dissodare nei territori. Era veramente quella la prassi organizzativa delle compagnie in quegli anni.
Trasformare questo mercato in un mercato sostenibile: da un lato, come giustamente diceva Franco, tramite una razionalizzazione del lavoro delle compagnie anche sul versante produttivo (per esempio aggirando la sindrome di Baumol mediante l’introduzione di tecnologie che sostituiscano il capitale variabile all'interno della "merce/spettacolo", riducendone i costi); in relazione a questo, occorre anche sottolineare la necessità che le compagnie si rendano conto di essere nella stessa barca economica di un sistema, adeguando le proprie scelte produttive alla sua consistenza reale, alle reali possibilità di coevoluzione con un'area dell'esercizio che ha limitate potenzialità economiche, senza sacrificare quindi le propria possibilità di lavoro e di vita ad un’iperuranica ricerca artistica, che è sicuramente legittima ma che altrettanto legittimamente rappresenta un suicidio (e non un omicidio degli "operatori assassini", come sostenevano Fanny & Alexander in una loro recente lettera apparsa sul "ateatro"). Un’osservazione che evidenzia la necessità della ridefinizione di un patto di coevoluzione fra mondo dell'esercizio, mondo della programmazione e mondo delle compagnie. "Coevoluzione" è esattamente il rapporto che c'è tra l'organismo e l'ambiente: tanto si modifica l'ambiente tanto si modifica in adattamento l'organismo. Se ci sono sistemi separati dal punto di vista fisico-biologico, uno dei due necessariamente perde vitalità o comunque cessa qualsiasi sistema di flusso di dialogo possibile.
Un'altra area di confronto secondo me fondamentale per la difesa del mercato, questo lo dico in particolare per il teatro ragazzi ma anche per la ricerca, é una riflessione seria sulla necessità di difendere i repertori: noi ci siamo sempre accodati, vuoi per pressione degli insegnanti (per quanto riguarda il teatro ragazzi) vuoi per una scriteriata frenesia di novità; ci siamo sempre impegnati, al di là degli obblighi ministeriali, in produzioni annuali (fra l'altro basate spesso sulla necessità della "copertura" di fasce di età piuttosto che su vocazioni, scelte reali o urgenze artistiche) che hanno fatto sì che una caratteristica teoricamente strutturale del mondo del teatro e della produzione dell'ambito del teatro ragazzi - cioè la ricerca, che ha bisogno di tempo - in realtà sia sacrificata, e secondo me si vede negli esiti, alla necessità di una produzione a ritmi serrati perché il mercato vuole questo: ma i bambini escono da scuola! Questo non ce lo siamo mai chiesti: io non ho capito perché non posso tenere uno stesso spettacolo in repertorio dieci anni, ma non perché mi piace tenerlo lì ma perché ha possibilità reali di distribuzione. Uno spettacolo di teatro ragazzi oggi muore dopo due stagioni (forse perché le maestre lo hanno già visto).
La difesa di questo dato, badate, non è solo una difesa economica ma è una difesa qualitativa: se io fra una produzione e l'altra mi tengo la possibilità di fare ricerca in vista del nuovo spettacolo, ricerca seria, laboratori con i bambini, la vecchia ripresa della relazione col destinatario, io qualifico il mio lavoro e un intero settore. Se io considero il teatro ragazzi alla sola stregua di un mercato, allora il mio lavoro diviene puro servizio e divengono legittime, ahimè, a quel punto le confuse percezioni degli assessori che non riescono più a discriminare fra la compagnia amatoriale, che non paga i contributi ENPALS e si dà a 200 euro, e la compagnia professionale, che paga i contributi e ha dei costi reali, ha forse una qualità più alta ma rischia comunque di essere sempre più indistinguibile rispetto a quell'altra cosa.
Un'altra proposta/domanda che volevo porre, infine, si basa su una pratica che sto sperimentando in questi giorni, non tanto su spinta mia quanto su richiesta da parte delle compagnie: nell'ipotesi di rilanciare un circuito alternativo, di fare sistema in maniera reale, quasi formalizzata - personalmente credo molto nella formalizzazione - non è proprio possibile, vista l’ampia sovrapponibilità di molti dei nostri cartelloni, creare realmente una razionalizzazione di circuito in base alla quale, in tempi anticipati, i teatri (ed in particolare io penso a quelli a lunga tenitura delle aree metropolitane, perché rappresentano uno snodo non economico ma solo promozionale per le compagnie), si mandano fra loro una circolare in cui pongono in rete idee sugli spettacoli, discutono le rispettive scelte nel tentativo di creare un sistema di scala che razionalizzi piazze ed economie, riduca i costi ed aumenti la visibilità delle compagnie?
Io credo che questo sia possibile ed è una modalità relazionale ed organizzativa che, nella prassi delle scelte, può realmente facilitare la scoperta di un mercato sostenibile per le compagnie. Se io devo ospitare per esempio una compagnia pugliese a Milano, per due settimane, con un garantito da fame (perché questo posso offrire), sento che è quasi un’esigenza etica – e che mi previene, fra l’altro, la necessità dello psichiatra - cercare di trovare a quella compagnia altre repliche sul territorio, cercare di tentare direttamente o ponendomi in relazione con altri programmatori simili, o con cui ho affinità estetiche e di area. Quando in questo periodo dell'anno conduco le trattative con i gruppi mi sento davvero male: perché, per un verso, ho una quantità rilevante di vincoli economici e, nel contempo e per altro verso, mi rendo conto che se lo snodo promozionale che io posso offrire a Milano è sicuramente abbastanza rilevante sulla città di Milano per le compagnie, a volte, rappresenta o può rappresentare la vita.
Ora: io credo che noi abbiamo, per un fatto di declinazione reale nella prassi delle nostre vocazioni, due obblighi fondamentali: da un lato l'obbligo di effettuare scelte coerenti con il mandato che in maniera prescrittiva ci è stato dato dal Ministero, cioè l'obbligo di stare attenti all'innovazione e di non appiattirci sulla logica dell'intrattenimento e della gestione del tempo libero, o su cartelloni giocati quasi essenzialmente sull'autoprogrammazione e quindi su un modello di stabilità parossistico e che toglie conseguentemente mercato alle compagnie; da un altro lato, io credo che faccia parte della nostra funzione il cercare di dare alle compagnie quanto più promozione e quanti più servizi è possibile.
E in questo senso allora forse le stabilità di innovazione – in collegamento virtuoso e di coevoluzione con i gruppi e soprattutto con l’area della stabilità diffusa – possono divenire sistema e costituire realmente circuito. Visto che i circuiti, che pure dovrebbero, non lo fanno - e questa è materia di battaglia politica - dobbiamo costruire noi il sostegno all'innovazione e alla promozione. E uno dei modi possibili è il coordinamento organizzativo, formalizzato e centralizzato o meno; quella razionalizzazione che dovrebbe rappresentare un dovere per le nostre imprese, perché crea economie - in uscita come in entrata – e al contempo rappresenta la declinazione coerente di funzioni istituzionali e culturali della nostra area.
Entro questi limiti, e cioè con la creazione di meccanismi di circuitazione e di coordinamento giocati sulla scelta fra affini, giocati sulla relazione con le compagnie, sul declinare coerentemente le proprie vocazioni e sul relazionarsi da pari con le cosiddette stabilità leggere (o compagnie stabili, o enti teatrali territoriali, chiamiamoli come vogliamo), io credo che si possa allora rfestituire una profonda dignità - da verificare sul campo e nella storia (perché è vera la storia sul sistema escogitato da Paolo Grassi e Ivo Chiesa in difesa del teatro d'arte) – anche ad un certo sistema degli scambi: perché lo scambio, sulla carta, non è altro che il riconoscimento, in entrata ed in uscita, dell’eguale dignità qualitativa di due prodotti, non è altro; non è un modello che implica logicamente o necessariamente la degenerazione in quello che poi è accaduto nella realtà del teatro italiano, cioè l'automatismo. E io credo che un progetto che voglia veramente diventare sistema, in fondo in fondo, debba riscoprire forme elastiche e coerenti di protezionismo di area, ed essere giocato anche sul ridare dignità e valore alle reciprocità fondate sulla qualità.
Probabilmente sono ingenuo. Ma secondo me realmente è possibile buttare lì piccoli semi di cambiamento sul sistema. Io non credo che siano possibili trasformazioni epocali e soprattutto, come ho già detto, ritengo improbabile che si possa - rispetto all'interlocutore istituzionale – cavare oggi, ma anche domani, molto di più che un ragno dal buco.
A meno che non si tenti di tutelare nella prassi una fisionomia che nel farsi sistema mostra la propria potenziale autonomia, e quindi il proprio essere possibile controparte, e quindi una dignità nella rivendicazione che sia insieme estetica, progettuale ed organizzativa.
NOTE
1 Una funzione che dovrebbe consistere nella promozione del pubblico, nel riequilibrio delle attività teatrali, nel sostegno all’innovazione e al valore culturale del teatro e che viene al contrario declinata nella sovvenzione ad un teatro che, dal punto di vista della valenza culturale, si è in realtà in questi anni (sia pure nel valore che possiamo attribuire alla tradizione) estremamente diluito nella dimensione del puro intrattenimento e che proprio per questo ha una significativa risposta di botteghino e che proprio per questo ha assunto livelli economici di mercato e di circuitazione insostenibili, incentivando e fomentando uno "star system" all’italiana totalmente ingiustificabile dal punto di vista dell’investimento e della spesa pubblica.
2 E’, questo, un altro tema caro al Prof. Trimarchi: un capitolo delicato, "su cui gli angeli esitano", difficilissimo da affrontare ma prima o poi ineludibile.
3 Un dato, questo, frequentissimamente sottolineato per esempio nel sito di Oliviero Ponte di Pino (ed in particolare nei forum, anche se a volte anche in maniera un po’ qualunquista, sia pure comprensibilmente).
4 Una terminologia ancor più giustificata dall’esito della recentissima "vertenza spettacolo": una litania di petizioni di principio genericamente orientata all'incremento di spesa sullo spettacolo, sostenuta pubblicamente in videocassette promozionali proprio da alcuni dei principali esponenti del nostro "Star system". Come a dire, citando Mao, che davvero "il nemico marcia sempre alla tua testa".
5 Un modello di definizione in base al quale il teatro ragazzi non si definisce per qualità o per vocazione ma si identifica semplicemente con l’insieme di tutte le compagnie che dichiarano di fare teatro ragazzi, il teatro di ricerca si identifica con l’insieme di tutte le compagnie che dichiarano di fare teatro di ricerca (cioè, stando ad una ricerca recente degli allievi della Scuola "Paolo Grassi", tutte!).
6 Il giudizio estetico sarà pure "soggettivo": ma nelle voci di corridoio sembra sempre avere sempre, direbbe Dewey, un notevole grado di "intersoggettività", di "asseribilità giustificata". Perché quando uno spettacolo è di bassa o bassissima qualità lo riconoscono quasi tutti, così come peraltro avviene – sia pure con minore unanimità – per le valutazioni positive.
7 Parlo in particolare per la ricerca: per la stabilità ragazzi in questo caso possiamo veramente porre fra parentesi molte cose, perché ritengo che abbia in realtà creato molto più sistema di quanto non abbia fatto invece l'area della stabilità di ricerca.
8 Perché con questo quadro produttivo gli scambi diventano impossibili: con cosa scambiare, a meno di non introdurre meccanismi di automatismo e quindi vanificare – nella direzione che ha avuto l'evoluzione storica degli stabili pubblici – la dignità possibile del meccanismo degli scambi che pure esiste?
9 E questo è avvenuto anche quando le compagnie non ne avevano le vocazioni: perché le compagnie di ricerca nascono per una vocazione eminentemente artistica, non organizzativa.
10 Il riferimento è alla cosiddetta "Teoria dei Sistemi", di cui le opere di Edgar Morin sono una tra le più interessanti interpretazioni.
|
La festa e l'utopia
Diario dal Festival d'Avignon (parte prima)
di Erica Magris |
Il mio soggiorno al Festival di Avignone 2004 è purtroppo stato breve (dal 16 al 19 luglio), ma molto frenetico e intenso. Di quelle giornate ho il piacere di raccontarvi ciò che di più significativo sono riuscita a vedere, ma anche le delusioni e défaillances organizzative, con l'intenzione più di trasmettervi l’atmosfera eccezionale respirata nella cittadina francese che di offrirvi una cronaca “professionale”.
Venerdì 16 luglio:
Primo impatto con una città in festa
Vent’anni fa un critico affermò che ad Avignone “non è più una città che ha un festival, ma un festival che ha una città”: oggi è questa l’impressione che si avverte avvicinandosi alle mura medievali che raccolgono il centro storico. Su qualsiasi supporto possibile, su lampioni, ringhiere, semafori, sono appese le locandine degli spettacoli che non fanno parte della manifestazione fondata da Jean Vilar nel 1947, ma del Festival Avignon Public-Off, istituito nel 1982, per consacrare ufficialmente la proliferazione di rappresentazioni ai margini del Festival iniziata alla fine degli anni '60. Nei numerosissimi luoghi teatrali della città si assiepano compagnie di prosa, danza, circo, che, stipulando convenzioni di produzione con i teatri locali, o semplicemente affittando una sala, si presentano al pubblico con la speranza di raggiungere un grande numero di spettatori e di essere notati dalla critica.
Quest’anno, nonostante le disastrose conseguenze dello sciopero degli intermittenti, che portò all’annullamento di entrambi i festival della scorsa edizione, i gruppi presenti sono 539, per un totale di 667 spettacoli accolti in 114 luoghi distribuiti nel territorio urbano ed in alcuni paesi dei dintorni. Entrando in città le locandine si moltiplicano e mescolano i loro colori variopinti a quelli dei tanti passanti che affollano le strade, delle compagnie in parata, degli imbonitori in costume impegnati a distribuire volantini e a procacciarsi spettatori, degli artisti da strada con i loro numeri, nella confusione festiva di una situazione completamente al di fuori della normalità quotidiana. Colpisce immediatamente l’estrema varietà di estetiche e generi teatrali che sono proposti: sembra ci sia spazio per tutti, dal teatro comico da boulevard ai grandi classici, dalla sperimentazione del teatro-danza e del nouveau cirque al teatro di poesia. Una delle mie compagne di viaggio, spettatrice avveduta delle scene parigine, storce il naso di fronte a questa accozzaglia…e in effetti alcuni titoli e alcune scelte grafiche suscitano una certa perplessità (ad esempio: Les 4 Deneuve nell’ambito del The moeufs show…dove “moeufs” indica in un argot non molto delicato le donne, o Pendaison ou cremaillère gioco di parole fra impiccagione ed inaugurazione della casa…). Dopo un momento di riflessione, però, il fenomeno rivela anche un volto positivo: eterogeneità dei “teatri” significa anche eterogeneità e molteplicità dei “pubblici”, che, in questo particolare contesto, hanno l’opportunità di incrociare i loro passi, di incontrarsi e di condividere un evento di portata collettiva in cui il passaparola e lo scambio di opinione costituiscono una componente fondamentale.
Attraverso le vie affollate raggiungiamo il Cloître Saint-Louis, il quartier generale del Festival In, dove si trovano l'ufficio informazioni, la biglietteria e un gradevole spazio all’aperto all’ombra dei platani, adibito ad ospitare incontri e conferenze stampa. Recuperiamo la consistente brochure del programma e l'indispensabile “Guide du Spectateur”, dove sono indicati giorno per giorno i luoghi e gli orari delle diverse manifestazioni.
Il programma dell'In è ampio e vario, e offre una panoramica privilegiata sulle tendenze contemporanee del teatro europeo nelle sue diverse forme: i nuovi e giovani direttori - Vincent Baudriller e Hortense Archambault, cresciuti sotto l’ala di Bernard Faivre d’Arcier - hanno puntato, dopo l’interruzione dell’anno passato, ad una rifondazione del Festival. Hanno voluto che si trasformasse in un'occasione di scambio e di confronto fra gli artisti, e hanno scelto di raccogliere “degli universi artistici forti e ben individualizzati, fra i quali ciascuno è libero tracciarsi il proprio percorso di spettatore” (Stralci delle dichiarazioni di Vincent Baudriller e Hortense Archambault in SALINO B., Nouveaux passeurs, numero speciale di “Le Monde” distribuito al Festival.). Istituita per ripensare il ruolo dell’artista “non limitandosi a mostrarne degli spettacoli, ma declinandone il lavoro e l'intera opera, dandogli un maggiore spazio di respirazione e di desiderio” è l’altra importante novità che si inaugura con l’edizione 2004: ogni anno la direzione è affiancata da un regista o coreografo, che oltre a presentare un numero consistente dei propri spettacoli, indirizza le scelte della programmazione (Gli artisti associati delle prossime edizioni saranno Jan Fabre per il 2005, Josef Nadj per il 2006 e Frédéric Fisbach per il 2007).
Thomas Ostermeier, è stato l’ “associato” di questa edizione: il trentacinquenne direttore della Schaubühne a Berlino dal 1999 è una delle punte della ricerca teatrale della Germania riunificata. Dall’inizio della sua attività nel 1996 in un insieme di edifici prefabbricati recuperati dal Deutsches Theater, la cosiddetta “Baracke”, Ostermeier si è distinto per un atteggiamento nello stesso tempo attento al passato e radicato nel presente. Ostermeier è infatti da un lato un regista colto che riconosce l’importanza della tradizione europea novecentesca, ispirandosi all’insegnamento di Brecht e soprattutto di Mejerchol’d, e non disdegna la messa in scena dei classici; dall’altro si dedica alla realizzazione scenica di opere forti e provocatorie di alcuni autori viventi e alla sperimentazione di nuove forme teatrali che sappiano coinvolgere anche un pubblico giovane. Per Ostermeier il teatro è un’arte dell’impegno, capace di giocare un ruolo importante nella società agendo sulle corde intime dei singoli: “Bisogna svegliare il corpo dell'animale fantastico che è il teatro con delle messe in scena stupefacenti, capaci di entrare nell'intimità sociale di ogni individuo. Perché il teatro che noi amiamo consiste nel riunire, proprio mentre il mondo di oggi - in cui si oppongono ricchi e poveri, est e ovest, nord e sud, ecc. - porta a separare”, questa la dichiarazione che sigilla la sua collaborazione al Festival.
La programmazione è caratterizzata da un interesse privilegiato alla scena contemporanea di area tedesca: oltre ad Ostermeier, che ha presentato Woyzeck di Büchner (nella Cour d’Honneur del Palazzo dei Papi), Nora (Maison de poupée) di Ibsen, Concert à la carte di Franz Xaver Kroetz e Disco Pigs di Enda Walsh, calcano le scene avignonesi Frank Castorf, René Pollesch, Christoph Marthaler. Ma sono presenti anche personalità francesi con regie più o meno “classiche” (Frédéric Fisbach con L’illusion comique di Corneille, Bernard Sobel con Un homme est un homme, Patrick Pineau con Peer Gynt), sodalizi autore-regista (Olivier Cadiot - Ludovic Lagarde e François Bon-Charles Tordjman), i tendoni da circo di Claire Lasne e Johann Le Guillerm, Rodrigo Garcia, Pippo Delbono, l'olandese Johan Simons e il belga Luk Perceval, una vasta gamma di coreografi come Sidi Larbi Cherkaoui, Costanza Macras, Sasha Waltz, Meg Stuart solo per citarne alcuni. Iniziamo a studiare la brochure, cercando di stabilire un programma di massima e sospirando al pensiero degli spettacoli che non riusciremo a vedere per incompatibilità cronologiche. Ci dirigiamo fiduciose alla biglietteria, dove, dopo una lunga coda, scopriamo che quasi tutti gli spettacoli dell’In sono al completo. Il teatro è dunque ancora capace di coinvolgere una grande quantità di persone, di essere un evento, un richiamo... viene da chiedermi se, oltre a decenni di politica culturale che sicuramente fanno la differenza, la forza del sistema teatrale francese non consista anche nella capacità di rispettare e potenziare il carattere composito ed eterogeneo del panorama teatrale contemporaneo, senza apporre etichette, senza erigere le barriere linguistiche e metodologiche che mi sembra imperino al contrario in Italia. Mi pare che l’assenza di definizioni perentorie come “teatro di regia”, “teatro di ricerca”, “teatro di prosa” nelle espressioni francesi correnti del pubblico e degli addetti ai lavori, sia un ulteriore sintomo di un atteggiamento di grande apertura verso il nuovo e di valorizzazione della tradizione.
Tornando al nostro trauma in biglietteria, usciamo maledicendoci per non esserci meglio organizzate e per non avere prenotato prima. Ma non ci lasciamo scoraggiare e appendiamo un annuncio con una richiesta di posti su un grande pannello a cui molti spettatori si sono rivolti per acquistare e vendere i biglietti. Intanto, dopo un attento esame delle manifestazioni parallele, decidiamo di aprire la giornata con la visione del film di Pippo Delbono Guerra... ma quando con quello che per noi sarebbe un largo anticipo arriviamo al cinema la sala è già piena... Ci premuriamo allora di prenotare i biglietti per scoprire un promettente e giovanissimo (classe 1979) artista, Jean-Baptiste André, che presenta la sua creazione nel circuito dell’Off alla Caserne des Pompiers (per la cronaca, era passato poco prima dal Festival Internazionale del circo di Brescia).
Intérieur nuit_ Ideazione, regia e interpretazione di Jean-Baptiste André: il circo e le nuove tecnologie nell'esplorazione dello spazio.
André, diplomato al Centro Nazionale di Arti del Circo, dove si specializza in equilibrismo sulle mani e in tecniche clown, fonda nel 2002 l'associazione [W], con lo scopo di produrre creazioni che contaminino il circo, il teatro e le nuove tecnologie. Intérieur nuit_ è il suo primo spettacolo, e, sebbene alcuni aspetti risultino ancora acerbi, soprattutto per quanto riguarda la struttura dell'azione, è piuttosto riuscito ed interessante per la declinazione delle relazione fra corpo, spazio reale e spazio virtuale.

Il piccolo palcoscenico è chiuso da tre alte pareti di legno: questo è l'interno notturno in cui penetriamo, dove il performer agisce la sua solitudine da insonne in una serie di sequenze frammentarie e incatenate fra loro da elementi sonori, visivi.

Sulla scena ci sono solo degli abiti, prima riposti ordinatamente sul proscenio, poi indossati l'uno sopra l'altro, infine sparpagliati un po' ovunque, ed una piccola camera digitale posta su un cavalletto. André esplora lo spazio, misura con il corpo le pareti, con grande virtuosismo fisico vi si appende e vi compie acrobazie.

Per alcune azioni la videocamera viene accesa ed utilizzata invertendo l'orizzontalità e la verticalità. Le immagini sono proiettate in diretta sulla parete di fondo, e gli spettatori di fronte il performer reale disteso per terra ed il performer elettronico in piedi di fronte al muro, in uno sbandamento della visione gestito da André con leggerezza ed ironia. In altri momenti il video serve ad isolare dei dettagli del corpo, che ingranditi nella proiezione, diventano attori di divertenti coreografie.

Lo sguardo di André si divide fra l’osservazione stupita del proprio corpo, del suo doppio e del pubblico, di cui cerca la complicità nel gioco percettivo e nel continuo straniamento provocato dalla sua abilità di circense e dalla tecnologia.
Usciamo di fretta dalla performance di André, perché dobbiamo ci aspetta Joyeux anniversaire di Claire Lasne, l'unico spettacolo dell'In di cui rimanesse qualche biglietto, probabilmente a causa della scoraggiante collocazione: 40 chilometri da Avignone, a Rasteau, un villaggio sperduto nella campagna della Vaucluse.
L'impeccabile organizzazione del Festival offre però agli spettatori una navetta gratuita, che in un'ora ci porta in un luogo delizioso: un tendone da circo posto in mezzo ad ondulate distese di vigne. Ci godiamo i colori del tramonto mangiando ai tavoli all'aperto decorati da ghirlande di lampadine colorate, e, dopo esserci rifocillate ci incamminiamo verso il tendone.
Joyeux Anniversaire, concezione e regia di Claire Lasne: l'utopia di un teatro popolare
Da diversi anni, come direttore del Centro Drammatico di Poitou-Charentes, Claire Lasne conduce un progetto vicino al tentativo di teatro nazionale ambulante sperimentato da Firmin Gemier a inizio novecento: invece di presentare i suoi spettacoli nello spazio del Centro, ha scelto un tendone itinerante per raggiungere il luoghi delle campagne da cui il teatro sembra essersi ormai ritirato. Unendo la tradizione delle compagnie di giro alle abitudini e agli spazi dei circensi, Claire Lasne, cerca di reinventare un teatro popolare, semplice, divertente, ma intelligente ed esigente dal punto di vista estetico e artistico.

Joyeux Anniversaire racconta la storia di una famiglia strampalata alla Pennac, immersa in un universo surreale ispirato ai disegni di Sempé: gli amori, le amicizie, i lutti e le alterne vicissitudini del vivere famigliare di Paul e dei suoi fratelli si intrecciano alla storia degli ultimi trent'anni. Nella pista sono collocati un ampio tavolo rotondo, con tanti sgabelli colorati, una cucina, con tutti i suoi utensili, delle valigie, un albero di Natale ed una radio: attraverso questo apparecchio il mondo esterno entra nell'intimità della casa e lega la dimensione domestica a quella pubblica: l'azione scenica è infatti intercalata dall'irrompere di brandelli sonori documentari, che sollecitano la memoria personale e collettiva degli spettatori, e collocano la vicenda dei personaggi nel fluire della storia.

L'inizio dello spettacolo è sorprendente: si accendono delle lampadine e dalla radio arriva il ritmico slogan di protesta del maggio '68 “poursuivons le combat“, da un trampolino a terra salta in pista un giovane con una buffa maglietta a righe, Paul, che corre intorno per salutare il pubblico; le grida si sono impercettibilmente trasformate nella voce del Generale De Gaulle, quando lo strano personaggio ci presenta suo padre: dal trampolino entra un attore travestito da orso, che subito si dirige in cucina ed indossa un grembiulino.

Poi, intercalati dal altri suoni dell'epoca, come la cronaca dello sbarco sulla luna, entrano anche i fratelli, anch'essi travestiti da orsi. Riunita la famiglia, tutti si siedono al tavolo ed avviano una ritmica catena di montaggio per spellare con le grosse zampe le patate, in un'immagine teatrale comica e perturbante allo stesso tempo. A poco a poco la situazione surreale ci viene spiegata dal narratore Paul: è Natale, il giorno del suo compleanno, che per il capriccio infantile di uno dei fratelli è ormai tradizione festeggiare travestendosi da orsi come se fosse carnevale. La storia comincia in un continuo décalage fra il presente scenico e il passato del racconto. Altri personaggi, disegnati con tratti netti e con tinte forti, ma mai caricaturali, entrano da un telo bianco posto su una porzione del tendone, dove, ad ogni entrata sono accompagnate da proiezioni video che completano con delle suggestioni visive le parole di presentazione di Paul. Canti, coreografie, gesti sostituiscono quasi completamente il dialogo, in una sarabanda di situazioni comiche e di immagini poetiche che con delicatezza toccano alcuni problemi della società contemporanea.

“Le persone cenano, non fanno che cenare, e durante questo tempo si costruisce il loro destino”: come sottolinea il programma di sala, lo spettacolo ruota intorno a questa frase di Čechov. Compleanno dopo compleanno arriviamo alla fine, quando i personaggi abbandonano la casa della famiglia originaria per seguire ognuno il filo dello propria vita: il grande tavolo viene diviso in tante tavole più piccole, sulle quali gli attori issano delle vele e, a piccoli gruppi iniziano a navigare in una proiezione di onde marine che invade l'intero spazio del tendone. Le luci si abbassano e gli spettatori accolgono con lunghi ed entusiasti applausi gli artisti che per un'ora e mezza li hanno trasportati in un universo di sogno e di ricordo.
Riprendiamo la navetta, che ci porta proprio davanti al nostro ostello. Dormire, dormire... per affrontare un'altra intensissima giornata teatrale!
Sabato 17 luglio:
Non solo teatro!
In mattinata torniamo al Cloître Saint-Louis, per la conferenza stampa di Sidi Larbi Cherkaoui, Luk Perceval, Johan Simons e Meg Stuart. Purtroppo bisogna ammettere che il giornalista cui è affidata l'animazione dell'incontro non dà l'impressione di essere molto preparato e d'altra parte gli artisti anticipano lavori che non sono ancora stati presentati al festival, quindi anche il pubblico è poco reattivo e non pone domande. La situazione è un po' sonnolenta e ci pentiamo di non avere scelto la contemporanea mise en espace di Oskaras Koršunovas de La Réserve dello scrittore lituano Gintaras Grajauskas.
Abbandoniamo quindi il Cloître Saint-Louis, e ci spostiamo alla palestra del Lycée Saint-Joseph. Collocato in una zona animatissima della città, gremita di locali con tavolini all'aperto disposti lungo un canale, l'edificio scolastico si affaccia su un ampio cortile chiuso da mura: qui, per particolare desiderio di Ostermeier e Pollesch è stato predisposto luogo d'incontro con bar, in un ambiente tendenza di canne di bambù, bidoni di latta colorati, poltroncine di plastica e illuminazione ai neon colorati, dove la sera si ritrovano gli artisti. Nella palestra si svolgono letture, alcuni spettacoli e soprattutto delle conferenze e dei dibattiti, cui sono chiamati a prendere parte scrittori, filosofi, sociologi: è “Le Théatre des idées”, concepito per affiancare ai progetti artistici una riflessione sul mondo contemporaneo.

Fra gli invitati, Jacques Derrida, Gianni Vattimo, Christian Salmon e tanti altri, per pensare insieme a temi scottanti come il ruolo dell'Europa nell'attuale situazione internazionale, le implicazione dell'evoluzione capitalista, il rapporto tra Oriente e Occidente. In questa giornata è presente Svetlana Aleksievič, scrittrice e giornalista bielorussa, che qualche settimana prima avevo avuto modo di conoscere in occasione dello spettacolo Reportage Chernobyl di Simona Gonella, tratto da un suo libro. Con grande curiosità entro nella palestra, dove sono pronti a iniziare l'incontro la scrittrice, Nicolas Truong, coordinatore dell'iniziativa, Victor Loupan, direttore letterario delle edizioni Presses de la Renaissance.
La parole des sans-voix: incontro con Svetlana Aleksievič
L'aspirazione di Svetlana Aleksievič è dare con i suoi libri la parola a coloro che non ce l'hanno e trasformarla in un testo che possa esprimere l'umano tanto quanto un grande testo letterario. In un russo pacato e melodico la scrittrice descrive l’origine della sua vocazione, che risale al rapporto con la nonna, una contadina ucraina. Dopo aver ascoltato la nonna raccontare di quella volta, durante una delle tante guerre passate per l’Est dell’Europa, che dopo la battaglia, lei e le altre donne del villaggio avevano trascorso una settimana a seppellire i cadaveri, la Aleksievič avvertì che il sapere libresco non è sufficiente a capire gli uomini e scelse di rivolgere il suo mestiere di giornalista a scoprire i sentimenti delle persone travolte dalla grande storia, ed in particolare nella guerra. La guerra, come afferma la scrittrice, è, come la morte, un fatto permanente in Russia, trattato con il linguaggio metallico ed eroico del regime comunista (con residui nell’attuale presente “democratico”…): nasce così il suo primo libro, La guerra non ha un volto di donna (non ancora tradotto in italiano) che esplora il vissuto delle donne che si trovarono costrette a prendere parte al conflitto mondiale e che in seguito furono spossessate delle loro vicende, non conformi alla retorica della vittoria. E sempre incentrati sul valore dell'esperienza del singolo nella storia come percorso di conoscenza sono anche i successivi I ragazzi di zinco (edizioni c/o, Roma, 2003) e Preghiera per Chernobyl (edizioni c/o, Roma, 2002) che raccolgono testimonianze della guerra sovietica in Afghanistan e del disastro nucleare della cittadina ucraina. La forza di questi mosaici di storie individuali sono tristemente confermati dall'esilio della Aleksievič, invisa all'attuale regime bielorusso di Aleksander Lukaschenko e rifugiata a Parigi, dove sta attualmente lavorando ad un libro sull'amore in Russia. La vividezza e la verità umana delle testimonianze ascoltate e rielaborate dalla scrittrice traboccano dalle pagine del libro per tornare spesso alla vita sul palcoscenico: molti infatti sono gli adattamenti teatrali delle sue opere realizzati in diversi paesi europei (Italia, Francia, Svezia, Svizzera, Russia), che rientrano certamente in quel territorio di teatro impegnato che quest’edizione del Festival di Avignone intende promuovere.
Purtroppo dobbiamo lasciare la voce calma e melanconica della Aleksievič all'inizio del dibattito, per raggiungere il Jardin de la Vierge, dove assisteremo a due performance promosse dall'iniziativa “Sujet à vif”. Si tratta di una coproduzione del Festival di Avignone e della SADC (Société des auteurs et compositeurs dramatiques), finalizzata a incentivare gli incontri fra coreografi, danzatori e artisti appartenenti agli ambiti più differenti, all'insegna dell'ibridazione e dell'impurità della danza contemporanea. Mentre corriamo per arrivare puntuali, riceviamo una telefonata in cui non speravamo quasi più: un tale Serge ha un biglietto per Nora la sera stessa! Prendiamo accordi per lo scambio, e, sempre più persuase che la fortuna aiuta gli audaci, decidiamo che per recuperare quello che ci manca (siamo in 2), ci presenteremo con larghissimo anticipo al teatro per metterci in lista d'attesa per i posti dell'ultimo minuto. Intanto arriviamo giusto in tempo al Jardin de la Vierge, un po' affannate prendiamo posto su una gradinata posta in un piccolo cortile interno chiuso dalle belle facciate di un palazzo settecentesco (credo!).
Tourlourou, testo e coreografia di Carlotta Sagna, interpretati da Jone San Martin
Erase - E(X), creazione della compagnia Joij Inc., coreografia del Wooster Group, interpretata da Johanne Saunier
Al ritmo di una marcia militare, entra la danzatrice, con il tutù e le scarpette a punta classiche, ma in fantasia mimetica militare. Si posiziona al centro di un bersaglio tracciato su una piattaforma, e nel silenzio, si rivolge al pubblico: “sai che devi morire il giorno dopo, cosa fai?”. Inizia così il gioco scenico: l’interprete si presta a diventare una ballerina-kamikaze, prigioniera del bersaglio. Il movimento è netto, preciso, sincopato, ed evidenziato dall'amplificazione sonora del rumore del corpo sulla pedana. Le posture classiche sono straniate e interrotte da gesti naturali e dal dialogo ironico con il pubblico. Resto affascinata dal rumore dell'attrito del corpo sul legno, dalla luce solare che disegna ogni singolo muscolo della danzatrice, dalla brezza che muove il tulle del tutù e le scompiglia i capelli.
Il lavoro successivo mi si rivela più ostico: ispirato al quadro erased De Kooning drawing, in cui Robert Rauschenberg si appropria, cancellandola, di un'opera di Willem De Kooning. Si tratta nella performance di cancellare un brano coreografico di Anne Teresa De Keermaeker, sovrapponendole il sonoro de Il disprezzo e trasformando progressivamente la danzatrice nella donna moderna che Godard tratteggia nel film. Nella prima parte la frase viene eseguita in silenzio, poi la danzatrice indossa un abito rosa e, reagendo ai segnali luminosi di tre lampadine colorate sincronizzate con brandelli di musica e di dialoghi del film, ripete, decostruisce e modifica la partitura originaria fino a consumarla integralmente.
Dal Jardin de la Vierge ci portiamo sulla scalinata del Théâtre Municipal, dove viene rappresentato Nora di Ostermeier. Sono le 19:00, lo spettacolo comincia alle 21:00 è già c'è qualcuno in fila. Siamo al sesto posto nella lista. Iniziamo a chiacchierare con i compagni di attesa, gente sulla cinquantina, veterani del festival che si divertono a raccontare le loro precedenti esperienze e a scambiarsi pareri sugli spettacoli in corso. Il chiacchiericcio è interrotto da alcuni strilloni con il nuovo numero di “Le Monde”, in cui c'è la critica di Brigitte Salino al Peer Gynt di Patrick Pineau, l’altro spettacolo in programma alla Cour d'Honneur. Tutti si affrettano a comprarlo, mi unisco anch'io: Pineau era il protagonista de La mort de Danton realizzata da Georges Lavaudant nel 2002, di cui avevo seguito le prove, e sono molto curiosa di conoscere i risultati della sua attività registica... Il tempo passa lentamente, cominciamo ad entrare in ansia: ce la faremo a vedere lo spettacolo di Ostermeier?
La risposta nel prossimo numero!
|
Il teatro e lo «Spirito della terra»
Un festival etno-ecologico per scoprire la Siberia e le periferie del teatro russo
di Mimma Gallina |
E’ dal 1992 che non andavo in Russia. Un’assenza lunga dopo una frequentazione intensa nel periodo della ‘perestroika’ (quell’era della trasparenza che sembra chiusa – temo definitivamente – dall’ultimo Putin). Negli anni a cavallo del ‘90 ho collaborato ai primi scambi teatrali intensi fra Italia e Unione Sovietica. E’ stata – per i molti che hanno lavorato sui due fronti a questo incontro – un’esperienza mitica, esaltante e faticosa; per noi italiani, una full immersion in un paese che emergeva, si apriva a vie artistiche e organizzative nuove, risucchiato continuamente verso il basso da un passato troppo ingombrante, che pesava sulle cose e sulle persone in ogni momento della vita e del lavoro. Era anche un paese alla fame. Incerto sul suo futuro. Nel giro di pochi mesi, nel 1991, sarebbe successo di tutto: il tentativo di colpo di stato, Gorbaciov cadeva, sorgeva l’astro di Eltsin, l’URSS si disgregava, con distacchi più o meno cruenti (la Lituania, l’Ucraina) e poi mancati distacchi, più cruenti ancora (la Cecenia, la questione del Caucaso).
Da allora, dalla Russia è arrivato in Italia molto teatro, molto importante e possiamo dire di conoscere bene le punte di qualità di quella tradizione e la sua vitalità.
Da parte mia, in questi anni ho frequentato molto l’Europa dell’Est, inclusa qualche ex repubblica sovietica, Ucraina, Moldova, ma ho colto per la prima volta quest’anno l’occasione di un ritorno nella grande federazione russa. L’opportunità è davvero stimolante: teatrale, e non teatrale, unica per scoprire nuovi territori e misurare il cambiamento della Russia, non dalle sedi di rappresentanza, ma dalle estreme periferie e proprio là dove l’anima slava si incontra con quella asiatica
Si tratta della seconda edizione del Festival Teatrale internazionale Etno-Ecologico ‘Tchir Tchayan,’ (ovvero Spirito della Terra) che si svolge ad Abakan, la capitale della Repubblica di Khakassia in Siberia, nella prima metà di agosto.
A MOSCA
Volo Alitalia da Malpensa. Italiani e russi siamo più o meno fifty/fifty, a colpo d’occhio, ma noto molte coppie miste con bambini: italiano il padre/russa la madre.
Inizio finalmente a riordinare le idee: mi sono portata Kapuscinski che trovo sempre formidabile (Imperium e Lapidarium), attacco Russia di Enrico Franceschini: che è chiaro e affettuoso: io penso che il giornalismo di viaggio debba essere scritto con il cuore, e per fortuna c’è una guida Lonely Planet: Russia asiatica..
Giulietto Chiesa l’ho lasciato a casa (è così chiaro che credo di averlo ben chiaro) e purtroppo non ho trovato Terzani, Buona notte signore Lenin – pare sia da non perdere ma è in ristampa.
Arrivo a Mosca: non sembra cambiato un gran che, almeno alla dogana. Due ore due di coda: sotto organico? disorganizzazione? ostentazione di potere? Tutto questo credo e altro (ma il terrorismo non centra): sono arrivati molti voli contemporaneamente (è possibile che i turni non ne tengano conto? ovviamente sì), i moduli della dichiarazione doganale sono equivoci e c’è chi chiede spiegazioni, chi deve rifarli, ogni tanto qualche addetto abbandona la postazione, nessuno sa se ritornerà e quando: ordinaria amministrazione (a proposito: i passaggi sono gli stessi dell’era sovietica, con lo specchio inclinato un po’ sopra la nuca dei passeggeri tanto da consentire al doganiere di vederli giù, fino ai piedi: mi sembrava già allora che facessero tanto guerra fredda).
Irina mi aspetta da due ore e altri ospiti del festival in arrivo dalla Repubblica Ceca da solo un po’ meno: è previsto un minibus che porta tutti in centro.

Voglio presentarvi Irina Miagkova, cui devo l’invito a questo festival: è presidente dell’associazione dei critici di teatro di Mosca e traduttrice dal francese, ha superato i sessanta e sa tutto del teatro russo, anche delle più remote periferie (e molto del teatro francese), oltre a questo è una donna molto simpatica e energica.
Attraversamento di Mosca: è domenica, una bella giornata, le 18 circa poca gente in giro ma caffè con tavoli fuori, molta pubblicità, vetrine lussuose, colori, macchine occidentali. Nel ‘90 c’era la coda per alcuni generi alimentari (e molto ne mancavano), i ‘berioska’ per i turisti (dove si trovava di tutto a prezzi stratosferici), apriva il primo MacDonald (mi ricordo la coda: c’è ancora! vistosissimo con la sua inconfondibile scritta ma in cirillico, primo di una lunga serie: "Mai come a Milano" mi dice Irina, che è stata di recente a un paio di festival italiani ed è passata in corso Buenos Aires). Sulla via dell’aeroporto ho visto un Ikea (l’inconfondibile cubo blu: e mi immagino che anche i russi ora abbiano librerie billy e materassi divan), un paio di centri commerciali color pastello, un distributore Agip (bene, ci siamo anche noi!): è la globalizzazione, baby!
In centro molte nuove costruzioni: un tentativo di architettura che non rinnega lo stile staliniano (i famosi palazzoni sono stati del resto molto ripuliti): una certa monumentalità, costruzioni su più livelli, un accenno di pinnacoli. Anche i palazzi storici sono stati in molti casi restaurati, le cupole delle chiese ortodosse sono ancora più brillanti. Tutto è un po’ meno grigio. Pare che la gente sia più allegra.
MOSCA/ABAKAN
All’aeroporto in metro e bus. Irina da pensionata passa senza biglietto (al rientro leggo sui giornali italiani di questi stessi giorni che è proprio uno dei privilegi che hanno tolto in una ‘riforma’ di agosto molto pesante che ridimensiona il welfare un po’ a tutti i livelli): c’è la coda allo sportello, allunga qualche rublo alla donna all’ingresso e passo con lei (senza biglietto, come una vera pensionata russa). Commentiamo: una ‘corruzione’ spicciola (io la percepisco come tale), del tutto normale, Irina non si stupisce che mi stupisca (ha frequentato molti francesi) ma questo non le impedisce di considerarmi ingenua, e un po’ idiota.
Aeroporto nazionale: scritte e annunci solo in russo, affollamento. La nostra è la linea area di ‘Novosibirsk’, il volo è diretto appunto al capolinea est della federazione, con scalo a Abakan. La vecchia gloriosa Aeroflot si è disintegrata in una miriade di compagnie locali: trovarle e organizzare un viaggio articolato dall’Italia è pressoché impossibile. Quasi 5 ore di volo, 4 ore di cambio fuso: normale in questo paese immenso. Siamo partiti nel primo pomeriggio e arriviamo alle 2 di notte. Ci sono alcuni componenti delle compagnie e tutti gli ospiti del Festival su questo volo (che poi sono francesi, cechi, turchi e moscoviti): ma non riesco a fare nessuna conoscenza perché siamo strettissimi, pigiati su un apparecchio molto piccolo (per una volta sono contenta di essere piccola anche io).
Ad Abakan ci fanno un’accoglienza molto festosa, ai piedi dell’aereo (giù dalla scaletta: come nelle foto degli anni ‘50): fiori a ciascun ospite, ragazze con costumi locali (della Kakassia) offrono la bevanda tradizione locale in ciotole di ceramica (è un succo un po’ acido, non alcolico), poi all’interno dell’aeroporto discorsi (fra gli altri c’è la signora ministro della cultura, il direttore dell’aeroporto e lo sponsor: la compagnia russa dell’alluminio!) e champagne (quello russo naturalmente: una terribile alternativa elegante alla vodka): calore, ospitalità e ufficialità che ben ricordo.
Comincio a identificare gli organizzatori e gli ospiti. In primo luogo il direttore artistico e regista del teatro nazionale delle marionette ‘Skaska’, che organizza il festival, Eugeni Ibragimov, e Svetkana Okolnikova, il direttore generale.

Noto subito che nessun indigeno parla nessuna lingua che conosco: quelli che se la cavano meglio sono i turchi (del teatro nazionale di Ankara), perché il kakassiano, come la maggior parte delle lingue delle regioni siberiane, è di ceppo turco e fra loro si capiscono benissimo (molto più che, ad esempio, fra le diverse lingue slave). L’Hotel Abakan (il migliore della città) è carino e la mia camera è grande. Di fronte c’è una discoteca ancora funzionante (sono le 3 circa).
ABAKAN e il FESTIVAL
LE COLAZIONI
Ovvero: la rigidità dell’homo sovieticus è felicemente sopravvissuta.
La prima colazione (molto importante qui) all’Abakan si fa nel ristorante annesso, aperto anche all’esterno, il nostro coupon prevede un ‘complex’ consistente in: uno zuppone molto ambito (non proprio il classico ‘Kasa’, che sembra un po’ il porridge), un dolce con molta crema, un piatto forte che la prima mattina altro non è che una grande fetta di pizza, naturalmente ‘ciai’ (the: come in quasi tutta l’Asia) o caffè. Vi assicuro che non sono particolarmente delicata: ma un complex dell’Hotel Abakan mi basterebbe per due giorni, in compenso non contiene niente che consideri commestibile di prima mattina. Il primo giorno me la cavo con ciai e dolce (cercando di togliere un po’ di panna). Il secondo provo a sostituire il tutto con uno yogurt: la ragazza mi fa capire che non ce l’ha; allora con un succo (soc: una delle poche parole russe che so), mi fa capire che va pagato a parte. La terza mattina Irina fa uno ‘scandalo’ e riesco a ottenere per noi (altri occidentali sono in imbarazzo analogo) un succo e un microscopico panino in sostituzione dell’ambito ‘complex’. L’ultimo giorno comparirà lo yogurt. Irina mi spiega che in Russia la rigidità/apatia o burocrazia si vince (tuttora) o con scenate o con pazienti aggiramenti: pratiche in cui – lingua a parte – è meglio che noi non ci azzardiamo neanche e in cui invece lei eccelle. Comunque imparo la lezione.
L’INAUGURAZIONE, LO SCIAMANESIMO
Il festival parte con una ‘vera’ inaugurazione, un coinvolgimento reale della città a diversi livelli: chiunque organizzi un manifestazioni di qualità, ma che si ponga come obiettivo anche il rapporto con la gente e con il territorio, sa che questo momento è un problema. Gli amici di Skazka si sono un po’ scaricati la responsabilità e il risultato non è esteticamente eccezionale, ma decisamente di massa: uno spettacolo folcloristico con bambini e ragazzi in abiti tradizionali (un po’ falsificati e poveri, ma che rivelano molto forte la componente orientale), organizzato da dipartimenti comunali e dalle scuole, una parata dal parco al teatro cui partecipa molta gente, assieme ai ragazzi precedentemente coinvolti e alle compagnie già presenti ad Abakan, infine un rito sciamanico e molti discorsi ufficiali (autorità e sponsor), opportunamente ridimensionati dalla presentazione una a una delle compagnie ospiti (qualche battuta, brevi scene, qualcuno in costume) e del logo del festival, molto bello, ispirato alle incisioni rupestri della zona (e riprodotto su magliette, bandane, pass, nella migliore tradizione dei festival internazionali).

E’ una giornata splendente, circa 25 gradi (dato sufficiente da queste parti per essere felici), e il centro della città – con le sue architetture anni 50/70 – appare abbastanza ben tenuto e gradevole. Gli abitanti di Abakan – soprattutto i bambini e le ragazze, soprattutto gli indigeni (con fattezze asiatiche) e i sangue misto – sono molto belli.

Il rito sciamanico (che caratterizzerà con forme diverse altre occasioni nei giorni successivi) è officiato da una sciamano donna, con alcuni assistenti, e consiste in una serie di invocazioni ai diversi spiriti, con richiesta di benevolenza, assecondate da movimenti ondulatori e una breve processione che si conclude intorno al fuoco, il tutto accompagnato da percussioni. A tutti si chiede di bruciare un nastrino nero (che simboleggia il male che viene così eliminato) e annodare a un albero tre nastrini colorati (volendo si può esprimere un desiderio: come quando cadono le stelle, in questi casi io sono sempre presa alla sprovvista).
(Chiedo sinceramente scusa agli esperti e appassionati di ritualità e teatro rituale per la probabile banalizzazione di questa descrizione; sono davvero ignorante in materia, e in questo primo impatto l’ironia ha il sopravvento e mi impedisce forse di cogliere sfumature importanti, ma posso certificare che l’effetto di insieme è abbastanza spettacolare e coinvolgente).

Lo stesso nome del festival ‘Tchyr Chajan’ (Spirito della terra) si richiama alla tradizione panteistica locale. E mentre sulla definizione di ‘etno-ecologico’ ci saranno alcune discussioni, sullo ‘spirito della terra’ sembriamo tutti allineati sulle posizioni sciamaniche: cioè ci prestiamo volentieri ai riti propiziatori! (rientrando a Milano mi sono accorta che mi era rimasta una combinazione di nastrini e mi sono affrettata a bruciare quello nero: non si sa mai)
(Nota di colore: la signora Sciamano la sera a cena si trova al tavolo degli ospiti turchi con cui può comunicare e, toccando la mano di un rappresentante del teatro di Ankara e guardandolo negli occhi, gli dice di stare molto attento al fegato e di essere moderato. Cinque giorni dopo il poveretto non riesce a partire con noi in battello perché – non essendo stato propriamente moderato – è colpito da una colica fulminante e ricoverato d’urgenza. Per fortuna la sciamana, chiamata al telefono, comunica subito all’ospedale diagnosi e cura.)
Mi sembra degno di riflessione questo revival dello sciamanesimo dopo la durissima repressione sovietica. Gli sciamani ereditano i propri poteri (nel senso che potrebbero avere – ma non necessariamente avranno – le stesse capacità e poteri dei genitori) e sono di diverso tipo: assimilabili a sacerdoti, ma anche solo assistenti, musicisti, guaritori o medici (la conoscenza e l’utilizzazione delle erbe ricopre un ruolo importante anche nei riti) e molto altro ancora.
Saremo nuovamente coinvolti in un rito sciamanico passando il confine fra il territorio di Abakan e quello di Krasnoyarsk: un benvenuto officiato appositamente per noi attorno a un totem, in un punto sacro, segnato dalle continue cerimonie rituali, e ancora nella prima giornata al parco nazionale, ma soprattutto ne troveremo traccia dappertutto intorno agli innumerevoli monoliti e ‘kurgan’ (steli o monumenti funerari) sparsi nella steppa (risalenti a qualche migliaio o anche un centinaio di anni fa): le cose per secoli non devono essere cambiate molto da queste parti, si sono solo interrotte per un’ottantina d’anni.
Al di là del sospetto che qualcuno degli organizzatori locali ci creda davvero (allo spirito della terra, perlomeno), lo spazio dedicato a questi riti corrisponde all’intenzione di richiamare le origini, le caratteristiche della cultura locale: una riscoperta delle ‘radici’ cui si collega la ‘sincerità’ degli spettacoli e che dà un senso al tema del festival (tanto per quanto riguarda il lato ‘etnico’ e, in questo caso, anche ecologico).

Cinque giorni di spettacoli
Il festival è organizzato dal Teatro Sakkza (che vuol dire racconto, fiaba): è il teatro nazionale di marionette della Khakassia, esiste dal 1979 ma solo recentemente ha ottenuto il riconoscimento di ‘teatro nazionale’ (non solo formale: scatto salari eccetera). Naturalmente il termine ‘marionette’ è riduttivo: il teatro utilizza una varietà di tecniche che raramente ho visto padroneggiare da una stessa compagnia – marionette a filo, burattini, pupazzi, di piccole dimensioni o enormi (anche per parate/spettacoli di strada), animazione su nero, ombre, bunraku, semplice uso di maschere e altro – gli animatori sono attori di primissima qualità, una quindicina in tutto, e quasi tutti anche ottimi musicisti. Il teatro nel suo complesso ha un attività molto intensa (30 spettacoli in repertorio dei 100 prodotti nei suoi 25 anni di vita, numerosissime rappresentazioni in due diverse sale, progetti di impegno sociale: da segnalare il lavoro nelle carceri, sostenuto anche da ‘Open found’) e considerando tecnici, personale di sala, amministrativo eccetera può contare su circa 60 dipendenti (ma su pochissimi soldi). Forse troppi, certo (per fortuna anche un po’ della protezione del lavoro dell’ex URSS è rimasta in vigore), ma è inutile sottolineare ancora una volta che da queste macchine un po’ burocratiche che sono (o sono stati) i teatri del centro e est Europa, e che dalla solidità e continuità operativa che hanno garantito è uscito un grande teatro: quale teatro di figura da noi può contare su un organico simile? e quale teatro, avendolo, continuerebbe a produrre anche spettacoli molto semplici, dove la semplicità – e la ricerca della semplicità – non è una condizione economico-organizzativa ma un punto di arrivo, una scelta artistica?
Il repertorio di Skazka – con spettacoli anche molto recenti e uno prodotto per l’occasione – ha una parte molto importante nel programma del festival, ed è per me una autentica rivelazione (da solo vale i viaggio). Penso che sia la consapevolezza della qualità – per certi versi della eccezionalità – del proprio lavoro che ha la comoagnia spinto all’organizzazione del festival, che da un lato consente di proporsi agli altri teatri russi come elemento catalizzatore, dall’altro favorisce l’apertura e i contatti internazionali.
Il regista Eugeni Ibragimov e i suoi collaboratori catturano lo spettatore – adulto o bambino: ma la maggior parte delle produzioni sono per adulti – con immagini, storie, personaggi, in apparenza naïf, in realtà di notevole complessità estetica, filosofica, tecnica. La precisione, la raffinatezza dei movimenti non insegue tanto il realismo – ovvero la massima possibile affinità con il comportamento umano (come nelle nostre tradizioni marionettistiche più blasonate – quanto la «verità» del personaggio, che a volte risulta davvero indimenticabile.
Eugeni è sulla quarantina, circasso (caucasico quindi), piccolo, vitalissimo e di grande comunicativa (del genere che supera le barriere linguistiche – infatti non parla nessuna lingua occidentale – e pare lo renda eccezionale nei laboratori: questo mi dicono gli amici francesi presenti). Dopo innumerevoli vicissitudini e mestieri, quinti piuttosto tardi (ma la vita per un caucasico è un po’ più difficile che per gli altri nella nuova Russia, e certo andrà peggiorando), è arrivato all’Istituto superiore di Marionette di Pietroburgo (il migliore di tutta l’area ex sovietica) e ad Abakan è approdato nel ‘98. Oggi è amato in tutta la Russia (e conosciuto in Polonia, nella Repubblica Ceca, in Francia).

Le sue origini segnano molto – e molti – spettacoli, ma si contaminano volentieri con altre tradizioni e culture, tanto nella scelta dei testi e dei temi che a livello visivo e musicale (da quella classica russa – colta e popolare – a quella ebraica, dalle suggestioni locali di una antica terra di confine che si riconosce oggi nelle repubbliche di Khakassia, Tuva, Altaj a una evidente curiosità e conoscenza dell’arte visiva del Novecento), il tutto produce una varietà di stili, anche grazie alla collaborazione di scenografi diversi (Ibragimov non crea personalmente i suoi pupazzi), ma una sintesi molto personale (sostenuta anche da una competenza tecnica e tecnologica rara e non ostentata: luci e movimenti così perfetti che non te ne accorgi).

Jacob Jacobson è una fantasia muta, con musiche dal vivo, tratta dalla commedia di Aaaron Zeitlin: una storia privata – amore, gelosia, abbandono – si svolge fra i diversi piani di un transatlantico, ai primi del novecento; una crociera simbolica, che riunisce classi diverse e diversi tipi umani che navigano verso la rovina, fra naufragi reali o sognati, fino a un immaginifico happy end: un epilogo in cielo, in cui la creazione del mondo riparte (forse si può rifare tutto, forse un mondo migliore è possibile). Marionette a filo e pupazzi mossi su nero si muovono su più piani e sono di almeno tre dimensioni, il che non consente solo effetti prospettici suggestivi, ma un’alternanza serrata, senza alcun rallentamento tecnico (lo spettacolo è coprodotto dal francese Théâtre de la Manifacture).
Anche La coppa d’oro parla della creazione, ma a partire dalla tradizione epica della Khakassia; la scena, le maschere e i pupazzi (in questo caso di dimensione umana), utilizzano elementi visivi dell’arte rupestre e dei reperti delle diverse stratificazioni preistoriche e storiche, la vicenda scarna riprende frammenti di leggende turche, tutto è dominato da suggestioni della tradizione sciamanica. Soprattutto nella componente musicale – che in questo caso sovrasta qualitativamente quella visiva – ed è basata sulla tradizione folk di Khakassia e Altay, con strumenti originali e quell’incredibile accompagnamento vocale ‘di gola’, che quasi non sembra umano, che di solito si connette alla tradizione di Tuva (solo un po’ diversa).
Il tema della storia del mondo e dell’uomo e dei nostri torti verso la natura, è molto caro a Ibragimov e al Teatro Skaska ed è al centro anche dell’ultima produzione, quella appositamente realizzata per il festival, di cui abbiamo visto un’anteprima (adattamenti e tagli sono annunciati), caratterizzata da un indicativo titolo provvisorio: Athanatomania (dal greco, anche nel titolo russo, cioè: la mania dell’immortalità). In una serie di brevi quadri, commentati da diapositive/citazioni particolarmente efficaci, si percorre la storia dell’uomo, dalla creazione, al diluvio, su su fino alle scoperte scientifiche, alle guerre recenti, alla caccia, allo squilibrio dell’ambiente. Ma anche in questo caso il finale è luminoso: un mondo migliore è possibile, sta a noi. Un po’ didascalico – perché no? – lo spettacolo è visivamente splendido: uomini, animali, oggetti sono in questo caso di piccole dimensioni, inquadrati, quasi schiacciati dalla scatola nera-mondo che si illudono di dominare. Una commedia umana (molti i passaggi spiritosi) e assieme una ‘tragedia dell’uomo’ (e ricorda infatti in alcuni passaggi l’opera di Imre Madach).

Pupazzi piccoli, piccoli e visione ravvicinata e raccolta, anche per lo spettacolo forse più unitario visivamente (ma molto ‘parlato’): Giuda Iscariota. Il traditore, adattamento di Ibragim Chauokh (il drammaturgo del teatro) del romanzo di Leonid Andreev. Esterni, interni e personaggi di una minuscola Palestina color ocra, illuminata da drammatiche luci di taglio, per una lettura non ortodossa del personaggio di Giuda: in questo caso il discepolo che più ama Gesù, il più buono e il più forte, l’unico che potrà portare a termine una missione così terribile. La costruzione dei personaggi in questa scala, e la forte componente testuale, valorizza al massimo la qualità degli attori-animatori.
Parlati certo, ma molto più accessibili, due spettacoli per bambini e per tutti.

Dove il mare è più blu si basa sulla Favola del pesce e del pescatore di Puškin: un racconto filosofico sull’incapacità di accontentarsi di quello che si ha: etica e ecologia anche in questo caso, con due pupazzi teneri e prepotenti.
Il vecchio e la lupa (che vedremo all’aperto nella seconda parte del Festival) è invece una favola circassa, ricostruita secondo la tradizione caucasica del carnevale folk ‘Jegu’: i pupazzi (di grande espressività in sé, essendo minime le possibilità di movimento) sono mossi da semplici bastoni grezzi e la qualità interpretativa degli animatori-attori è fondamentale. Nell’accompagnamento musicale dal vivo che da allo spettacolo un ritmo serrato, prevalgono le percussioni – tradizione circassa anche in questo caso. Qui Eugeni è tornato alle radici, e ha fatto uno spettacolo modernissimo.

Non parlerò di tutti gli spettacoli del festival ma di quelli che per diverse ragioni (non solo estetiche), mi sembrano più interessanti.
Restano nell’ambito del teatro ‘di figura’ voglio segnalare un’altra opera notevole, tanto più in quanto ‘opera prima’ di una giovane scenografa, artista visiva: Dopo la pioggia (Una storia familiare per adulti, si precisa quasi come un sottotitolo) di Tatiana Batrakova. E’ la storia molto delicata di un amore impossibile, o che semplicemente non c’è stato: un vecchio gattone malandato, un po’ gentiluomo di campagna (un po’ Oblomov), e una capricciosa vecchia barboncina, ritornano col pensiero ai gesti non fatti e non colti, fantasticano su quello che avrebbe potuto essere e cercano tardivi e comici recuperi (come quando il gatto porta in dono all’anziana amica un topolino ucciso). In uno spazio piccolissimo ma colmo di oggetti minuscoli, con due case/gabbie distanti e vicine e una terra di nessuno dedicata al ricordo e al sogno, i due animatori muovono i pupazzi a vista, e seguono con la mimica la loro storia (muta) assecondati da uno struggente accompagnamento musicale classico. Uno spettacolo cechoviano, con echi della grande narrativa, della distanza, della malinconia, dell’inverno, della incapacità di agire: il più russo che ho visto. La compagnia è il Teatro di Marionette della Repubblica di Mari El e anche questo mi sembra interessante: quanti di voi l’hanno sentita? Era territorio militare, praticamente tagliata fuori dal mondo.
(Negli anni in cui l’URSS si stava disintegrando, «Cuore» – credo – aveva pubblicato un’intera pagina con i nomi dei popoli sovietici. Forse qualcuno lo ricorderà: il lettore doveva indicare VERO o FALSO , fra circassi, ingusci, ceceni – oggi noti – e i meno noti yakuty, nivkhi, tungusi eccetera. Erano tutti veri!).
Anche nel teatro di solide tradizioni interpretative russe classiche, fondato nel 1930, di Komy-Permyastsky (non lontana dalla più nota Perm, a ovest degli Urali), è arrivata una piccola rivoluzione. Nel nostro villaggio, questa volta con attori in carne ossa, propone una favola-leggenda locale ‘a morale’ : nello scontro fra ricco e povero al cospetto di un ridicolo improbabile zar (nessuna allusione a Vladimir I naturalmente) vince l’intelligenza. La novità sta nel fatto che anche qui – nel cuore della Russia – è in atto un recupero della tradizione dei diversi popoli e il testo è recitato nella lingua locale, quella della minoranza-maggioranza, che è di ceppo ungro-finnico (un’isola etnico-linguistica persa nella steppa: chi sa, un gruppo rimasto indietro dalle grandi migrazioni).
Sarà la gioia di riappropriarsi delle proprie radici, la giovinezza della compagnia, il ritmo della storia (un po’ Bertoldo un po’ Il re è nudo): lo spettacolo del regista e scenografo Anatoly Popov, è davvero fresco, sincero, molto divertente (un grande successo ad Abakan, nonostante la differenza di lingua).
Personalmente trovo degno di nota che si abbia il coraggio di mettere in scena – per adulti – favole simili: del resto la semplicità, l’essenzialità dei temi, è una delle cose che il festival intende, e vuole valorizzare, come ‘etnoecologiche’.
Dal teatro di Orel – qui siamo a poche ore a sud ovest di Mosca (e potete facilmente trovare la città sulla carta geografica) – il festival ha deciso di invitare uno spettacolo che ha ormai dieci anni di successo in Russia, ma anche in California (dove ha debuttato): Zanna Bianca (un musical-parabola dal romanzo di Jack London), diretto da A. Michailov. La storia del famoso lupo, ma anche il rapporto simbolico fra uomo e natura, e l’evoluzione di un amore, sono realizzati con le tecniche tipiche del musical – coreografie, musica e una minima componente recitata – da una compagnia d’insieme, molto affiatata e molto professionale. Qualche cedimento al gusto americano nelle coreografie, non è comunque tale da compromettere l’originalità dello spettacolo, e si colloca in una linea di apertura e interesse internazionale di questo teatro (anche per l’Europa, quindi: l’Italia prossimamente).
Il teatro drammatico e musicale di Tuva, attivo a Kisyl dal 1936, ha colto invece l’occasione del festival per mostrare il meglio delle ricchissime tradizioni del territorio: musicali (le percussioni, le voci di gola) e di danza (decisamente di influenza orientale: mongola e cinese), legate allo sciamanesimo e al buddismo, violentemente repressi in periodo sovietico, e che stanno attraversando ora un grande revival (in parte sincero, in parte – mi sembra – orientato in senso commerciale/turistico). Lo spettacolo era un vero pasticcio, ma il virtuosismo vocale spiega il fanatismo degli appassionati di world music (provate a cercare in internet e ne avrete la prova).

(Sono stata a Kyzil e un po’ in giro per Tuva, credo che il fascino della musica, dello sciamansimo e del suo accostamento, e contaminazione, con il buddismo, non sia estraneo all’incredibile paesaggio collinare-desertico, incontaminato: siamo nel centro geografico dell’Asia, al confine con la Mongolia – recentemente riaperto – e Pechino è molto più vicina di Mosca).

Da Tuva, anzi proprio dal teatro di cui abbiamo appena parlato, arrivava anche Maxim Munzuk, l’indimenticabile protagonista di Dersu Uzala, il film di Akira Kurosava del 1975. A Munzuk è dedicata una mostra un po’ sintetica, che si propone però come prima tappa di un progetto franco-ceco, che vuole valorizzare il successo mondiale del film.
Tutti di buon livello, ma non particolarmente originali gli altri spettacoli russi. Limitate e amichevoli per ora (ma siamo alla seconda edizione e tutti sperano che il festival possa crescere), le presenze straniere: Estonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Egitto, Turchia.

Una scoperta per tutti è l’antico teatro turco delle ombre (risale al XXVIII secolo): con un laboratorio e uno spettacolo, l’istrionico Mustafah Mutlu, le sue storie e il suo personaggio Karagoz (che dà il titolo allo spettacolo) diventa un po’ la star del festival. Il recupero e il lancio internazionale di questa antica tradizione è opera del Teatro Nazionale di Ankara, ma Mustafàh fa davvero tutto lui: costruisce, anima e da voce a tutti i suoi personaggi, caratteri e storie popolari, naturalmente, col profumo di antichi bazar.
Da Ostrava e Tylova (Repubblica Ceca), due giovanissime compagnie propongono a loro volta la loro ricerca sulle tradizioni popolari (la ritualità, il carnevale): spiritosa la ricostruzione delle diverse versioni della Leggenda di Santa Dorotea.

E una singolare sintesi di tradizione vocale popolare fra Europa centrale e Russia asiatica, ci arriva da Eva Kanalas: Eva ha viaggiato a lungo in tutta quest’area, dall’Ungheria, alla Moldova, all’Altay, ha a studiato e fuso con pazienza e passione le differenti tradizioni vocali, le tecniche di respirazione. Il suo concerto (molto semplice, ma molto teatrale) è una sorta di esperanto della vocalità, oltre il quale sembra di ritrovare i rumori della natura, i richiami degli animali, il vento.
INTORNO AD ABAKAN
Ma Abakan non è solo teatro (e credo che neppure voi sareste venuti qui solo per gli spettacoli). La città è al centro di un territorio bellissimo: una prima escursione, ci porta fino a 60 km. circa dal centro, ed è alla scoperta di alcuni dei principali monoliti e monumenti megalitici (simili a quelli bretoni o scozzesi), steli funerarie, totem, percorsi e recinti sacri imponenti e un po’ misteriosi, così persi nella steppa. Pare che qui in Khakassia ce ne fossero migliaia.
La steppa è un prato incolto, un altopiano ondulato a perdita d’occhio. Qua e là qualche cavallo selvaggio e qualche cascina con recinti per il bestiame. Osservando meno distrattamente, l’erba è piena di piccoli fiori: fiori del freddo, come i nostri d’alta montagna, bianchi o di un azzurro intenso, o fucsia. Siamo in piena estate ma si può intuire il freddo e si può immaginare il paesaggio bianco a perdita d’occhio, con 35/40°C sotto zero per molti mesi l’anno.

Una seconda escursione, più impegnativa, ci porta fino a un parco regionale, naturalistico e archeologico, a 150 km circa a nord-ovest (oltre Abakan, nella regione di Krasnojarsk). Si costeggia a lungo lo Jenissey:, si intravedono grandi complessi industriali, in un caso almeno molto ben tenuti e relativamente recenti (è la Compagnia dell’Alluminio, il nostro sponsor: che pare brilli per correttezza ambientale e efficienza!), altri, vistosamente obsoleti. Immense tubature corrono lungo la strada e attraversano la steppa e mi chiedo e chiedo se trasportino gas metano e dove: è una delle grandi ricchezze della Siberia, che nasconde nel suo sottosuolo petrolio, carbone, oro, diamanti (in misura superiore ai territori del Golfo i primi e al Sudafrica i secondi), una ricchezza straordinaria, che fa della Russia il paese forse più ricco di materie prime del mondo. Ma nessuno me lo sa dire con precisione; del resto qui nessuno parla – a noi almeno – della crisi (dai contorni non chiarissimi) del colosso petrolifero russo di cui i giornali italiani, vedo al rientro, scrivono ampiamente Una ricchezza immensa è un immenso pericolo: certo la Cina verrà qui a prendere il suo petrolio (sono i giacimenti più vicini), speriamo pacificamente, e speriamo che il nuovo giro di vite di Putin contro l’autonomia delle Repubbliche non urti troppo le suscettibilità locali, dove in gioco non c’è qualche sciamano e la lingua kakassa, ma l’oro nero (anche le repubbliche autonome della Siberia centro meridionale, queste ai confini con la Mongolia – si vedranno infatti nominare da Mosca i loro governatori).
A un’ottantina di km. da Abakan il paesaggio diventa più marcatamente collinare ed è coltivato (grano e cereali), le cascine sono più frequenti, si vede anche qualche piccolo agglomerato. Poi boscoso. La nostra meta è il villaggio di Kazanovka dove inizia il parco: fra colline, fiume e bosco, le rocce nascondono incisioni rupestri che andiamo a scoprire con la guida di un simpatico giovane archeologo (i percorsi non sono segnalati per timore di vandalismi e saccheggi e in effetti non sarebbe facile trovare i reperti da soli): peccato che le spiegazioni siano in russo, con traduzione in turco e rari riassunti in francese (di Irina quando ne ha voglia). Risalgono da 3.000 a 500 anni a.C.: animali domestici e selvatici, di significato probabilmente rituale, ma che raccontano una vita non molto diversa da quella che contadini e allevatori conducono in parte tuttora. Il territorio è costellato da totem (tuttora sacri, di inconfondibile forma fallica) e steli funerarie. Se i pezzi scolpiti sono nei musei, ha un grande fascino trovarli così, persi nella natura. Ai bordi del parco archeologico (è stato ricostruito (anche per ospitare gli escursionisti) un villaggio di ‘jurte’: le classiche capanne siberiane, vaste strutture ottagonali di legno (tronchi grezzi o un intreccio di pali) coperte di feltro.
In uno di pochi momenti non programmati, mi spingo non lontano da Abakan, nella cittadina di Minusinsk, che conserva una chiesa abbastanza antica e un museo, all’interno di un bell’edificio ottocentesco., che pare sia il più ricco della ragione. C’è un po’ di tutto: reperti preistorici, soprattutto dell’età del bronzo, elementi di arredo, vetrine dedicate alla storia recente:il periodo sovietico inclusa guerra in Afganistan, la (prima) guerra in Cecenia, e anche all’artigianato e all’industria locale. Niente sui gulag, niente di niente.
Il tutto è molto polveroso e povero, ma sembra sia davvero il meglio che possano permettersi e il meglio della zona.
ABAKAN e la sua GENTE
La città di Abakan è recente, non credo di aver visto edifici precedenti gli anni ‘30 (il teatro Skaska risale agli anni ‘70 e l’enorme teatro drammatico è di poco precedente), fatta eccezione per qualche vecchia casa in legno, in tipico stile russo (finestre decorate e colorate, recinti e orti). Lo sviluppo – come per la maggior parte delle città siberiane che non si trovano sul percorso della transiberiana – risale alla grande colonizzazione, la spinta staliniana verso est, verso le miniere e comunque una qualche prospettiva di sopravvivenza dopo la crisi agricola e alimentare degli anni trenta. La città è stata ben concepita, viali grandi, molti giardini. Il parco centrale ospita una gigantesca statua di Lenin, una delle poche – mi dicono – in cui è seduto.

Per inciso: è probabile che in occidente non si sappia con chiarezza che Lenin – abbattuto nelle ex repubbliche sovietiche- in Russia è ancora l’indiscusso padre della patria (mi chiedo ad esempio: quando Berlusconi incontra il suo amico Putin è al corrente di quanto ancora sia leninista?). Ne parlo un po’ con gli amici russi: Lenin forse ha fatto qualche errore, ma non era consapevole, contrariamente a Stalin. E gli stermini in Caucaso ancora lui vivente?: quella era guerra civile. Vero, probabilmente. Inutile approfondire e sono troppo poco informata per introdurre i distinguo che penso ci vorrebbero. Non è facile parlare di storia, figuriamoci di politica: rispetto ai primi anni novanta – quando la gente parlava, parlava, parlava molto volentieri – mi accorgo che le mie domande irritano (se pure non – non ancora almeno – come quando rispondere poteva essere fatale). Parlando in un gruppetto di democrazia, sento un’efficace, scherzosa definizione: ‘la Russia è una monarchia burocratica’. Altrettanto scherzosamente gira la voce che un certo funzionario è lì a osservarci in quanto agente dell’(ex) KGB : ancora nei primi ‘90 gli agenti erano spesso gli interpreti stessi (che francamente mi mancano un po’: forse è per questo tipico accostamento che si studiano così poco le lingue?). Eppure la leadership Putin non sembra proprio messa in discussione: perfino Irina, che di certo ne coglie tutti i limiti, mi dice che è il primo politico russo di cui non si vergogni: parla una lingua correttissima e con scioltezza, non fa gaffes, non beve. E Gorbacev allora?: era un uomo del partito, molto più assimilabile alla vecchia nomenclatura, leggeva i suoi discorsi etc. Povero Gorby, così fondamentale e così poco popolare: potremo magari pensarci come sindaco per Milano...
I grandi edifici a 4/5 piani ricordano lo stile – e il degrado – moscovita: il problema della manutenzione e della pulizia degli spazi collettivi acquista in Russia, secondo Kapuscinski – e tuttora mi sembra – significati che vanno molto al di là del dato pratico, o del rapporto con la proprietà, investe l’idea che l’individuo ha di sé, del suo rapporto con la collettività. Abakan però come le altre città siberiane che ho visitato – è abbastanza pulita, nell’architettura non manca qualche originalità locale (nei balconi in legno, negli infissi etc.), qualche segno di decorazione tardo liberty, qualche ardita ‘modernizzazione’ (degli ingressi dei negozi al piano terra).

Si nota anche uno sviluppo recente: qualche edificio quasi nuovo in centro e una crescita della periferia (inclusa una recentissima chiesa in stile ortodosso classico), dove noto molte case unifamiliari in costruzione, di dimensione consistente, segno inequivocabile di sviluppo di una classe media.
La persona più intraprendente che ho conosciuto è il fondatore/proprietario del recentissimo ristorante-night club ‘Cosmos’ dove gli ospiti del festival cenano: è un uomo sui 35 anni, fattezze russe, del genere ‘duro’, le sue ambizione sono di avere tanto una clientela giovane, che di nuovi ricchi, e magari di stranieri: ma di stranieri per ora ad Abakan non se ne vedono, e del resto non si capisce perché ci dovrebbero venire. E’ praticamente uno sponsor del festival e comunica volentieri – è lui che mi accompagna al museo di Minusinsk – ma tramite la giovane segretaria: lui non parla una parola di inglese, come quasi nessuno ad Abakan (neppure in albergo).
A questo proposito faccio degli esperimenti coi giovani per strada chiedendo semplici indicazioni stradali (per il teatro, per la stazione, per il mercato): nessun ragazzo parla inglese, i maschi non si sforzano neppure di capirmi e aiutarmi, le ragazze, dopo il primo stupore, decifrano e danno indicazioni in russo e a gesti (più avanti, proseguendo il viaggio da sola, verifico che le donne della mia età – solidarietà? – sono quelle che si sforzano di più di aiutarti).
Un ragazzo francese ospite del festival – Lorent – riesce a stabilire qualche rapporto in più, da coetaneo: qualcuno trova alla fine qualche parola. Arrivano a scambiare informazioni sul servizio militare. Ne parliamo coi colleghi russi: mentre noi lo stiamo abolendo, mentre l’armata rossa (o rotta) è sempre più a pezzi, per i ragazzi resta un fondamentale rito di passaggio verso la maturità, i corpi e le facce cambiano, dopo, si ostenta durezza.
I giovani la sera si riuniscono in piccoli capannelli davanti alle rivendite di alimentari e alcolici (solo raramente davanti a veri e propri bar e solo in pochi all’interno dei locali) che sono aperte fino alle 23 e qualcuna anche 24 ore: acquistano birra in bottiglie grandi e passeggiano sorseggiandola. Tutti i ragazzi (e quasi tutte le ragazze) fanno lo struscio con in mano la bottiglia (maschi con maschi e femmine con femmine, rare le compagnie miste), qualcuno si infila in una sala giochi. Gira anche qualche bottiglia di vodka che, suppongo, d’inverno sostituirà la birra, disponibile in tutte le marche, nazionali ed estere, da 10 a 30 rubli: è notorio che la Russia vanta il primato mondiale per alcolismo, e mi sembra già di vederne qualche traccia nelle facce di questi ragazzi (ma dove si vedranno d’inverno poverini?). La campagna contro l’alcool, si sa, è stato forse il principale errore di Gorbacev, come può un uomo russo non bere?
Le ragazze sono vestite come le nostre ragazze (cioè in modo un po’ provocante: sempre che si considerino provocanti per esempio l’ombelico in vista e le magliette strette sul seno spesso prosperoso) e sono molto truccate (come del resto le loro mamme e nonne): ma me le immagino, poverette, infagottate per proteggersi dal freddo dieci mesi l’anno e penso che sia veramente il minimo. Del resto sono anche spesso molto belle, più dei ragazzi. Si individuano subito i russi-russi e gli indigeni (con fattezze mongole: se pure non così numerosi come a Tuva, dove sono la maggioranza).
Cos’hanno questi ragazzi della profonda provincia russa di diverso dai nostri (di una profonda provincia italiana)? Sono molto simili certo, queste sere d’estate sono un sabato del villaggio globale, ma temo siano più lontani dal mondo: pochissimi i punti internet ad esempio (e come navigare del resto senza inglese?). Girano pochi quotidiani, la televisione ricorda la nostra peggiore televisione: i telegiornali hanno un taglio decisamente locale, e il mondo passa attraverso X Files o Sonia Braga (che doppiata in russo è ancora più improbabile del sergente Moulder). Come potranno, questi ragazzi, accorgersi o reagire di fronte alle censure all’informazione, ad una prossima chiamata in Cecenia, o all’ultima riforma (che rende le elezioni una farsa)?
Cosa potrà importare loro di tutto questo, se non sanno neppure che – o perché – sta fallendo la compagnia del petrolio che potrebbe essere la loro ricchezza?
Gli spettatori del festival, davvero molto numerosi, confrontati con la ‘strada’ sono probabilmente un élite, un po’ più ‘borghesi’ (vestiti della festa, ma malissimo: è quello che passa il convento nei negozi locali, forniti, ma a modo loro, soprattutto con prodotti nazionali in cui per le donne dominano i tessuti sintetici). A teatro si va spesso tutta la famiglia: è periodo di vacanza, gli spettacoli sono – anche – per ragazzi, i prezzi bassi: il festival è un’offerta opportuna e gradita. Come è nella tradizione russa singoli spettatori portano spesso fiori agli attori: e anche i marionettisti qui sono vere proprie star (quelli del Teatro Skaska: del resto se lo sono conquistati, sono conosciuti e se lo meritano). Gli applausi ritmati – sono di solito molto caldi.
Il festival ha anche un altro sponsor individuale (oltre al proprietario del Cosmos): è Natasha, una signora quarantenne gentile, non bella ma vestita meglio della media anche quando è in tuta (di marca), che mette a disposizione il suo lavoro (accudisce maternamente gli ospiti, senza parlare nessuna lingua oltre al russo e li scarrozza con un macchinone di sua proprietà), e paga anche qualche conto per il teatro, per pura amicizia (naturalmente tutti la coccolano). Da dove arrivino i suoi mezzi, non so, ma certo una figura impensabile in periodo sovietico.
A qualche km. dalla città, nella collina che domina il fiume Abakan, c’è la zona delle dacie: come a Mosca, come dappertutto: anche qui la dacia non è tanto un luogo di riposo, quanto di secondo lavoro, è l’orto familiare (da qui verdura e sopravvivenza, e mantenimento del legame con la terra). Alcune sono villotte, altre poco più che capanni per gli attrezzi, più o meno ben tenute, non riscaldate (me le immagino in pieno inverno sommerse dalla neve).
DOVE SONO I GULAG?
Si stima che in Siberia, nel periodo stalinista, abbiano pero la vita 20 milioni di persone. I campi più duri e la maggiore concentrazione era più spostata a nord est e nella zona delle miniere, ma anche qui dovevano essercene molti (tuttora ci sono prigioni importanti, naturalmente per reati comuni). Irina ha un ricordo simpatico legato a una conferenza tenuta in zona nei primi anni ‘60: ricorda di essere capitata per caso a mangiare nell’unico possibile locale di Minusinsk: un postaccio, ma con un menù sofisticato, in francese, a prezzi bassissimi: incuriosita ordina tutto quello che può: una specie di pranzo di Babette; scopre poi che il cuoco è un ex deportato che non sa dove tornare e nella sua vita precedente era stato un grande chef (ristoranti, ambasciate, forse al Cremino!).
Chi sa quanti, dei pochi scampati, saranno rimasti.
Ma i campi, dove sono? Un po’ saranno state catapecchie non in condizione di stare in piedi. Un po’, quelli legati alle strutture produttive, saranno stati riconvertiti, e avranno subito lo stesso degrado. Ma possibile che non si sia pensato di tenerne in piedi uno?
O a un monumento al deportato. O a un museo. ALLA MEMORIA insomma?
(A Kysyl/Tuva entro nel piccolissimo ‘museo dell’oppressione’ – o della repressione – e mi aspetto di trovare qualche traccia: ma no, si riferiscono all’oppressione di buddisti, sciamani e indigeni in genere).
Forse da qualche altra parte nella grande Siberia ci sono tracce più conservate: forse, come suggerisce Kapuscinski, bisogna cercare le tombe collettive lungo la transiberiana. Certo, fra non molto la gente di qui – i giovani soprattutto – non ne saprà nulla. Non è un dettaglio come sa chi è stato a Auschwitz-Birkenau o anche solo alla Risiera di San Sabba. Non posso fare a meno di pensare che non sarà così difficile rifarne di nuovi.
LE CENE AL COSMOS
La prima cena al Cosmos è un ricevimento alla grande, come me ne ricordo a Mosca, del genere a buffet. Spicca il pesce affumicato (di fiume), aringhe, un ottimo salmone. Fra le verdure funghi soprattutto (e una specie di vol-au-vent con crema di funghi), naturalmente gli immancabili cetrioli, pomodori, cavoli, poi riso. I vini rossi vengono dal Sud America (commenti con i francesi), ma per fortuna ci sono vodka e cognac (ottimi). Le cene successive saranno tipiche russe: insalate ‘russe’ appunto, zuppe di cavolo o di carne, carne grassa con verdure. Il tutto è un po’ invernale. Però il pane nero è ottimo!
Le cene al Cosmos, che si articola in due piani aperti per cenare e ballare e dispone di un medio palcoscenico, si chiudono con numeri di cabaret: giovani attori legati al festival, qualche attore ospite, niente di speciale, ma un’atmosfera davvero festosa (ideale per fare tardi: se si potesse davvero comunicare!).
VERSO LA RISERVA NAZIONALE
FESTIVAL IN TRASFERTA
Dopo la prima fase ad Abakan il festival si sposta nel parco/riserva nazionale lungo il ‘mare Sayan’ (Sayano-Sushensko Reservoir): ci siamo tutti: gli organizzatori, le compagnie, gli ospiti, oltre a qualche funzionario del ministero della cultura e addetti al parco (ecologi o semplici guide): l’obiettivo è fraternizzare, discutere, fare escursioni e anche qualche spettacolo. Il tutto per 4 giorni. Un’idea molto bella e un’occasione unica.
LA DIGA
La guida Lonley Planet parla poco di questa riserva, credo perché non è semplicissima da visitare (guide, permessi). Punto di partenza è la portentosa diga Sayano Shushenskaia, il bacino idroelettrico di Sayanogorsk, dove arriviamo dopo due ore di bus . E’ la più grande diga di Russia e la quarta del mondo per emissione di energia, immensa quanto eccessiva, impressionante però e molto reclamizzata dalla grandeur sovietica: può produrre molta più energia di quanta se ne possa utilizzare/incanalare a lunghe distanze e del tutto superflua a livello locale (eppure ci sarà stato un piano?!). Gli impianti a valle sembrano infatti degradati/sottoutilizzati.
L’impresa ha creato un vero disastro ecologico, anche se è in questo disastro che ora noi ci godiamo i 4 veri giorni siberiani.

IL MARE DI SAYAN: LA TUNDRA!
Il fiume Jenissey ha creato quello che giustamente chiamano ‘mare di Sayan’, molto più di un lago, che si addentra nei monti Sayan fino alla Repubblica di Tuva. Per percorrerlo fino al campo base ci mettiamo più di 10 ore e ce ne vogliono altre 2 o 3 per arrivare all’estremo sud. Non sono stati distrutti villaggi o culture, ma si sono completamente squilibrati flora, fauna, clima: si è creato un vero e proprio microclima, molto più umido. In compenso il paesaggio è grandioso, selvaggio: navighiamo per 10 ore fra due pareti di boschi fitti (è la tundra), a volte il corso è largo e complicato da diramazioni, altre chiuso da rocce scoscese (al rientro vedremo in alto numerosi stambecchi, e sappiamo che ci sono orsi, perfino qualche leopardo delle nevi). Naturalmente si intravedono pesci (e qualcuno pesca).
Però l’effetto più vistoso del paesaggio acquatico è l’enorme quantitativo di tronchi galleggianti (e i tronchi che marciscono producono altre alterazioni chimiche nell’acqua), in alcuni punti sono recintati da cavi e boe, ma molti sono liberi tanto che, all’inizio del percorsi soprattutto, il battello naviga a vista: è comunque molto rinforzato a prua e mi immagino di essere su una di quelle mitiche rompighiaccio sovietiche che arrivavano a salvare le nostre incaute spedizioni al polo!

Questi tronchi non sono lì da poco, ma da quando è stato creato il bacino (una trentina d’anni). Recuperarli sarebbe costosissimo (anche se poco dopo la diga abbiamo visto le cataste di tronchi freschi e la fabbrica che li trasforma in carbone, molto contrastata dagli ecologisti) e non è stata accettata un’offerta giapponese, di recuperarli a proprie spese, e pagarli anche. L’informazione mi sembra suggestiva ma non del tutto convincente, come la spiegazione di Irina: orgoglio e grandeur sovietici non avrebbero permesso che un paese straniero interferisse nella zona. OK, allora, ma ora? Anche ora: non è questione di soldi, l’orgoglio nazionale è più forte (‘siete del tutto idioti in questo, voi queste cose della Russia non le capite’). Irina, e gli altri che la spalleggiano, non approvano questi difetti nazionali – i soldi dei giapponesi farebbero molto comodo al paese – a c’è ancora molto, comprensibile orgoglio nei confronti della grande ingegneria sovietica (certo se tutte queste capacità e ricchezze fossero state investite meglio!).
Ma la verità è anche che Irina (e gli altri russi che si occupano di teatro, fa eccezione un po’ l’ecologa), non capiscono bene perché faccio tutte queste domande cretine, perché mi interesso tanto a questi dettagli (il recupero dei tronchi, se là c’è stato un incendio, se c’erano villaggi sotto) e non mi godo la grandezza del paesaggio.
La foresta è mista: ai tronchi chiari delle betulle si alternano conifere (larici, credo) e un sottobosco molto fitto. Sono belle le striature bianco-argentate, pennellate sottili, che illuminano il verde cupo. Fra andata e ritorno vedremo questo paesaggio (12 ore di paesaggio apparentemente identico) in tutte le sue sfumature, con sole e cielo blu, cielo livido, pioggia e in tutte le ore del giorno. Credo di non essermi mai misurata con una situazione naturale simile (unico paragone possibile – ma su piccola scala – l’Islanda, forse, o certi paesaggi alpini) .
I BATTELLI/L’EQUIPAGGIO
Siamo ben 4 battelli (che ovviamente non possono comunicare fra loro durante il viaggio, se non ogni tanto superandosi/ raggiungendosi, con grandi saluti, come una gita scolastica). Compagnia simpatica, all’inizio si fa festa, si canta. Nel nostro gruppo ci sono i responsabili del centro nazionale per il teatro (due signore e un giovane molto compassati e controllati), gli ospiti francesi (la simpatica direttrice del centro di teatro di figura di Charleville-Mezières, Lucille, con il candido compagno Philippe, e il giovane Lorent, che è venuto da queste parti sulle orme di Dersu Uzala), una giovanissima e simpatica compagnia teatrale ceca (6 o 7 ragazzi molto motivati: e che almeno parlano inglese, oltre che russo), una giovane documentarista norvegese (silenziosa e molto ingombrante con la sua pur piccola telecamera), un pianista egiziano (Muhamed, che ha studiato a Pietroburgo, è molto ben informato, e per niente musulmano almeno a giudicare dalla vodka). Ma la vera anima del viaggio si rivela l’attore-animatore turco Mustafah, che sembra non uscire dai suoi personaggi: canta, balla e continua a farne tutte le voci, non sembra particolarmente afflitto perché la delegazione ufficiale del teatro nazionale sia rimasta ad Abakan (per l’indisposizione di un funzionario: tanto non è niente di grave), riesce anche ad insegnare qualche canzone in turco ai cechi e a Irina che è una gran festaiola.

Poi il tempo peggiora, ci si annoia un po’. Si mangia in continuazione (colazione, pranzo, cena) e si beve ciai. La nostra cuoca – l’equipaggio in genere – è simpatica e anche molto brava. Il bello di comandante, mozzo e cuoca è che sono di ottimo umore e sembrano contenti come noi, anche se non così sbracati.
AL CAMPO
Il nostro campo è oltre una specie di porto naturale, si apre all’improvviso e sono già le 22 passate. Ha piovuto e non si possono usare le tende. Dormiremo in alcune case (3) realizzate per gli ospiti (nuove, belle e ben equipaggiate) e, i più giovani (non io per fortuna) nelle cabine dei battelli, dove torneremo anche a mangiare.
La mattina presto tento un’escursione (sono molto contenta di aver portato gli scarponi anziché il computer: per tutti e due non c’era posto) ma poco fuori del campo i sentieri non sono segnati: qui ci si muove via acqua, le vie alte sono per gli animali. Dall’alto vedo una specie di villaggio, dove ci porteranno nel pomeriggio con uno dei barconi: è un vero vecchio villaggio contadino con orti (un orto con verdure e girasoli c’è anche al nostro campo), integrato da casette per gli operatori ecologici e dalle attrezzature per le osservazioni metereologiche; ci sono anche una quindicina, di splendidi cavalli selvaggi ed è qui che facciamo il bagno (in pochi per la verità) nell’acqua verde del mare di Sayan (ovvero del fiume Jenissey): fredda ma sopportabile con il sole fuori, densa come un liquido amniotico, avvolgente, molto gradevole. Al campo del resto faremo (il giorno dopo) un’esperienza altrettanto fisicamente gratificante la ‘BANJIA’: la vera sauna russa: FANTASTICA! In questo caso (ce ne sono di più grandi e industriali: ne parla con vivacità Franceschini e le abbiamo viste in molti film) è una casetta di legno con una grande vecchia stufa a legna che viene portata a una temperatura altissima, gettando acqua sulla stufa si alimenta il vapore e si alza ulteriormente la temperatura. Ci si frusta a vicenda con rametti di betulla (siamo fra signore) o altre piante, appositamente e non casualmente scelte (ci sono teorie e una letteratura in proposito), si interrompe versandosi addosso acqua gelata da un grande pentolone. Tutto ciò a più riprese, riposandosi per qualche minuto all’esterno. La tradizione – e l’uso maschile della banjia – prevede che nelle interruzioni si mangi e si beva vodka.
Ecco una cosa di cui avevo sentito parlare ma che non avevo mai fatto: forse non ho reso l’idea, ma è gradevolissimo. Capisco – e spero – che sia una di quelle abitudini/tradizioni legate al clima e non solo che nessuna Jacuzzi potrà sostituire.
Così paonazza potrò godermi meglio la festa finale, così come la sera prima – rinfrancata dal bagno nel fiume – lo spettacolo serale nella grande jurta: si tratta di un grande spazio poligonale di legno, semiaperto, con panche intorno e con focolare al centro.
SPETTACOLI E INCONTRI
In realtà lo spettacolo serale sono i russi: ci sono tutte le compagnie ospiti, che sono per la quasi totalità provenienti dalla grande periferia russa. Credo che i luoghi comuni e la retorica siano una maledizione, anche per questo paese. Ma questa gente che si riunisce e canta (in attesa del vero spettacolo), trovando subito il terreno culturale comune (le canzoni popolari che sanno tutti) e l’accordo vocale giusto, formando con naturalezza un coro perfetto, da cui emergono, neanche si fossero accordati, le voci soliste), questa gente E’ ‘la grande anima russa’: un misto di allegria e malinconia, sentimentalismo e sofferenza, la durezza sparisce anche dalle facce, e la dolcezza della lingua cantata, intorno al fuoco, è quasi ipnotica (noto che Philippe – non teatrante, lavora nella telefonia, ma viaggiatore molto ricettivo – è davvero commosso: ‘inoubliable’ continuerà a dire di questa serata e del nostro viaggio). Al canto spontaneo segue – nella jurta- un concerto dimostrazione con strumenti originali della zona e accompagnamento vocale (di gola e non) I musicisti – che sono poi componenti delle compagnie – sono serrati in uno spazio piccolo-piccolo, davanti al fuoco.. E’ quasi impossibile che attori occidentali (italiani almeno) sappiano cantare, suonare e ballare come gli attori russi (e in genere dell’est): in questo continuano a darci molti punti!


Gli spettacoli più impegnativi, per quanto semplicissimi, si svolgono di giorno all’aperto (fra questi, bellissimo, ‘IL vecchio e la lupa’ di cui ho detto), come all’aperto è stato il rito sciamanico di inaugurazione: un po’ più complesso che a Abakan, ritmato da sapienti percussioni e con invocazioni alla madre tundra, al padre fiume e nostra partecipazione diretta.

Tutti abbiamo l’aria un po’ divertita e ironica – che più che meno – ma ci prestiamo senza problemi: mi sembra di capire che la maggior parte dei russi presenti sono tuttora atei (Irina per esempio, che ce l’ha con la Chiesa Ortodossa, ma quando ne parla male – in russo e francese è molto attivamente spalleggiata dagli altri). E’ forse proprio l’ateismo che rende lo sciamanesimo accettabile: in fondo è un gioco che esalta la tradizione e i valori della natura .
Nelle discussioni sul senso del festival (etno-ecologico), colgo che è proprio questo, senza grandi riflessioni, che ai responsabili interessa: recuperare originalità (etno), sincerità e semplicità (una sorta di ‘ecologia’ teatrale). Non si tratta tanto (soltanto) di affrontare temi legati alla natura e all’ambiente. C’è consapevolezza dei rischi impliciti nell’enfatizzazione delle specificità delle culture regionali (di chiusura verso le altre cultura, rifiuto della modernità, ma anche nazionalismo etc.) sono intuiti ovviamente, ma si preferisce non approfondire, almeno per ora. La realtà è che tutte le repubbliche periferiche hanno più o meno avuto le loro tentazioni di indipendenza, nessuna ha più alcuna speranza/velleità in proposito, importante è quindi che almeno non perdano/recuperino, le loro lingue e culture: lo stato centrale (Mosca) fa solo in apparenza e certo non abbastanza questa politica , mentre è da questo patrimonio che può arrivare alla cultura e al teatro russo un po’ di vitalità e ‘sincerità’. Tanto Svetlana, la direttrice del teatro e del festival, che Irina, ritengono che il teatro russo sia afflitto da cupezze, contorsioni false e poco espressive: la verità, l’immediatezza di comunicazione, la semplicità è stato il criterio per selezionare gli spettacoli.
Quanto alla coscienza ecologica (e alla consapevolezza delle problematiche ambientali) è in realtà molto superficiale (per quanto poeticamente sentita, come in Eugeni Ibragimov). Quando in un incontro fra teatranti e ecologi (cioè addetti del parco) chiedo conferma al fatto che la Russia non ha ancora ratificato in protocollo di Kyoto, solo gli ecologi sanno a cosa mi riferisco.
Faccio presente in una specie di assemblea conclusiva (dove si aspetta molto il nostro parere di stranieri), che – visto che il tema del festival si articola su due linee (eco e etno) intrecciate – la linea intrapresa/le scelte sono probabilmente corrette a livello russo, ma se si vuole che il festival diventi davvero internazionale (e non mi risultano altri festival focalizzati su una tematica così forte, significativa a livello mondiale, attuale etc.), tema e obiettivi vanno un po’ precisati/ teorizzati tanto nella direzione della funzione del teatro nella sensibilizzazione ambientale, che sul significato di ‘etnico’. Se no, dall’Italia, ad esempio, potranno arrivare tarantelle e mandolini, o al massimo commedia dell’arte (niente di spregevole, intendiamo, ma forse si può dare al tema un taglio più contemporaneo).
Vedo espressioni di consenso fra gli attori mentre Irina – che mi traduce dal francese in russo – è decisamente arrabbiata con me: la tesi dell’’etnosincerità’ è soprattutto sua e lei è pur sempre la presidente dei critici di teatro di Mosca (i russi quindi hanno difficoltà a contraddirla: ma siccome è una donna abbastanza eccezionale, oltre che aperta e molto preparata, sono certa che il suo nervosismo si trasformerà in riflessioni interessanti, forse qualche polemica sulla via del ritorno). Mi rendo conto di non essere stata cerimoniosa, come ci si aspetta in questi casi: cerco di rimediare, smusso il mio pensiero complimentandomi per la qualità – reale – degli spettacoli ‘etnici’ (che poi, in sintesi, hanno utilizzato testi in lingue originali, o modi-temi locali), e soprattutto ringrazio e lodo sinceramente l’idea e l’organizzazione (davvero complessa) del festival, oltre all’opportunità unica che mi è stata data. Penso davvero che potrebbe diventare un importante evento/appuntamento internazionale. .
PREMI PER TUTTI
Il soggiorno al parco nazionale termina con una grande festa in cui – anche con ironia verso i festival russi che sono di norma finalizzati alle premiazioni – vengono ‘premiati’ e ringraziati tutti, chiamati uno a uno, con diplomi personali e regali (dalle compagnie agli ospiti, agli sponsor, ai comandanti dei battelli). Naturalmente si fa festa con buffet, vino, vodka, cognac, canti e danze; per fortuna: la temperatura è scesa a livelli da (nostro) inverno o forse è l’umidità (e la banjia di poco prima) che me la fa percepire vicina a zero. Il processo di ‘fraternizzazione’ sembra funzionare, soprattutto fra i russi – che in gran parte non si conoscevano prima – molta cordialità, nonostante la difficoltà di comunicazione, anche con noi occidentali, con grandi sorrisi da parte degli uomini e abbracci dalle donne .
La giornata di ritorno è un po’ dura, piovosa fino al pomeriggio, la navigazione sembra lentissima, ma trionfale alla fine con un sole e una luce che allevia le stanchezze e ci riporta tutti sui ponti dei barconi.
Per 4 giorni i cellulari sono rimasti muti e non abbiamo aperto il portafoglio etc.
Ore 22: arrivi, addii (io riparto al mattino, quasi tutti partono per Mosca con l’aereo delle 01), molta cordialità, scambio biglietti da visita.
Irina sembra preoccupata per il mio viaggio, di cui peraltro ha autorevolmente approvato il piano. La delegazione moscovita – signore molto sedentarie che balbettano un po’ di inglese – si chiede cosa diavolo vado a fare a Kyzyl e come farò con la lingua.
Me lo chiedo un po’ anch’io. E’ dal 1° agosto che parlo prevalentemente francese (con qualche raro intermezzo di inglese), il mio russo è rimasto fermo a «karasciò» e «spasiba», in compenso gesticolo come Pulcinella! Quindi me la caverò di sicuro.
Proseguirei volentieri, ma ora di teatro non c’è proprio più niente da raccontare.
|
The Grammelot Professor
Il teatro epico di Dario Fo e Franca Rame nelle classi di italiano in Nord America
di Walter Valeri [Harvard University] |
Utilizzare i testi di Dario Fo e Franca Rame nei corsi di lingua italiana nelle università del Nord America è diventata una consuetudine. Sia perché dalla fine degli anni ’70 sono gli autori italiani più tradotti e rappresentati nel mondo, sia perché i loro testi sono un ottimo strumento per introdurre gli studenti alla conoscenza della nostra cultura popolare e della nostra lingua. Dario Fo, con le sue 80 opere teatrali sin qui scritte, lezioni di teatro reperibili in video, 19 regie di testi non suoi (da Moliére a John Gay sino a Rossini) saggi, scritti giornalistici, dipinti, lezioni di storia dell’arte, non solo è un campione di autonomia attorale, ma viva testimonianza ed apparentamento con quei commediografi e autori prolifici le cui opere sono modelli e fari di permanenza nella cultura teatrale e letteraria occidentale, oltre che italiana. Forse è bene ricordare che l’italiano parlato di oggi è una lingua segnata da una dinamica sociale particolarmente complessa e viva. Dove l’antica tradizione e varietà dei dialetti, l’evoluzione della lingua letteraria nata nel XIII secolo, il nuovo italiano televisivo standard, si scontrano in una dialettica permanente. Un fenomeno decisamente recente se appena nel 1936, come ricorda Corrado Veneziano,
"l’Italia era interna a un complesso processo di italianizzazione. Le regioni non avevano ancora assunto una propria autonoma solidità istituzionale, le spinte dialettali venivano percepite come divergenti e distraenti, e la valorizzazione di un particolare tipo di ‘nazionalità’ tendeva a censurane i suoni, costrutti, forme. Poco preoccupata di dialettiche linguistiche extranazionali (e anzi con gravi problemi di radicalizzante isolamento), la lingua italiana – a livello grammaticale e sintattico, ma anche lessicale e fonetico, - era priva di quel senso di problematicità e reciprocità che sempre caratterizza lo scambio e la negoziazione umana: era ingabbiata in una sua preconfezionata struttura e architettura. Nel giro di pochi decenni, le spinte che sempre sottostanno alle attività dell’uomo hanno messo da parte tali astrazioni e, con la stagione degli anni ’60 e soprattutto ’70, si è affacciata una nuova generazione di intelletuali e forze culturali. La quale, più modernamente, ha cercato di affrontare quella irriducibile contrapposizione che esiste tra lingue ‘standard’ e ‘minori’, colte e popolari fino a riprodurre l’unicità individuale – creativa e riformulativa dello scambio linguistico." 1
Una delle prime farse di Dario Fo, Non tutti i ladri vengono per nuocere(1958), è già presente in un’antologia pubblicata negli Stati Uniti all’inizio degli anni ’80 dal titolo: Teatro, Prosa, Poesia. Un volumetto che, a vent’anni di distanza, potrebbe servire come guida pratica e strumento di lavoro per gli insegnanti di italiano dei vari dipartimenti di lingua e letterature romanze che prevedono l’uso del teatro come strumento per migliorare la conoscenza della nostra lingua. Nella pagina introduttiva della sezione Teatro di questo manuale si legge:
"The theater is said to be a re-creation of life, presented in an imaginative and interpretive form, so as to excite our interest and our participation as well as delight us. The American poet, Robert Frost, defines literature in general as a ‘performance in words’. When we become intellectually and emotionally engaged in a literary work, we experience a kinship with the author to the point of thinking that he has managed to express ‘our very feelings’, or has given us at least an entirely different perspective on our concepts". 2
Non si potrebbe dire meglio per sottolineare i meccanismi espressivi che operano nella vita di ognuno di noi e del linguaggio teatrale o letterario che, in maniera attiva, influisce nell’ apprendimento o trasferimento del sapere. In genere possiamo dire che gli elementi che caratterizzano l’ apprendimento di una lingua, attraverso l’uso del teatro, si basano sull’ ‘immaginazione’, "l’interpretazione’, ‘la partecipazione’, "l’espressione" attiva e passiva, in presenza del testo designato. Sono momenti fondamentali della glotto-didattica che interagiscono durante il processo di acquisizione, introiezione, esposizione e reinterpretazione del testo, della sua funzione comunicativa corredata e rinforzata con esercizi di grammatica, sviluppi tematici e lessicali appropriati. Così come appare fondamentale ribadire che durante il processo di apprendimento gli allievi devono ricreare e chiarire, con l’aiuto dell’insegnate, il significato drammaturgico di ogni scena. Ogni frase, ogni parola va compresa dandole soprattutto significato e valore pratico di scambio. Vale a dire: gli allievi devono aver presente e si devono fare carico del loro obbiettivo finale: comunicare in modo chiaro ad altri (al pubblico, se vogliamo, o agli studenti che assieme a loro partecipano alle prove) attraverso la voce e l’azione, il maggior numero di informazioni contenute nel testo teatrale. La differenza fra l’uso di un brano di prosa e un testo drammatico è tutta qui, nell’uso e ottimizzazione di una somma di linguaggi che confluiscono nella performance. È chiaramente responsabilità dello studente trasferire con profitto il testo letterario dalla pagina all’immaginazione dello spettatore attraverso l’azione drammatica. Quello che invece rimane unico, non generalizzabile sotto molti aspetti, è lo specifico, la natura di ogni lingua e cultura. Nel nostro caso la storia dell’Italia e della lingua italiana: una vicenda culturale e politica che era e rimane unica nella storia dei paesi dell’Europa occidentale, per quelle ragioni che Robert Dombroski ben riassume in una prefazione di alcuni anni fa al volume monografico Italy: Fiction, Theater, Poetry, Film since 1950 stampato dal Council on National Literatures (2000):
"What sets the last fifty years apart from the earlier century is an increase in the intensity and consistency of literary activity at a level that could be called at once ‘high’ and ‘popular’. The essential reason for this is that, with the defeat of fascism and the liberalization of Italian social and political institutions, Italy has become a nation, not just in principle, but in fact. Gramsci’s ideal of a ‘national-popular’ literature, a reality in England and France since the early nineteenth century, has to a large measure now been realized in Italy." 3
Non c’è dubbio che, fra gli scrittori ed intellettuali che in Italia hanno maggiormente inciso e contribuito a creare questa unicità culturale sono, fra gli altri, Dario Fo e Franca Rame; per la vastità e consistenza della loro opera teatrale e per la costante presenza sui palcoscenici nazionali ed internazionali che dura da oltre cinquant’anni. Le loro commedie, da un punto di vista espressivo, sono profondamente permeate di parole e strutture sintattiche che fanno parte dalla lingua orale; frasi gergali, aneddoti tratti dalla quotidianità, con riferimenti storici e culturali che derivano da un’osservazione diretta e attenta della società, secondo uno stile comico di cui l’attore-autore Dario Fo è maestro indiscusso. Da cui ne deriva che l’utilizzo dei loro testi, nelle classi di italiano, implica anche una ricostruzione dei significati e dei contenuti delle singole frasi, secondo attività linguistiche comparative non così difficili (purché se ne afferri la problematica). Possono soprattutto stimolare negli studenti-attori, oltre che l’attenzione, iniziative sussidiarie di ricerca. Le osservazioni sui testi di Fo, già durante la prima fase di lettura ed analisi, si prestano ad essere disposte su diversi livelli: secondo una sequenza che va dal particolare al generale; aggiungendo note puntuali che definiscano in modo chiaro e spieghino
espressioni gergali, riferimenti storici legati alla storia dell’Italia contemporanea e della letteratura drammatica popolare ed erudita. Sin dalle origini il teatro satirico di Dario Fo e Franca Rame, come nella tradizione occidentale che vede in Aristofane il grande plantageneta, si cimenta con la comicità esercitata in presenza degli eventi tragici che si succedono nella società. Una comicità non di intrattenimento, ma impegnata in un'opera di smascheramento e affrontamento dell’ideologia del potere politico ed economico dominante. Anche se può sembrare ostico e difficile da accettare, la figura centrale, il cardine della crezione di Dario Fo, anche da un punto di vista linguistico, resta l'attore: " La mia crescita come attore è andata di pari passo a quella come scrittore. Ho imparato a scrivere e a pensare per il teatro nello stesso momento in cui crescevo come interprete", ha avuto modo di ribadire in una recente intervista rilasciatami lo stesso Fo. Da cui ne deriva ancora oggi, nonostante l’assegnazione del premio Nobel per la letteratura a Fo nel 1997, la difficoltà e reticenza da parte della critica militante o accademica, di parlare di Fo come autore di testi teatrali. Per quel suo continuo e puntiglioso rimando all'attore, come mediatore della 'tradizione orale' e non letteraria. "Io ho imparato il dialetto dai fabulatori, da loro ho imparato il dialetto più arcaico, era quello dei vecchi del luogo che non si peritavano assolutamente di italianizzare il dialetto, come succede adesso. Loro, evidentemente, conoscevano le forme idiomatiche, le strutture stesse della lingua. Ecco, io ho imparato la struttura del dialetto, che è cosa diversa dal parlare in dialetto. Sono questa struttura e questa lingua che si trovano poi nei miei testi teatrali", sempre dalla voce di Fo. L'esemplarità di Dario Fo, in quanto attore-autore, sta nella sua prodigiosa capacità di forgiarsi anche un linguaggio scritto non canonico per immettere l’immediatezza e fisicità del corpo espressivo nella dinamica e sequenza delle frasi. Un codice linguistico ‘eccentrico’ di scena, composto da una parte testuale direttamente intrecciata e reimpastata (scritta e riscritta instancabilmente a ridosso del pubblico) con in più quell'esplosione di creatività orale presa dai dialetti della valle del Po che lo stesso Fo definisce "grammelot". Gli allievi devono per forza prendere coscienza che il suo testo teatrale si sviluppa nella compresenza di struttura e improvvisazione. Altrimenti tutto rimane astratto e incomprensibile. Esemplare la dichiarazione di Fo: "Io non sono solo un letterato che scrive. Il teatro è fatto di oralità, suono, musica, tempi, ritmi, azione, e anche naturalmente scrittura. Diciamo che esistono due tecniche. Ci sono quelli che studiano esattamente le parole, e poi le recitano meccanicamente, rischiano di dimenticarsi completamente del loro significato. L’altro modo è suggerito da una famosa citazione di Shakespeare, che dice: ‘dovete sempre recitare come fosse la prima volta, le parole dovete ritrovarle’. Come se uno non conoscesse fino in fondo lo svolgimento di una frase, e dovesse ricostruirla mentre la dice."Già dai tempi del Dito nell'occhio (1953) e Sani da legare (1954) la sua scrittura per la scena, letta in trasparenza, è un pullulare continuo di presenze extratestuali. Un vero e proprio linguaggio 'abitato' come direbbe Bachtin, con in più il gusto della macchinazione scenica, costruita con la meticolosa precisione dei meccanismi linguistici e drammaturgici ad orologeria di George Feydeau. Ma il 'grammelot', citato prima, resta la vera, grande e misteriosa invenzione linguistica che lo stesso Fo intende nella stessa intervista come: "termine di origine francese, coniato dai comici dell'Arte e maccheronizzato dai veneti che dicevano `gramelotto`." E' una parola priva di significato intrinseco, un vero e proprio rompicapo per gli insegnanti di italiano, che spesso preferiscono ignorare questo epifenomeno linguistico, per non complicarsi la vita; un papocchio di suoni che riesce egualmente a evocare il senso del discorso. 'Grammelot' significa appunto, per Fo: "Un gioco onomatopeico di un discorso, articolato arbitrariamente, ma che è comunque in grado di trasmettere, con l'apporto di gesti, ritmi e sonorità particolari, un intero discorso compiuto". Precedentemente questo termine compare in alcune pagine di Leon Chancerel, critico e storico del teatro, attore in gioventù e collaboratore per qualche tempo di Jacques Copeau. In quella sede si testimonia come il vocabolo "grommelot" sia nato da un atto di creatività, un'invenzione, un gioco linguistico attorale spontaneo, intorno al 1918. Maria Helene Daste, figlia di Jacques Copeau, e anch'essa parte della scuola teatrale del Vieux Colombier, sostiene (in una dichiarazione registrata il 16 giugno, 1993) che "agli attori, come ai bambini, capita di inventare delle parole. Così è successo per il 'grommelot'. All'inizio si era usato il termine 'grummelot', che derivava da 'gremeau', e lo si utilizzava per designare un gioco di improvvisazione linguistica che imitava le espressioni, i ritmi e le sonorità tipiche di determinate situazioni." Stando alla testimonianza di Marie Helene Daste, la lezione originale sarebbe quindi "grommelot"; e "grammelot" il risultato di una traslazione italiana molto più recente e vicina nel tempo di quella proposta da Fo, che la fa risalire alla Commedia dell'Arte. Esiste una parola omofona, benché decurtata di una sillaba, "grelot" che significa sonaglio, bubbolo; e che, per estensione, è presente nell'espressione gergale (in argot) con "avoir le grelots", che significa avere fifa. Cioè agitarsi e modificare il grado della comprensibilità delle parole espresse (sino al farfugliamento); tipico di chi si trova in uno stato di spavento o forte alterazione emotiva. Tale espressione (segnaletica di una 'situazione') veniva usata comunemente dai personaggi e dalle maschere della Commedia dell'Arte nella Parigi del '500 ed era, come si dice in gergo teatrale: 'un tormentone'. Sull'incerto argomento ci sono serie ricerche trasferite in una tesi di laurea discussa all'Università della Sapienza di Roma ed un libro estremamente accurato ed illuminante scritto da Alessandra Pozzo dal titolo spiritoso Grr..grammelot parlare senza parole. Resta il fatto però che il 'grammelot' è, da un lato, una peculiarità testuale del teatro di Fo e, dall'altro, l'evidente ripresa in chiave novecentesca di uno degli elementi fondamentali dei Comici dell'Arte italiani del XVI e XVII secolo in cui "I personaggi parlavano tutti dei dialetti diversi. Tale moda era particolarmente favorita in quanto ogni spettatore poteva trovarvi un proprio conterraneo e il gran numero di scene mimiche rendeva questo genere di teatro accessibile e interessante anche per l'estero", come ha scritto Kostantin Miklasevskij nel suo vecchio ma fondamentale saggio sulle origini e la natura della Commedia dell’Arte.
Tornando alle virtù attorali e autorali di Dario Fo, impossibili da disgiungere nel momento in cui si fa un uso didattico serio dei suoi testi, è bene soffermarsi anche sulla sua gestualità e mimica spiccata. Un linguaggio tipicamente corporale di chiara discendenza francese (si fa riferimento ai vari Marcel Marceau ed Etienne Decroux) veicolati sullo stesso Fo, nel corso del suo apprendistato, da Jaques Lecoq, maestro di mimo che firma le azioni mimiche dello spettacolo realizzato in collaborazione con Franco Parenti e Giustino Durano Il dito nell'occhio. La presenza del mimo resta una componente importante in Dario Fo, che si distanzia dalla 'pantomima bianca' o dal mimo estetizzante francese, come ancora una volta ha chiarito Bernard Dort in occasione della prima di Mistero Buffo portato in Francia al Theatre du Challot nel 1973: "Dario Fo ha tutto per essere un mimo prodigioso. Sa riunire in un gesto della mano, del braccio o del corpo quei movimenti casuali ai quali noi non cessiamo di abbandonarci". Poi, lo stesso Dort puntualizza: "ma quello che appare sono le figure mutevoli, transitorie degli uomini immersi nella storia e nella lotta delle classi". L'attore-autore Dario Fo è un demiurgo, crea attorno a sè tutti gli elementi del testo (pre-testo) dello spettacolo, costruendo la propria 'maschera permanente', come fulcro generatore d' ogni elemento apprezzabile già in fase di scrittura. Questa radicalità non pretende di insorgere contro il testo scritto, in senso tradizionale, come è capitato in Italia inrtorno agli anni ’80, con rappresentazioni tendenti a spingere verso il grado zero la scrittura teatrale tout-curt. Si tratta piuttosto di enfatizzare e valorizzare l'unicità dell'individuo, sia l’allievo o l’allieva (per le classi di italiano) o l’attore. Riproponendoli come portatori o portatrici di una somma di specifici linguaggi che convergono in un esercizio di recita. In tal modo la recita, quindi la lezione, viene sottratta alla separatezza dei ruoli. L'azione dell'attore e dell’allievo non è improntata secondo l'imitazione dei soli corpi che non si vedono sulla scena: quello dell'autore e del regista demiurgo (il professore), ma è emanazione e compresenza dei due ruoli fondamentali vivificati grazie alla rappresentazione.
Pur essendo autore di tante commedie a più personaggi, sono i monologhi il 'precipitato' naturale dell'intera atttività di Fo. Da Poer Nano (1952) a Il tempio degli uomini liberi (2004) passando attraverso Mistero Buffo, Tutta casa letto e chiesa o altri Monologhi femminili scritti a due mani con Franca Rame, sono innumerevoli i monologhi di cui Dario Fo è autore e unanimemente maestro indiscusso: " Il mezzo più diretto, che trae la propria forza e lo stile dalle viscere del teatro popolare , è il monologo.", afferma lo stesso Fo. Genere in cui chiaramente i suoi talenti sono intrecciati e interagisco perfettamente mostrando la straordinarietà della sua arte attraverso un incredibile 'parlare teatrale' pieno di iperboli, scarti improvvisi di senso e di stile, astrazioni surreali associate a descrizioni realistiche, montate su di un ritmo che non si può che definire miranbolante e istrionico. I monologhi e le scenette di Mistero Buffo (nella versione italiana, curata direttamente da Franca Rame) sono un banco di prova straordinario per gli studenti e una chiave d’accesso fondamentale per capire ed interpretare l’intera opera teatrale di Dario Fo e Franca Rame. Nella sua straordinaria capacità di monologare Fo oscilla continuamente tra canto e racconto (si vedano emblematicamente: La nascita del Giullare, Il Matto e la Morte, Le nozze di Cana, Il cieco e lo storpio, La fame dello Zanni e Bonifacio VIII, etc.) per giungere a una fusione linguistica e teatrale immediatamente fruibile, per quanto complessa. Capace di catturare il senso della vista e dell'udito dello studente e dello spettatore ideale a cui l’allievo si rivolge, slittando continuamente tra i suoni 'gravi' e gli 'acuti', ricorrendo al diaframma; spostando i timbri vocali delle parole all'interno della fascia di emissione, specie durante l'esecuzione del "grammelot". Non a caso lo stesso Fo nel suo Manuale minimo dell'attore esorta gli attori ad imparare a fabbricarsi il proprio teatro. A tessere e impostare un testo con parole, gesti e situazioni immediate, ma soprattutto ad uscire dall'idea falsa e pericolosa che il teatro non sia altro che letteratura. Questa esortazione, di pari passo, può e deve essere trasferita agli studenti invitandoli a prendere coscienza della necessità di personalizzare il testo letterario dal momento in cui passano dalla pagina scritta alla sua trasposizione orale.
Anche lo stile per Fo è ben definito; ed è quello del teatro epico dove l'attore, attraverso il personaggio, racconta una storia, un fatto, una situazione reale. Per questo l’autore fa spesso riferimento ad esempi del passato storico, anche quello più remoto: "L'identificarsi con il personaggio è qualche cosa che è sempre stata abborrita dagli antichi. I greci non recitavano, non si traformavano, ma palesemente facevano intendere che c'era l'attore (nel nostro caso lo studente di lingua) di mezzo; al punto che l'attore principale recitava tutte le parti, non preoccupandosi tanto di imitare la voce della donna o dell'uomo, ma attraverso la gestualità, le inflessioni, le dimensioni vocali, suggeriva l'idea della donna, della fanciulla, della vecchia, l'idea dell'uomo. La concezione del grande teatro era contro l'identificazione, ed è una concezione propria di tutti i tempi, che attraversa i vari generi, dal teatro giapponese al teatro delle marionette. I grandi attori non si identificano mai con il personaggio, lo raccontano e lo presentano." Attingendo all’epos e ai miti popolari i testi teatrali di Dario Fo e Franca Rame, hanno un'autonomia assoluta di dialogo con gli studenti e col pubblico, una credibilità storica che fonda le radici nel sistema 'uomo' o ‘donna’. Nel momento stesso in cui si recita o si legge un loro monologo crolla il muro dell'economia controllata dello spettacolo, secondo una concezione del teatro borghese, e tutto viene continuamente riassorbito e rigenerato da quell'elemento naturale, mai interamente qualificabile, e quindi misterioso, che è il corpo o voce dell’allievo usata come strumento di rappresentazione e replica.
E’ comunque chiaro come, nello momento stesso in cui ci si accinge ad utilizzare un testo di Dario Fo e Franca Rame, sia necessario far comprendere agli studenti di che genere di materiale si tratti. Non solo spiegare la natura grammaticale e lessicale del testo, ma anche: come viene considerato dalla sua società chi l’ha scritto? Perchè l’ha scritto? E, soprattutto, per chi l’ha scritto? Non può essere tenuto nascosto che l’intera opera di Dario Fo e Franca Rame è stata concepita come strumento di contro informazione o ad alta valenza civile. Occorre dare risposte approfondite a queste tre domande che richiedono una fase di ricerca dedicata alla natura, alla dinamica e alla storia politica ed economica della società italiana contemporanea. Per quanto riguarda la vita dell’autore, una breve biografia può essere sufficiente, ma essenziale sarà tracciare un rapporto e quindi una linea di continuità del suo teatro, del testo adottato come strumento linguistico, con l’origine e le tradizioni del teatro epico popolare italiano. Non tanto per sconfinare nel reame della storia del teatro e della letteratura, ma semplicemente per capire il significato ed i contenuti del testo medesimo. L’assoluta originalità del teatro di Dario Fo non deriva dall’assenza di precedenti. Al contrario. E` il risultato di una sintesi tra la cultura dell’autore e l’invenzione di nuovi modelli linguistici rintracciabili a diversi livelli in tutte le sue opere. Si può anche aggiungere che cinquant’anni di storia italiana può essere in buona parte ricostruita e compresa seguendo il filo conduttore che passa attraverso i testi di Dario Fo e Franca Rame. Specialmente per quegli aspetti polemici, episodi politici e conflittuali, quasi mai documentati o espressi nei testi scolastici ufficiali. Per svolgere un lavoro linguistico utile coi testi di Dario Fo e Franca Rame si tratterà di seguire con gli studenti prospettive critiche, filologiche, storiche e pedagogiche a volte avventurose, ma eccezionalmente stimolate da quelle domande e risposte che nascono direttamente dal processo di accertamento verbale dei loro testi. Non c’è dubbio che il teatro popolare, più di ogni altro genere letterario, è in grado di proporre e trasmettere in forma scritta il discorso orale. Così come l’oralità è il contenitore naturale dell’ ‘epos’ legato all’esperienza della vita quotidiana: al tempo stesso memoria ed elaborazione permanente del passato di un popolo. Attuazione e sintesi linguistica straordinaria della cultura del paese che l’esprime, in senso ampio. In ambito pedagogico il teatro comico di Dario Fo e Franca Rame può veramente diventare l’esperienza linguistica attiva di un singolo studente o studentessa inserita in una piccola comunità (la classe) e sollecitata da uno stimolo fantastico (lo spettacolo o il saggio finale) alimentato da temi di interesse comune.
Resta da chiedersi perché gli allievi molto spesso, se interpellati in modo appropriato, mostrino di preferire il genere comico. A mio avviso, al di là della supposta preferenza dei giovani per le cose `leggere` o ‘poco serie’, è perché: sono ‘naturalmente’ attratti da quel genere di comicità impegnata nel promuovere un punto di vista alternativo, critico o antagonista rispetto a quello ufficiale. Gli studenti capiscono immediatamente che mettendo in scena i monologhi satirici o le farse teatrali di Dario Fo e Franca Rame, assieme allo sviluppo della conoscenza della lingua italiana (che include termini o argomenti spesso trascurati o rimossi se non addirittuta apertamente censurati) godono del piacere della trasgressione. Al di là delle origini e ragioni di tale piacere, che non è certo qui il caso di analizzare, effettivamente la frequentazione della comicità contenuta nella satira, in ambito pedagogico, offre l’occasione di riflettere criticamente sugli aspetti della vita sociale. Inoltre, da un punto di vista della dinamica di gruppo, ogni manuale di psicologia dell’età evolutiva evidenzia l`importante ruolo prossemico della risata e la profonda funzione del riso nei giovani; momento importante di coagulo e socializzazione all’interno di un gruppo di studenti. Il riso che scaturisce tipicamente dalla messa in situazione comica di un contenuto grave, a volte drammatico o addirittura tragico, è una delle forme espressive auspicabili in ogni processo pedagogico. Gli allievi ridono, se autorizzati e sollecitati al buon umore, e contemporaneamente metabolizzano empaticamente i meccanismi linguistici presenti nella comunicazione educativa. In generale, come scrive Lucie Olbrehts-Tyteca nel suo saggio Il comico del discorso, dedicato alla teoria generale del comico: il riso è utile ed è uno strumento auspicabile per sviluppare la conoscenza della realtà e la dinamica degli eventi che la compongono, non tanto ai fini del divertimento puro e semplice, quanto perché (attraverso la comicità) si coglie al meglio il significato di un argomento e delle idee di cui il linguaggio è naturale portatore. E noi sappiamo quanto siano vitali le idee nell`ambito della comunicazione e del linguaggio dato che per idee noi solitamente intendiamo delle cose da dire associate a come dirle. In termini di linguaggio le idee sono fatte dalla descrizione ( non necessariamente e solo in stile prosastico) di tutto ciò che nella vita si è visto, udito, toccato, studiato: in altre parole di tutta la propria esperienza.
"La differenza fra le varie lingue consiste nella diversa utilizzazione che i singoli popoli fanno dei suoni, combinandoli in modo tale da poterli applicare alle idee diverse. Sicché le convenzioni linguistiche si danno in base all`associazione di un determinato materiale con il suo rispettivo sistema di idee. Il parlante ha la possibilità di formulare liberamente nuove associazioni tra parole ed idee in modo innovativo." 4
Fa parte dell` esperienza pedagogica comune di ogni buon insegnante riconoscere in un testo comico un ottimo aggancio a cui legare obbiettivi linguistici e didattici. Bisogna segnalare la ‘particolare’ qualità della risata e dei temi spesso sottintesi e ricorrenti nel loro teatro: una sorta di cartina di tornasole dei rapporti tra teatro e società, tra cultura e potere.
Invitare apertamente gli studenti a discutere e dibattere i temi associati alla lezione di lingua italiana che si svolge durante le prove e l’analisi drammaturgica del testo teatrale significa trasferire dalla pagina scritta alla scena, dai banchi di scuola alla performance una riflessione intellettuale su situazioni, emozioni, fatti, contingenze reali, che appartengono all’intima funzione di ogni atto pedagogico attraverso una critica convincente. Per questo il teatro comico, nell’urgenza della situazione drammatica, riunisce tutti quegli aspetti del linguaggio che l’allievo ha precedentemente appreso durante i suoi corsi di lingua: verbi, espressioni, principi di intonazione, accenti congiungendoli con frammenti di acquisizioni culturali e storiche legate alla società italiana. Il momento significativo nell’uso del teatro come strumento per apprendere la lingua italiana non è dato dalla piacevole rappresentazione in sé; ma dal rapporto di creatività, analisi e complicità di gruppo che si stabilisce attraverso il riso e la valorizzazione iper-testuale che gli allievi svolgono coscientemente durante il periodo di prove. Nel teatro di Dario Fo e Franca Rame i due elementi fondamentali di ogni pedagogia si congiungono mirabilmente: l’alto coinvolgimento del sistema delle idee e del pensiero critico degli allievi, in chiave etica-filosofica oltre che linguistica, e la leggerezza liberatoria dello stile comico..
E` bene sin dalla prima lezione far presente agli allievi che in definitiva il testo, e quindi lo spettacolo, per Dario Fo è l`artificio drammatico di cui fare uso per instaurare un dialogo con il pubblico in modo satirico e comico. La satira ha un effetto benefico per Dario Fo, dato che " è impegnata in un contrasto aperto, legato alla confutazione razionale e all`esposizione pubblica di un diverso modo di concepire il ruolo e la funzione della cultura e, in prospettiva, della politica". Evidenziando il potenziale della satira, sia come argomentazione logica o come tecnica suasiva del discorso, il docente insegna agli allievi come esprimere un dissenso critico che si inalvea retoricamente in un rito teatrale e culturale; utile per un`analisi di fatti politici ed economici della società. Gli allievi dovranno esercitarsi sin da subito a percepire linguisticamente la presenza dell`ironia e, attraverso l`analisi logica, evidenziare nell`ordine del discorso i vari elementi comici che la satira contiene. Impareranno così a produrre in italiano, in forma orale e scritta, con intonazioni e manipolazione del linguaggio appropriate, il carattere dialogico e provocatorio della satira. Poiché la satira, da un punto di vista del linguaggio, favorisce l`accesso ad una vasta gamma della terminologia colloquiale che entra nel circolo vivo della lingua per la creazione di inediti veicoli metaforici. Le parole vi sono esposte in maniera sempre nuova, così da svolgere la completa potenzialità dei significati, o si evidenziano l`un l`altra, attraverso la scacchiera della sinonimia e dell`antinomia. L`aquisizione teorico-pratica dell`uso della satira e del discorso comico, il suo fine argomentativo e persuasivo, sarà un passo importante e decisivo nello sviluppo e nella padronanza della lingua italiana da parte degli studenti.. I testi delle commedie di Dario Fo e Franca Rame servono egregiamente a questo scopo. Sono un esempio formidabile per commentare i fatti della storia attraverso delle idee che si contrappongono a quelle ufficiali. Sono le idee (o se vogliamo l`ideologia) tipiche della cultura popolare. Relative al popolo italiano, inteso come moltitudine di cittadini, come recita lo Zingarelli; oppure secondo una forma di teatro che "ha la sua culla nella vita tradizionale del nostro popolo, e particolarmente nelle grandi feste annuali e stagionali di rinnovamento e propiziazione a cui partecipa l`intera società dagli strati più umili agli aristocratici" come scrive Paolo Toschi nell`introduzione al suo libro Le origini del teatro italiano. E` importante far intendere agli studenti che gli elementi corrosivi e polemici contenuti nella satira di Dario Fo hanno una funzione sociale utile e positiva, non nichilistica, poiché sin dai tempi di Aristofane la società occidentale ha un bisogno fisiologico della satira (fondamentale nella psicologia dei popoli) In concreto, se durante il corso di lingua italiana si intende fare uso di una delle tante commedie, video o cassette audio delle opere di Dario Fo e Franca Rame oggi è facile reperirle ed acquistarle perché disponibili nelle edizioni Einaudi e nel circuito internet che consente l`acquisto diretto dei materiali. Esistono anche edizioni critiche di alcuni testi annotati quali: Non tutti i ladri vengono per nuocere, Gli imbianchini non hanno ricordi, L’uomo nudo e l’uomo in frack, Morte accidentale di un anarchico, etc., appositamente pubblicate per quegli studenti e docenti di lingua italiana che intendono avvalersi di un testo facilitato nell`accesso alla comprensione. Oppure si può estrapolare e ricorrere a semplici scenette, gags o sketches, individuate nelle varie farse, atti unici o brani trascritti da trasmissioni televisive. Ma per raggiungere il miglior risultato si consiglia vivamente di introdurre gli allievi allo studio e all`uso dei monologhi di Dario Fo e Franca Rame. Specie i monologhi che compongono Mistero Buffo, oppure: Storia della tigre e altre storie, Fabulazzo osceno, Johan Padan a la descoverta de le Americhe (ovviamente nella versione tradotta nell’italiano standard a cura di Franca Rame) o i monologhi femminili presenti in Tutta casa letto e chiesa, Coppia aperta, quasi spalancata, L’eroina, Grasso è bello!, Sesso?, Grazie, tanto per gradire, etc. Questo perchè i monologhi sono la quintessenza dell’arte teatrale di Dario Fo e Franca Rame. Contengono in forma concentrata tutti gli elementi, gli spunti comici e satirici che costituiscono, in un intreccio indissolubile, l`intima qualità linguistica e poetica del loro teatro. E` nel monologo affabulatorio che si può percepire e sperimentare, ricostruendolo: il ritmo, la musicalità e la simultaneità dei significati tipici della lingua italiana orale che, come in tutti i codici linguistici orali , si associa e riflette la percezione uditiva e tattile della realtà. Una qualità linguistica espressiva stratificata e vibrante in grado di coinvolgere anche emotivamente lo studente e che fatalmente, nella fase alfabetica, tende ad appiattirsi. Nel caso di Mistero Buffo, in termini pratici si tratta di procedere alla scelta dei brani che costituiranno il materiale drammatico oggetto del corso. Io suggerisco, in ordine cronologico: La nascita del giullare, Moralità del cieco e dello storpio, Il matto e la morte, Le nozze di Cana. Tenendo presente che i singoli monologhi, vista la difficoltà e impegno attorale che comportano possono essere suddivisi ed assegnati a diversi allievi i quali si alterneranno nel dar vita al personaggio narrante. E` importante anche mostrare e commentare in classe con gli allievi, la versione in video recitata dagli autori di almeno uno o due dei brani prescelti; o altre commedie che daranno un`idea significativa dello stile popolare e del modo specifico di recitare degli autori. Quindi:
a) Individuare le difficoltà linguistiche. Spiegare le frasi ideomatiche. Chiarire il senso delle parole ‘oscure’, che risulteranno certo presenti, vista la qualità orale e di diretta derivazione gergale dei testi.
b) Spiegare i nodi storici e sociologici contenuti nel testo; secondo necessità e curiosità degli studenti. Se necessario, ricorrere alla collaborazione di insegnanti di altre discipline o motivare gli allievi all`uso dell`internet per ottenere risposte o spiegazioni soddisfacenti che possono essere condivise e trasmesse all`intera classe. Soprattutto quando il testo fa riferimento ad episodi della cultura popolare, della storia o società italiana medioevale, rinascimentale o con riflessi polemici sulla storia contemporanea.
c) Far leggere più volte e ad alta voce il brano originale agli allievi e mostrare la differenza fra la parola scritta e la parola orale, sottolineando come il ‘tono` della voce, la ‘velocità’, il ‘ritmo’, la situazione in cui viene pronunciata ed inserita la parola porta a modificarne il valore semantico sino ( condizione estrema) a capovolgerne il significato.
d) Chiedere agli allievi di riunirsi in piccoli gruppi di lavoro affinché realizzino un riassunto scritto del brano. Quindi a turno ne facciano un`esposizione orale e riassuntiva alla classe. E` importante che questa operazione venga svolta interamente dagli allievi e non dal docente che, per l`occasione, deve prestare una presenza passiva per favorire il raggiungimento dell`obbiettivo didattico principale secondo lo schema delle "quattro abilità": comprensione della lingua parlata, produzione della lingua parlata, comprensione della lingua scritta, produzione della lingua scritta.
e) Successivamente sostenere con loro una conversazione e sollecitarli a formulare in forma scritta ed orale delle domande appropriate, commenti e riflessioni.
f) Procedere alla definizione ed assegnazione delle parti e del testo italiano da memorizzare che costituirà la recita finale tenendo conto del livello linguistico e attorale degli allievi.
g) Analizzare e sperimentare con gli allievi nello spazio che ospiterà la recita finale i movimenti di scena, i singoli gesti adeguati al contesto suggerito dalle battute, dalle didascalie o dalla situazione contenuta nella scena. A volte è utile sostituire, nella frase preliminare, alcune parole difficili con un grammelot inventato dagli allievi per sottolineare che, nel caso della recita, le abilità di un parlante sono collegate al codice mimico espressivo ‘naturale’ proprio di ogni allievo o allieva facendoli intervenire con il corpo o la mimica facciale, il volume della voce, sui significati della lingua e i valori espressivi.
h) Ideare e stabilire collettivamente la scena in cui si svolge la rappresentazione: ambientazione e definizione dei luoghi deputati, sia fisici che psicologici. Immaginare che cosa accadrebbe al testo, ai suoi contenuti e alla storia rappresentata, se si modificasse l`ambientazione o l`umore dei personaggi.
i) Far individuare agli studenti quali, fra loro, saranno gli allievi-attori necessari per assegnare le parti; stabilendo prima in forma scritta e poi orale le caratteristiche fisiche e psicologiche utili per trasporre compiutamente il testo drammatico. Eventualmente, aggiungere nuovi personaggi per sviluppare la ‘situazione’.
j) Far scegliere agli studenti la sceno-tecnica necessaria: le musiche, i suoni naturali (il vento, la pioggia, il canto notturno dei grilli, etc.) le luci naturali o artificiali che tengano conto del giorno, l`ora, la condizione climatica in cui si svolge la rappresentazione. Decidere quindi i costumi e il trucco appropriati.
k) Regolare la recita per la ripresa video, la presenza del pubblico o studenti e docenti di altre classi di italiano che recensiranno lo spettacolo.
l) Far seguire alla recita un dibattito in lingua italiana col publico, nel corso del quale gli allievi ripercorrano i momenti salienti della loro esperienza o, tramite il video, durante una o più lezioni con commenti orali e scritti.
La dialettica dell’apprendimento della lingua così si realizzerà interamente durante le prove; che, in verità, altro non sono che la ‘lezione di italiano’, per quella esplorazione del testo, verifica dei contenuti, riformulazione e trasmissione delle idee che vi sono contenute. Il tutto a livello di gioco. Un gioco che si accompagni sempre con il massimo dell’impegno, con un vivo rapporto d’entusiasmo e spirito creativo, in modo da mobilitare tutte le risorse degli studenti, impiegando tutti i supporti teatrali richiesti e stimolati dal contesto esplorato: dalla scenografia alle luci, dai costumi alla musica, dall’idea che si fa parola e viceversa, al servizio del racconto e rappresentazione di quelle verità e stato di coscienza a cui i giovani sono, per innocenza e coraggio, fortunatamente ancora sensibili.
NOTE
1 Corrado Veneziano, "Laboratorio permanente di perfezionamento della lingua italiana." Inedito.
2 Althea Caravacci Reynolds, Argentina Brunetti, TEATRO, PROSA, POESIA, 1982, Saratoga, CA, ANMA LIBRI &Co
3 Robert Dombroswky, ITALY: FICTION, THEATRE, POETRY, FILM SINCE 1950, Griffon House Publications 2000
4 Alessandra Pozzo, GRR…GRAMMELOT: PARLARE SENZA PAROLE. DAI PRIMI BALBETTII AL GRAMMELOT DI DARIO FO, Bologna - CLUEB, 1998
Bibliografia di riferimento
Le commedie di Dario Fo e Franca Rame, Vol.I - XIII, Einaudi
Il paese dei mezaràt, Dario Fo, Feltrinelli, 2002
Lezioni di Teatro, Dario Fo, Einaudi, libro e video, 2001
Lu Santo Jullare Francesco, Dario Fo, Einaudi, libro e video, 1999
Fabulazzo, di Dario Fo, a cura di Lorenzo Ruggiero, Walter Valeri, Kaos 1992
Sesso? Grazie tanto per gradire, F. Rame, Jacopo e D. Fo, video C.T.F.R. 1998
TOTO’, manuale dell’attor comico, Dario Fo, Vallecchi, 1995
Il Papa e la Strega, Dario Fo, video, produzione C.T.F.R. 1991
Mistero Buffo, Dario Fo, video, produzione C.T.F.R. 1991
Storia della Tigre, Dario Fo, video, produzione C.T.F.R. 1991
Manuale minimo dell’attore, Dario Fo, Einaudi, 1987
Isabella tre caravelle e un cacciaballe, D. Fo, video, produzione C.T.F.R. 1976
Ci ragiono e Canto, regia Dario Fo, video, produzione C.T.F.R. 1976
Mistero Buffo, Dario Fo (audio cassette) Vol. I - VI
Sesso? Grazie, tanto per gradire, F. Rame, Dario e Jacopo Fo (audio Vol. I – II)
(su Dario Fo e Franca Rame)
Dario Fo e la pittura scenica, Christopher Cairns, Edizioni Scientifiche Ital. 2000
Dario Fo, Marina Cappa e Roberto Nepoti, Gremese, 1998
Il gesto, la parola, l’azione, Marisa Pizza, Bulzoni, 1996
Un comico in rivolta, Claudio Meldolesi, Bulzoni, 1978
Il teatro di Dario Fo, Paolo Puppa, Marsilio 1978
Dario Fo parla di Dario Fo, di Erminia Artese, Lerici, 1977
La storia di Dario Fo, di Chiara Valentini, Feltrinelli 1977
Dario Fo & Franca Rame, Joseph Farrell, Methuen 2001
Dario Fo, Joseph Farrel and Antonio Scuderi, Southern Illinois University, 2000
Franca Rame: a woman on stage, Walter Valeri, Bordighera, 1999
Dario Fo: People’s court jester, Tony Mitchell, Methuen 1999
Grr...grammelot: parlare senza parole. Dai primi balbettii al grammelot di Dario Fo,
Alessandra Pozzo, Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna, 1998
Dario Fo and popular performance, Antonio Scuderi, LEGAS, 1998
Dario Fo and Franca Rame, David L. Hirt, Macmillan, 1991
(alcuni web site utili per reperire materiali vari su Dario Fo e Franca Rame)
www.dariofo.it
www.dariofo.it
www.francarame.it
www.nobelprizes.com/literature/1997
www.geocies.com/Broadway/Wing/8730
|
|
Le recensioni di "ateatro": IX Crescita per la Tragedia Endogonidia di Romeo Castellucci
Per Uovo performing arts festival
di Oliviero Ponte di Pino |
Uno spazio di un candore abbacinante e lattiginoso. Una tavola riccamente imbandita, una sedia sulla quale è seduta una donna, anch’essa vestita di bianco. Tutto è immacolato, con una patina preziosa e antica. Come in un quadro uscito dal Settecento, l’insieme è elegante e raffinato. Ma questa solennità contrasta con la solitudine di questa figura, il suo silenzio.
La donna si serve, mangia la zuppa, lentamente, come in un rito. Sbriciola il pane, lo spinge dalla tovaglia fino a farlo a cadere sul pavimento. Appoggia il braccio sul tavolo, la testa sul braccio, si addormenta.
Da sinistra entra un inserviente, una sorta di Pierrot con un secchio e un forcone. Esplora lo spazio, vede le briciole. Inizia a pulire. Solo che al posto dello straccio dal secchio estrae un pezzo sanguinolento di animale. Il biancore del pavimento si tinge del colore del sangue. Terminato il compito, questo clown sadico e stralunato se ne va.
La donna all’improvviso si sveglia e condensa tutta la sua rabbia in un urlo che lancia contro il pubblico.
La Societas Raffaello Sanzio le definisce «azioni teatrali» e fanno parte del progetto della Tragedia Endogonidia che impegna in questi anni il gruppo cesenate. Per la precisione, questa IX Crescita ha inaugurato Uovo, performing arts festival milanese.
Minimale e intensissima, la performance della Raffaello si brucia in pochi minuti ma lascia una traccia profonda. Costruisce una metafora, e lascia che si sedimenti nella memoria e nelle emozioni dello spettatore, per interrogarlo e arricchirsi di possibili significati, come un rito misterico.
In questi anni, con la Tragedia endogonidia e le sue propaggini, la Societas tenta di fondare una mitologia, che possa essere interpretata a diversi livelli, nel suo sostrato archetipico ma anche negli inevitabili rimandi all’attualità, quasi a far .coincidere la dimensione rituale e quella politica. Spesso ci riesce ed è un merito grandissimo, con sofisticata semplicità.
|
A Torino la terza edizione del Malafestival
Il programma
di Redazione ateatro |
Terza edizione per Malafestival arts in mala causa, a Torino e Avigliana, con la consulenza artistica di Giacomo Verde. Tra gli ospiti, la Compagnia della Fortezza di Volterra e Tam teatromusica.

clicca qui x leggere il programma.
|
Al Pacino è Shylock nel film di Michael Radford
Alla Biennale di Venezia e nel Bardofilm database
di Redazione ateatro |

Al Pacino ce l’ha fatta. Uno dei suoi sogni d'attore era quello di interpretare il ruolo di Shylock, e ora è protagonista del Mercante di Venezia, film che Michael Radford ha tratto dal testo di Shakespeare, girato a Venezia negli scorsi mesi e ora presentato alla Biennale 2004.

Ma quella di Radford non è certo l’unica pellicola tratta da quel testo (così come non si tratta dell’unico film shakespeariano in cui è coinvolto lo straordinario attore americano). Per saperne di più, è possibile consultare l’imperdibile Bardofilm database e la filmografia essenziale Shakespeare: dai testi al grande schermo, oltre che leggere il saggio Bardomovies.
Senza dimenticare una delle più interessanti messinscene contemporanee del testo, quella firmata da Peter Sellars e analizzata da Anna Maria Monteverdi in Politica teatro immagini, che si misura con l’attualità del testo, come fa - almeno nelle intenzioni, pur non essendo attualizzato nelle scene e nei costumi - il film di Radford.
|
Italy for Rwanda 1994-2004
Un progetto per capire, per non dimenticare
La tournée italiana di Rwanda 94, lo spettacolo di Jacques Delcuvellerie
di Italy for Rwanda |
Tournée italiana dello spettacolo
Rwanda 94
Une tentative de réparation symbolique envers les morts, à l’usage des vivants
Nel decennale del genocidio
Palermo
Torino
Roma
Milano
Reggio Emilia
12 settembre – 10 ottobre 2004
In nessun’altra parte del mondo è più urgente che in Africa il bisogno di un maggiore impegno democratico. Il continente africano ha sofferto terribilmente per il dominio dell’autoritarismo e del governo militare nella seconda metà del Ventesimo secolo, dopo la fine degli imperi britannico, francese, portoghese e belga. L’Africa ha poi avuto anche la sfortuna di trovarsi intrappolata nel pieno della guerra fredda, quando ogni superpotenza coltivava l’amicizia di capi militari in cambio della loro ostilità verso i propri nemici. Un continente che, negli anni Cinquanta, sembrava essere destinato a sviluppare sistemi democratici nei nuovi Stati finalmente indipendenti si è trovato ben presto in mano a una serie di uomini forti legati all’una o all’altra sponda della guerra fredda. Il loro dispotismo ha fatto concorrenza a quello del Sudafrica, fondato sull’apartheid.
Ora il quadro sta lentamente cambiando, con il Sudafrica post-apartheid che svolge un ruolo di primo piano. Tuttavia, come ha sostenuto Kwame Anthony Appiah, "la decolonizzazione ideologica è destinata a fallire se non tiene conto sia della ‘tradizione’ indigena sia delle idee ‘occidentali’".
Proprio mentre vengono accolte e realizzate specifiche istituzioni democratiche che sono nate e si sono sviluppate in Occidente, è necessaria, se si vuole avere successo, una seria comprensione delle profonde radici del pensiero democratico nella stessa Africa.
Amartya Sen, La democrazia degli altri, Mondadori, Milano 2004
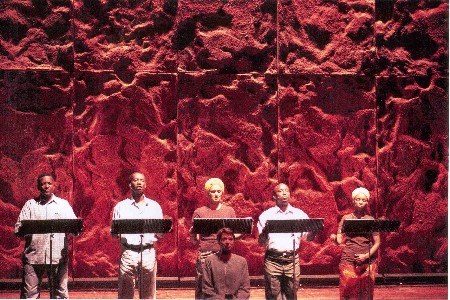
Italy for Rwanda 1994-2004
Un progetto per capire, per non dimenticare
di Antonio Calbi *
In Rwanda, fra aprile e luglio 1994, in soli 100 giorni
oltre 1.000.000 di persone sono state uccise.
I genocidari non hanno ucciso un milione di persone:
hanno ucciso prima una persona, poi un‘altra, poi un’altra ancora…
Giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto.
Ogni minuto di ciascun giorno, qualcuno da qualche parte veniva ucciso,
implorando pietà.
Nessuno ha ascoltato.
E il massacro è andato avanti.
10.000 morti al giorno.
400 ogni ora.
7 al minuto.
Ma l’ecatombe non è stato l’unico risultato del Genocidio.
Decine di migliaia di persone sono state torturate,
mutilate, violentate.
Decine di migliaia di uomini, donne, bambini, anziani
hanno sofferto per le ferite da machete, da armi da fuoco,
per le infezioni, la fame.
C’è stata una illegalità diffusa, saccheggi e caos.
Le infrastrutture del Paese sono state distrutte,
gli apparati dello Stato sono stati smantellati.
Le case distrutte, saccheggiate.
Ci sono stati più di 300.000 orfani
e oltre 85.000 bambini diventati capifamiglia.
Migliaia di donne sono diventate vedove.
Molte di loro sono state vittime di stupri e abusi sessuali
e hanno assistito all’uccisione dei propri figli,
dei propri mariti, fratelli, genitori, amici.
Molte le famiglie completamente cancellate,
con nessun testimone che possa dar conto della loro esistenza
e della loro distruzione.
Le strade erano stracolme di corpi.
I cani hanno fatto scempio dei corpi, anche dei corpi dei propri padroni.
L’intero Paese puzzava di morte.
Un immenso cimitero a cielo aperto,
una immensa discarica di corpi macellati
e abbandonati lì dove erano stati giustiziati
o gettati nelle centinaia e centinaia di fosse comuni.
I genocidari hanno avuto ben più successo nel loro infausto scopo
rispetto a quanto noi osiamo immaginare.
Il Rwanda è stato ucciso.
Quest'anno ricorre il decennale del Genocidio in Rwanda nel 1994. Una delle più immani tragedie mai accadute, fra i capitoli più neri del Novecento e dell’intera Storia dell’Umanità. Un Genocidio non soltanto rimosso dalla coscienza collettiva ma di cui l’Occidente ebbe allora una informazione completamente falsata e oggi a rischio oblio.
Perché tutto questo è accaduto? Perché questo odio, questi morti, questa indifferenza davanti al Genocidio, questa complicità con gli assassini?
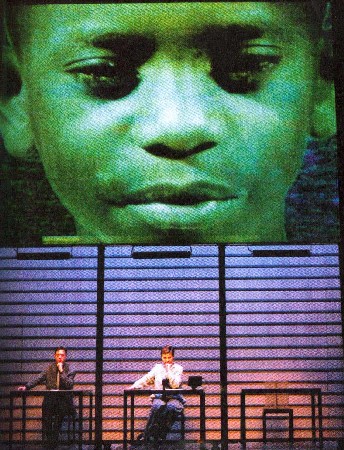
Sono queste le domande che si è posto il regista e autore Jacques Delcuvellerie e i suoi collaboratori ed è da queste domande, dalla necessità di dar loro delle risposte, che ha avuto origine il progetto di teatro totale Rwanda 94.
A dieci anni da quella tragedia, vicinissima nel tempo seppur geograficamente distante, queste stesse domande non hanno trovato ancora una risposta.
Il progetto nazionale "Italy for Rwanda 1994-2004" è dedicato alla memoria di quel Genocidio e vuole rappresentare una occasione per capire, per non dimenticare. Ideato e condotto da Teatri 90 progetti di Milano, è una manifestazione articolata che nel corso di cinque settimane rappresenta in altrettante città italiane Rwanda 94 – Une tentative de réparation symbolique envers les morts, à l'usage des vivants. Intorno allo spettacolo, come occasioni propedeutiche alla visione delle rappresentazioni o come momenti di approfondimento, "Italy for Rwanda 1994-2004" ha costruito un palinsesto di mostre, incontri, convegni, proiezioni di film e documentari.
"Italy for Rwanda" è un progetto di rilevanza nazionale e internazionale realizzato sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e sostenuto, in ordine di tappa, da: Regione Siciliana, Città di Palermo, Provincia Regionale di Palermo, Città di Torino, Provincia di Roma, Regione Lombardia, Comune di Milano, Provincia di Milano, Regione Emilia Romagna, Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia. Realizzato in collaborazione con Teatro Eliseo Stabile di Roma, Teatro Politeama di Palermo – Orchestra Sinfonica Siciliana, TST – Teatro Stabile di Torino, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, I Teatri di Reggio Emilia, e con ETI – Ente Teatrale Italiano, Ambasciata del Canada in Italia, Milanoltre, PAV, Aryadeva Comunicazione Integrata. Communication partner, Lowe Pirella. Media partner, Vita Non Profit Magazine. Uniche aziende private che contribuiscono alla realizzazione della manifestazione sono Kemeco per la tappa di Palermo, Henkel per quella di Milano. Hanno concesso il loro patrocinio: Ministero degli Affari Esteri, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Amnesty International, C.N.I. UNESCO, Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus.
Oggi il Rwanda sta percorrendo con coraggio, determinazione, speranza la difficile via della pacificazione. Un’intera Nazione, un intero Popolo, un intero Paese vuole e deve superare il periodo più nero della propria storia, deve e vuole guarire una ferita vasta e profonda. Possiamo fare molto per questo paese che in quei drammatici tre mesi del 1994 è stato abbandonato dalla Comunità Internazionale, la quale non ha voluto e saputo intervenire per fermare lo stermino. Non crediamo sia sufficiente che l’Onu dichiari il 7 aprile, giorno di inizio dei massacri, giornata della memoria del Genocidio rwandese. Kofi Annan non c’era a Kigali, lo scorso 7 aprile, allo Stadio Amahoro (Pace) di Kigali, affollato di presidenti degli stati africani, di corpi e rappresentanze diplomatiche, di migliaia di cittadini rwandesi. Uno stadio intero unito nel pianto, il pianto di un immenso funerale, di un dolore enorme e forse inestinguibile. Non sono sufficienti, ma crediamo debbano essere apprezzate, le scuse del governo belga, pronunciate dal primo ministro Verofstad Guy, sempre nelle stesso stadio, nella stessa occasione. E un poco imbarazza la posizione della Francia -– impegnata nello scambio di accuse con l’attuale governo rwandese presieduto da Paul Kagame –, e che probabilmente si è macchiata di gravi responsabilità.

Noi confidiamo in una grande adesione degli italiani a questo progetto che intreccia cultura, teatro, politica internazionale, solidarietà. Partecipare allo spettacolo, presenziare a uno degli incontri in programma, non è un impegno così gravososo. Certo abbiamo messo in conto che lo spettacolo di Groupov possa intimorire: per il soggetto che tratta, per la sei ore di durata, per la lingua francese nel qual è realizzato (ma con traduzione simultanea in cuffia in italiano). Allo stesso tempo crediamo sia importante e doveroso accogliere questa occasione per testimoniare la propia attenzione, la propria sensibilità, il proprio impegno. Verso il popolo rwandese, ma anche verso noi stessi, verso l’uomo in generale. La violenza, da sempre all’ordine del giorno nella storia umana, l’aggressività nella vita di ogni giorno, le guerre che avvampano il mondo, l’equilibrio ulteriormente intaccato l’11 settembre 2001, non ci legittimano a disinteressarci di un Genocidio quale quello rwandese. Un evento tragico e fortemente emblematico della fragilità degli equilibri che tengono in scacco il pianeta, e non soltanto del Male che pervade la vita. Male che sta a noi saper eliminare, o perlomeno contenere. Perché, come scrive Shakespeare, in uno dei suoi più disperati ritratti dell’animo umano, in Otello (I, 3):
Sta in noi essere così o così.
I nostri corpi sono i nostri giardini;
e la volontà è il giardiniere.

Rwanda 94 è qualcosa di più di uno spettacolo-evento. Frutto di un lavoro di documentazione e montaggio sviluppato per ben cinque anni dall’ensemble belga Groupov, diretto da Jacques Delcuvellerie, ha debuttato al festival di Avignone e poi nella forma definitiva a Liegi per poi essere rappresentato in Europa e nel mondo. In Italia ha avuto una sola memorabile rappresentazione, il 28 luglio 2002, a Udine, nell'ambito del Mittelfest.
Rwanda 94 è una creazione di grande valore etico, di grande impegno civile e umanitario, che dà visibilità all’orrore di un Genocidio rimosso - e dimostra come il teatro possa e debba essere, all’occorrenza, un cantiere attivo della coscienza, uno strumento per conoscere e comprendere e una occasione di solidarietà umanitaria.
Chi vede, sa; e chi sa, non dimentica più.
Yolande Mukagasana ha perduto tutta la sua famiglia nel Genocidio. Lei stessa è sfuggita per un soffio alla morte, al prezzo di una volontà, di un coraggio, di una intelligenza straordinarie. Yolande racconta la sua storia, da sola, nei 40 minuti che aprono lo spettacolo. La coscienza europea non ha avvertito l’enormità del genocidio rwandese. I giornali ne hanno riportato solo le cifre e la televisione ha trasmesso soltanto le immagini di corpi abbandonati lungo le strade, senza alcuna realtà, senza umanità. Erano stati uccisi e, in più, disumanizzati. Era necessario che qualcuno, con la sola realtà della propria esistenza, senza retorica e senza melodramma, incarnasse tutte queste persone che non avevano più una storia.
Rwanda 94 è una veglia funebre, con i suoi tempi di raccoglimento e di evocazione. In sei ore di spettacolo, si concretizza una sfida quasi impossibile: denunciare e commuovere, mettere insieme interpreti belgi e testimoni rwandesi, unire finzione e testimonianza, musica contemporanea e melodie africane, Recitazione e testimonianza. Un esempio di teatro della coscienza contemporanea durante il quale la tensione resta altissima fino alla fine, quando lo spettatore si scioglie in lacrime e applausi, e dove la consapevolezza, il sapere, non è mai scisso dall’emozione. Uno spettacolo che rappresenta un caso unico di intreccio fra passione e intelligenza, creatività e imperativo etico, necessità di sapere e emotività.
Rwanda 94: gli avvenimenti
Un minuscolo stato nel cuore dell’Africa con 7,3 milioni di abitanti: hutu (84%), tutsi (15%), pigmei (1%). L’equilibrio su cui si regge il Rwanda è fragilissimo: nel 1994 la situazione precipita. Queste le date principali della tragedia.
6 aprile. L’aereo che trasporta il presidente Juvénal Habyarimana è abbattuto da un missile mentre è in fase di atterraggio all’aeroporto di Kigali. Le milizie estremiste hutu e l’esercito cominciano a massacrare i tutsi e gli hutu moderati.
7 aprile. Dieci caschi blu belgi sono uccisi mentre cercano di proteggere il primo ministro, signora Agate Uwilingiyamana, che viene assassinata.
9 aprile. Paracadutisti francesi e belgi evacuano gli europei da Kigali: gli estremisti hutu formano un governo provvisorio.
25 maggio. La Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite definisce Genocidio i massacri in Rwanda.
22 giugno. L’Onu autorizza la Francia a intervenire per un periodo di due mesi: ha inizio l’operazione Turquoise.
11 luglio. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa stima le vittime in più di 1.000.000.
8 novembre. L’Onu decide la creazione del Tribunale Penale Internazionale per il Rwanda con sede ad Arusha, in Tanzania.
Il 6 aprile 1994 l’aereo presidenziale viene abbattuto. In poche ore la captale Kigali è chiusa da posti di blocco dell’esercito delle milizie estremiste hutu. Comincia la caccia agli oppositori hutu moderati e all'intera comunità tutsi. Durerà tre mesi. Verranno uccise 10.000 persone al giorno. In meno di 100 giorni, col machete, con le mazze chiodate, a colpi di fucile, di mitragliatrice, di granate, annegati o bruciati vivi, uomini, donne, bambini, anziani, saranno sterminati in città, sulle colline, nei templi e nelle chiese, nelle scuole e negli ospedali, nei campi e nei villaggi. Il terzo Genocidio ufficialmente riconosciuto dalla Comunità Internazionale in questo secolo, si è svolto davanti gli occhi del mondo intero. Gli esperti lo avevano annunciato da tempo, preceduto da pesanti massacri nel 1992 e nel 1993, predetto da una commissione d'inchiesta della Federazione Internazionale dei Diritti dell'Uomo nel 1993, dove l'entourage presidenziale era chiaramente indicato come responsabile.
Sul posto si trovava una forza armata dell'Onu comandata dal generale Roméo Dallaire, colui che aveva inviato nel gennaio del 1994 un messaggio urgente al segretario generale descrivendo i preparativi del massacro pianificato. Non solo non fu fatto niente, ma dopo l'assassinio di dieci caschi blu belgi, le forze dell'Onu abbandonarono il paese, lasciando che il Genocidio si compisse senza alcun ostacolo.
Durante questi tre mesi d'inferno, alcuni paesi intrapresero una battaglia diplomatica al fine di impedire che questa carneficina venisse qualificata come Genocidio. Si trattava di evitare che gli Stati venissero costretti a intervenire contro il governo rwandese, come prevede la legge internazionale se il Genocidio è accertato. Verso la fine, la Francia ottenne un mandato e fece partire l'operazione Turchese. Mentre il Genocidio era rimasto quasi invisibile sugli schermi, uno spiegamento mediatico accompagnò le forze francesi in Africa. Alla fine, l’operazione Turchese salvò delle vite, ma soprattutto protesse l'esodo degli assassini e favorì l'emigrazione in massa della popolazione sconvolta e sempre scortata dalle forze che avevano compiuto il Genocidio. Sembra che il fine reale dell'operazione fosse non tanto di arrestare il Genocidio quanto di frenare e sminuire la vittoria del Fpr (Fronte Patriottico Rwandese) composto di esiliati principalmente tutsi.
I media occidentali si sono occupati di questo Genocidio, ma dando una versione semplificata dei fatti. Diranno che i tutsi , noti anche con il nome di vatussi, erano un’etnia minoritaria ma costituivano da secoli la classe feudale dominante. Dopo la rivoluzione democratica e l’indipendenza, del 1962, gli hutu, largamente maggioritari, prendono il potere: cacciando dal paese un gran numero di tutsi. Sul finire degli anni Ottanta, i rifugiati rwandesi tutsi fondano un partito politico armato, l’Fpr, chiamato a condurre una guerra al regime hutu. Dopo violenti conflitti si giunge a un accordo di pace, che prevede il ritiro dei tutsi e la condivisione del potere. E’ in questo contesto che il presidente Habyarimana viene assassinato e l’odio pluridecennale delle élites estremiste hutu contro i tutsi si scatena, sfociando in Genocidio.
Ma può un massacro come questo essere definito un problema "tipicamente africano"? La ferocia e il numero delle atrocità compiute durante il conflitto, l’impossibilità di considerare l’opposizone tutsi/hutu un fattore etnico; l’importanza dell’Europa nello scatenamento del Genocidio, sono problemi che Rwanda 94 svela come momenti indispensabili, per comprendere, riflettere, ricordare.
Il Genocidio ha distrutto la vita di centinaia di migliaia di famiglie, coloro che sono sopravvissuti sono stati feriti per sempre. Oggi costituiscono una piccola minoranza in un paese fortemente sconvolto; molti si sentono abbandonati, incompresi, alcuni hanno gravi problemi mentali e le loro condizioni di vita sono in genere misere. E' a loro, in qualche modo "morti viventi", e alla memoria dei loro cari assassinati, che è dedicato il lavoro di Groupov. Essi ne sono l'ispirazione e la voce. Ed è a loro che dedichiamo anche il nostro lavoro e il progetto "Italy for Rwanda 1994-2004"
* Con suggestioni da Jacques Delcuvellerie (Rwanda 94), Giovanni Porzio ("Panorama", 1 agosto 2002), Kigali Memorial Centre.
Rwanda 94 in Italia
di Jacques Delcuvellerie
Abbiamo concepito Rwanda 94 come "un tentativo di riparazione simbolica nei confronti dei morti, a uso dei vivi". In altre parole con la convinzione che alcuni crimini riguardano tutta la comunità umana. Nessuno, a mio parere, è esonerato dal riflettere sulle cause, sui processi, sulle responsabilità, perché a questo punto si è spezzato qualcosa che ferisce profondamente la possibilità stessa di vivere insieme su questo pianeta.
Presenteremo Rwanda 94 in cinque città italiane, grazie al lavoro che Antonio Calbi ha condotto da un anno per rendere possibile questa tournée. Allora, ho cercato di interrogarmi, innanzitutto, sui rapporti che ho con questo paese e con i suoi abitanti.
E’ ovvio che l’Italia è il paese europeo a me più vicino, a parte la Francia dove sono nato e sono cresciuto, e il Belgio dove sto lavorando da più di trent’anni. Non solo l’ho attraversata da Nord a Sud per il piacere, l’amore, il lavoro – peraltro la madre della mia figlia più piccola è abruzzese –, Groupov ha nel suo collettivo degli Italiani, e ci fu anche un periodo in cui volevamo creare un centro permanente di sperimentazione in un piccolo paese di fronte al Gran Sasso, San Pietro di Isola…
Sento di avere un debito particolare verso coloro che, in Italia negli anni Sessanta e Settanta, hanno sviluppato un lavoro legato alle tradizioni popolari: il Dario Fo dell’epoca dei grandi spettacoli musicali, Giovanna Marini, la Nuova Compagnia di Canto Popolare, i Dischi del Sole e tante altre persone e realtà militanti. Anche se il nostro fare teatro era, all’origine, ben più influenzato da New York e dagli emarginati dei paesi del Est – il cui incontro si è materializzato in un gruppo come lo Squat Theatre – non ho mai perduto di vista questa fonte e ho personalmente partecipato per lungo tempo a ricerche e a creazioni ispirate alle forme artistiche delle classe cosiddette "subalterne". Tutto questo, nella mia storia, aveva una certa coerenza: ricercare le radici culturali degli oppressi, amare una donna i cui genitori erano scappati dalla miseria scegliendo l’esilio, vivere in mezzo a coloro – turchi, spagnoli, arabi, italiani…– che condividevano la stessa sorte.
Quando è nato Groupov, nel grande disincanto degli anni Ottanta, il lutto impossibile delle speranze anteriori è stato, per me, anche quello di una certa Italia. Questo lutto non è tuttora finito però, venticinque anni dopo, alla disperazione è subentrata la rabbia. Groupov non miete successi, come fanno in molti, con la nostalgia splendente. Come il Choeur des Morts de Rwanda 94, adesso siamo "arrabbiati, molto arrabbiati".
Forse questa potrebbe essere una ragione particolare per presentare Rwanda 94 a Palermo, Torino, Roma, Milano, Reggio Emilia. In questo paese, che ha buttato fuori dalle sue frontiere milioni dei suoi figli, i quali hanno conosciuto il razzismo, la discriminazione, lo sfruttamento forsennato prima di riuscire a integrarsi o di abbandonarsi al crimine e che, ai giorni d’oggi, come privo di ogni memoria, esercita a sua volta l’etnismo, il razzismo, il regionalismo sciovinista, l’esacerbazione criminale delle differenze. In questo paese che ha dato vita al fascismo e dove il fascismo, sia sotto le sue forme arcaiche e folcloristiche, sia sotto le sue forme ultramoderne, ritorna in modo arrogante e dominatore.
Il Rwanda è l’ultimo esempio e il più palese, delle conseguenze estreme delle teorie e delle ideologie razziali manipolate al servizio degli interessi del potere. Tutto sommato credo che all’Italia potrebbe far bene interrogarsi su questi tempi, sulla propria amnesia nazionale, attraverso la memoria del Genocidio del Rwanda. Non è certo una necessità specificamente italiana, però diciamo che qui, sembra che si ponga con clamore e urgenza.
RWANDA 94
Une tentative de réparation symbolique envers les morts,
à l'usage des vivants
Di
Marie-France Collard, Jacques Delcuvellerie, Yolande Mukagasana,
Jean-Marie Piemme, Mathias Simons
Collaborazione drammaturgica
Dorcy Rugamba, Tharcisse Kalisa Rugano
Musiche
Garrett List
Regia
Jacques Delcuvellerie
Regista assistente
Mathias Simons
Immagini
Marie-France Collard
Canti
Jean-Marie Muyango
Con
Yolande Mukagasana, Nathalie Cornet, Ansou Diedhiou, Stéphane Fauville,
René Hainaux, Clotilde K. Kabale, Carole Karemera, Francine Landrain, Majyambere,
Massamba, Diogène Ntarindwa, Maurice Sévenant, Alexandre Trocki
Direzione d’orchestra
Garrett List
Musicisti
Manuela Bucher (viola), Geneviève Foccroule/ Stéphanie Mouton (piano),
Vincent Jacquemin (clarinetto), Véronique Lierneux (violino), Marie-Eve Ronveaux (violoncello)
Cantanti
Christine Schaller, Véronique Sonck
Scene
Johan Daenen
Costumi
Greta Goiris
Maschere / marionette
Johan Daenen, Greta Goiris, Françoise Joset, Marta Ricart Buxo
Luci
Marc Defrise assistito da Frédéric Vannes
Direzione tecnica
Fred Op de Beeck
Assistente generale
Benoit Luporsi
Disegno sonoro / regia suono
Jean-Pierre Urbano assistito da Fabian Bastianelli et Jeison Padro Rojas
Direzione di scena
Joëlle Reyns, Yoris Van den Houte, Max Westerlinck, Pierre Willems
Sarta di scena
Carine Donnay
Regia luci
Marc Defrise / Frédéric Vannes
Regia video
Fred Op de Beeck
Stagiaire
Judo Kanobana
Produzione / amministrazione
Philippe Taszman, Sophie Coppens et Aurélie Molle
Amministratrice di compagnia
Françoise Fiocchi
Una produzione Groupov
n coproduzione con Théâtre de la Place, Théâtre National de la Communauté Wallonie Bruxelles, e Bruxelles/Brussel 2000, Ville Européenne de la Culture.
Con il sostegno del Ministère de la Communauté française – Direction générale de la Culture – Commissariat Général aux Relations Internationales de la Communauté française de Belgique (CGRI), Théâtre et Publics asbl, Rose des Vents Scène Nationale Villeneuve d’Ascq, Fondation Jacquemotte, Agence de la Francophonie, DGCI – Coopération belge au Développement, CITF, ONDA.
Spettacolo in francese con traduzione simultanea in italiano, in cuffia.
Durata 6 ore circa:
parte prima 2 ore
intervallo 20’
parte seconda 2 ore e 50’
intervallo 20’
parte terza 1 ora
Dopo due work in progress di circa cinque ore presentati a Liegi nel gennaio 1999 e al Festival di Avignone nel luglio 1999, lo spettacolo Rwanda 94 ha debuttato nella sua forma definitiva nel marzo 2000 da Groupov al Théâtre de la Place a Liegi e non ha cessato da allora di essere rappresentato in Europa e negli altri continenti.
Ha ricevuto in Belgio il Premio del Teatro 2000, il premio della ricerca SACD e il Premio Océ e in Francia una menzione speciale del Sindacato della Critica Teatrale.
Rwanda 94 è uno spettacolo che apre la strada di una nuova missione per il teatro: la varietà dei suoi linguaggi e tutte le loro risorse (voce, musica, canto, immagini, il racconto dei sopravvissuti) sono al servizio di un’istanza civile: far conoscere uno dei massacri più sanguinosi della storia contemporanea, quello avvenuto in Rwanda nel 1994.
Per dare un nome ai colpevoli, un’identità alle vittime, un ruolo all’informazione. Per dare visibilità all’orrore di un eccidio drammatico e silenzioso – 1.000.000 di morti – e dimostrare come il teatro possa essere un cantiere attivo della coscienza, strumento e occasione umanitaria.
Rwanda 94 è frutto di un lavoro di documentazione e montaggio durato ben cinque anni. Occasione unica per la qualità dell’allestimento, la drammaticità dei temi, la forza attrattiva dello spettacolo.
Yolande Mukagasana ha perduto tutta la sua famiglia nel Genocidio. Lei stessa è sfuggita per un soffio alla morte, al prezzo di una volontà, di un coraggio, di un’intelligenza straordinarie, ma anche, come spesso accade in certi drammatici momenti, per una combinazione del caso.
Yolande racconta la sua storia, da sola, nei 40 minuti che aprono lo spettacolo. "Non sono un’attrice", premette. Questo inizio rappresenta un momento fondamentale di Rwanda 94. Prima di tutto perché un genocidio non si può evocare. E’ una realtà che oltrepassa i mezzi dell’espressione artistica, qualunque essa sia.
La coscienza europea non ha avvertito l’enormità del genocidio rwandese. I giornali ne hanno riportato solo le cifre e alla televisione si sono visti solo dei corpi, anonimi, abbandonati lungo le strade, senza alcuna realtà, senza umanità. Erano stati uccisi e, in più, disumanizzati, resi anonimi. Era necessario che qualcuno, con la sola realtà della propria esistenza, senza retorica e senza melodramma, incarnasse tutte queste persone che non avevano conservato il loro volto, che non avevano conservato il loro nome, che erano stati spogliati di storia.
Rwanda 94 è una "riparazione simbolica nei confronti di quei morti". Un modo di mettersi in contatto tra un essere umano e l’essere umano di una realtà che è sconosciuta e pressoché inconoscibile. Se io, spettatore, che non ho lo stesso colore della pelle di questa donna, che non ho vissuto nel suo contesto culturale, sento ugualmente qualcosa per il modo in cui lei parla dei suoi bambini, della sua disperazione, della sua lotta, allora il Genocidio diventa meno astratto. Perché è esattamente questo il carattere del Genocidio. Lo si può vivere, non lo si può comprendere.
Rwanda 94 è una "veglia funebre", con i suoi tempi di raccoglimento e di evocazione. In sei ore di spettacolo, la sfida quasi impossibile: denunciare e commuovere, far convivere insieme interpreti belgi e tradizioni rwandesi, musica contemporanea e melodie africane, recitazione e testimonianza. Uno spettacolo in sintonia con l’essenza del teatro, in quanto "presenza viva che manifesta i morti".
Infine, un esempio realizzato di teatro della coscienza contemporanea.
Groupov è un ensemble formato da artisti di diverse discipline e di differenti nazionalità (attori, scrittori, musicisti francesi, belgi, italiani, americani…) fondato nel 1980 su iniziativa di Jacques Delcuvellerie e oggi articolato tra l’attività di ricerca sperimentale e la realizzazione di un repertorio di attualità politica contemporanea. A cominciare dal 1990 Groupov si è impegnato in un progetto sulla "questione della verità"" in Belgio e all’estero sono stati allestiti e rappresentati L’annuncio a Maria di Paul Claudel, Trash – A lonely prayer di Marie-France Collard, Madre coraggio di Bertolt Brecht, tutti testi e spettacoli come tentativi di risposta alla sofferenza umana. La creazione di Rwanda 94 si iscrive nella continuità di questo percorso e ne costituisce la quarta tappa.
Nato in Francia, ma attivo da molti anni in Belgio, dal 1976 Jacques Delcuvellerie si dedica al teatro, realizzando inoltre per la radio e la televisione belga numerosi programmi, molti dei quali dedicati alla cultura popolare. E' stato il conduttore per dieci anni della trasmissione televisiva Videographies. Fondatore e responsabile di Arte-Belgique, rinuncia via via alle sue numerose attività, per concentrarsi solo sul teatro e sull’insegnamento. Dal 1990 questa dedizione è esclusiva.
Yolande Mukagasana è una sopravvissuta al genocidio dei tutsi rwandesi del 1994. Infermiera, nei primi giorni del massacro perse il marito, i tre figli (il maggiore aveva 15 anni), il fratello. Lei si salvò miracolosamente, nascosta da una vicina hutu, sotto l’acquaio della cucina come racconta nel suo primo libro, La morte non mi ha voluta (La Meridiana, 1998), e nello spettacolo Rwanda 94, di cui è autrice e interprete.
E’ autrice inoltre di N’aie pas peur de savoir. Rwanda: une rescapée tutsi raconte (Editions Robert Laffont 1999) e Les blessures du silence. Témoignages du génocide au Rwanda (Actes Sud 2001).
Insieme a Danis Tanovic e Luisa Morgantini, ha ricevuto nel 2003 il Premio della Fondazione Archivio Disarmo.
Il progetto Rwanda 94
di Jacques Delcuvellerie
Il progetto Rwanda 94 è nato da una rivolta molto violenta. Di fronte agli "avvenimenti" stessi: il Genocidio perpetrato nell'indifferenza e nella passività generale. I morti non avevano nomi, visi, importanza. Nello stesso tempo, rivolta contro i "discorsi" che trasformavano questi avvenimenti in informazioni, alla televisione, alla radio, sulla stampa. Questa "drammaturgia" dell'informazione è uno dei soggetti dello spettacolo. A parte rare eccezioni la tragedia rwandese veniva presentata come una guerra tribale, un massacro interetnico fra hutu e tutsi, un problema tipicamente africano. La responsabilità occidentale non sembrava per nulla implicata in quello che appariva implicitamente come una recrudescenza della barbarie negra da quando gli europei se ne erano andati. Benché la storia del Rwanda non ci fosse nota all'epoca, io e Marie-France Collard sospettammo da subito che una tale semplificazione non poteva corrispondere alla realtà. Il fallimento dell'Onu, le grandi differenze di valutazione delle responsabilità secondo i media anglosassoni, belgi e francesi e soprattutto l'operazione Turchese ci persuasero che erano in gioco potenti interessi stranieri. Groupov intraprese allora un lungo lavoro d'inchiesta con etnologi, storici, giornalisti, sopravvissuti, testimoni, e organizzò tre viaggi di documentazione sul posto. L'equipe drammaturgica di base – scrittori, musicisti, registi, alcuni attori – ha partecipato dall'inizio alla fine a questa inchiesta e nello stesso tempo elaborava i primi elementi e la prima struttura della futura creazione. Poco a poco, l'obiettivo dello spettacolo si è precisato. Si è progressivamente definito come "un tentativo di riparazione simbolica verso i morti, a uso dei vivi".

Foto di Lou Hérion.
Questo orientamento implicava che il nostro lavoro non fosse solo di lutto e deplorazione, ma tentasse di rispondere alla domanda: Perché? Perché questo è capitato? Perché questo odio, perché questi morti, perché questa indifferenza davanti al Genocidio, perché questa complicità con gli assassini?
Noi consideriamo nefasta l'affermazione dei "saggi" secondo la quale l'orrore è inconoscibile e che l'analisi delle cause a cui si può risalire è impotente a renderne conto realmente.

Foto di Lou Hérion.
Questa posizione è stata molto sostenuta a proposito del Genocidio degli ebrei. Da un lato si diffondono ad ampio spettro la testimonianza dei sopravvissuti, le immagini del crimine, le descrizioni della macchina di morte e dei suoi ingegneri nell'intenzione altamente dichiarata di mettere in guardia le nuove generazioni dal ritorno dell'innominabile; dall'altro si rifiuta la possibilità stessa di comprendere e di analizzare razionalmente il fenomeno. Da questa doppia attitudine risulta una fascinazione morbida estremamente ambigua. Si costituisce una azione umana come prova insondabile di una "metafisica del male" e la responsabilità si divide tra un pazzo, Hitler, e l'uomo ordinario: quelli che l'hanno eletto, quelli che hanno creduto in lui, quelli che non volevano sapere, quelli che sapevano ma non hanno fatto niente, quelli che gli hanno facilitato il lavoro, quelli che vi hanno direttamente partecipato, ecc.
Avendo decretato come inappropriati, o meglio come riduttivi, gli approcci economici, politici del Genocidio, non resta più che il diavolo e la parte oscura che ciascuno porta in sé. L'avvenimento comincia così a sfuggire alla Storia e a entrare nel dominio della lotta eterna fra Bene e Male, quasi a dire che a voler prevenire il ritorno di questa modalità si annuncia già il risorgere del mostro.

Foto di Lou Hérion.
Questo tipo di approccio esiste anche a proposito del Rwanda. E' vano ripetere senza sosta: Mai più!, descrivendo l'orrore, ma decretando le cause aldilà della comprensione umana. E' l'incontro con i sopravvissuti che ha determinato ancora più fermamente questo orientamento. Yolande Mukagasana, sfuggita al genocidio e presente nello spettacolo, ci ha più volte ripetuto: "Voglio sapere perché i miei figli sono morti".
Rwanda 94 tenta dunque, imperfettamente certo, ma risolutamente, di restituire voci e visi alle vittime, ma anche di interrogare i motivi del loro sterminio.
La morte non mi ha voluta
di Yolande Mukagasana
Estratto dal monologo che apre Rwanda 94.
Ndi ikiremwamuntu gituye ku isi.
Ndi umunyafukira wo mu Rwanda.
Ndi umunyarwandakazi.
Sono un essere umano del pianeta Terra.
Sono un’Africana del Rwanda.
Sono Rwandese.
Nono sono un’attrice. Sono una sopravissuta del genocidio in Rwanda. Questa è la mia nuova identità. Quello che sto per raccontarvi sono sei settimane della mia vita che ho trascorso durante il genocidio.
Nell’aprile del 1994, sono una donna sposata. Assieme a mio marito Joseph, abbiamo tre figli: Christian, 15 anni, Sandrine, 14 e Nadine, 13. Siamo felici. Nel quartiere di Nyamirambo, a Kigali, dove vivo, mi chiamano Muganga, che in kinyarwanda, la lingua dei rwandesi, significa dottore. Mi chiamano così perché in Rwanda i dottori sono piuttosto rari. In realtà, sono la capo-infermiera di un piccolo ambulatorio dove è necessario che io curi chiunque. Il che mi fa pensare che di nemici non ne posso avere. Ma il 6 aprile, la situazione cambia in modo disastroso.
In tarda serata, mentre sono ancora nell’ambulatorio, il telefono squilla. E’ mio marito: Yolande, torna subito, ho bisogno di parlarti. Non ho avuto nemmeno il tempo di replicare, che aveva già messo giù il telefono. La sua voce non era normale, era angosciata. Mai, in sedici anni di matrimonio, mio marito mi aveva parlato in quel modo. Chiudo l’ambulatorio e mi rendo conto, tornando verso casa, che tutto è cambiato: le persone con le quali solitamente mi intrattenevo per quattro chiacchiere, di colpo non mi salutano più. Da parte mia, faccio i soliti cenni di saluto, ma le mie parole non trovano eco e i loro sguardi cercano di evitare il mio. Ho molta paura e mi pongo tante domande. A casa, trovo mio marito accovacciato in un angolo della sala da pranzo, la testa fra le mani. Disperato, piange sussurandomi: Perdonami Yolande, avrei dovuto accettare la tua proposta di provare ancora a fuggire da questo paese. Il genocidio, dal tempo che se ne parla, penso che stia davvero per cominciare. L’aereo del presidente è stato abattuto mentre tornava dalla Tanzania.
Non gli credo. Per me si tratta di una menzogna. Ma mi accascio al suo fianco e piango anch’io. Poco dopo, vedo arrivare mio fratello minore Nepo. Ha il viso tutto emaciato come se avesse appena finito di piangere. Chiama mia figlia Sandrine e le dice: Portami della farina. Con un pugno di farina di manioca in mano, si rivolge a me e mi chiede: Che cos’è questa Yolande? – E’ della farina. – No, questo non è farina, sono i tuoi: tuo marito, i tuoi figli, sono io, i tuoi parenti, i nostri amici. Dopo di che, soffia con violenza facendo volare via la farina. E ora dov’è la farina? Rispondo: E’ volata via!
Mio fratello mi fa arrabbiare perché non è proprio il momento di parlare della farina. E va avanti: E’ così che ci perderai tutti Yolande. Perderai tuo marito, i tuoi figli, gli amici, anche me, Yolande, mi perderai. Ma tu non morirai perché la morte non ti vuole. Avrai perso tutto: la speranza, la fiducia, la dignità. Avrai perso tutto Yolande, salvo l’amore. E con l’amore, ci vendicherai.
Al momento, non ho capito bene il suo discorso.
Poi, mio fratello, ci propone di scappare nel sud del Paese, in Burundi, ma era impossibile lasciare Kigali. Si uccideva ovunque e nelle strade gli sbarramenti impedivano qualsiasi possibilità di fuga dalla città. Abbiamo appena fatto in tempo a tornare a casa. Adesso Yolande non ci rimane che aspettare. – Aspettare cosa Nepo?, dico io – La morte, risponde lui. Ancora oggi, rivedo mio fratello risalire nel suo minibus… Dallora, non l’ho più rivisto. Mai più. Sei anni dopo il genocidio, mia nipote Véné mi ha presentato una valigia che custodisce gelosamente sotto il suo letto e nella quale vi sono alcuni pezzi di ossa che ha ritrovato su di una collina nei vestiti di Nepo, gli unici riconoscibili.
Mio marito, orfano per colpa di altri massacri perpetrati contro i Tutsi – come quelli che nel 1963 il mondo non ha mai voluto riconoscere – non riusciva a prendere la minima decisione. Sembrava già morto. Di conseguenza, ho chiamato i miei figli: Ascoltate, oggi andremo a passare la notte nella boscaglia. (…) In quella boscaglia, ci siamo rimasti un’intera settimana, senza nulla da mangiare né acqua per i miei figli.
La mattina del 7 aprile, io e mio marito abbiamo lasciato i ragazzi nella boscaglia per tornare a casa e ascoltare la radio. Era l’unico modo per capire cosa stava accadendo intorno a noi. Mi sono connessa alla RTLM, Radio Televisione Libera delle Mille Colline, una radio che non faceva altro che disseminare odio tra i fratelli, diffondendo una lista interminabile di morti. Quando tutto a un tratto, ho sentito il mio nome. Pensavo di diventare matta, ma anche mio marito aveva sentito la stessa cosa. Con Jospeph, ci siamo guardati negli occhi senza trovare il tempo di reagire perché il telefono ha cominciato a squillare ininterrottamente. Alcuni amici chiamavano per dare le loro condoglianze a mio marito, ma rispondevo io al telefono. Un vero incubo. Altri ci chiamavano per darci il loro ultimo addio: Gli assassini sono qui vicino. E’ giunto il nostro turno. Volevamo dirvi addio. Anche a voi non rimane molto tempo. Dei ragazzi telefonavano e dicevano: Hanno ucciso i nostri genitori, ma mia madre respira ancora, lei può venire ad aiutarci a portarla in ospedale?
Questi bambini non capivano che non potevamo farne nulla per loro, e ancora oggi mi chiedo se qualcuno può immaginare la disperazione di questi bambini di fronte alla nostra impotenza. A mia volta, ho preso il telefono e ho chiamato nel mondo intero, in tutti i Paesi dove speravo di avere ancora degli amici. Ho chiamato in quasi tutte le ambasciate di Kigali, ho chiamato la sede dei Caschi Blu. Quando non c’era una segreteria telefonica, la risposta è stata la stessa ovunque: Non possiamo fare nulla per lei, Signora. Ho chiamato la Nunziatura Apostolica, ma mi hanno messo giù il telefono. Disperata, ho anche chiamato la sede dei ribelli dell’Fpr ma la linea telefonica era stata tagliata. Di colpo, ho capito quello che mio fratello intendeva con: Bisogna aspettare. Ma io la morte non la volevo aspettare. Forse gli adulti potevano anche aspettarla, anche se non sapevamo perché. Ma come spiegare ai bambini che devono aspettare la morte, una morte preceduta da torture e umiliazioni, senza ragione, per il semplice fatto di essere nati [Tutsi]? Io non ce la facevo proprio.
Siamo ritornati nella boscaglia, dove, nei giorni trascorsi lì, ho avuto il tempo di ricordare la mia infanzia. Pensai a quando, all’età di 5 anni, scoprii che mi chiamavano Tutsi dopo che una lancia mi trafisse la coscia destra. Uomini vestiti di foglie di banano picchiavano mia madre affinché rivelasse dove si nascondeva mio padre, per ucciderlo. La rivedo che m’impedisce di piangere tappandomi la bocca con le mani. Se piangi, mi diceva, torneranno e ci uccideranno perché ovunque stanno uccidendo i Tutsi. Così, considerato che non potevamo andare in ospedale, se non a rischio di venire uccisi, sono stata curata da mia madre, con delle foglie di non so quale pianta che mia mi metteva sulla ferita.
Il 12 aprile, André, un nostro giovane vicino di casa, arriva nella boscaglia. Ha granate ovunque, nelle tasche e sulle spalle. Ma quello che mi fa più paura è il suo machete che brilla al sole. Lo vedo incamminarsi in direzione di mia figlia Nadine. Ho l’impressione che abbia molta paura. Dov’è tuo padre?, le chiede. E mentre Nadine abbassa lo sguardo, mio marito si presenta direttamente a lui: André, cosa vuoi, sono qui. – Jospeh – dice il ragazzo singhiozzando –, non ho nulla contro di te, né contro la tua famiglia, ma oggi è la fine dei Tutsi. Ascolta la radio, è un ordine ufficiale. Mi hanno spedito qui per dar fuoco alla boscaglia, ma non ne ho il coraggio. Fuggite da mia nonna, vi vuole molto bene e vi nasconderà. Ma state attenti a mio padre, è crudele e vi vuole assolutamente morti.
E’ bastato muoversi un po’ nella boscaglia per vedere tutti quei ragazzi, tutte quelle donne che avevo curato urlarci contro: Ecco i serpenti, ecco gli scarafaggi, bisogna catturarli. Mi chiedevo che cosa avessi fatto di tanto grave perché i mie figli venissero braccati in quel modo. Mi sono sentita tradita. Ho reagito e ho portato i miei figli dalla nonna di André, che ci ha accolto in lacrime. Per me è una santa donna, ci ha nascosti in una piccola stanza buia, ma non ci siamo rimasti al lungo perché l’indomani mattina suo figlio ci ha scoperto e cacciato via. Vedo ancora sua madre affrontarlo e dirgli: Se verserai anche una sola goccia di sangue tutsi, questo sangue ti perseguiterà tutta la vita, perseguiterà te e i tuoi discendenti. Sono tua madre, Jean, non dimenticarlo. – Me ne frego, quello che voglio è che se ne tornino a casa loro.
Così, siamo tornati a casa. (…) Mio marito mi dice: Ascolta Yolande, ho preso una decisione: per meglio proteggerci, dobbiamo separarci. Ho chiamato tua nipote, Spérancie, verrà a prendere i ragazzi, mentre tu andrai a nasconderti non so dove. Io, andrò alla barriera – No, se ci vai ti uccidono. – Lo sai che è un ordine ufficiale, devo assolutamente andarci, e se mi uccidono, forse avrete salva la vita. (…) Quando m’incamminerò verso la barriera, i loro sguardi saranno puntati su di me, questo permetterà ai ragazzi di poter attraversare la strada senza essere visti. Abbi coraggio perché devi sopravvivere per i nostri figli.
Ho capito che si stava sacrificando per salvarci.
Vedo Spérancie venire a prendere i miei figli e mio marito incamminarsi verso la barriera. (…) Io, mi sono rifugiata dal mio primo vicino, Côme, che era diventato un assassino e io non lo sapevo. Lui comunque non c’era perché era andato "a lavorare", come si diceva in quei giorni. Il genocidio era diventato un lavoro civico. Ero con Cécile, sua moglie, quando a un tratto vediamo dalla finestra Côme recarsi con un gruppo di militari armati verso la barriera dove si trovava mio marito. Hanno iniziato a separare gli Hutu dai Tutsi per poi fucilare solo i Tutsi. Mio marito non ha avuto la fortuna di morire subito. L’ho visto trascinarsi verso casa mentre Côme tornava a casa sua con tutta una serie di indumenti e alimenti che aveva prelevato da casa nostra. (…) Non appena mi ha visto, mi ha cacciato via. Nella fuga, ho visto una folla accanirsi contro una persona. Ho riconosciuto i vestiti di mio marito. Lo picchiavano, cadeva ma lui si rialzava, lo tiravano su e di nuovo lo picchiavano ancora, finché ho visto un machete abbattersi sul suo suo braccio. Ho visto la sua mano cadere per terra. Un filo rosso ha attraversato i miei occhi, mi sono sentita soffocare, sono svenuta.
Dopo il mio risveglio, avevo molta sete. Sono tornata da Côme perché non sapevo dove andare. Ho chiesto da bere e ho saputo da sua moglie Cécile che ero andata via da due giorni. (…) Poi, ho deciso di andare a trovare i miei figli... Li ho ritrovati vivi, feriti ma vivi, umiliati ma vivi. Per noi, questo era l’essenziale. …
Hanno iniziato a raccontarmi tutto quello che avevano subito: Mamma, ci hanno torturati, siamo stati costretti a riconoscere un cadavere, era quello di papà. Volevano che ripetessimo che apparteneva al Fronte Patriottico Rwandese, e noi lo abbiamo fatto. Eppure, tutte queste persone erano amici di papà. (…) Mio figlio Christian si è messo a piangere: Mamma – mi disse –, non ti voglio vedere qui, devi partire, perché non hai alcuna possibilità di salvarti. Non vogliamo assistere alla tua morte, il cadavere di papà ci è bastato. E’ stato tradito da loro che pensava fossero suoi amici. Hanno colpito Nadine dicendo che aveva delle grosse gambe da ragazza Tutsi. Hanno colpito Sandrine dicendo che cresceva per diventare alta come gli alberi. Spérancie è stata costretta a rivelare dov’eri, ma gli abbiamo detto che eri morta. Allora, un amico di papà ha voluto darmi un colpo di machete sulla testa, mi sono protetto con il braccio ed è così che si è tagliato. Mio figlio aveva una frattura aperta all’avambraccio. Volevo medicarglielo, ma Christian mi ha detto: Mamma non perdere tempo, ci hanno avvertito che alle sette del mattino verranno a ucciderci.
Erano forse le cinque o le sei. Non lo so. In quei giorni, non avevamo più la nozione del tempo, né tantomeno dei giorni. Contava solo la vita o la morte. Sebbene i miei figli insistevano affinché ci separissimo, rimanevo convinta del contrario.
Un nostro ex giardiniere si è presentato da noi, con un machete in mano: Tu, serpente, cosa ci fai qui? Devi partire, altrimenti farai uccidere i tuoi figli. Se tu non ci sei, forse avranno una possibilità di sopravvivere. Ma se ti vedono, allora morirete tutti assieme. Così, sono andata via con la speranza che i miei figli avrebbero avuto la vita salva. Ancora oggi mi dico che se non fossi partita i miei figli sarebbe probabilmente ancora vivi. Mi sento una madre indegna, che ha abbandonato i suoi propri figli alla morte.
Sono andata da Déo, un altro amico. Ma anche lui mi ha cacciata via. (…) Poco dopo, una ragazza si è presentata davanti a me: Sei tu che perseguitano? Mi chiamo Emmanuelle, mi hai guarita quando tutti i dottori mi prendevano per pazza. Io ti nasconderò. (…) Emmanuelle mi ha nascosta sotto un doppio lavello di cemento. Per poterci stare dovevo far passare i tubi di scarico fra le mie gambe e piegare la testa. Sotto quel lavello ci ho passato undici giorni. (…)
Emmanuelle mi aveva comprato una carta d’identità hutu. Mi disse: So che non è il tuo nome, né tantomeno la tua foto, ma ormai non ci fanno più caso. Guardano soltanto la menzione hutu o tutsi, per essere uccisi o risparmiati. Così mi sono fatta registrare sotto falsa identità. (…) Grazie a un amico, sono stata condotta dai Caschi Blu africani all’Hotel des Milles Collines, dove alcuni di noi sarebbero stati scambiati con dei prigionieri hutu in mano al Fpr. (…) Nella hall dell’albergo, ritrovo per miracolo Spérancie: Spérancie – le chiesi d’istinto –, dove sono i miei figli? (…) Ma zia, Emmanuelle non ti ha detto nulla? Appena dopo la tua partenza, sono arrivati degli assassini e ci hanno obbligati a svestirci. Ci dicevano che tutto ciò che avevamo, ora apparteneva agli hutu. Ci hanno fatto uscire e messi in fila. Mancavi solo tu. Ci hanno guidati fino alla fossa. Tuo figlio era davanti, il suo sguardo mi atterrisce ancora, prima di essere colpito per primo con un colpo di machete alla nuca e essere buttato giù nella fossa. Sandrine ha subìto la stessa sorte, Nadine invece non ha aspettato e si è buttata giù viva nella fossa da dove continuava a urlare: "Spérancie, scappa via, va a cercare mia madre, dille di perdonarmi, ho avuto paura della morte e del machete, e così mi sono buttata viva nella fossa". Ha continuato a parlarmi fino al punto in cui ha iniziato a delirare. Ho supplicato affinché venisse uccisa, ma si sono rifiutati. Qualcuno ha detto: "Non è la figlia di Muganga, è la sua impiegata". Nel frattempo, Nadine mi chiamava, e alla fine ha smesso di delirare, perché era stata ricoperta dagli altri cadaveri. Zia, perdonami, ti ho fatto il male più grande, non sono riuscita a proteggere i tuoi figli.
A questo punto Yolande si alza, fa un passo avanti verso la platea, alza la mano e dice:
Coloro che non avranno la volontà di ascoltarmi sono complici del genocidio in Rwanda. Io, Yolande Mukagasana, dichiaro davanti a voi e di fronte all’umanità che chiunque non voglia conoscere il calvario del popolo rwandese è complice dei carnefici. Non voglio né terrificare, né impietosire, voglio testimoniare. Solo testimoniare. Questi uomini, che mi hanno fatto subire le peggiori sofferenza, non li odio, né li disprezzo, ho persino pietà di loro.

Yolande Mukagasana è autrice di La Mort ne veut pas de moi (La morte non vuole saperne di me, La Meridiana 1998), N'aie pas peur de savoir (Non aver paura di sapere, Editions Laffont 1999), Les Blessures du silence (Le ferite del silenzio, Actes Sud 2001).
Traduzione di Joshua Massarenti
Italy for Rwanda 1994-2004
Tournée italiana dello spettacolo Rwanda 94
nel decennale del Genocidio
Palermo
Regione Siciliana
Assemblea Regionale Siciliana
Città di Palermo
Kals’art Palermo Festival
Provincia di Palermo
Libera Università della Politica di Palermo
Kemeco
Aryadeva Comunicazione Integrata
Teatro Politeama / Orchestra Sinfonica Siciliana
Ersu
Alessi
Publisette
TRM
12 settembre 2004 – ore 17.30
Palermo, Teatro Politeama
Piazza Castelnuovo
Tel. 091.7007635
www.enteteatrale.it
Torino
Città di Torino
TST Teatro Stabile di Torino
La Stampa
18 settembre 2004 – ore 18.00
Torino, Teatro Alfieri
piazza Solferino, 4
tel. 011.5176246
www.teatrostabiletorino.it
Roma
Provincia di Roma
Università degli Studi Roma Tre – Master in Politiche
dell’Incontro e Mediazione Culturale
Casa Internazionale delle Donne
Ambasciata del Canada in Italia
24, 25 settembre 2004 – ore 19.00
26 settembre 2004 – ore 17.00
Roma, Teatro Eliseo
via Nazionale, 183
tel. 06.4882114
www.teatroeliseo.it
Milano
Regione Lombardia
Comune di Milano
Provincia di Milano
Teatri 90 progetti
Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa
Festival del Mediterraneo
Festival Milanoltre
Ambasciata del Canada in Italia
Vita Non Profit Magazine
Henkel
2 ottobre 2004 – ore 17.30
3 ottobre 2004 – ore 15.00
Milano, Teatro Strehler
largo Greppi, 1
tel. 02.72333222
www.piccoloteatro.org
Reggio Emilia
Regione Emilia Romagna
Provincia di Reggio Emilia
Comune di Reggio Emilia
I Teatri di Reggio Emilia
Rec – Reggio Emilia Contemporanea
Agac
Coop Service
Boorea
Istituto Antonio Banfi di Reggio Emilia
Emergency
La Corte Ospitale
9 ottobre 2004 – ore 17.00
10 ottobre 2004 – ore 15.30
Reggio Emilia, Teatro Romolo Valli
piazza Martiri del 7 luglio, 7
tel. 0522.458811
www.iteatri.re.it
Rwanda 1994: origini di un genocidio
di Michela Fusaschi
Rwanda, piccolo paese nel cuore dell’Africa, descritto ancora alla fine degli anni Ottanta per la magnificenza del suo paesaggio: paese dalle "mille colline" e dall’eterna primavera dove le catene montuose e gli altopiani si alternano a piccoli e grandi laghi e a fiumi che scorrono densi, carichi di terra rossa lungo valli profonde. In quei corsi d’acqua e su quelle colline nel 1994 hanno trovato la morte non meno di un milione di persone: oggi a distanza di dieci anni in queste acque… la memoria dell’orrore ma anche una nuova vita per il futuro.
Nel nostro paese poche parole, solo brevi cenni nello scorrere dei servizi televisivi troppo spesso caratterizzati dalle immagini sensazionalistiche dei corpi straziati e mutilati gettati in quei fiumi o lasciati morire sulle alture, hanno riproposto l’ennesima facile lettura: una lotta tribale o etnica, atavica e inevitabile che ha rafforzato la retorica dell’Africa come continente condannato perché selvaggiamente violento.
Ma come è potuto accadere tutto questo? Il bisogno di risposte oltre la banalità, ci spinge a ripercorrere a ritroso un cammino nelle storie, nei percorsi antropologici delle identità, rivedendo criticamente innanzitutto i concetti di etnia e di "conflitto etnico" impiegati indiscriminatamente quali categorie di interpretazione di quella realtà. Le vicende storiche del popolamento antico, i miti di origine, la letteratura popolare e le fonti orali confermano una storia di migrazioni e scambi; l’arrivo, a partire dal XIII e XIV secolo, nella regione dei Grandi Laghi di popolazioni di pastori, identificabili come Tutsi, che si installarono nel territorio trovandovi dei gruppi denominati Twa e Hutu adottandone lingua e tradizioni. Questi tre gruppi con-vivendo nello stesso spazio fisico e sociale per secoli hanno realizzato una forma di integrazione in un’unica realtà socio-culturale come testimonia ancora oggi l’esistenza della comune lingua – il kinyarwanda – ma anche le stesse istituzioni politiche per lo meno fino all’arrivo degli esploratori europei. Nella seconda metà del XIX secolo, infatti, il Rwanda costituiva uno dei tanti regni africani ed era retto da una dinastia Tutsi e da una classe aristocratica che associava gli Hutu nell’esercizio di alcune prerogative politiche, come nell’organizzazione del regno, e rituali – come ad esempio nella costruzione del tamburo regale Karinga, o nel contratto tra allevatori e contadini, l’ubuhake – attraverso cui venivano garantiti benessere e prosperità a una comunità strutturata anche su forti basi claniche.
In quell’epoca, il re tradizionale, il Mwami, aveva il pieno controllo del potere solamente nella parte centrale del regno; nelle zone più a nord esistevano infatti alcuni "principati hutu" che godevano di una larga autonomia e di una condizione di "protettorato". Sicuramente nel periodo precedente la colonizzazione le categorie Hutu e Tutsi non avevano il carattere discriminante ed esclusivo che verrà attribuito loro in seguito come prodotto dello sguardo occidentale; già le prime relazioni di esploratori e missionari, tedeschi prima e belgi poi, fornirono una visione della società basata su una presunta "gerarchia razziale" fondata sull’impressione estetica e sulle teorizzazioni dell’epoca per cui gli europei "classificarono" la componente tutsi fra le "popolazioni hamitiche" di ascendenza nilotica. Erano gli anni che vedevano l’affermazione dell’"ipotesi camitica", teoria che avrebbe fornito un quadro classificatorio generale e al cui interno venne elaborata l’idea di una separazione irriducibile fra Hutu e Tutsi. Come discendenti di Cam, figlio di Noè, alcuni gruppi africani identificati come camiti vennero considerati i sopravvissuti di un’umanità originaria di cui avrebbero fatto parte, fra gli altri, anche gli egiziani che avevano dato vita a una grande civiltà, a differenza dei cosiddetti "primitivi" dell’Africa nera associati al mondo selvaggio della foresta. La minoranza tutsi individuata così in relazione alla colorazione della pelle più chiara rispetto agli hutu, già a partire dagli anni Venti, verrà apparentata ai bianchi europei capaci di civilizzazione e sarà, in questa veste, ritenuta la sola in grado di governare il Rwanda intero. In tutte le monografie dell'epoca coloniale la "razza hamitica" è quella dei pastori-guerrieri Tutsi – i Camiti – superiore alla "razza nera" degli agricoltori Hutu – Bantu –; non solo, la pratica agricola diviene la caratteristica del gruppo considerato inferiore. Le politiche indigene condotte dai colonizzatori belgi con l’appoggio dei missionari, tra gli anni Venti e Trenta, cristallizzarono i gruppi hutu e tutsi in "classi sociali/etniche" o "etnie" istituzionalizzando un sistema di disuguaglianze sul piano socio-culturale. L'amministrazione coloniale scelse infatti di appoggiare l'aristocrazia tutsi al potere consentendone un accesso privilegiato nelle scuole e negli uffici pubblici. Attraverso una serie di riforme imposte dai belgi l'istituto della regalità sacra, venne completamente desacralizzato, le prerogative rituali degli hutu si persero progressivamente in favore di un'aristocrazia oramai legittimata dall’ipotesi camitica scritta e fissata nei libri di testo scolastici una volta per tutte e insegnata alla nuova classe dirigente.
Conseguenza delle dinamiche della "situazione coloniale", le "due etnie" hutu e tutsi, furono in questo modo letteralmente "inventate" grazie all’azione congiunta dell’amministrazione coloniale e dei missionari. La "finzione coloniale" delle etnie si concretizzò nella società, primariamente attraverso un’arbitraria riorganizzazione territoriale, ma ciò che storicamente permise la trasposizione dal piano ideologico alla realtà quotidiana fu senza dubbio il censimento della popolazione effettuato negli anni Trenta che sancì per la prima volta la menzione dell’"identità etnica" – fissata, una volta e per sempre – sui documenti personali. Fu un censimento condotto in maniera del tutto arbitraria individuando nel numero dei capi di bestiame posseduti in quel momento il criterio di appartenenza a uno o all'altro gruppo: si diventava Tutsi con dieci vacche o più e, allo stesso modo, si diventava Hutu con meno di dieci vacche.
L'ideologia "razziale" propagandata nel periodo coloniale e l’"etnismo scientifico" divennero quindi gli elementi di base della formazione della nuova classe dirigente che precedettero l’indipendenza. La polarizzazione della società rwandese nelle "due etnie" Hutu e Tutsi verrà a costituire l’ingombrante eredità del periodo coloniale: il rivoltamento del mito della supremazia razziale della minoranza Tutsi-hamita diverrà l’elemento ideologico delle rivendicazioni della massa Hutu che, esclusa dalla gestione del "patto coloniale", interpreterà il processo che prepara l’indipendenza in termini antimonarchici e soprattutto anti-tutsi.
Alla fine degli anni Cinquanta l’élite Hutu cominciò a mobilitarsi rivendicando quei diritti che l’amministrazione coloniale belga aveva negato loro appoggiando la monarchia Tutsi. Dal 1956 al 1959 il paese fu percorso da ondate successive di estrema violenza fra quelle che si erano trasformate in vere e proprie fazioni sociali Hutu e Tutsi. La cosiddetta "Rivoluzione sociale" del 1959 e la successiva Indipendenza del 1962 ribaltarono completamente la situazione: la vittoria elettorale del partito Parmehutu e la proclamazione successiva della Repubblica, con a capo Grégoire Kayibanda, porranno fine alla supremazia politica della monarchia avviando un processo di progressiva estraniazione della componente tutsi considerata come nemica della nuova nazione ora fondata su un presunto primato storico dell’insediamento degli hutu. Si realizzò un completo rivoltamento della storia scritta dal colonizzatore, sostenuto anche dal fatto che in Europa era il momento storico in cui prevaleva l’attenzione alle masse popolari.
La repubblica rwandese portava con sé la contraddizione tra l’orientamento democratico e il permanere della paura di un ritorno all’ordine precedente, di cui i Tutsi erano visti come portatori e interpreti. La storia del giovane stato si presenta dunque come la riproposizione costante del tema della minaccia tutsi, continuamente "strumentalizzato" dalle classi dirigenti che si succederanno al potere: episodi di estrema violenza si susseguirono a partire dal già ricordato 1959, alle crisi del 1963-64 e del 1973 determinando importanti ondate di rifugiati tutsi verso i paesi limitrofi come l’Uganda, la Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) e la Tanzania, preparando così le condizioni per l’instabilità dell’intera area dei Grandi Laghi africani.
Nel 1963 alcune centinaia di rifugiati Tutsi, definiti all’interno Inyenzi, cioè "scarafaggi", tentarono di rientrare nel paese: le persecuzioni furono durissime, migliaia le vittime come pure i rifugiati. Nel luglio del 1973, l'allora Generale Maggiore Juvénal Habyarimana, comandante in capo della Guardia Nazionale, si impadroniva del potere attraverso un colpo di stato ponendo fine a dodici anni di presidenza di Grégoire Kayibanda: governerà fino al 1994 inasprendo i conflitti sociali e marginalizzando sempre di più la minoranza tutsi e gli hutu moderati fautori del dialogo.
Il risentimento sociale aveva trovato le sue basi nell’odio totale maturato nei confronti di coloro che oramai erano diventati stranieri in casa loro: i Tutsi che rappresentavano sempre di più nell’immaginario collettivo una vera e propria minaccia; non bastava più cacciarli perché sarebbero tornati, era arrivato il momento del loro annientamento secondo un progetto preciso definito da alcuni studiosi "nazismo tropicale".
Gli eventi precipitarono nell’ottobre del 1990 quando il Front patriotique rwandais (FPR), composto dalla seconda generazione degli esiliati Tutsi in Uganda, lanciò una vera e propria offensiva in territorio rwandese che si trasformò in una sanguinosa azione di guerra sferrata dalle alte autorità dell'apparato amministrativo. L'ala più estremista, legata al movimento presidenziale, pensando che i Tutsi residenti in Rwanda, definiti "complici dell'interno" e quelli rifugiati all'estero si sarebbero prima o poi coalizzati, aveva creato progressivamente un'organizzazione para-militare di massa in grado di uccidere su larga scala.
Per capire il clima ideologico di quel periodo basta rileggere un passo tratto dal periodico estremista Kangura, del novembre 1990: "nella storia [mateeka] del Rwanda i primi arrivati furono i Batwa (Pigmoidi) che si consacrarono alla caccia e alla raccolta; in seguito sono arrivati i Bahutu (Bantu) che hanno abbattuto la foresta per coltivare e che hanno stabilito un'organizzazione sociale; infine sono venuti i Batutsi (Nilotici, Etiopi) che si sono dedicati all'allevamento. Perché si vuole cambiare la nostra storia? Chi ha il diritto di cambiare la storia del paese?".
Il riferimento ai Bahutu come abbattitori di foresta rappresenta un elemento fondamentale per l’interpretazione e la comprensione della storia contemporanea rwandese suggerendo l'idea che l'attività della deforestazione abbia costituito un referente simbolico nella formazione dell'identità Hutu. La connessione fra l'abbattimento della foresta, l'introduzione dell'agricoltura e l'instaurazione di un'organizzazione sociale fonda la legittimazione ideologica degli Hutu che si autorappresentano come i veri abitanti del Rwanda. In questo senso, coloro i quali "tagliano" gli alberi e abbattono la foresta, creano le condizioni per l'esistenza stessa del paese e divengono, nel linguaggio di Kangura, i rappresentanti del "popolo-nazione rwandese".
Il 6 aprile 1994 con l’abbattimento, poco prima dell'atterraggio all'aeroporto di Kigali, dell'aereo che trasportava il presidente rwandese Juvénal Habyarimana e quello burundese Cyprien Ntaryamira, inizia quello che è stato definito come il terzo genocidio della storia. Gli agenti delle milizie meglio conosciuti come gli esponenti dello "hutu power" poche ore dopo l’attentato, cominciarono a "lavorare" per eliminare i nemici della nazione dando inizio a uno dei più violenti massacri del XX secolo. Gruppi armati formati dagli elementi della Guardia Presidenziale, dalle Forces armées rwandaises (FAR) e da abitanti delle città e delle colline si riversarono nelle strade all'inseguimento della popolazione Tutsi. Circa un milione di persone furono uccise dagli Interambwe, "quelli che lavorano insieme", nell’arco di tre mesi. Simbolo del genocidio il machete attraverso cui tutti e tutte furono colpiti identificati sulla base di un "ideale fisico", ma soprattutto dalle carte di identità che, dopo la colonizzazione, menzionavano l'appartenenza "etnica".
Gli studiosi concordano sul fatto che questi massacri furono attentamente preparati secondo un piano ben orchestrato e un'ideologia chiaramente razzista. In numerosi racconti il tagliare il corpo, abbatterlo come un albero per farlo letteralmente a pezzi gettandolo poi nei fiumi o nelle latrine è un modello ricorrente della straordinaria crudeltà di questo genocidio. La pratica dei massacri avveniva secondo schemi precisi: gli assalitori cominciavano impiegando dapprima armi da fuoco, come granate all’interno dei luoghi dove si era cercato riparo, intervenendo successivamente con il machete a "finire il lavoro". I superstiti raccontano di una pratica collettiva della crudeltà estrema congiunta a una vera e propria "estetica" della violenza traducibile nell’ineluttabile necessità di dimostrare la crudeltà stessa.
I ricordi del massacro presentano un'incredibile sequenza di "rituali macabri" compiuti da quelli che venivano chiamati Bene Sebahinzi, cioè "i figli degli abbattitori". Prima di eliminare fisicamente l'Altro, il o la Tutsi, occorre recidere, tagliare i legami che costui o costei ha con il mondo, fare in modo che non possa mai più camminare o lavorare su una terra che non è sua perché non rwandese, bensì ritenuto/a di origine etiope e quindi straniero/a. Come tale non può vivere con l’Hutu, non essendo nemmeno fisicamente simili: "sono troppo alti", dicono i miliziani dei tutsi mentre si apprestano a ucciderli; è necessario tagliare loro i piedi, "accorciarli", per impiegare una brutale espressione del periodo. Lo scopo dell'azione violenta non è primariamente l'uccisione dell'altro ma la messa in scena di una crudeltà che non risparmia niente e nessuno; nemmeno i parenti più prossimi, la propria moglie o il proprio marito. Gli amici e i vicini di casa si trasformano nel nemico più insidioso rispetto a cui, spesso, non c'è scampo.
Il 1994 del Rwanda è venuto assumendo un valore paradigmatico come modello di riferimento per quei conflitti identitari dell’epoca attuale, quelli che Mary Kaldor ha ricompreso nella definizione di "nuove guerre" fondate sulla "politica delle identità", ovvero su quei movimenti che muovono dall’identità etnica o religiosa per rivendicare a sé il potere dello stato (1999). Le "identità in conflitto" rappresentano certamente un dato del presente e, secondo alcuni, un elemento caratterizzante il prossimo futuro, esse tuttavia si fondano su un uso "strategico" del passato che rimane spesso ancora tutto da indagare. Il caso degli Hutu e dei Tutsi ci richiama ancora una volta alla comprensione delle molteplici implicazioni e della complessa articolazione dei processi di costruzione dell’identità. Quell’identità che non deve e non può considerarsi un dato di partenza "naturale" e "oggettivo" ovvero un elemento statico del tutto estraneo alla storia. Le atrocità di massa vissute in Rwanda, come principio di determinazione di senso, sono giunte a sovvertire l’orizzonte unitario della storia nonché l’intero significato dell’esperienza umana; esperienza dalla quale dovremmo ripartire insieme per superare quella tragica rigidità degli schemi di distinzione che, attraverso il dramma rwandese, ci hanno così profondamente segnato.
Quando il teatro denuncia l’Impero
La scena vigile
di Andrea Porcheddu
A qualcuno non piacque. Lo ricordo bene. Qualcuno storceva il naso, in nome di non so quale idea di teatro. Altri dicevano che, semplicemente, era troppo lungo. Uno se la prese con la drammaturgia… Ma altri – e non erano pochi – erano commossi, emozionati, inquieti, scossi. Profondamente scossi, toccati nel loro essere spettatori passivi di fronte a tutto quello che avevano visto sul palcoscenico. Immobili in platea, ma con un senso di rabbia, frustrazione, dolore. Più o meno la stessa situazione, più o meno quanto avveniva anni prima, quando il Rwanda viveva un Genocidio di proporzioni terribili e tanti, troppi, erano stati seduti a non far niente. Cambiavamo canale, quando la tv trasmetteva le immagini repellenti della inconcepibile guerra rwandese: è uno scontro tribale, dicevano, che noia… Si può dire che noia, di fronte alla vita? E si può sbadigliare di fronte alla morte?
Quando il Mittelfest presentò, per la prima volta in Italia, quell’evento unico che è Rwanda 94, restai – per quel che può contare – assolutamente sgomento. Credevo di sapere, e non sapevo. Credevo di aver capito, e invece nulla mi era chiaro della terribile strage che scosse, dieci anni fa ormai, il piccolo paese centroafricano.
Rwanda 94 era, prima di tutto, un appassionato e lungo lavoro di ricerca, era implacabile testimonianza. Ma non solo: era "racconto" e finzione, tragedia e videodocumento…
Sono diversi i motivi di valore di quel progetto: motivi che, nel 2004, diventano ancora più cogenti. Il tempo passato non ha cambiato nulla: prima, dopo, insieme al Rwanda, la ex-Jugoslavia, il Golfo, l’Iraq… Ancora guerre, ancora violenze. Ma lo scontro tra hutu e tutsi resta, per molti aspetti, ancora una ferita aperta, un peccato cui non si è rimediato, una offesa non sanata.
Vale la pena, forse, distinguere due dei molteplici piani in cui può essere "letto" il lavoro di Groupov. Il primo, forse evidente – ma non dominante – è proprio quello della Informazione. I materiali assemblati attorno all’evento scenico, infatti, sono preziosa fonte, documento completo e a sé stante: con l’appassionata ricerca fatta da Marie-France Collard, Jacques Delcuvellerie e dai loro collaboratori si arriva a colmare, almeno in parte, la vergognosa latitanza dell’Occidente. Il loro lavoro dice, comunica, spiega, illustra, mostra: fa quanto avrebbero dovuto fare (e in gran parte non hanno fatto) i nostri corrispondenti, i nostri giornalisti, i nostri storici del conteporaneo. Rwanda 94 documenta un Genocidio. In un’epoca in cui l’esercizio della memoria è costantemente negato, messo in discussione, ripudiato a favore di un "presentismo" dell’ottimismo e della vitalità, farsi carico del fardello della testimonianza e della memoria (una "riparazione verso i morti, ad uso dei vivi", recita il sottotitolo) è compito ingrato, eppure meritorio. Rwanda 94 ci dice cose che non sappiamo, che non avremmo saputo, se non attraverso il sistematico e implacabile lavoro di Groupov.
Passati dieci anni dalla follia che portò allo sterminio dei tutsi, cosa resta?
Del Rwanda, almeno nella nostra provinciale e razzista Italia, sappiamo ancora poco, e poco sembra interessare. Quando dei signori in cravatta verde si inventano "ronde" contro l’immigrazione, quando un governo firma leggi poi dichiarate inconstituzionali perché lesive della dignità umana, aprire gli occhi sull’insipienza occidentale, capire un po’ meglio i danni provocati dal colonialismo e dal post-colonialismo, affrontare la responsabilità di politiche internazionali basate sullo sfruttamento sistematico del più debole, può senza dubbio essere utile. E se questo avviene grazie al teatro, è un segnale doppiamente significativo…
Già, il teatro: ecco il secondo piano di lettura.
Rwanda 94 è uno "spettacolo": paradossalmente, verrebbe da dire, è uno spettacolo. Qui si aprono infinite possibilità di analisi, e vale la pena – in occasione della tournée italiana – concentrarci proprio su questi aspetti. Il lavoro di Marie-France Collard e Jacques Delcuvellerie rimanda – immediatamente – alla straordinaria e apocalittica scrittura di Peter Weiss, e della sua Istruttoria: teatro-documento, si dice a proposito di quell’opera del 1964. Le testimonianze del processo di Francoforte del 1963 contro i responsabili del lager nazista di Auschwitz sono ricostruite in un poema, in forma oratoriale, che colpì l’immaginario pubblico e che coronava il lungo percorso, tutto novecentesco, del cosiddetto "teatro politico". Racconto per quadri, dunque, asetticamente documentativo, senza alcuna (o con poche) concessioni alla "teatralità". Il Brecht degli anni migliori, il suo "teatro epico", è poco lontano...
Rwanda 94 affonda le sue radici in quella esperienza, la rilancia e la moltiplica: dando senso profondo al ruolo – sociale e politico – di chi decide di fare del proprio teatro un gesto di militanza civile, politica, umana.
Teatro politico: Groupov fa nomi e cognomi, dichiara connivenze e fallimenti, errori e affari loschi. Fa ricerca, si documenta e si schiera, ma dalla parte di chi ancora sa indignarsi, di chi non accetta la violenza e interessi economici capaci di viziare i rapporti umani. Parla di tutto, denuncia tutto.
È significativo: mentre il teatro italiano si affanna a evocare il povero Pasolini che affermava "Io conosco i nomi…", qui, Delcuvellerie i nomi li fa, senza paura. E lascia allo spettatore il compito di capire, di tessere le fila di quell’enorme racconto, di far sì che tutto quello che è accaduto non accada più.
S’il vous plaît, soyez vigilantes… ripete all’ossessione un’attrice.
Non solo: la struttura riprende la narrazione per quadri, per situazioni, per stazioni cara a Weiss. L’antinaturalismo è dichiarato, ma lo spettacolo gioca per spiazzamenti, per accumulo con piccoli o grandi scarti: tutto si mescola, in scena, in una foma teatrale che ingloba e supera le canoniche strutture della teatralità occidentale.
Ecco, allora, la presenza esplosiva della biografia, della "storia di vita". In apertura delle sei ore di spettacolo, sola in scena, Yolande Mukagasana ricorda e racconta. Piange di fronte alla sua storia, eppure non si tira indietro: racconta di sé, e dell’infinita tragedia che l’ha colpita. Un racconto lungo, straziante, di una donna e della sua vita: non c’è mediazione teatrale, non ci sono filtri. Yolande racconta perché si sappia, perché tutti sappiano: la sua storia diventa memoria condivisa, la sua (auto)biografia si fa testimonianza, attraverso il racconto di sé la donna può continuare a sopportare lo strazio, e dà senso – conferisce la sacralità della verità fragile, umana, povera, del dolore. Poi, Groupov opera un ulteriore cambiamento di rotta: alla presenza immediata di Yolande Mukagasana, fa da contraltare una lunga sequenza di pura finzione, di teatralità anche a tratti dozzinale: quasi un teatro fin troppo "finto", forzato nel suo naturalismo manierato, o addirittura virato al "musical". Ecco, infatti, canzoni e swing.
Ma poi ancora cori, canti, musiche dal vivo, in forma oratoriale, da liturgia laica che sa molto, però, di rito religioso.
E, infine, all’interno della struttura aperta dello "spettacolo", c’è spazio anche per una lunga conferenza dello stesso regista: conferenza vera e propria, scientifica, analitica. Ancora una volta si supera la mediazione del teatro, e si usa lo spazio (l’edificio), la presenza simultanea della comunità di artisti e di quella degli spettatori, per fare altro. Per fare altro del teatro: una conferenza con video e documenti spezza ancora il ritmo, spezza il clima, porta il pathos altrove. Non c’è identificazione possibile, non c’è immedesimazione concessa: il teatro è continuamente evocato, per essere utilizzato, piegato alle esigenze del dire.
Soyez vigilantes…
Eppure, lo spettacolo ha momenti di grande e raffinata teatralità. Intanto la ricca partitura musicale, di Garrett List, che tesse una trama di rimandi e sonorità dove tornano canti tradizionali africani e minimalismo, dodecafonia e rumorismo, Berio e Ornette Coleman. Gli attori-cantanti seguono una partitura di grande suggestione: è un’Opera, allora, viene da pensare… Assistiamo a una nuova ipotesi di teatro d’Opera? Forse, e siamo autorizzati a crederlo dalla struttura stessa del "libretto", e dall’organico dei musicisti coinvolti (trio d’archi, clarinetto, pianoforte). Certo è che, se non di "opera", quanto meno di "teatro-musicale" potrebbe trattarsi, almeno in gran parte... Però, ancora una volta, Rwanda 94 non si lascia definire, non consente categorizzazioni, e vira verso qualcosa d’altro: qualcosa di indefinibile eppure di apparentemente già conosciuto.
Dunque: teatro di narrazione, teatro documento, teatro musicale, dramma borghese…
Dove è l’essenza di quest’opera? Probabilmene, il lavoro di Delcuvellerie sa dire qualcosa di significativo su un tema irrisolto: la possibilità di un "tragico" del contemporaneo. La tragedia, si sa, come elemento fondante la comunità ellenica, si basava su princìpi morali condivisi, su una presenza imprescindibile della divinità-destino e quindi sul sistematico confronto con la morte. Oggi, quella struttura teatrale viene svuotata del proprio fondamento rituale, rimane – come nel caso del teatro di Ronconi – come vuoto simulacro con cui confrontarsi "ironicamente", oppure – ad esempio nel tentativo della "tragedia dell’oggi" di Romeo Castellucci e della Sociètas Raffaello Sanzio –, come obiettivo per una "riscrittura" in forma nuova, diversa.
Eppure c’è chi asserisce un possibile "tragico nel contemporaneo" (si veda, ad esempio il lavoro di Lars von Trier): ed è in questo contesto che possiamo collocare il possente lavoro di Groupov.
Rwanda 94 è una tragedia, classica, del post-moderno: mantiene vivi, in sé, gli elementi strutturali della tragedia ellenica, li rielabora alla luce della evoluzione dei linguaggi fino alla destrutturazione della struttura stessa, e vi aggiunge, sapientemente, uno sguardo "politico" – rituale e religioso, ma al tempo stesso laico e sociale – che impregna di sé l’evento. Insomma, Rwanda 94 è una denuncia dell’Impero operata con le armi della civiltà teatrale; è un grido di rivolta contro i misfatti dell’uomo; una ferma e precisa presa di posizione dell’Artista-intellettuale; un pasoliniano gesto "poetico-politico", che declina la teoria in prassi viva e comunicativa. Senza fondamentalismi, senza nemici da abbattere o incarnazioni del male, senza pretesa di assoluto.
No, il teatro di Groupov è semplicemente uno spettacolo, che chiede una cosa sola: Soyez vigilantes…
Italy for Rwanda
1994-2004
Tournée italiana dello spettacolo
Rwanda 94
Une tentative de réparation symbolique envers les morts, à l’usage des vivants
Nell’anno del decennale del genocidio
Un progetto
Teatri 90
Sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica Italiana
Realizzato in collaborazione con
Teatro Eliseo Stabile di Roma
e
Teatro Politeama di Palermo / Orchestra Sinfonica Siciliana
TST Teatro Stabile di Torino
Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa
I Teatri di Reggio Emilia
Sostenuto da (in ordine di tappa)
Regione Siciliana
Assemblea Regionale Siciliana
Città di Palermo
Provincia Regionale di Palermo
Città di Torino
Provincia di Roma
Regione Lombardia
Comune di Milano
Provincia di Milano
Regione Emilia Romagna
Provincia di Reggio Emilia
Comune di Reggio Emilia
Con la partecipazione di
ETI - Ente Teatrale Italiano, Ambasciata del Canada in Italia,
Festival Milanoltre, PAV, Aryadeva Comunicazione Integrata
Con il contributo di
Kemeco, Palermo
Henkel, Milano
Communication partner
Lowe Pirella
Media partner
Vita Non Profit Magazine
Con il patrocinio di
Ministero degli Affari Esteri
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea
Amnesty International
C.N.I. UNESCO
Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus
Hanno collaborato
Palermo Kals’art 2004
Libera Università della Politica di Palermo
Ersu dell’Università di Palermo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Alessi spa
Publisette
TRM
Festival del Mediterraneo del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa
Università degli Studi Roma Tre – Master in Politiche dell’Incontro e Mediazione Culturale
Casa Internazionale delle Donne di Roma
Rec – Reggio Emilia Contemporanea
Agac
Coop Service
Boorea
Istituto Antonio Banfi di Reggio Emilia
La Corte Ospitale di Rubiera
Emergency
La Feltrinelli
Ideazione e cura
Antonio Calbi
Organizzazione
Claudia Di Giacomo (PAV)
Collaboratori del curatore
Michela Fusaschi
Joshua Massarenti
Direttore tecnico del tour
Gianfranco Lucchino
Consulenza fiscale e amministrativa
Il Studio
Hanno collaborato al progetto
Amparo Calamai
Lara Clementi
Francesca Donnini
Chiara Petternella
Francesca Pierangeli
Orsola Sinisi
Communication partner
Lowe Pirella
Media partner
Vita Non Profit Magazine
Uffici stampa
Sergio Marra per Palermo
Carla Galliano per il TST – Teatro Stabile di Torino
Luana Nisi per il Teatro Eliseo Stabile di Roma
Dolores Redaelli per il Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa
Mario Vighi per I Teatri di Reggio Emilia
Silvia Taranta e Bianca Vellella per l’Eti – Ente Teatrale Italiano
Traduzioni
Francesca Donnini
Marie-Claude Gouy
Joshua Massarenti
Francesca Pierangeli
Rachel van Hees
Trasporti
Porcacchia, Roma
Traduzione simultanea
Italico, Roma
|
Il Festival del Ticino si apre ai nuovi progetti
Nasce la sezione "Lavori in corso"
di Festival del Ticino |
All’alba della sua nona edizione il Festival del Ticino, la rassegna di musica, arte e spettacolo dal vivo che si svolge ogni primavera all’interno dell’area del Parco del Ticino, ha deciso di aprire le porte a produzioni artistiche nuove e non convenzionali. Il cartellone dell’edizione 2005 prevede infatti la nascita della sezione LAVORI IN CORSO, la quale darà spazio a progetti di spettacoli dal vivo (musica, teatro, danza e combinazione dei precedenti) ancora in fase di perfezionamento e che necessitano di una prima verifica di pubblico.
Artisti solisti e compagnie, professionisti e non, italiani e stranieri, insomma chiunque abbia in cantiere una creazione innovativa e originale avrà l’occasione di presentarla ad un pubblico consolidato. Uniche condizioni: la semplicità dell’allestimento, l’adattabilità a luoghi non convenzionali e l’accettazione di un contributo spese simbolico.
Gli interessati a partecipare dovranno inviare una domanda scritta entro il 31 ottobre 2004 a:
LAVORI IN CORSO/Festival del Ticino
Ufficio Cultura - Comune di Vergiate
Piazza Matteotti 25
21029 Vergiate (Va)
o via email a:
lavoriincorso@festivaldelticino.it
Il facsimile è disponibile presso la Biblioteca Comunale di Vergiate, tel. 0331 964200, fax 0331 964120 o scaricabile dal sito www.festivaldelticino.it.
La direzione artistica del Festival effettuerà le selezioni, con eventuale richiesta di audizione di 20 min. circa, nel mese di novembre 2004 e comunicherà l’esito entro il 31 dicembre 2004.
Gli artisti selezionati parteciperanno alla prima edizione dei LAVORI IN CORSO del Festival 2005, il quale si svolgerà come di consueto tra aprile e maggio.
L’organizzazione si farà carico delle spese di allestimento, di soggiorno o trasferimento degli artisti, oltre che di promozione e comunicazione.
Il Festival del Ticino si caratterizza come rassegna di musica, arte e spettacoli con forti valenze innovative, proponendo spettacoli non confezionati e prevedibili, ma che esprimono ancora la freschezza e la fatica della ricerca.
Preceduto da tradizionali concerti nei quali si avvicendano le migliori formazioni musicali locali il Festival avrà luogo nei diversi Comuni dell’area varesina che danno vita alla manifestazione (Vergiate, Somma Lombardo, Sesto Calende, Arsago Seprio, Casorate Sempione, Golasecca), ma anche a Bernate Ticino nell’area milanese, con costante attenzione alle migliori realtà artistiche locali, cui viene dedicato ampio spazio.
Per informazioni rivolgersi a:
Roberta Bianchi
LAVORI IN CORSO Festival del Ticino
lavoriincorso@festivaldelticino.it
www.festivaldelticino.it
|
Il nuovo numero di "Prove di drammaturgia"
Il teatro di narrazione: una nuova performance epica?
di Redazione "Prove di drammaturgia" |
E' disponibile l'ultimo numero di
PROVE DI DRAMMATURGIA
rivista di inchieste teatrali
numero 1/2004
P E R U N A N U O V A P E R F O R M A N C E E P I C A
a cura di Gerardo Guccini
In questo numero:
PERFORMANCE E NARRAZIONE ALLO SPECCHIO DELLE MILLE E UNA NOTTE
di Kassim Bayatly
VOCAZIONI
di Gabriele Vacis
I SENTIERI DEI RACCONTATORI DI STORIE:
IPOTESI PER UNA MAPPA DEL TEATRO NARRAZIONE
di Pier Giorgio Nosari
IL TEATRO NARRAZIONE:
FRA "SCRITTURA ORALIZZANTE" E ORALITA' CHE-SI-FA-TESTO
di Gerardo Guccini
COL TESTO ALLE SPALLE:
STRATEGIE INTERPRETATIVE NELLA LETTURA D'ATTORE
di Beniamino Sidoti
DARIO FO E LA FABULAZIONE EPICA
di Simone Soriani
IL NARRATORE E I SUOI PERSONAGGI.
UN PERCORSO ATTRAVERSO IL TEATRO DI MARCO BALIANI
di Silvia Bottiroli
MANDIAYE N'DIAYE E IL TEATRO DI NARRAZIONE:
TECNICHE DELL'ORALITA' AL SERVIZIO DELLO SPETTACOLO
di Luigi Mastropaolo
SUI SUONI DELLE LINGUE IN SCENA
di Vanda Monaco Westerstahl
L'ATTORE: UN LADRO DI STORIE
CONVERSAZIONE CON PIERPAOLO PILUDU (CADA DIE TEATRO)
a cura di Fabio Acca
Il prezzo di ogni numero di "Prove di Drammaturgia" è di euro 3,58 (iva inclusa). Se vi interessa ricevere la nostra pubblicazione vi preghiamo di inviare la sottoscrizione di euro 7,16 - per i prossimi due numeri consecutivi - a mezzo vaglia postale intestato a CARATTERE, via Passarotti n. 9/A - 40128 Bologna. Per ulteriori informazioni: CARATTERE - tel. e fax 051/374327. caratterecomunicazione@virgilio.it
|
La quinta edizione dei Teatri delle diversità
A Cartoceto il 9 e 10 ottobre
di Teatri delle diversità |
L’evento
Nei giorni 9 e 10 ottobre prossimi, presso il Comune di Cartoceto (Pesaro e Urbino), con il sostegno dell’Amministrazione Municipale, si terrà il Quinto Convegno Internazionale di Studi "I teatri delle diversità" promosso dall’Associazione "Nuove Catarsi"-Editrice della rivista "Catarsi-TEATRI DELLE DIVERSITA’" che dal 1996 ha inaugurato, a livello europeo, una ricerca scientifica sulle esperienze di espressione creativa con finalità artistiche e/o socio-terapeutiche nei territori dell’handicap, disagio mentale, carcere, tossicodipendenze ed in altri settori del sociale.
Con il Patrocinio e la compartecipazione di Regione Marche Presidenza della Giunta regionale - Provincia di Pesaro e Urbino - Comune di Cartoceto.
Con il Patrocinio di Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" - E.T.I. (Ente Teatrale Italiano) – A.M.A.T (Associazione Marchigiana Attività Teatrali).
Con la collaborazione di Comune di San Costanzo - Istituto comprensivo "Marco Polo" di Lucrezia – Cartoceto - Cooperativa sociale Labirinto di Pesaro – Cooperativa sociale Mediterranea - Cooperativa culturale Conte Camillo – Associazione "Amici di Luca" – Stalker Teatro - Cada Die Teatro – Teatro Viola – Compagnia Diverse Abilità – Teatro Aenigma.
Programma
5 OTTOBRE - SCUOLA MEDIA «MARCO POLO» / Lucrezia di Cartoceto
ore 09.00 Il coma: un tempo sospeso
Incontro di sensibilizzazione con animazioni espressive
in collaborazione con l’associazione «Amici di Luca» di Bologna.
*********
6 OTTOBRE - SCALO6ORE / Fano
ore 21.30 > Mario il Cavallo
Proiezione del film di Sergio Pappalettera sul tema del disagio mentale
Ospite Danilo Reschigna (Teatro Viola di Milano), attore protagonista
*********
9 OTTOBRE – CONVENTO DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO / Cartoceto
ore 9.30 Apertura dei lavori / Saluti istituzionali
Interventi di Marcello Secchiaroli, Assessore alle Politiche Sociali della Regione Marche, Ivaldo Verdini, Sindaco di Cartoceto.
ore 10.00 Il Laboratorio delle idee
Incontro con il Comitato Scientifico della Rivista Europea «Catarsi -TEATRI DELLE DIVERSITÀ» composto da: Andrea Canevaro, Sisto Dalla Palma, Piergiorgio Giacchè, Claudio Meldolesi, Piero Ricci, Guido Sala, John Schranz, Daniele Seragnoli,
Vezio Ruggieri, Luigi Squarzina, Gianni Tibaldi.
ore 12.00 > Prove aperte di documentazione psichiatrica
Performance di Danilo Reschigna del Teatro Viola (Milano)
Pausa pranzo
ore 15.00 > Action
Performance della Compagnia Stalker Teatro (Torino)
regia di Gabriele Boccacini
con gli ospiti e gli operatori dei servizi di salute mentale dell’Asl 12 di Cossato (Biella).
ore 16.30 Teatro e Disagio Psichico
Riflessioni di artisti, operatori e studiosi
interventi di Tiziana Piersanti e Anna Di Quirico (Compagnia Diverse Abilità - Roma),
Salvo Pitruzzella (Palermo), Mariano Dolci (Reggio Emilia), Piero Ristagno (Catania).
ore 18.00 Legge quadro sullo spettacolo e teatro sociale
Spazio riservato alle proposte di legge sullo spettacolo dal vivo.
Intervento programmato di Beppe Navello.
ore 19.00 > Dedicato a Gigi
Performance di Cada Die Teatro (Cagliari) con Alessandro Mascia e Mauro Mereu.
Pausa cena
TEATRO DELLA CONCORDIA / San Costanzo
ore 22.00 > Il Pianeta irritabile
Spettacolo teatrale della Compagnia Teatro Aenigma (Urbino)
dall’omonimo racconto di Paolo Volponi,
con Marcello Camilli, Daniela Rimei, Michalis Traitsis, regia di Vito Minoia.
*********
10 OTTOBRE – CONVENTO DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO / Cartoceto
ore 09.30 La giornata libera di un fotografo
Incontro con Maurizio Buscarino, un viaggio di trent’anni e più nel mondo del teatro.
ore 11.00 Teatri delle diversità e Media
Per una maggiore e migliore visibilità del teatro
Tavola rotonda conclusiva in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro
Invitati: Giuseppe Liotta, (Presidente dell’ ANCT), Claudio Facchinelli, Gianni Rossetti, Giovanni Mantovani, Gualtiero De Santi, Renato Palazzi, Mario Mattia Giorgetti, Antonio Audino.
Coordinazione dei lavori del Convegno a cura di:
Emilio Pozzi, docente di Teatro e Spettacolo - Facoltà di Sociologia Università degli studi di Urbino «Carlo Bo»
Vito Minoia, docente di Teatro di Animazione - Facoltà di Scienze della Formazione Università degli studi di Urbino «Carlo Bo»
Direzione rivista europea Catarsi -Teatri delle diversità
ore 13.30 Chiusura dei lavori
Per chi non lo sapesse…
Cartoceto dista: 15 km da Fano, 28 km da Pesaro, 40 km da Urbino. La via più breve per raggiungere la sede del Convegno è l’autostrada A14, uscita Fano (12 km). Immettendosi sulla superstrada per Roma uscire a "Lucrezia-Cartoceto". Per chi arriva da Roma, invece, l’uscita è a "Calcinelli" e poi proseguire per "Saltara-Cartoceto."
Cartoceto non è ben collegata con i mezzi pubblici. Occorre arrivare a Fano in treno (Ferrovie dello Stato - linea adriatica Ancona-Bologna) e poi proseguire in bus (linee AMI o BUCCI).
Informazioni dettagliate da e per tutte le sedi ferroviarie possono essere cercate sul sito delle ferrovie dello stato: www.trenitalia.com
BUS da Fano a Cartoceto [non in servizio domenica 10] – Linee AMI
FANO (stazione autocorriere) 7.30 11.30 12.40 16.40 18.30 19.30*
CARTOCETO 8.05 12.05 13.15 17.15 19.10 19.40
* Non linea diretta ma Fano-Calcinelli ore 19.00 cambio ore 19.30 con Calcinelli-Cartoceto.
CARTOCETO 6.50 8.10 12.05 14.50
FANO 7.25 8.50 12.40 15.25
Da Pesaro a Fano la linea Ami effettua il servizio ogni 30 minuti. il sabato e ogni ora la domenica.
Ospitalità
A prezzi convenzionati con l’organizzazione del Convegno è possibile pernottare, o scegliere opzioni di Bed&Breakfast, in Alberghi e Agriturismo della zona.
Per informazioni e iscrizioni:
Conte Camillo P.S.C. a r.l. – Via Flaminia, 315 – 61030 Lucrezia (PU)
Tel. 0721.877272 – fax 0721.876671 – e.mail: info@contecamillo.it
Associazione Culturale "Nuove Catarsi" – Via San Nicola, 7 - 61030 Cartoceto (PU)
Tel. 0721.898406 - Tel./fax 0721.893035 – cell. 339 1333907/ 3287299337 – e.mail: nuove.catarsi@libero.it
Quinto Convegno Internazionale di studi "I teatri delle diversità"
Cartoceto 9-10 ottobre 2004
Scheda di iscrizione
(fateci pervenire, via fax o posta elettronica, il sottostante modulo compilato in ogni sua parte)
Con il presente modulo, il sottoscritto _________________________ nato a ______________ __________ il ___________ residente a ______________________________ cap __________
Via ___________________________________________________________________________ tel:_______________________________________ e-mail:_______________________________ comunica la propria adesione al Quinto Convegno Internazionale di Studi "I teatri delle diversità", organizzato dall’associazione Nuove Catarsi, che si terrà a Cartoceto (PU) nei giorni 9 e 10 ottobre 2004.
Iscrizione al Convegno (9 – 10 ottobre 2004)
Detta iscrizione, costa € 60,00 (Sessanta Euro) e dà diritto a:
- attestato di partecipazione e materiale relativo ai lavori;
- volume "Teatro e disagio" - primo censimento nazionale di gruppi e compagnie che svolgono attività con soggetti svantaggiati-disagiati, oppure, in alternativa, all’abbonamento annuale alla rivista "Teatri delle diversità" o a tre numeri arretrati a scelta della stessa;
- ingresso agli spettacoli in programma nella giornata di Sabato 9 ottobre e ingresso allo spettacolo Il Pianeta irritabile rappresentato nel Teatro Comunale di San Costanzo.
La somma sopra indicata, potrà essere inviata tramite vaglia postale, indirizzato ad Associazione culturale "NUOVE CATARSI", via S. Nicola, 7, 61030 – Cartoceto (PU)", con indicazione della causale e dei propri dati.
Data __________________
Sottoscrizione
_____________________________
I propri dati saranno utilizzati esclusivamente all’interno dell’associazione. Non saranno divulgati all’infuori dell’ambito sopra accennato; Il sottoscritto potrà in qualsiasi momento chiederne, ai sensi della legge 675/96, la modificazione o la cancellazione. Conformemente a detta legge, esprime il proprio consenso.
Esprimo il mio consenso
_____________________________
|
E' scomparso Giovanni Raboni
Poeta, scrittore, critico e autore teatrale
di Redazione ateatro |
Il poeta Giovanni Raboni è morto questa mattina a Parma in seguito ad un attacco cardiaco. Era ricoverato dal giorno di Pasquetta al Centro cardiaco dell'ospedale San Raffaele della città emiliana. Era nato nel 1932 a Milano, la città dove aveva sempre vissuto.
Poeta, scrittore, critico di grande raffinatezza, intellettuale dal sincero impegno civile, Giovanni Raboni dal 1987 al 1998 è stato critico teatrale del «Corriere della Sera» e poi consigliere d’amministrazione del Piccolo Teatro, da cui era stato escluso nel 2002 in maniera scandalosa (x ricostruire la vicenda, cerca "Raboni" nel forum Fare un teatro di guerra?) .
E’ anche autore di due testi teatrali, Rappresentazione della Croce (andato in scena con la regia di Pietro Carriglio) e Alcesti o la recita dell’esilio (portato in scena da Cesare Lievi all'inizio di quest'anno); entrambi i testi sono pubblicati da Garzanti, che ha anche raccolto le sue Poesie negli Elefanti.
Traduttore di grande livello (aveva all'attivo la traduzione completa della Recherche di Proust), per il teatro aveva firmato le traduzioni di Fedra di Racine (regia di L. Ronconi, 1985, con Anna Maria Guarnieri; Torino 1984); Partage de midi di Claudel (regia di A. R. Shammah, Milano 1987-88), Ruy Blas di Victor Hugo (regia di L. Ronconi; Torino 1996) e Le false confidenze di Marivaux (regia di M. Sciaccaluga; Genova 1997), La scuola delle mogli di Molière (regia di J. Lassalle; Milano 2002).
|
Maria Giovanna Elmi sarà il nuovo presidente dello Stabile del Friuli-Venezia Giulia
La nomina di competenza del Comune
di Redazione ateatro |
Sarà Maria Giovanna Elmi il nuovo presidente dello Stabile del Friuli-Venezia Giulia. La nomina è di competenza del Comune, ed è stata annunciata oggi nel corso di una conferenza stampa dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza (centro-destra).

Maria Giovanna Elmi è nata nel 1940 a Roma e ha inziato la carriera come annunciatrice Rai nel 1970. E' stata valletta accanto a Mike Bongiorno, con cui ha presentato il Festival di Sanremo nel 1977 e 1978, poi ha condotto Il sistemone con Paolo Valenti dal 1983 e Sereno variabile con Osvaldo Bevilacqua dal 1986.
Negli anni Novanta, dopo che la sua popolarità aveva avuto un brusco calo, ha intentato causa alla Rai perché, pur ricevendo uno stipendio, l'azienda non la faceva lavorare mentre per contratto non poteva passare a reti concorrenti. Negli ultimi tempi si era esibita in una serie di televendite su alcune televisioni locali. (Per ulteriori informazioni, imperdibile il suo sito ufficiale: solo per dirne una, si impara che "Si dedica al “Sociale” dal 1974 quando diventa donatore sangue del Gruppo Donatori Rai"; per il suo quadro astrale e le operazioni di chirurgia estetica, vedi il forum Nuovo teatro vecchie istituzioni).
Evidentemente è questo il curriculum ideale per assurgere ai vertici di un teatro stabile. Certo la nuova presidentessa potrà svolgere un ruolo importante nell'incontro di martedì 21 a Genova, dove i vertici degli stabili italiani, raccolti intorno a Luca De Fusco, presenteranno il loro "libro bianco per sfatare tutti i luoghi comuni sui teatri pubblici".
In effetti di luoghi comuni ne circolano parecchi, sull'involuzione degli stabili, ma questa nomina ne spiazza certamente qualcuno. E non saranno sicuramente banali i consigli che la Elmi vorrà dare a Luca Ronconi e Maurizio Scaparro, impegnati a Genova per ridefinire la "missione" del teatro pubblico in Italia.
|
Nasce IRIS, l'associazione sud-europea per la creazione contemporanea
Raccoglie 55 teatri e festival di Francia, Italia, Spagna e Portogallo
di IRIS |
Lo scorso venerdì 23 luglio, ad Avignone, durante i giorni del Festival, è stata ufficialmente costituita IRIS, Associazione sud-europea per la creazione contemporanea. Membri fondatori dell’Associazione sono 55 organismi di quattro Paesi: Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Sono teatri e festival che lavorano e producono nell’ambito della creazione contemporanea dello spettacolo dal vivo.
La costituzione dell’Associazione è il risultato di una serie di incontri che hanno avuto inizio a Modena nel dicembre 2003.
IRIS ha sede in Francia, a Parigi, e si pone come obiettivo principale quello di favorire e sostenere nuove dinamiche e nuovi progetti formativi e produttivi di artisti indipendenti. L’intenzione è migliorare le condizioni di produzione e distribuzione dell’arte scenica contemporanea nel circuito europeo, di garantirne una continuità, e contemporaneamente di rivendicare la necessità di un’attenzione specifica da parte delle istituzioni europee, nazionali e locali.
Si vuole altresì favorire un continuo scambio di idee, che rafforzi la conoscenza reciproca delle realtà artistiche e dei progetti dei Paesi rappresentati.
In occasione della costituzione ufficiale è stato nominato il primo Consiglio d’Amministrazione, di cui fanno parte tre membri di ciascun Paese, che si è riunito a Parigi il 10 settembre scorso. In questa occasione la prima assemblea dell’Associazione è stata convocata per il 26 e 27 novembre a Madrid. L’Assemblea dei soci ha nominato alla Presidenza Pietro Valenti, Direttore di Emilia Romagna Teatro Fondazione.
IRIS
Membri Fondatori
Francia
Didier Thibaut, La Rose des Vents, Villeneuve d’Ascq
Dominique Jambon, Espace Malraux, Chambery
Patrick Ranchain, La Caserne, Marsiglia
Marie-Odile Wald, Théâtre National de Bretagne, Rennes
Jean-Marie Horde, Théâtre de la Bastille, Parigi
Alain Fourneau, Les Bernardines, Marsiglia
Mireille Guerre, Les Informelles, Marsiglia
Cristiano Carpanini, L’Officina, Marsiglia
José-Manuel Gonçalves, La Ferme du Buisson, Marné-La-Vallée
Salvador Garcia, Scéne national Bonlieu, Annecy
Jean-Paul Angot, Le Cargo, Grenoble
Vincent Baudriller, Festival d’Avignon
Antoine Conjard, l’Hexagone Scéne national, Meylan
Angelina Berforini, Centre Dramatique National, Caen
Laurie Marsoni, Théâtre National de Toulouse, Tolosa
Richard Coconnier, Centre Dramatique National, Bordeaux
Jacky Ohayon, Théâtre Garonne, Tolosa
Gildas Le Boterf, La Halle aux Grains, Blois
Corine Gaillard, Le Lieu Unique, Nantes
Marie Collin, Festival d’Automne, Parigi
Monique Guillouet, Le Théâtre Scéne national, Auxerre
Dominique Chenet, Théâtre d’Arles
Marc Belit, Le Parvis, Ibos-Tarbes
Italia
Pietro Valenti, ERT Fondazione, Modena
Massimo Paganelli, Armunia, Castiglioncello
Luca Dini, Fondazione PontederaTeatro – Fabbrica Europa Firenze
Paolo Aniello, CSS, Udine
Isabella Lagattolla, Festival delle Colline Torinesi, Torino
Velia Papa, Inteatro, Polverigi
Gianfranco Capitta, Fondazione Orestiadi, Gibellina
Igina Di Napoli, NuovoTeatroNuovo, Napoli
Claudia Zeppi, La città del Teatro, Cascina
Marcella Nonni, Ravenna Teatro
Silvia Bottiroli, Santarcangelo dei Teatri
Roberto Ricco, Teatro Kismet, Bari
Franco Ungaro, Teatro Koreja, Lecce
Ninni Cutaia, Teatro Mercadante, Napoli
Alessandro Bertini, Teatro Metastasio, Prato,
Franco Ruggieri, Teatro Stabile dell’Umbria, Perugia
Gigi Cristoforetti, Festa del Circo, Brescia
Portogallo
Rui Sena, Quarta Parede, Covilha
Miguel Honrado, Teatro Viriato, Viseu
José. A Laginha, Devir, Faro
Luisa Taveira, CCB, Lisbona
Giacomo Scalisi, CCB, Lisbona
Gil Mendo, Culturgest, Lisbona
Fracisco Frazao, Culturgest, Lisbona
Vasco Neves, Festival Citemor, Montemor-O-Velho
Luis Firmo, Transforma, Torres Vedras
João Aidos, Teatro Aveirense, Aveiro
Vasco Macide, A Oficina, Guimarães
Renzo Barsotti, Festival Sete Sois Sete Luna, Lisbona
Isabel Barros , Balleteatro
Gabriela Cerqueiera, Istituto des Artes, Lisbona
Spagna
José A. Sanchez, Université de Cuenca
Andres Morte, Mercat de las Flors, Barcellona
Jordi Tort, Teatro Lliure, Barcellona
Laura Extébarria, La Fundicion, Bilbao
Manuel Llanes, Teatro Central, Siviglia
Maral Kekejian, Teatro Pradillo, Madrid
Matéo Feijoo, Festival Escena Contemporanea, Madrid
Oscar Deasi, La Porta, Barcellona
Paz Santa Cecila, Valencia Escena Oberta, Valencia
Simona Levi, Festival Inn Motion, Barcellona
Tena Busquet, Teatro Principal, Olot
Margarida Troguet, Teatro Municipal, Lleida
|
Il forum IETM a Milano dal 17 al 21 novembre
ateatro parteciperà al forum
di IETM |
MILANO
IETM FORUM 2004
Meeting Annuale Plenario 17-21 Novembre 2004
Sarà l’Italia ed in particolare Milano ad ospitare, dal 17 al 21 Novembre 2004, il forum annuale plenario di IETM, il primo e più esteso network culturale nel mondo, di cui fanno parte oltre 450 membri e organizzazioni provenienti da 45 nazioni diverse che condividono l’intento di stimolare la crescita della qualità delle arti performative contemporanee in ambiente globale, attraverso la realizzazione di contesti che facilitano la comunicazione e la crescita professionale, lo scambio dinamico di informazioni e il trasferimento di know-how.
Il Forum di Milano si svilupperà in 5 intense giornate articolate in meeting, gruppi di lavoro, seminari, workshop, performance, opportunità di incontro e scambio internazionale a cui avremmo il piacere siamo lieti di invitarvi comunicandovi che la partecipazione sarà volutamente aperta anche ai non-membri del network.
ll meeting prenderà vita negli spazi del quartiere Bicocca, cittadella universitaria alle porte di Milano, distretto nato dall’operazione di riprogettazione delle vaste aree Pirelliane dismesse, in un’ottica di ridestinazione d’uso dagli spazi della produzione manifatturiera agli spazi della produzione di sapere, progetto che si inserisce come componente centrale di un più ampio processo di trasformazione di Milano da città industriale a città dei servizi e della conoscenza.
Un’occasione unica perché la città in quegli stessi giorni ospiterà anche CreaMi "milano accoglie i giovani creativi" e il Futurshow 3004, due eventi che si intersecheranno trasversalmente con il forum IETM in un unico metaprogetto che convergerà intorno al tema/questione centrale della cultura giovanile e dell’innovazione.
A partire da questo macro-tema nasceranno gruppi di lavoro e di approfondimento che spazieranno nei contenuti dalla nuova identità delle residenze artistiche alle rinnovate modalità di co-produzione, dal confronto sui centri indipendenti alla concezione allargata di mobilità, al ruolo rinnovato della critica e delle nuove tecnologie applicate alle arti performative, e così via. Momenti, questi, di discussione che nascono principalmente per alimentare contesti fertili a generare incontro e circolazione di conoscenza.
Agli operatori italiani saranno, inoltre, riservate brevi sessioni di in/formazione introduttive ai temi della cooperazione internazionale, a cura della Fondazione Fitzcarraldo.
In particolare, Giovedì 18 Novembre si terrà una prima sessione in lingua italiana su "Networking and Transnational Cooperation", volta ad illustrare i principali aspetti e le implicazioni dello sviluppo dei progetti a livello transnazionale.
Per partecipare è indispensabile registrarsi al sito www.ietm.org entro il giorno 8 Ottobre 2004 (oppure dopo questa data ma pagando in più € 25 a persona): cliccando su "future" entrerete nella pagina dedicata al meeting di Milano, proseguendo poi con la scelta "how to register" avrete la possibilità di registrarvi.
Un membro per ogni organizzazione avrà la possibilità di usufruire di una borsa di partecipazione gratuita inoltrando previa richiesta a info@ietm-milano2004.it, il secondo componente della stessa organizzazione avrà, a sua volta, la possibilità di partecipare versando una minima quota d’iscrizione pari a 25 €.
La viva adesione degli operatori nazionali, in un momento cruciale della politica italiana per lo spettacolo dal vivo, sarebbe fortemente auspicata. Potrebbe infatti rappresentare un’opportunità chiave per dare un’impronta generazionale al sistema delle arti performative, nel tentativo di creare una "massa critica" in grado di prospettare un rinnovato modo di intendere la gestione della cultura, attraverso una rete di persone, azioni ed idee nella dimensione e nello scambio internazionali.
Certi di aver suscitato curiosità ed interesse, Vi aspettiamo a Milano.
i nostri più cari saluti,
Il Comitato Scientifico IETM Milano.
ANNUAL OPEN FORUM MEETINGS (called MEMBERS’ FORUM since 1999)
Incontri rivolti ad importanti argomenti chiave, questioni politiche, e problematiche interne, solitamente seguiti da una media di 300 membri.
Members’ Forums were held in :
Sceaux (France) 1989 - Vienna (Austria) 1990 - Rouen (France) 1991 - Ljubljana (Slovenia) 1992 - Manchester (Great Britain) 1993 - Brussels (Belgium) 1994 - Bergen (Norway) 1995 – Lisbon (Portugal) 1997 - Cardiff (Great Britain) October 1998 – Barcelona (Spain) October 1999 - Reykjavik (Iceland) October 2000 – Galway (Ireland) November 2001 – Aarhus (Denmark) October 2002 – Milan, (Italy) 17-21 November 2004
ANNUAL PLENARY MEETINGS
Tre giorni di discussioni informali, riflessioni, dibattititi, pianificazione e scoperta, seguiti da una media di 400 membri e operatori delle performing arts.
IETM Plenary Meetings were held in :
Polverigi (Italy) 1981 - Paris (France) 1981 - Amsterdam (Netherlands) 1982 - London (Great Britain) 1982 - Saarbrücken (Germany) 1983 - Barcelona (Spain) 1984 - Brussels (Belgium) 1984 - Berlin (Germany) 1985 - Edinburgh (Great Britain) 1985 - Copenhagen (Denmark) 1986 - Bologna (Italy) 1988 - Salzburg (Austria) 1989 - Zagreb (Yugoslavia) 1990 - Lisbon (Portugal) 1991 - Geneva (Switzerland) 1992 - Stockholm (Sweden) 1993 - Budapest (Hungary) 1994 - Seville (Spain) 1995 - Vienna (Austria) 1996 – Paris (France) 1997 - Rotterdam (Netherlands) March 1998 - Helsinki (Finland)April 1999 - Prague (Czech Republic) April 2000 – Lille (France) April 2001 – Trieste (Italy) April 2002- Birmingham (Great Britain) 9-12 October 2003 - Budapest (Hungary) 22 – 25 April 2004
Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione o sulle sessioni di lavoro potete rivolgervi a :
Massimo Mancini - membro board of directors IETM, organizzatore meeting Milano massimo@ietm-milano2004.it
Linda Di Pietro: linda_di_pietro@tiscali.it
Elena Di Stefano: elenadistefano@libero.it
|
Fritz Kater autore tedesco dell´anno per il 2004
Secondo il referendum di «Theater Heute»
di Charlotte Menin |
Per il secondo anno consecutivo Fritz Kater è stato eletto dai critici tedeschi autore dell´anno. Ogni anno l’annuario di «Theater Heute», la più importante rivista tedesca di teatro, pubblica le scelte sulle produzioni del teatro nazionale: 38 critici eleggono il teatro dell’anno, lo spettacolo dell’anno, il regista dell’anno, l’attrice e l’attore, lo scenografo e il costumista, il giovane attore e la giovane attrice, l´autore tedesco e l´autore straniero dell’anno. Si tratta in effetti della nomination più attesa, il maggior riconoscimento dei critici in Germania. Il testo sulla base del quale viene scelto l´autore dell´anno, dev’essere stato messo in scena nella stagione.
Quest´anno il premio è andato a Fritz Kater (nome d´arte di Armin Petras, annata 1966) la pièce we are camera / Jasonmaterial, un grottesco dramma familiare e di spionaggio tra la Germania divisa e l´oggi per due personaggi femminili e tre maschili.

In Italia è imminente la lettura scenica curata dal Festival dei Quartieri dell´Arte di Viterbo della pièce tempo di amare, tempo di morire che è valsa all´autore, oltre alla nomina di autore dell´anno del 2003 a seguito della trionfale prima assoluta al Thalia Theater di Amburgo, curata dall´autore stesso, il prestigioso premio dei Mühlheimer Theatertage. L´appuntamento in Italia al Festival dei Quartieri dell´Arte è per il 2 ottobre.
Fritz Kater è ormai più che un fenomeno, che del resto presenta analogie con gli importanti lavori del non meno conosciuto René Pollesch. Il riconoscimento dei critici non fa che sottolineare un´attenzione ormai consolidata dell´area tedesca per una drammaturgia decostruita e meticciata con linguaggi presi a prestito da altri media: si moltiplicano le opere commissionate a Fritz Kater, così come ulteriori produzioni delle pièces disponibili da parte di teatri di tutta l´aria tedesca, le cui prime assolute vengono immancabilmente messe in scena dall´alter ego registico Armin Petras. «Fritz Kater possiede la rara quanto notevole capacità di evocare intere commedie e tragedie con un´essenzialità analoga alla vignetta di un fumetto. E, en passant, crea una delle più affascinanti storie d´amore del giovanissimo teatro contemporaneo», afferma il quotidiano «Die Welt» su tempo di amare, tempo di morire. La vicenda di we are camera / Jasonmaterial (la pièce vincitrice), invece, «si svolge durante la notte di Capodanno del 1969 in un hotel finlandese e protagonista è una famiglia tedesca capeggiata da un biologo che rivela alla moglie il suo trascorso di spia. Le tensioni della Guerra Fredda penetrano nella dinamica delle relazioni affettive dei personaggi e la storia slitta rapidamente nel dramma familiare».
|
Ancora polemiche per lo Stabile del Veneto
I Ds divisi sulla proroga del mandato a De Fusco
di Redazione ateatro |
Ancora polemiche dopo il prolungamento del mandato di direttore della Stabile del Veneto Luca De Fusco fino al 2009. Per la precisione, non si spegne il dibattito all’interno dei DS dopo la frettolosa decisione del Consiglio d’Amministrazione dell’ente.
Il nodo della questione è che all’atto del voto era stato dato per scontato l’appoggio alla decisione del Comune di Venezia (che detiene il 25% delle quote, mentre un altro 25% è del Comune di Padova, e il restante 50% è di competenza regionale). La nomina era passata con il 75% di Regione e Comune di Venezia, anche se il Comune di Padova aveva inviato una lettera al presidente del teatro Laura Barbiani e al rappresentante del Comune di Venezia Alfonso Malaguti (che aveva votato per la riconferma di De Fusco), chiedendo di rinviare la decisione.
Ora due consiglieri del Comune di Venezia, Agostini e Marini, hanno presentato una interrogazione al sindaco Costa, per chiedergli «se corrisponde al vero il nulla osta da parte del sindaco» per la riconferma del direttore artistico fino al 31 dicembre 2009. «Se così non fosse, si chiede quali iniziative intenda assumere il sindaco di Venezia affinché si soprassieda alla nomina del direttore artistico e non ritenga opportuno formulare richiesta di sospensione della delibera del Consiglio di amministrazione del 26 luglio».
Insomma, la questione dello Stabile spacca i Ds veneti – anche se le malelingue dicono che la decisione contestata abbia avuto una spinta decisiva da parte della direzione nazionale dei Ds, su calde pressioni genovesi.
A pensar male aiuta la lista degli spettacoli del Teatro di Genova gratificati lo scorso anno con le patacche dei Premi Olimpici del Teatro, dove hanno un ruolo decisivo proprio De Fusco, Barbiani (che in CdA aveva garantito, pare, per l'ok di Costa) e il genovese Carlo Repetti, oltre che naturalmente il grande protettore di De Fusco, Gianni Letta. Ma naturalmente queste sono solo illazioni...
|


