Uomini nudi, censure, soldi e tanti spettacoli
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and1
I fondi del FUS
Dove finiscono i finanziamenti ministeriali allo spettacolo?
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and2
Un Otello khmer alla Biennale di Venezia
Samritechak dell'Ensemble di Danza e Musica della Royal University of Fine Arts di Phnom Penh diretta da Sophiline Cheam Shapiro
di Fernando Marchiori
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and20
Le recensioni di "ateatro": Bascule di Anomalie
a Villa Borghese per "Metamorfosi – Festival di confine fra teatro e circo"
di Clara Gebbia
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and30
Le recensioni di "ateatro": Il mercante di Venezia di William Shakespeare
regia di Elio De Capitani per il Teatro dell'Elfo
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and31
Dall'archivio di "ateatro": Il mercante di Venezia di William Shakespeare
regia di Stephan Braunschweig al Piccolo Teatro (1999)
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and32
Le recensioni di "ateatro": Agamennone. Sono tornato dal supermercato e ho preso a legnate mio figlio
di Rodrigo García
di Alessandro Romano
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and33
Il teatro nell'era digitale
Le Théâtre à l'ère du numérique, Parigi, 24 ottobre 2003
di Anna Maria Monteverdi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and38
Dall'archivio di ateatro: La camera astratta di Giorgio Barberio Corsetti & Studio Azzurro
originariamente pubblicata su «il manifesto», 18 giugno 1987
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and39
Partiture
Michele Sambin: dalle video performance musicali al teatro carcere
di Anna Maria Monteverdi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and40
Il monaco guerriero del teatro italiano
Sul teatro di Danio Manfredini
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and70
Dürrenmatt pittore in mostra a Bologna
Bologna, Galleria d’Arte Moderna, fino al 2 novembre
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and80
La famiglia Fo apre una televisione
Atlantide tv inizierà a trasmettere il 3 novembre
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and81
www.dramma.it di ottobre
Le novità del sito
di www.dramma.it
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and82
Nasce FaQ, il coordinamento delle compagnie di produzione lombarde
Il documento delle 13 compagnie
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and83
Il CdA del Piccolo censura Dario Fo?
Sergio Escobar sulla prima pagina del "Corriere della Sera"
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and84
Shakespeare in movie
Il cinema shakespeariano in rassegna a Milano
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and85
Michele Sambin e Mario Martone a Invideo 2003
Il programma della rassegna milanese
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and86
Kantor in mostra a Torino
Video, teatro, disegno e fotografia
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and87
L'armata a cavallo da Isaak Babel'
Un’internazionale di uomini buoni
di Moni Ovadia
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and89
Il Bread & Puppet a Milano
Un po' di documentazione
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and90
Uomini nudi nel nuovo logo di "ateatro"?
Decine di maschi disinibiti invocano il nuovo numero della strepitosa webzine
di Ufficio grafico ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and91
L'editoriale di ateatro 59
Uomini nudi, censure, soldi e tanti spettacoli
di Redazione ateatro
Questo ateatro 59 è pieno di uomini nudi che danzano allegramente, apposta per voi golosone! Ma è anche un numero poderoso, con decine di saggi, recensioni, informazioni.
Poi – novità! novità! novità! – ci sono anche molte notizie: perché se non ve ne siete accorti, la sezione delle news è sempre più ricca di informazioni aggiornate quasi quotidianamente. Così non vi basta più visitare il sito quando arriva la nostra molestissima mail (se arriva, però a volte si perde per strada, nei labirinti della rete...). Adesso vi tocca visitarlo più spesso, non appena succede qualcosa di importante, per essere aggiornati in tempo reale. Per esempio, i più pettegoli avrebbero potuto spassarsela seguendo minuto per minuto la fallita – forse – censura a Dario Fo, che non doveva più recitare al Piccolo Teatro.
Ricordatevi però che le notizie le potete sempre inserire anche voi, mandandole alla redazione, oppure utilizzando direttamente i forum. (Ah no, mica potete, DOVETE!!! inserire notizie e commenti, mica possiamo fare tutto noi...)
Ma non è tutto, naturalmente. Tanto per cominciare, dove finiscono i soldi del FUS, quelli assegnati dal Ministero dei Beni Culturali? Abbiamo scaricato i dati dal sino del Ministero e preparato una bella tabellona, dopo di che Elena Cerasetti & Federica Fracassi (Teatro Aperto) hanno estrapolato qualche statistica e un paio di grafici. Così, tanto per farvi venire qualche idea.
Però non si parla solo di soldi, in questo ateatro59. Siamo andanti anche alla Biennale di Venezia, quella affidata a Peter Sellars, abbiamo visto tanti spettacoli, da Victor García ai Teatridithalia (un grazie a Fernando Marchiori, Clara Gebbia & Alessandro Romano).
Soprattutto nella ricchissima sezione tnm, l’imprevedibile amm racconta del convegno sul teatro nell’era del digitale che si è tenuto di recente a Parigi (lei c’era...) e ripercorre la carriera di videoartista di Michele Sambin.
Ancora, in anteprima, la prefazione di olivieropdp al libro che Lucia Manghi ha dedicato al teatro e all’attività pedagogica di Danio Manfredini, Piuma di piombo.
Vi basta o non vi basta?
Nel frattempo le visite al sito continuano a salire. Forse è buon segno. Forse è un segno che là fuori, nel mondo, c’è qualcosa che non va... Però siete tutti così placidi, tranquilli.
I fondi del FUS
Dove finiscono i finanziamenti ministeriali allo spettacolo?
di Redazione ateatro
Ogni anno la spartizione del Fondo Unico dello Spettacolo (ovvero i soldi che il Ministero dei Beni Culturali destina allo spettacolo) è oggetto di una calibrata spartizione tra centinaia di realtà (per la Prosa compagnie, teatri, festval, circuiti, scuole...).
E' un evento importante, per tutto il teatro italiano, anche se i criteri vengono da sempre discussi. Spesso i denari pubblici vengono dati a chi non ne ha bisogno (ricchi impresari privati), oppure dispersi in mille rivoletti a compagnie prssoché sconosciute. Spesso si registrano casi clamorosi (vedi i Teatri Uniti, quest'anno superpremiati per il loro Sabato, domenica e lunedì ma puniti da un decurtamento radicale).
Sta di fatto che prendere soldi dal Ministero, in genere, aiuta a rastrellare finanziamenti anche da altre fonti (enti locali, in genere, vista l'assenza pressoché totale di sponsor per la prosa).
Abbiamo scaricato dal sito del Ministero i dati relativi all'ultima tornata di finanziamenti e li abbiamo messi in una splendida tabella. Poi, con l'aiuto delle due kamikaze di Teatro Aperto Federica Fracassi & Elena Cerasetti, abbiamo raggruppato alcuni dati per provare a individuare qualche tendenza.
Non aggiungiamo nulla (per ora). Ma abbiamo molte curiosità e soprattutto ci piacerebbe sentire i vostri commenti.
Per vedere la tabella e i grafici, clicca qui.
Un Otello khmer alla Biennale di Venezia
Samritechak dell'Ensemble di Danza e Musica della Royal University of Fine Arts di Phnom Penh diretta da Sophiline Cheam Shapiro
di Fernando Marchiori
Quella che poteva apparire come una edizione in tono minore della Biennale Teatro (due soli spettacoli in programma, più le prove aperte di un lavoro in progress del suo direttore, Peter Sellars) ha offerto ad un pubblico attento e numeroso un formidabile esempio di pratica cross-cultural, mostrando, in tempi di facili commistioni ‘etniche’ e globalizzazioni del gusto, come sia possibile tenere rigorosamente aperte le questioni capitali dell’identità e della differenza, della tradizione e dell’innovazione, dell’autonomia dell’arte e dell’urgenza del presente.
Building & Rebuilding, Visionaries & Peacemakers è del resto il titolo di questo 35° festival, la cui prima tranche è stata dedicata a una sorta di ‘progetto Otello’, la storia del moro di Venezia essendo per Sellars ‘una metafora appropriata per l’Europa odierna. Un’Europa fatta di controlli, di guardie, di sorveglianza sui confini e limiti all’immigrazione’. Il che giustifica anche la scelta di proporre dei film nella mostra del teatro - tutte pellicole che parlano di esilio, emigrazione, emarginazione.
Primo spettacolo è appunto Samritechak, interpretato dall’Ensemble di Danza e Musica della Royal University of Fine Arts di Phnom Penh diretta da Sophiline Cheam Shapiro. Ma non si tratta banalmente di un Otello cambogiano, né di un Otello ‘raccontato attraverso la danza classica cambogiana’, come troppo umilmente recita il programma di sala. Siamo stati in realtà testimoni di qualcosa di molto più complesso e importante. Cercheremo di spiegare perché, senza dimenticare le suggestioni emerse, intorno al personaggio shakespeariano e alla sua rilettura cambogiana, negli incontri condotti da Sellars con Amin Maalouf, con Toni Morrison e con la stessa Cheam Shapiro.
La danza tradizionale cambogiana
‘Avete presente quei bambini disperati con il ventre gonfio? Ecco, io avrei potuto essere una di loro.’ Non esita a raccontare di sé e della sua famiglia, Sophiline Cheam Shapiro, mentre spiega le drammatiche vicende che hanno portato alla quasi completa cancellazione di un patrimonio millenario come la danza khmer durante il regime di Pol Pot. Dal 1975 al 1979 i khmer rossi misero al bando spettacoli e scuole di danza, ne bruciarono costumi e scene, ne uccisero danzatrici e maestri. La stessa Sophiline Cheam è una delle poche sopravvissute ai campi di sterminio. Sul piano artistico la perdita rischiava di essere davvero definitiva, tenuto conto anche del fatto che la danza classica era solo da pochi decenni accessibile ad un pubblico più vasto, rappresentata nei teatri, poiché tradizionalmente si trattava di una pratica rituale rivolta esclusivamente alla corte e ai suoi ospiti. Nato infatti nel VI secolo nei villaggi e nei templi, il robam kbach boran assunse ben presto un ruolo di mediazione tra i sovrani e gli dèi, tra il mondo materiale e quello spirituale. Solo nel 1965 il re Sianuk promosse una sistematizzazione degli insegnamenti, fino ad allora trasmessi oralmente e con l’esempio di generazione in generazione, aprendo quella Royal University of Fine Arts che i khmer rossi devastarono dieci anni dopo.
Ma la diaspora cambogiana è riuscita a salvare i principi della danza insegnandone le tecniche in particolare nei campi profughi in Thailandia e nelle comunità di rifugiati in California, a Long Beach.
Ideogrammi danzanti
La danza khmer ha qualcosa come 4500 movimenti e posizioni, che si compongono in complesse figurazioni fino a formare sequenze narrative e descrittive di notevole articolazione sintattica. Vi sono gesti ciclici codificati nei secoli (come il ciclo della natura, che Sophiline Cheam Shapiro nel corso dell’incontro con il pubblico scompone nei suoi passaggi essenziali: albero, foglia, fiore, frutto, caduta del frutto maturo e rinascita dell’albero dal seme); altri, più facilmente decodificabili anche per noi occidentali, che esprimono comandi (di richiamo e allontanamento, per esempio) o stati d’animo (pianto, ira, ecc); altri ancori più simbolici per indicare bellezza, amore (le braccia incrociate sul petto) o felicità (un’elaborata figura dove tra l’altro la pianta di un piede incontra il palmo di una mano).
Tradizionalmente il robam kbach boran, lo stile ‘restaurato’ negli ultimi vent’anni, è interpretato solo da danzatrici, con il volto dipinto di bianco, sia per apparire come esseri celestiali, puri e perciò degni di comunicare con le divinità, sia per esaltare i ricchi costumi in cui prevale l’oro delle stoffe, il luccichio dei lustrini e delle sete, delle cavigliere e dei copricapi. Generalmente improntato a un sereno distacco che risalta i movimenti, il volto può seguire o contraddire le direzioni dei gesti con l’espressione degli occhi, mostrando lo sguardo, ma senza mai giungere alle deformazioni del kabuki o del kathakali.
Lo sviluppo delle azioni è composto, l’evoluzione delle figure è quasi rallentata. ‘Dietro la lentezza dei gesti - spiega la coreografa - c’è una meditazione in movimento’. Un equilibrio del corpo e della mente che sembra lasciare il tempo allo spettatore di cogliere il fissarsi di una forma, quasi lo sbalzare di un ideogramma o di un bassorilievo che richiama l’iconografia dei templi, per poi subito disporsi altrimenti senza interrompere il flusso della scrittura corporea.

L’alterazione dell’equilibrio avviene, come spesso nel teatro orientale, sostenendo il corpo non sull’intera pianta del piede. In questo caso è più la parte posteriore a entrare in gioco, con frequente sollevamento dell’alluce negli spostamenti e nelle posture di tensione. Un po’ come nel teatro balinese. L’andatura è di conseguenza a gambe leggermente piegate, con piedi rivolti all’esterno, mentre le braccia hanno movimenti sinuosi che porgono e sostengono e a volte ravvivano (per esempio con la torsione del gomito) le posizioni e i movimenti delle mani. Qui è forse l’aspetto più affascinante di quest’arte. Le mani ruotano, si aprono a ventaglio, diventano fiori esotici, preziosi ricami aerei, quasi si rovesciano nella curvatura straordinaria delle dita. Basta un indice al ripudio, al comando, al duello. Oppure sembrano rispondersi in disegni, replicati nelle scene di massa da ali di danzatrici, strombature viventi di un tempio. Parlano una lingua che seduce e sa raccontare, anche a noi che ne ignoriamo la grammatica, storie grandi e lontane. Persino quella di Otello.
La trasmutazione di Otello
E’ proprio attraverso la storia di Otello, anzi, che Sophiline Cheam Shapiro permette anche al pubblico occidentale di accedere alla tradizione estetica cambogiana. Con un duplice movimento. Ne scopriamo infatti alcuni aspetti seguendo il ‘nostro’ punto di vista, la ‘trama’ di Shakespeare, e nel contempo siamo portati a capovolgere la prospettiva, intuendo anche il ‘loro’ sguardo dentro questo classico della letteratura occidentale, accogliendo la portata innovativa di una lettura per molti versi originale proprio mentre rispetta i canoni culturali khmer.
Colpisce anzitutto l’eliminazione del tema razziale. Il Moro, il principe scuro (questo il significato del nome Samritechak), è qui interpretato da una donna con il volto imbiancato, incarnazione del mitico nguah, mezzo uomo e mezzo gigante. Razza e religione, aspetti fondamentali nell’opera shakespeariana, sono totalmente assenti nello spettacolo e, come ha notato Amin Maalouf, non sentiamo neppure il bisogno di ritrovarli. Trasmutata nei colori e nei suoni della corte cambogiana, la storia appare dominata interamente dalle passioni umane, e non è dunque difficile comprendere il rilievo dato nello spettacolo alla figura di Desdemona/Khanitha Devi, fin dall’iniziale scena del ripudio paterno. Una scena dai toni diremmo melodrammatici, secondo le nostre categorie. Ma è chiaro che la coreografa ha visto Shakespeare anche attraverso Verdi: dalla presentazione dei personaggi chiamati alla ribalta in apertura dell’opera, alle scene corali (il matrimonio, la partenza per la guerra, la danza della vittoria) viene da pensare a un musical. Del resto i personaggi cantano con le voci del coro e degli strumenti della pinpeat orchestra raccolta su un lato del palco (tamburi, xilofono e uno strumento a fiato che, per timbro e scale, sembra muoversi a metà tra gli spessi microtoni di una cornamusa e le volute modali del soprano di Coltrane, ma appartiene invece anch’esso interamente alla tradizione cambogiana).
La scenata del padre risulta comunque di inattesa forza e brutalità. «Ricòrdati», dice a Otello/Samritechak, «che come ha tradito me, lei finirà col tradire anche te». L’anatema fondante la vicenda, il destino lanciato a compiersi tragicamente, ineluttabilmente. Siamo nel pieno dominio del maschile. Desdemona si mette in gioco completamente e su questa scelta la legge maschile del padre incide il segno del disprezzo. Lei è segnata. Ma è proprio su quel segno che farà leva il capovolgimento del finale shakespeariano.
Khanitha Devi entra così, per amore, dentro quel mondo maschile, ma per assumerne il senso più nobile. Ne diventa la testimone proprio perché non vi è mai del tutto coinvolta e saprà superarlo in nome delle leggi non scritte, le più profonde, quelle sostanziali e non formali, le stesse che muovono Antigone. Di qui la forza di opporre alle accuse del padre e del marito, giganteschi anche nella loro ottusità, una visione alternativa e meno antropocentrica del mondo. Di qui anche l’insistenza nel perorare la causa di Cassio anziché ripiegare in una rassegnata autodifesa. Diventa lei il centro dell’azione. In un certo senso è lei Otello, e lo spettacolo, come ha suggerito Toni Morrison, potrebbe più propriamente intitolarsi Desdemona.
La traduzione della tragedia in danza funziona grazie a tale scelta rivoluzionaria, che porta in primo piano, verso l’esterno, anche i contrasti interiori e mantiene la tensione drammatica sempre sul filo dei sentimenti, in una logica tutta ‘femminile’ dei rapporti e della giustizia. Così anche il finale appare allo stesso tempo rispettoso dei canoni del teatro cambogiano, che esclude la morte in scena, e coerente con il processo di ‘desdemonizzazione’, per così dire, dell’Otello. Khanitha Devi risorge di fronte al marito che invoca punizione per il delitto commesso. ‘Abbiamo visto troppi assassinii - riassume Peter Sellars - vogliamo cambiare pagina.’ Ma la riconciliazione implica l’assunzione di responsabilità per quanto accaduto, ricorda con pacata fermezza la coreografa.
Jago, Virul e il vecchio William
Tutte donne in scena, dicevamo, tranne un uomo che dà vita al personaggio di Jago/Virul. Anche questa eccezione risponde all’antica attribuzione di ruoli. La danza khmer riservava alle donne le parti dei personaggi principali - maschi, femmine e giganti - mentre lasciava agli uomini la parte delle scimmie. Vidul è infatti una scimmia, è l’unico a portare una maschera, grande e colorata, grottesca, con un perenne ghigno bestiale. Si muove sgraziato, a gambe molto piegate, con agili passettini. Non possiede il linguaggio delle mani, e quando alza il palmo aperto sembra incapace di curvare le dita, di opporre il pollice. Il suo costume non brilla e naturalmente termina in una lunga coda. Quando entra in possesso del fazzoletto di Desdemona, la sua danza diabolica è un’ipostasi dell’ambiguità, e la sua ombra sul fondale enfatizza la doppiezza di tutto il suo essere. Ma non è un corpo estraneo, anzi è ben introdotto negli ambienti di corte, al punto che tutti i personaggi prestano fede ai suoi inganni. E’ dunque ‘uno di noi’ a portare il sospetto, il male, la morte, non il principe scuro, lo straniero. Così in Shakespeare, Jago non viene dall’altra parte del Mediterraneo, ma è ‘dalla nostra parte’ e il suo stesso nome, come ha ricordato Maalouf, è forse abbreviazione di Santiago, suggerendo in modo subliminale al lettore seicentesco un riferimento al potere dominante del tempo, quello dell’impero spagnolo.
Nessun dubbio, quindi, che Jago, diventato Virul, possa servire a riflettere sugli eccidi di una dittatura sanguinaria del sud-est asiatico negli anni Settanta. E che la storia di Otello, diventato Samritechak, possa parlarci dell’Europa di oggi e di quella fondamentale linea di divisione del Mediterraneo che, come al tempo di Shakespeare, continua a correre da Gibilterra a Cipro (ne ha parlato Maalouf). Quel che tuttavia si vuole, in conclusione, ribadire di fronte al lavoro di Sophiline Cheam Shapiro è il felice equilibrio nella dialettica innovazione-tradizione e il rispetto delle differenze nello scambio transculturale. Scriveva Jan Kott sostenendo l’inevitabile contemporaneità del drammaturgo inglese: ‘Shakespeare è come il mondo, o come la vita. Ogni epoca vi trova quel che cerca e quel che vuole vedervi’. Certo, ma a patto che vedendoci ciò che vogliamo vedere noi, si veda anche un poco ciò che vuole vederci l’altro (e viceversa). E che trovandovi i khmer si finisca per incontrare anche il vecchio William.
Le recensioni di "ateatro": Bascule di Anomalie
a Villa Borghese per "Metamorfosi – Festival di confine fra teatro e circo"
di Clara Gebbia
Il 23 e 24 settembre alla Tenda del Galoppatoio di Villa Borghese, è andato in scena il secondo appuntamento di "Metamorfosi – Festival di confine fra teatro e circo" diretto da Giorgio Barberio Corsetti.
La compagnia francese Anomalie ci ha stupiti con la semplicità (poetica) e la complessità (ginnica) di Bascule. Quello che ci si apre alla vista all’accendersi delle luci, è uno scenario abbastanza ordinario: un qualsiasi angolo di strada, delimitato da lamiere ondulate e da porte. In mezzo, la bascule, questa macchina semplicissima, nient’altro che una leva, che in apparenza serve per saltare. In realtà questo asse di legno con un piede di metallo e un chiodo in mezzo è un vettore dimensionale, una macchina fabbrica-mondi, un frullatore di atomi, capace di scagliare chi la usa (e, magia delle magie, chi la vede usare) in universi paralleli e capovolti.
In questo angolo di strada si incontrano e si salutano i passanti e gli abitanti di questo "ordinario" quartiere. Ma anche se i gesti sono quelli di tutti i giorni, salta agli occhi immediatamente che si tratta di un quotidiano eccezionale: ci si abbraccia camminandosi l’uno sull’altro, si parla mentre si sta sulle mani, si rotea, ci si arrampica, si salta con la bascula, il tutto aprendo e chiudendo porte per poi cadere tutti insieme per terra, perfettamente all’unisono. In questa millimetrica casualità e stravagante normalità, irrompe ad un certo punto il circo, annunciato da fanfare e da un corridoio di luce che si disegna nel buio della strada come per sottolinearci l’attesa di un evento eccezionale.

Il circo arriva con il più circense dei numeri: la donna chiusa in uno scatolone e trafitta da lamiere! Solo che il mago è ridicolo, e la donna non capiamo bene che fine faccia… Ed è tutte le volte così per tutti gli altri personaggi del circo che di tanto in tanto interrompono la vita di quartiere: il mangiatore di prosciutto, il giocoliere che usa palle da bowling, la valletta sgraziata e perennemente sorridente che tenta faticosamente di attraversare un cerchio di metallo… oppure il mago in cilindro con un busto eccezionalmente lungo e gambette straordinariamente corte, che esegue l’eccezionale numero di rimediare due muscoletti alle proprie braccine smunte.
In compenso piegare una tovaglia da tavola in due diventa un gioco di destrezza e precisione inimitabile, eseguito però con la tranquillità e la distrazione dovuta ai gesti quotidiani.
Il pubblico ha applaudito a lungo, con mani e piedi, e ha risposto con entusiasmo alla ventata di euforia (e di adrenalina) provocata dagli irrefrenabili acrobati. E credo che fossimo grati a Bascule non soltanto per la leggerezza e il divertimento che ci ha procurato, ma per quei salti con la bascula; perché in aria ti capovolgi, e quando atterri il mondo si è girato, e le regole (logiche e fisiche) di prima non valgono più, e tutto avviene in barba al principio aristotelico di non-contraddizione e alla legge di gravità e a tutte le altre leggi che dicono alle cose e alle persone come e dove devono stare…Uno spettacolo pensato su coppie di opposti: circo/quotidianità, sogno/realtà prodezza/banalità. Ma primo fra tutti c’è il paradosso in carne e ossa del circense che affronta il pericolo e la morte, ogni sera, godendo e facendo gioire.
Le recensioni di "ateatro": Il mercante di Venezia di William Shakespeare
regia di Elio De Capitani per il Teatro dell'Elfo
di Oliviero Ponte di Pino
Per portare in scena uno dei testi più discussi e controversi di Shakespeare (prima per l’Estate Teatrale Veronese e ora nella stagione milanese al Teatro Leonardo), Elio De Capitani e i Teatridithalia evitano di confrontarsi direttamente con il tema dell’antisemitismo e scelgono invece la strada per loro più congeniale. Puntano cioè, in una scena costituita da una sequenza di sipari dipinti e coloratissimi, sulla teatralizzazione, sul gioco spettacolare, sulla facilità e felicità comunicative offerte da una trama ricca di elementi di collaudata presa e di personaggi fortemente caratterizzati. O meglio, esasperano questi elementi puntando su un consapevole e divertito kitsch, con una notevole libertà d’invenzione. A cominciare dai costumi (firmati come le scene da Carlo Sala), che spaziano tra diversi stili ed epoche: per esempio, il Settecento postmoderno della coppia di «buffi» Solanio e Salerio (Luca Torracca e Alessandro Genovesi), che paiono anticipare l’universo mercantile goldoniano (e che alla fine del primo tempo si presentano chissà perché con la giacca infilata al contrario); o i luccichii da discoteca del trio di vitelloni Graziano (Massimo Giovara), Lorenzo (Mario Perrotta) e Bassanio (Paolo Pierobon), che però poi opteranno per completi più istituzionali quando decideranno di diventare persone perbene. O ancora gli accenni caricaturalmente esotici dei pretendenti alla mano di Porzia (Ida Marinelli), improbabili principi del Marocco e dell’Andalusia.

Da sinistra, Mario Perrotta (Lorenzo), Alessandro Genovesi (Salerio), Luca Toracca (Solanio), Massimo Giovara (Graziano); in basso, Bolo Rossini (Lancillotto).
Anche lo Shylock di Ferdinando Bruni si fa carico di tutti i cliché dell’iconografia antisemita: è il classico ebreo pallido con la barbetta a punta, la kippah nera e i tefillim, crudele e vendicativo. Ma in genere tutte le caratterizzazioni sono esasperate, a volte fino alla macchietta. Il servo Lancillotto (Bolo Rossini) è truccato da clown e parla come Stanlio, con stralunato accento inglese e molti strafalcioni, così come sua madre Margareth sembra una specie di Mary Poppins piombata in lagina da chissà dove. Non mancano insomma le gag, scena dopo scena. Si va persino verso il musical, con le musiche di Mariolone Arcari suona dal vivo e con alcuni intermezzi cantati: addirittura, la terribile pretesa di Shylock, ovvero la richiesta in garanzia di una libbra della carne del «mercante di Venezia» Antonio, viene allegramente canticchiata. Insomma, anche le situazioni più dure vengono sdrammatizzate con ironia (e spesso puntando al facile divertimento).

Ferdinando Bruni (Shylock).
Del testo shakespeariano, che porta in scena una situazione tragica condendola con elementi fiabeschi (la prova dei tre scrigni cui sono sottoposti i pretendenti di Porzia, l’anello che la stessa Porzia affida al promesso sposo come pegno d’amore) e romanzeschi - come la fuga di Jessica, la figlia di Shylock (Elena Russo) con il cristiano Lorenzo (Mario Perrotta - viene dunque privilegiato il lieto fine da commedia, con le triplici nozze e il «vissero felici e contenti» conclusivo (dal quale restano esclusi i due protagonisti, l’astioso ebreo e il malinconico mercante). In questo quadro, il razzismo (e in specifico l’antisemitismo, un tema già affrontato dal gruppo ai tempi di I rifiuti, la città, la morte di Fassbinder) viene preso in considerazione come uno dei tanti fatti della vita. Tanto le brutali aggressioni antisemite di Antonio (Giancarlo Previati) quando la torva vendicatività di Shylock non vengono in alcun modo giudicati. I loro artefici vengono presentati semplicemente come esseri umani tra molti altri, persi tra mille altri eventi e trame più o meno spassosi.
Il mercante dei Venezia
di William Shakespeare
regia di Elio De Capitani
Milano, Teatro Leonardo
Dall'archivio di "ateatro"
Per info su altre messinscene di questo testo, vedi:
- Peter Sellars al Goodman Theatre di Chicago (1994);
- Stephan Braunschweig al Piccolo Teatro di Milano (1999);
- Trevor Nunn al National Theatre di Londra (2003).
E ancora:
I venticinque anni del Teatro dell'Elfo.
Gli spettacoli dell'Elfo nelle recensioni di Oliviero Ponte di Pino.
Dall'archivio di "ateatro": Il mercante di Venezia di William Shakespeare
regia di Stephan Braunschweig al Piccolo Teatro (1999)
di Oliviero Ponte di Pino
Da qualche tempo il Piccolo Teatro sta chiamando a collaborare giovani registi (quasi tutti stranieri, in verità), in una necessaria operazione di svecchiamento. Ecco dunque approdare sulla scena di via Rovello – ma riprendendo l’impianto dello spettacolo realizzato qualche mese fa alle Bouffes du Nord di Parigi – Stéphane Braunschweig, ex enfant prodige della scena francese ormai accompagnato da una solida fama internazionale.
Il suo Mercante di Venezia è di giansenistica semplicità. La scena è occupata solo da tre cubi d’acqua illuminati dall’altro, dove galleggiano altrettante barchette in miniatura; nel corso dello spettacolo, sullo sfondo, come attraccata a un molo, e poi sospesa a mezz’aria, come un’idea, s’intravederà la sagoma di una vera barca. Per il resto, nello spazio spoglio e foderato di nero, con l’unico accompagnamento delle severe melodie di un violoncello, c’è solo il gioco degli attori, anch’essi vestiti quasi tutti di nero: gli uomini in giacca e canotta Armani-style, le donne in abiti vagamente d’epoca. È un lavoro di raffinata semplificazione, che presuppone un’attenta lettura del testo per metterne a nudo i nodi strutturali e le simmetrie, ma soprattutto gli scontri tra diverse posizioni ideologiche. Quello che affascina il regista, con ogni evidenza, sono le idee espresse dai personaggi, in rapporto ai loro sentimenti e naturalmente agli altri personaggi. In questo caso, com’è ovvio, al centro della riflessione è il denaro – e la sua possibilità di valutare gli affetti, l’amicizia e l’amore ma anche l’odio: il rapporto che lega il malinconico Antonio e il dissipato Bassanio, il patto matrimoniale di quest’ultimo con Porzia (con il quiz fiabesco dei tre scrigni d’oro, argento e piombo), la fuga d’amore di Jessica e Lorenzo… Lo spettacolo assume così il tono vagamente brechtiano di un dramma didattico, una parabola dove si pesa l’ideologia. Esemplare nella sua semplicità e leggibilità il trattamento simmetrico nelle prime scene delle malinconie di Antonio e Porzia, che riprende nella postura la celebre incisione di Dürer.
Non sorprende dunque che nell’usare questo metodo con un testo problematico come Il mercante di Venezia, Braunschweig affronti di petto la questione più controversa: quella del dibattuto antisemitismo della pièce – e dunque in subordine l’eventuale antisemitismo di Shakespeare. La regia sposta l’accento su una sorta di principio di realtà: il razzismo antisemita viene dunque assunto come un dato di fatto, così come lo è anche il risentimento e la sete di vendetta della sua vittima, in questo caso Shylock. Rispetto all’intreccio amoroso, l’enfasi si sposta sul verdetto finale, dove le ragioni e i sentimenti si misurano con la giustizia, le sue regole – e l’uso che se ne può oggettivamente fare. La conclusione non è un lieto fine, piuttosto l’inevitabile conclusione di un’equazione di cui sono state esaminate tutte le variabili: le posizioni dei singoli e la ragion di Stato, .
Nel testo è Shylock – l’uomo che vuol tagliare la celeberrima libbra di carne ad Antonio – a difendere il proprio diritto con una delle più accese (e convincenti) perorazioni umanistiche dell’intero teatro di Shakespeare – cioè, più o meno l’inventore dell’uomo moderno. Ma, sembra avvertire Brauschweig, la dignità e integrità dell’essere umano è solo uno degli elementi, e neppure il più importante. Quello che conta, per noi gli spettatori, è piuttosto esaminare – attraverso lo specchio dei personaggi – le diverse alternative e possibilità, e le rispettive ragioni, per poi dare il nostro giudizio con una decisione libera e razionale.
Allievo di un grande maestro d’attori come Antoine Vitez, Brauschweig si appoggia in notevole misura ai suoi interpreti: e i risultati del lavoro si vedono, in una compagnia equilibrata e attenta, dove spiccano il nevrotico Bassanio di Roberto Trifirò, la determinata Porzia di Laura Marinoni e il titubante Antonio di Paolo Calabresi. Oltre naturalmente al nevrotico e tormentato Shylock di Roberto Herltizka.
Originariamente pubblicato su "il manifesto", marzo 1999.
Le recensioni di "ateatro": Agamennone. Sono tornato dal supermercato e ho preso a legnate mio figlio
di Rodrigo García
di Alessandro Romano
"Me gusta el hombre cuando el hombre es un animal: Me gusta el animal del hombre cuando folla y suda, ... incluso cuando engaña ... hasta cuando mata por venganza...." ("Mi piace l’uomo, quando l’uomo è un animale: Mi piace l’animale dell’uomo quando scopa e suda... persino quando inganna... addirittura quando uccide per vendetta").

Come in Ronald el payaso de Mac Donald, anche in quest’ultima creazione della Carniceria Teatro, Agamennone. Sono tornato dal supermercato e ho preso a legnate mio figlio, sono i corpi umani a ergersi a protagonisti del lungo racconto scritto e diretto da Rodrigo García. Veicolano funzionalmente la sua forte e diretta presa di posizione contro la tragicità dell’essere umano vittima di quel "terrorismo consumistico" che lo costringe a vivere come gli si comanda, ad accumulare carrelli di prodotti inutili, andando contro alle proprie voglie, contro ai propri piaceri carnali, contro al proprio istinto.
"…compré pan integral cuando odio el pan integral, … Y compré papel higiénico perfumado, cuando yo no puedo limpiarme el culo con algo que huele a perfume … Y compré cien botellas de agua mineral, cuando en casa el agua corriente es cojonuda y se puede beber sin problema". ("Ho comprato pane integrale, quando odio il pane integrale, … e carta igienica profumata, quando non riesco a pulirmi il culo con qualcosa che profumi … e ho comprato cento bottiglie d’acqua minerale, quando a casa l’acqua del rubinetto è buonissima e si può bere senza problemi").

Come bestie scatenate, come animali selvaggi gli attori esplodono l’energia e la brutalità di gesti incontrollabili, spasmodiche acrobazie e rapide e inumane contorsioni, coniugando movenze atletiche ad agili strutture narrative, suggestioni a spiegazioni, immedesimazioni a visioni. Corpi snaturati da alchimie esplosive di cibi espellono una notevole quantità di significati, veicolano rapporti umani, urlano messaggi di speranza, scatenano istinti di rivalsa, disegnano racconti di vita. Questa fisicità nuda e appariscente, a tratti bestiale, riflette le trasformazioni del fisico umano, vittima del potere del danaro e dei prodotti del consumismo globale. Un martellante parallelismo tra ritratti umani snaturati dalla fame (i video proiettati sullo sfondo ci mostrano immagini di occhi incavati, di mani imploranti, di scheletri viventi), e corporature scultoree (i caschi blu dell’ONU che guidano le missioni di pace e solidarietà, esibendo le loro "straordinarie doti umane"). García proclama il ritorno a un’animalità primordiale, giustificando apertamente reazioni, aggressioni, istinti, ne fa il fondamento della propria idea di umanità. I suoi sono messaggi di denuncia, solide prese di posizione, violenti e carnali manifesti di propaganda antiterroristica; ma si parla di terrorismo dell’informazione, del consumo, del potere, di una tragicità insita nella storia dell’umanità, incarnata da questi cinque corpi (gli attori Rubén Amettlie, Nico Baixas, Gonzalo Cunill, Juan Navarro e Anne Maud Meyer) che si divincolano in un alternarsi continuo di ritmi e suoni, pause e vibrazioni. Ad aizzarli, bestie inferocite, animali feriti, insanguinati, le assordanti note del complesso catalano Standstill e il furibondo mix di immagini proiettate sullo sfondo.

In questa lucida e spietata visione non c’è via d’uscita, un’alternativa plausibile a questo lampante e sonoro manifesto di denuncia, soprattutto a causa di una dichiarata impossibilità di coesistenza tra potere, volontà e speranza. Questa è la società in cui viviamo: al centro sette potenze mondiali, raffigurate da sette alette di pollo fritto. Tutt’intorno la spazzatura, i resti di un’incomprensibile e iniqua distribuzione della ricchezza, quell’immondo cumulo di sudiciume e speranza a cui nessuno si avvicina.
"…porque para rescatar la Esperanza de entre tanta basura …, hay que soltar el dinero" ("perché per riscattare la Speranza da tutta questa spazzatura si devono sganciare i soldi").
E questo non avviene. I soldi e il potere, restano ai potenti, la speranza e la volontà ai deboli.

Le nuove generazioni devono capirlo, il padre ha il dovere di raccontare al figlio come stanno le cose, come nasce la tragedia:
"…Y le explico que la TRAGEDIA empieza en el mundo industrializado, que la TRAGEDIA siempre ha empezado donde estaba el DINERO y la comida" ("...e gli spiego che la tragedia principia sempre nel mondo industrializzato, che la tragedia è sempre iniziata dove c’erano il denaro e il cibo…).
...e di picchiarlo se non capisce. "Palizas", "Hostias": ("legnate", "botte"). Due delle parole più diffuse nel vocabolario del regista ispano-argentino, punto di partenza del suo ossessionante e impietoso gesto di ribellione sociale che, anche in quest’ultima produzione, si fa arte su un palcoscenico ridotto ad un immenso immondezzaio, cimitero di nazionalismi e imperialismi, speranze e illusioni.
E lo spettatore? Travolto, impressionato, imbarazzato dinanzi a tanta schiettezza, a tanto ardire, dinanzi a questa composizione di pulsioni sfrenate, sempre nervosa e guizzante, coinvolto direttamente e con continuità in uno show erotico, in un gioco di trasformazioni e significazioni costruite da un eccezionale amalgama di body-painting, video, musiche dal vivo e musiche registrate.

È questa la tragedia odierna. Una parabola scenica che smaschera i fautori di tanta disumanità: Bush-Agamennone, Berlusconi-Agamennone, Blair-Egisto e ancora Lady D.-Clitemnestra, Bin Laden-Egisto, Canale 5-Cassandra, Monica Lewinski … Associazioni chiare e forti, immagini di copertina, punta di un iceberg del potere che spinge inesorabilmente l’umanità alla deriva.
Agamennone. Sono tornato dal supermercato e ho preso a legnate mio figlio
di Rodrigo García
Una produzione Teatro Mercadante di Napoli, Fondazione Orestiadi di Gibellina e Carniceria Teatro
ex Italsider di Bagnoli (Napoli)
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
Il teatro nell'era digitale
Le Théâtre à l'ère du numérique, Parigi, 24 ottobre 2003
di Anna Maria Monteverdi
Emanuele Quinz, presidente dell'associazione Anomos e Stéphane Cagnot di Dédale hanno ideato e coordinato il convegno internazionale Création numérique, les nouvelles écritures scéniques di cui è stata presentata la prima tappa dal titolo Le théâtre à l'ère du numérique a Parigi, Centre Georges Pompidou il 24 ottobre 2003 nel quadro del Festival Résonances-IRCAM. Insieme a Quinz e Cagnot ha lavorato un qualificato gruppo di membri del comitato scientifico tra cui Armando Menicacci, direttore del Laboratoire Mediadanse, Ludovic Fouquet, ricercatore teatrale, Florence Laly, membro dell'equipe di Manège, Scène Nationale di Maubeuge e programmatrice del Festival Via, Clarisse Bardiot, ricercatrice del Laboratoire de Recherche sur les Arts du Spectacle al CNRS, e Franck Bauchard, ricercatore e responsabile del settore teatrale del Ministero della Cultura francese.
Il programma di Création numérique continuerà nei prossimi mesi alla Comédie Française: La scène des interfaces, 16 dicembre 2003; Les métamorphoses de l'acteur, febbraio 2004; Les questions professionnelles: production et diffusion, aprile 2004; Texte, dramaturgie, écriture, maggio 2004. Gli atti del convegno verranno pubblicati come volume monografico di "Anomalie", la rivista di Anomos.
Gli incontri del 24 ottobre si sono articolati in tre momenti di approfondimento con relative tavole rotonde e dibattiti alla presenza di un numeroso pubblico di studenti, ricercatori, professionisti del teatro e artisti. Dopo una prima introduzione di Franck Bauchard sul tema della giornata di studio e di Bernard Stiegler e Andrew Gerszo, rispettivamente Direttore e responsabile della sezione pedagogica e del polo "Spettacolo" dell'IRCAM sulle attività e sui progetti intrapresi dall'Istituto di ricerca musicale, il programma prevedeva i seguenti ambiti di studio:
1. Les précurseurs
Scena e tecnologia: la creazione contemporanea in una prospettiva storica.
2.Le choc du numérique
Alcuni esempi di esperienze significative di teatro e nuove tecnologie dal 1960 ad oggi.
3. Les nouvelles formes scéniques, panorama européen.
La situazione in Italia, Germania, Polonia e Francia.
Al termine della giornata di convegno, una performance-dimostrazione del gruppo Konic thtr dal titolo Tools.
Nell'ambito della sezione dedicata ai precursori, la direttrice del Laboratoire de recherches sur les arts du spectacle del CNRS di Parigi Béatrice Picon Vallin (assente, ma la sua relazione è stata letta da una collaboratrice di Anomos) ha proposto come già nei volumi da lei curati, Les ècrans sur la scène e La scène et les images, una lettura della scena tecnologica odierna in continuità con le teorie e con le innovazioni delle avanguardie novecentesche, come un ulteriore contributo al tema della conquista di un "teatro della totalità espressiva" e di un nuovo spazio scenico generato a partire non dalla pittura o dalla letteratura ma dalla luce e dal movimento:
«La scena architettonica di Craig, la scena costruttivista o quella della Bauhaus, generano delle macchine di scena in grado di scomporre lo spazio tridimensionale in una serie di quadri in base ai quali gli attori devono controllare i movimenti scenici; l'azione si va a definire così, come una padronanza delle forme plastiche nello spazio. La luce tende allo stesso modo a eliminare la pittura per distribuirsi essa stessa nello spazio che fluidifica colori e movimenti. Oggi la macchina scenica diventa macchina di proiezione delle immagini e l'azione degli attori dovrà tener conto di queste immagini, fisse o animate che abitano contestualmente con loro, lo spazio. Immagini che possono "catturare" l'attore in diretta ed essere archiviate, immagini che appaiono "fantasmatiche", sul punto di svanire, scomparire ed in forza delle quali l'attore è raddoppiato, ingrandito, esaltato, o cancellato e sotto sorveglianza.» (B.Picon-Vallin, Un stock d'images pour le théatre. Photo, cinéma, vidéo, in B.Picon-Vallin, a cura di, La scène et les images, Paris, Cnrs éditions, 2001, p.21)
La Vallin propone una suddivisione temporale in cinque stadi di questa storia del teatro tecnologico alla cui innovazione avrebbero contribuito in maniera diretta, fattori di crisi sociale, politica, ideologica ed economica.
1. Gli anni Venti in Russia
2. Gli anni Venti-Trenta in Germania
3. Gli anni Cinquanta-Sessanta a Praga
4. Gli anni Sessanta in America
5. Gli ultimi vent’anni del secolo in Europa e in America
Particolare attenzione viene rivolta dalla Picon-Vallin al "teatro della totalità" di Moholy-Nagy, all'attore-marionetta di Oskar Schlemmer e al suo celebre Balletto triadico e a Josef Svoboda, lo scenografo ceco inventore della Lanterna magika e del sistema di poliproiezioni Polyécran presentati all'Esposizione Universale di Bruxelles (1958). Vengono mostrati anche alcuni frammenti del documentario biografico di Denis Bablet Josef Svoboda scènographe (1983); il frammento riguarda Intolleranza 1960, spettacolo-manifesto per un'idea multimediale del teatro (avente non poche implicazioni politiche) creato nel 1961 insieme con il musicista Luigi Nono su libretto di Angelo Maria Ripellino per la Fenice di Venezia prima (ma le immagini furono censurate) e successivamente per Boston (1965). Quest’ultima versione prevedeva la sostituzione dell'immagine cinematografica con un sistema di riprese televisive a circuito chiuso: era in gioco, come ricorda lo stesso Bablet "una nuova forma di opera, un nuovo tipo di teatro totale".
Sylvie Lacerte, direttrice del Find Lab (Laboratoire international de recherche et de developpement de la danse) di Montréal, ha proposto l'esempio pionieristico di EAT-Experiments in Art Technology, l’organizzazione fondata nel 1966 da Billy Kluver, Fred Waldhauer e dagli artisti Robert Rauschenberg e Robert Whitman. La nascita è dettata dall'evento 9 Evening: theatre and engineering a New York. Si trattava di performance che mettevano insieme danza, teatro, musica e video. Tra gli artisti: J. Cage, S.Paxton, D. Tudor, R. Rauschemberg, L. Childs. Sylvie Lacerte ha lavorato alla ricostruzione dettagliata di queste operazioni artistiche che sposavano in maniera inconsueta le tecnologie. Come ricorda la studiosa nel suo testo sulla storia dell'EAT on line su http://www.olats.org/pionniers/pionniers.shtml, sito che è parte del progetto Pionniers & Précurseurs dell'OLATS-Observatoire Leonardo des Arts et des Tecno-Sciences, editore anche della rivista «Leonardo» - per una documentazione sugli artisti del Novecento le cui opere e il cui pensiero sono stati determinanti per l'arte tecnologica:
«Pour la mise sur pied de cet événement, un système électronique environnemental et théâtral fut inventé par l'équipe des ingénieurs. Le THEME-Theater Envirnmental Module-fut mis sur pied pour répondre aux besoins des dix artistes, en fonction de situations théâtrales bien spécifiques. Le THEME, qui n'était pas visible de la salle, permettait, entre autres, le contrôle à distance d'objects et la possibilité d'entendre des sons et de voir des faisceaux lumineux provenant de sources multiples et simultanèes».
La Lacerte ha mostrato un frammento di una delle 9 performance, Open score di R. Rauschemberg e J.McGee (ing.) con Franck Stella e Mimi Kanarek che giocavano una partita a tennis con racchette nei cui manici erano inseriti microfoni senza fili che amplificavano il suono della pallina.
Nella seconda sezione Christopher Balme, docente di Teatro e Direttore del Dipartimento dello Spettacolo di Mayence (Germania) ha proposto un intervento dal titolo Contamination and Deployment: Theatre and Technology 1960-2003.
Balme traccia tre traiettorie del rapporto tra teatro e tecnologia:
1. video arte
2. teatro multimediale
3. performance digitale e performance attraverso internet.
Dopo aver anticipato le posizioni antitecnologiche del teatro degli anni Sessanta in particolare quelle di Jerzy Grotowski e Peter Brook, Balme nota giustamente come questa querelle théâtre ou technologie sia ancora un argomento molto dibattuto. Per la sezione relativa alla prima ondata dell'innovazione tecnologica vengono ricordate le esperienze artistiche di Nam June Paik ma anche quelle di Jacques Polieri negli anni Sessanta, così come le opere video di Bill Viola e gli spettacoli di Giorgio Barberio Corsetti per il periodo relativo agli anni Settanta e Ottanta. Balme sostiene come tali artisti pur distanti quanto a pratiche artistiche, abbiano comunque in comune un'attitudine estetica che cerca di superare la tradizionale dicotomia tra arte e tecnologia. In riferimento al passaggio dalla video arte alla scena vengono citati alcuni artisti della cosiddetta "scena multimediale" statunitense tra cui The Wooster Group di Elizabeth LeCompte, pionieri dell'uso in scena del video, live e preregistrato. Ricordiamo lo spettacolo Brace up! (1993).

Brace up!, regia di Elizabeth LeCompte: Scott Renderer, Jeff Webster (sui monitor più grande), Paul Schmidt (sul monitor più piccolo), Kate Valk. (photo © Mary Gearhart).
Il loro lavoro è proseguito idealmente con John Jesurun e The Builders Association (in particolare si ricorda Everything that rises must converge, 1990). L'interazione tra azione dell'attore e video è l'importante precondizione secondo Balme per lo sviluppo della performance digitale e internet. Balme ha mostrato alcuni frammenti dallo spettacolo di Robert Lepage The Seven Streams of the River Ota, primo progetto teatrale realizzato con la compagnia multidisciplinare Ex Machina in cui il regista canadese sviluppa una trama visiva fatta di silhouette, corpi e immagini video letteralmente incrostati insieme a formare un muto teatro d'ombre, metafora visiva della condizione di persistenza della memoria di Hiroshima nel mondo occidentale e orientale. Nella seconda parte, relativa al digitale, Balme ha parlato della prima performance via Internet, Hamnet (1993) degli Hamnet Players di Stuart Harris. Si tratta di una perfomance realizzata via chat attraverso il canale Internet Relay Chat (IRC) #hamnet. Sull'esperimento si veda online
il saggio di Brenda Danet.
Per il panorama europeo Izabella Pluta-Kiziak (Università di Silésie, Polonia) ha proposto l'intervento Entre l’Internet et la réalité postcommuniste con frammenti video dagli spettacoli della Komuna Otwock: Bez tytulu e Trzeba zabic pierwszego boga.
La ricercatrice ricorda come il fenomeno del teatro e nuove tecnologie assuma un aspetto particolare e decisamente differente in Europa dell'Est rispetto all'Ovest o all'America. L'attuale mutamento politico ne sarebbe un fattore determinante. Ci sono implicazioni economiche e forti legami con la tradizione teatrale che frenano una reale sperimentazione in questa direzione. La ricercatrice ha proposto:
- un quadro storico del cosiddetto Teatro alternativo dopo il 1989 e la direzione di ricerca del teatro polacco, a partire dall'interrogativo:"Peut-on vraiment introduire n.t. dans le théâtre polonais après Grotowski et Kantor?",
- un panorama delle manifestazioni, festival, centri di ricerca. Tra gli altri: il Festival Internazionale di Teatro Alternativo Réminiscences Théâtrales, Cracovia; Malta-Festival de Théâtre, Poznan; WRO Centre des arts des médias, Wroclaw (organizzatore della Biennale des Arts des Médias).
- la generazione dei registi «plus jeunes, plus talentueux» che utilizzano video in scena: Grzegorz Jarzyna con Psychosis 4.48, Anna Augustynowicz, Mloda smierc, Balladyna.

Desing: Gropius / Dlaczego nie bedzie rewolucji del gruppo teatrale polacco Komuna Otwock.
- il caso della Komuna Otwock, il giovane gruppo anarchico polacco di teatro alternativo, considerato la voce della nuova generazione: i suoi spettacoli hanno forma libera, tra la performance, il teatro e la danza e tratti di teatro politico; presenza in scena di schermi, proiezioni ed effetti stroboscopici.
Meike Wagner ricercatrice di Teatro all'Università di Monaco e alla Sorbonne Nouvelle di Parigi, ha presentato due progetti:
1. Alientje (2002) del gruppo olandese Wiersma & Smeets che lavorano con proiezioni, figurine di carta, oggetti ripresi da un semplice sistema audiovisivo. Si tratta di una proposta di teatro ragazzi.

2. Cyberpunch (2003) del gruppo teatrale di Thomas Vogel di Berlino. Si tratta di un progetto di "cyberstage" con personaggi virtuali in interazione con marionette e attori reali sulla scena. Il "cyberstage" di Thomas Vogel è un work in progress.


Per il panorama italiano ho proposto un excursus su tre ambiti storici:
1. l'eredità del Teatro-immagine: il panorama del teatro di ricerca italiano arricchito della presenza dei media in scena e l'eredità del Teatro-immagine degli anni Settanta.
2. Videoteatro italiano: dalla Postavanguardia alla Nuova Spettacolarità: Barberio Corsetti-Studio Azzurro.
3. Teatri90 e la "terza onda": la nuova generazione del teatro italiano.
E come casi-studio, Giacomo Verde dal Teleracconto a Storie mandaliche 2.0; e Motus, all'installazione al teatro (Twin rooms).
Motus, giovane ma già storica formazione teatrale riminese ex Generazione Novanta diretta da Daniela Nicolò e Enrico Casagrande. Il loro teatro attraversa da sempre i territori più svariati della visione: cinema, video, architettura, fotografia; una visio eclettica e poliedrica, irrispettosa delle specificità dei generi che opera in scena sul cut up di burroughsiana memoria, sul découpage, sulla tecnica del mixer e del montaggio. Nel progetto Rooms culminato con Twin rooms mettono in scena De Lillo e l'incubo della videosorveglianza. La città quale mosaico di microvisioni: un'enorme "digital room" contigua alla scena-dispositivo che rappresenta una camera d'albergo, ospita un ammasso incontrollato di immagini e una tentazione psicotica al loro consumo.
Giacomo Verde, mediattivista, computer artist e technoperformer. Ha costruito la sua estetica sull'ideologia del low tech, per socializzare saperi tecnologici; anche a teatro sostiene la causa della democraticità e della accessibilità del tecnologico e solleva la questione politica delle immagini televisive. Il teleracconto ovvero la ripresa in diretta di oggetti in macro contestualmente alla loro visione su monitor, ironica critica all'universo mediatico, da modalità teatrale (techno)narrativa per ragazzi è diventato un procedimento chiave del suo teatro: immagini create live ed effetti digitali costituiscono i fondali video che si modificano seguendo il corso della narrazione in OVMM ispirato alle Metamorfosi di Ovidio (insieme con il gruppo xear.org). E' un modo per affermare provocatoriamente che "La televisione non esiste" e che "Tutte le immagini sono astratte". Storie mandaliche 2.0 (2003) creato con Zonegemma e Xear.org è uno dei primi esempi di spettacolo interattivo applicato ad una drammaturgia ipertestuale (testi di Andrea Balzola).
Konic thtr Fondato da Rosa Sanchez e Alain Baumann rispettivamente coreografa-performer e musicista- artista multimediale. Creatori di dispositivi, interfacce e ambienti per progetti artistici interattivi, installattivi e performativi (danza, teatro, concerto) realizzati per "aumentare le possibilità espressive di attori e danzatori". A Parigi hanno presentato una dimostrazione-spettacolo dal titolo Tools in cui mostrano i molteplici dispositivi interattivi sviluppati per numerosi spettacoli dal 1990 ad oggi: sistemi elettronici per la creazione e la manipolazione in tempo reale del video, del suono e dell'immagine in 3D.
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
Dall'archivio di ateatro: La camera astratta di Giorgio Barberio Corsetti & Studio Azzurro
originariamente pubblicata su «il manifesto», 18 giugno 1987
di Oliviero Ponte di Pino
Reduce dal successo di «Dokumenta 8» è approdato a Milano il nuovo lavoro di Studio Azzurro e Giorgio Barberio Corsetti, La camera astratta. Due gruppi impegnati nella ricerca sui mezzi espressivi – il primo sul fronte del video, il secondo su quello del teatro – confrontano le loro esperienze, in un intreccio raffinato e innovativo che è insieme una riflessione sui media e un tentativo di rinnovare il linguaggio dello spettacolo.
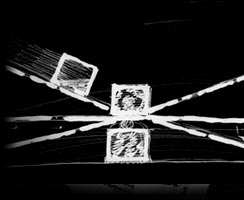
Studio Azzurro e Giorgio Barberio Corsetti proseguono così nella loro ricerca comune e parallela. Il gruppo di giovani videomaker milanesi continua il lavoro sull’habitat del video, considerato quindi come «televisore»: un oggetto di serie inserito nella quotidianità, e non un semplice schermo da riempire di immagini, di cui è necessario quindi verificare le possibilità d’azione trasferendolo su una scena teatrale.
Giorgio Barberio Corsetti e i suoi sei giovani attori (Philippe Barbut, Massimo Borriello, Anna Paola Bacalov, Benedetto Fanna, Irene Grazioli e Giovanna Nazzaro) hanno accolto nel loro spazio inventivo e animato questo elemento estraneo, inserendolo con naturalezza nel loro universo poetico e spettacolare.
La nuova tappa di una collaborazione che ha già al suo attivo Prologo a Diario segreto contraffatto e Correva come un lungo segno bianco porta l’ambivalente titolo La camera astratta.
Lo spunto narrativo è lo spaccato di un immaginario e labirintico ambiente mentale, durante una camminata all’aria aperta: un intreccio di immagini e visioni, proiezioni e fantasticherie. L’esile aneddoto offre, in pratica, soprattutto lo spunto per una raffinata esercitazione sul rapporto tra teatro e video, in cui non mancano punte di virtuosismo tecnologico, con effetti di sorprendente complessità. Il palcoscenico è continuamente attraversato dalle vitalistiche e ironiche presenze degli interpreti, e sfondato verso una palpabile quarta dimensione spaziotemporale dalle «finestre» di venticinque monitor.

Nell’epoca della riproducibilità tecnica del reale, La camera astratta porta in scena e verifica nella pratica proprio questa possibilità di duplicazione con i suoi paradossali effetti di pseudoverità. I monitor trasmettono infatti – grazie al coordinamento di un apposito computer collegato a videoregistratori e videocamere – sia le immagini riprese in tempo reale nel retropalco che quelle collezionate in precedenza in esterni, raddoppiando la scena teatrale in un evidente «effetto diretta». Ma la proiettano contemporaneamente nell’immaginario mantenendo l’astratta segmentazione imposta dall’inquadratura alla realtà. L’incontro tra video e teatro fa infatti contemporaneamente slittare l’effetto dell’uno e dell’altro: i monitor, accostati in segmenti e colonne, ricompongono l’immagine frammentata dell’inquadratura e rimandano oltre il limite del visibile; nello stesso istante, con la possibilità di muoversi e attraversare lo spazio, di mostrare immagini diverse (il volto di un attore, oggetti naturali come sassi, acqua, vapore, legna) i video acquisiscono insieme lo spessore di veri e propri personaggi, mentre la dimensione teatrale della compagnia di Giorgio Barberio Corsetti trova nuove prospettive: il corpo (sul cui libero gioco è basata la poetica del gruppo) perde la sua integrità, sezionato e scomposto dal video. Allo stesso modo, contagiato dal mezzo, il corpo finisce per venire risucchiato nella materia impalpabile e alonata di cui sono fatti i suoi simulacri elettronici.
Per ora la nuova dimensione proiettata dal video nella scena teatrale – o meglio fuori dalla scena teatrale, oltre la «quinta parete» del reale – resta soprattutto la base per costruire un inedito linguaggio, che amplia le possibilità dei due mezzi.

Per quanto riguarda La camera astratta, il tema dell’incomunicabilità, e quello della indefinibilità e indecibilità del reale e dell’immaginario, cari a Giorgio Barberio Corsetti, misurandosi con il video, trovano soprattutto una nuova formulazione: ma dai primi passi di questa interessante e godibile sperimentazione si intravvede la possibilità di un successivo approfondimento tematico e poetico.
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
Partiture
Michele Sambin: dalle video performance musicali al teatro carcere
di Anna Maria Monteverdi
Questo testo è stato redatto per il catalogo dell'edizione 2003 di Invideo, in occasione della personale che la rassegna milanese ha dedicato all'artista. (n.d.r.)
“Tutto ha inizio dal binomio immagine-suono. E un artista singolo che lavora su questi due elementi. Gli strumenti che usavo negli anni Settanta erano la pellicola, prima Super Otto poi 16 mm, perché lì immagine e suono erano inscindibili e interdipendenti, poi il video. Partire per questa utopica ricerca di costituzione di un linguaggio unico che comprendesse segni visivi e segni sonori”.
Così Michele Sambin racconta oggi del suo esordio artistico sotto il segno della pittura, del cinema, del videotape d'arte e di una performatività video e musicale, solitaria. Dopo un periodo di sperimentazione filmica testimoniato da Laguna, Blud’acqua, Tob&Lia (1968-1976), che lo colloca nel novero dei registi del cinema d’artista insieme ad autori come Andrea Granchi, Sylvano Bussotti, Gianfranco Baruchello, Ugo La Pietra, Sambin si dedica al “videotape creativo” (1974).

Guardando alle storiche soluzioni di “composizione globale” e ai pittori-cineasti della prima e seconda avanguardia (Léger, Richter, Fischinger, Ray, Moholy-Nagy), ai registi indipendenti e sperimentali (Warhol, Brakhage, Snow), ai concerti Fluxus, alle esperienze americane del Black Mountain College di Cage e c., ai dispositivi video di ambito concettuale (Graham, Campus, Nauman), alle opere-evento della performance art, Sambin mette in scena la tematica principale delle sue opere: il tempo.

“Quando uno cerca di mettere insieme la pittura con la musica subito scatta la dimensione temporale e su questo tema troviamo le prime esperienze del cinema sperimentale: Brakhage, Michel Snow e ancora prima il canadese Mac Laren, che disegnava il suono sulla pellicola. E’ un concetto importante per me, questo del tempo, offrire una visione che si sviluppi nel tempo. Io partivo come artista visivo, e il primo conflitto è quello che si crea tra visione - la pittura - che ha un tempo non determinato e la musica che vive solo nel tempo”.
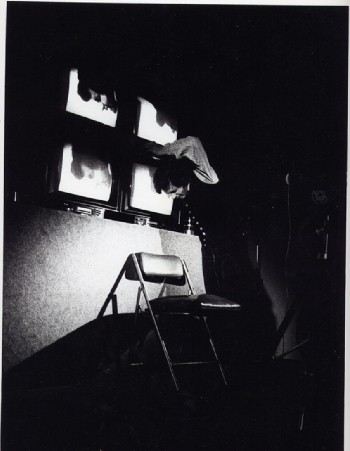
E’ all’interno dell’Università Internazionale dell’Arte di Venezia dove era stato chiamato a tenere dei laboratori di cinema e forme plastiche (1972-1975) che per Sambin avviene il passaggio dalla pellicola al videonastro, al nastro magnetico:
“Fu un momento di alta formazione, c’erano architetti come Buckminster Fuller (1) che davano un taglio trasversale alle categorie artistiche”.
E' incaricato di acquistare un’attrezzatura video e di condurre le prime sperimentazioni con il nuovo mezzo:
“Era un Akai, l’antesignana del primo Sony Portapack, e aveva ancora un nastro ¼’’. Ed è stato per me un’esplosione di creatività. Con il 16 mm tre minuti di girato erano molto costosi e lunghissimi i tempi di attesa tra il fare e il vedere. Cominciava ad essere interessante anche il problema del rapporto tra video e teatro perché nelle ultime situazioni cinematografiche non presentavo più solo pellicole per la proiezione ma sonorizzavo il film dal vivo; diventava fondamentale la relazione vivente, lavoravo con l’immagine in tempo reale. L’immagine diventava uno stimolo per creare suoni”.

Le prime esperienze di videorecording e di videoinstallazioni vanno in direzione di un naturale sviluppo performativo, tendendo sempre più ad esplodere oltre la cornice-schermo-galleria e a diventare puro evento, accadimento in tempo reale, e per il pubblico, “condizione di esperienza” (Duguet), un insediarsi direttamente all’interno del flusso “presente-continuo” delle immagini. In Ripercorrersi (1978, Prod. Centro video Palazzo dei Diamanti, Ferrara) protagonista è il pubblico che percorre uno stretto spazio che conduce a un luogo dove sono visibili su monitor, attraverso il sistema di video a loop e un gioco di ritardi di visione, rimandi ciclici del suo corpo. Dice Sambin:
"Le videoinstallazioni sono un elemento fondamentale del mio passaggio al teatro: il pubblico assiste a un processo che non è solo elettronico ma anche fisico”.
Sulla performatività implicita delle installazioni video Anne Marie Duguet osservava:
«L’installazione è realizzata per essere esplorata dal visitatore che, facendo ciò, non solo ne costruisce progressivamente la percezione, ma anche mette in gioco quella degli altri visitatori. L'esistenza stessa di certe opere (….) esige un'attività particolare da parte del visitatore per potersi manifestare pienamente. Questi esegue dunque una performance che diviene spettacolo per gli altri. Bisogna insistere sulla temporalità specifica di queste opere che sono innanzitutto dei processi, che esistono solamente nella durata della loro esperienza, nel qui e ora della loro attualizzazione. Esse appartengono ad un'arte della presentazione e non di rappresentazione.» (2)
Spartito per Violoncello è una performance musicale del 1974 in cui il videotape viene utilizzato come parte integrante della composizione. Anelli e chiodi gettati sul tavolo e il movimento stesso della telecamera che riprende gli oggetti sono tradotti in linguaggio sonoro; dietro l’evento, Cage e la musica indeterminata. La video-calligrafia come spartito verrà usata in molte performance musicali tra cui Looking for listening (1977, Prod. Asac-La Biennale di Venezia). L’evento è, evidentemente, irripetibile e non prevedibile.
“In Spartito per violoncello usavo la telecamera come strumento musicale dei tempi di visione: la scuotevo, la muovevo e questo determinava un input che l’esecutore - che ero io stesso - decodificava in termini musicali. C’era un po’ di Léger, un po’ Anemic cinema. Partivo dall’idea di usare il monitor come spartito.”
Esiste anche una videoregistrazione che documenta la performance; come per molte altre videocreazioni di Sambin, più che supporto per la memoria si tratta di un'ulteriore estensione-prolungamento temporale dell'opera stessa; l'operatore crea movimenti inattesi, zoomate che esplorano dentro il monitor: in questa condivisione paritetica della dimensione della “pura durata” di corpo e macchina, e in questo proliferare di processi attivati dalla musica e dal videotape, il performer diventa contestualmente al concerto, materiale per la ripresa. Il video è il primo risultato dell’incontro con Paolo Cardazzo della Galleria del Cavallino di Venezia, con il quale Sambin stabilirà una relazione duratura di stima reciproca. La Galleria nata nel 1972 inizia infatti, a documentare le performance ospitate nello spazio espositivo, anche sulla scia dell’imponente lavoro di registrazione di Luciano Giaccari a Varese, che nello stesso periodo stava teorizzando le diverse tipologie videodocumentative. (3)

Sambin sarà il primo artista a sperimentare a partire dal 1976, declinando in seguito l'operazione in moltissime varianti, il videoloop, il video a bobina aperta (open reel). E' un procedimento circolare generato dalla semplice unione delle estremità dei due nastri di registrazione e di lettura in cui l'immagine e il suono vengono ripetuti a ciclo. (4) L'artista registra ad intervalli, suoni e gesti; il nastro scorre, va alla bobina di lettura che rimanda l'immagine con un breve scarto al monitor; l'artista in carne ed ossa diventa a questo punto, l'interlocutore del suo “se stesso elettronico” con cui affronta un dialogo infinito. Prendendo a prestito termini cari al Marshall Mac Luhan de The Gutemberg Galaxy (1962) e Understanding Media (1964), il video diventa “protesi”, prolungamento di una sua funzione:
“Era una dimensione concettuale, più che di attenzione all'immagine perché il senso di questa operazione era quello di usare il video come possibilità di estensione espressiva di un corpo. Parlavo con me stesso, suonavo con me stesso, mi intervistavo, facevo cose che senza questi supporti non potevo fare. Il video come amplificazione, come protesi, è da intendere come strumento che non ferma un processo, ma che lo amplifica, lo moltiplica”. (5)
Nelle performance e nelle video installazioni realizzate con il videoloop - tra cui Duo, per un esecutore solo (1979); Anche le mani invecchiano (1980), Sax soprano (1980) - l'artista continua all’infinito a suonare, parlare e a (cor)rispondersi, vocalmente, musicalmente e visualmente. L'artista dà un'efficace spiegazione (e dimostrazione pratica) in Vtr and I (1978) in cui viene isolato e investigato questo specifico funzionamento autoriflettente del Video Tape Recorder. Si tratta di una vera esposizione autoanalitica del proprio lavoro d'artista, un'"operazione video-linguistica" perché il dispositivo video "è tematizzato e preso come oggetto di indagine”. (6) L'azione performativa è della macchina, prima ancora che del corpo: il gesto mimico-facciale e sonoro ripetuto ad intervalli davanti a una telecamera, attraverso un videorecording e un feedback causato dal posizionamento della telecamera davanti al televisore, innesca un meccanismo a catena. Il corpo incontra se stesso nello spazio del monitor e si mescola alle forme astratte autogeneratesi dal video, dando vita a un effetto di sovrimpressione delle immagini con il loop e ad una loro rinascita (e metamorfosi) ciclica. La riproducibilità è (ossimoricamente) generativa. Dall'unicità della perfomance alla performatività dei media di riproduzione.
Usando il tempo non nella sua sequenzialità-consequenzialità ma con continui détournement e sfasamenti, manipolandolo, ritoccandolo, invertendolo come fosse una materia concreta e quasi plasmabile, scindendo il suono dall'immagine corrispondente (come in Echoes, 1976, Autoritratto per 4 telecamere e 4 voci, 1977 e come nel progetto di video installazione per violoncello sospeso in moto perpetuo e apparecchiature audio e video From right to left, 1981) Sambin produce un decisivo e significativo spiazzamento percettivo rispetto all'esperienza dello spazio-tempo quotidiano. Questa dimensione articolata del tempo, soggettivizzata e personalizzata, sembra suggerire proprio il valore del tempo come conquista attiva e individuale:
“Di solito la familiarità con un mondo 'perfettamente doppiato' in cui ogni aspetto visivo è necessariamente collegato ad un aspetto sonoro (anche il silenzio è suono) non ci fa notare questa spontanea connessione, le cose così come stanno ci sembrano naturali. Spezzare questo legame significa ottenere dei modi di percepire meno consueti, in cui ad ogni fatto non corrisponde necessariamente ciò che di solito gli viene associato”. (7)

Il videoloop viene usato in seguito, per Il tempo consuma (1979), l'opera più tautologica e concettuale di Sambin. Un “metronomo umano” (il corpo dell’artista oscillante a intervalli regolari) è ripreso da un video e trasmesso ad un monitor. Il performer scandisce la frase: “Il tempo consuma le immagini, il tempo consuma i suoni” che genera, nel processo ciclico di registrazione-cancellazione-registrazione, una grande quantità di immagini di sé ed un effettivo deterioramento fisico del nastro e di conseguenza, del suono e dell’immagine incisi. Nata come opera video è diventata videoperformance e successivamente installazione per tre videoregistratori sincronizzati, commissionata per la manifestazione milanese Camere incantate curata da Vittorio Fagone (1980). ll passaggio dal video al teatro avviene con il Tam Teatromusica, fondato da Sambin a Padova all'inizio degli anni Ottanta insieme con Pierangela Allegro e Laurent Dupont, e in un primo momento i lavori teatrali vengono ancora presentati nelle Gallerie d'arte frequentate da Sambin come videoartista e come performer:
"Il mio passare al teatro è dovuto - grazie o purtroppo - alla Transavanguardia di Achille Bonito Oliva. In quegli anni c'era una grande esplosione di performatività, anni che ho vissuto come una gioia degli intrecci delle arti, di incontri con Laurie Anderson, Marina Abramovic, personaggi che hanno tracciato una linea di non pittura, di non scultura, lontani dal mercato. La Transavanguardia spezza queste utopie degli anni Settanta perché mettevano in crisi il sistema dell'arte (i video non si potevano vendere). Bonito Oliva riporta l'arte alla disciplina: pittura e scultura. E soprattutto la restituisce al mercato».
L’orientamento estetico ispirato al rapporto immagine-suono per le videoinstallazioni e le performance e l’esperienza di musicista elettronico di Sambin si riveleranno fondamentali nella definizione della nuova composizione scenica degli anni Ottanta che, non rinunciando alla musicalità e alle tecnologie audiovisive, privilegia ideologicamente come già nelle performance degli anni Settanta, “il tempo reale e la condivisione di procedimento, l’arte dal vivo e il rapporto diretto con lo spettatore”. Il primo spettacolo del Tam si intitola Armoniche (1980); all’immagine e al suono si unisce il gesto, in un rapporto reciproco “fluido”, “armonico”. Anche Opmet (1982) prevede l'uso di video in scena che trasformano le azioni dei performer “dentro e fuori dal Cronos o tempo universale” mentre in Lupus et agnus (1988) è lo spettatore a scegliere se assistere allo spettacolo attraverso i monitor oppure attraverso un percorso frammentato tra le azioni degli artisti nei diversi spazi. Il progetto di teatro-carcere apre una delle più fortunate stagioni del Tam Teatromusica che si conquista sul campo una propria riconoscibilità e autoralità. MeditAzioni è il progetto biennale che ha permesso di realizzare laboratori coi detenuti, spettacoli teatrali, un libro-diario della Allegro e l'opera video Tutto quello che rimane insieme con Giacomo Verde. Se il video prima era estensione del corpo dell'artista, qui diventa abbattimento virtuale di una separazione:
“In carcere il video diventa fondamentale. Lo avevo abbandonato perché pensavo 'Parla solo con se stesso, non mi interessa più'. Quando i detenuti non potevano uscire perché il magistrato non gli aveva dato il permesso, lo spettacolo era stato già programmato e la gente li aspettava fuori, ho preso una telecamera e ho chiesto loro: 'Dite alla telecamera quello che direste se ci fosse il pubblico'".
Il video diventa quindi strumento di vitale importanza per il teatro che, nell’impossibilità di una “diretta” qui e ora, è costretto a darsi ai propri interlocutori esterni, in “differita” e a distanza. E' alla qualità di riproducibilità del video che è affidato il compito di trasmettere quel messaggio teatrale oltre il teatro secondo il Tam: “Attraverso l’arte," scrive Pierangela Allegro, "la nostra religione, si può arrivare al cuore degli uomini e attraverso la condivisione (che non vuol dire tolleranza) si possono creare crepe insanabili nel muro dell’indifferenza”.
Nel testo l'autrice ha inserito un'intervista inedita a Michele Sambin realizzata tra Volterra e Castiglioncello nell'agosto 2003, in occasione della presentazione al Festival Volterrateatro della performance musicale Più della vita. Sullo spettacolo vedi la recensione di A.M.Monteverdi su ateatro 56.
NOTE
1 "Buckminster Fuller: scienziato, architetto, disegnatore, inventore della cupola geodesica. Le sue teorie tendono a modificare la tecnologia per migliorare le condizioni sociali. Molto seguito dai giovani nordamericani e dai pionieri della televisione alternativa”, da R. Faenza, Senza chiedere il permesso. Come rivoluzionare l’informazione, Milano, Feltrinelli, 1973. Rimando al libro di Faenza anche per le caratteristiche tecniche relative ai primi VTR.
2 Anne-Marie Duguet, Installazioni video e interattive. Definizioni e condizioni di esistenza, in Visibilità zero, a cura di V. Valentini, Graffiti, 1997, p.14. Sui dispositivi installattivi video vedi S.Cargioli, Sensi che vedono. Introduzione all'arte della videoinstallazione, Pisa, Nistri-Lischi, 2002.
3 Sulla Galleria del Cavallino vedi B. Di Marino, Elettroshock, 30 anni di video in Italia, a cura di B. Di Marino e L. Nicoli, Roma, Castelvecchi, 2001. Nel 1972 Giaccari scriveva la Classificazione dei metodi di impiego del videotape in arte, introducendo per la prima volta la distinzione tra “ video diretto” (caldo, creativo) e “video mediato” (freddo, documentativo). Sulla classificazione: L. Giaccari, Dalle origini della videodocumentazione al museo elettronico in Elettroshock, cit., pp. 37-40.
4 Con il videoloop Sambin non intende tanto la mise en abîme del feedback visivo quanto la bande sans fin. Il nastro di registrazione video immagazzina immagini che passano al nastro di lettura con un intervallo di tempo pari alla lunghezza dello scorrimento elicoidale tra le due bobine. Il procedimento artistico rientrerebbe sia in quella categoria definita da Mario Costa dei “videoriporti”, in cui l’artista “opera per o con il video” che in quella della “videoperformance”, in cui il dispositivo video “entra a far parte, come uno specifico insostituibile, di un’azione-operazione”. (M.Costa, L'estetica dei media. Avanguardia e tecnologia, Milano, Castelvecchi, 1999, p.254-255).
5 Sambin fa riferimento sia a Io mi chiamo Michele e tu?, che alla Autointervista inserite nella video installazione Il tempo consuma per Camere incantate (Milano, 1980).
6 M.Costa, L'estetica dei media, cit.,p.255.
7 M. Sambin, Testo inedito datato 17-9-1977.Sul significato politico e sociale del tempo nel video ha riflettuto il filosofo Lazzarato, passando attraverso Marx, Bergson e Paik: «Le tecnologie del tempo ci liberano dalla percezione naturale, dalle sue illusioni e dal suo antropocentrismo e ci fanno entrare in un’altra temporalità. Esse aboliscono la subordinazione del tempo al movimento e, di conseguenza, ci permettono un’esperienza diretta del tempo(...). L'istante è in questo caso, un divenire che, invece di essere incastrato tra passato e futuro, diventa germinativo, produttore di altre coordinate ontologiche» (M. Lazzarato, Videofilosofia. La percezione del tempo nel postfordismo, Roma, manifestolibri, 1996, pp.109-110).
Il monaco guerriero del teatro italiano
Sul teatro di Danio Manfredini
di Oliviero Ponte di Pino
E' in uscita Piuma di piombo. Il teatro di Danio Manfredini di Lucia Manghi (il principe costante, Milano, 2003, 160 pagine, 12,50 euro & lo potete comprare anche online).
In anteprima per
Danio Manfredini è il monaco guerriero del teatro italiano. Per lui il lavoro dell’attore è un duro esercizio di autodisciplina e un percorso di conoscenza. Una tecnica e un’etica. Richiede una dedizione assoluta e impone difficoltà e sofferenze, perché obbliga a scandagliare le parti più oscure di noi stessi. «Il teatro è un’arte dura», confida con la voce appena velata dalla stanchezza. «Attraversi dei tuguri neri, in cui il corpo ti pesa, e non ti muovi più». Il contatto, lo scontro con il pubblico non consentono compromessi: appena la tensione cala, il lavoro dell’attore diventa insensato, sciatto. Prostituzione.
Eppure, come tutti gli autentici credenti, Danio dubita. Dubita del teatro, dove troppo spesso si svuota la forza del rito. Dubita di sé stesso, dei propri mezzi e qualità, o della propria costanza e dedizione, e cade nello sconforto, si chiude in se stesso – nella rabbia o nell’apatia. Finché il demone non lo assale di nuovo, e gli restituisce la forza per attraversare la propria ombra.
Persino nel variegato e sfrangiato universo della nuova scena italiana, Danio Manfredini rappresenta un caso a sé, un’eccezione che è difficile inquadrare in qualche regola. Solitario e schivo, nell’arco di vent’anni ha costruito con ascetico rigore una mezza dozzina di preziosi spettacoli, per lo più assoli, replicati di rado, soprattutto per la sua ombrosa ritrosia e il suo tormentato rapporto con il teatro.
Al tempo stesso, molti colleghi lo considerano un maestro. Per la sua coerenza, per il suo rifiuto di fare facili concessioni, per la fedeltà ai suoi principi. Ma anche perché, attraverso numerosi seminari e workshop, ha disseminato un metodo e una pratica di lavoro che hanno segnato ormai alcune generazioni di teatranti. E’ diventato quasi imbarazzante vedere nei curricula di troppi giovani attori una dicitura pressoché obbligatoria: «Ha partecipato a un seminario di Danio Manfredini». Infatti lui si irrita, e vorrebbe che non lo citassero. Tuttavia la sua traccia resta: anche perché insegna che l’attore non è solo un esecutore, un replicante programmato, una marionetta (o una supermarionetta, anche se deve averne tutte le qualità tecniche). La sua pedagogia dimostra che quello strano essere è prima di tutto un creatore, e che la sua creatività affonda le proprie radici nella consapevolezza di sé.
La sua vocazione era la pittura. Così quando il proprio lavoro o il teatro lo deludono, quando la tensione tra l’intenzione e il risultato, tra il gesto e l’opera non lo soddisfano, e naturalmente quando si tratta di immaginare un nuovo spettacolo scena dopo scena, torna a dipingere. Acquerelli e chine con figure precise e fragili, che spesso emergono da sfondi stesi con le varianti più tenui di colori primari: un azzurro che tende al grigio, il rosa e l’arancio...
Ma per raccontare la storia, bisogna fare un passo indietro, in una serata milanese molto qualunque. A casa di questo giovane aspirante pittore che non frequenta il teatro si presenta all’improvviso César Brie, un attore argentino esule in Europa, come tutti i suoi compagni della Comuna Baires. E’ un caso o un destino, ma Danio è incuriosito. Segue un suo seminario e inizia a lavorare anche con la compagna di César, Iben Nagel Rasmussen, una delle anime dell’Odin Teatret diretto da Eugenio Barba, e viene iniziato alle pratiche del training. Alla base c’è un intenso addestramento fisico e vocale, una tecnica che permette di trasformare corpo e voce in uno strumento, ma anche di saggiare le sue possibilità e i suoi limiti.
Per certi aspetti non siamo molto lontani dalla pittura e dalla musica: non ci sono parole, solo movimenti e suoni. Il training ruota intorno al gesto prima come espressione di una interiorità e poi come segno e dunque comunicazione. Anche qui – come di fronte alla tela – si tratterà poi di fissare questi gesti e di inserirli in una composizione. Solo che la tela non c’è: bisogna di lavorare su di sé, sul proprio corpo – non su un oggetto esterno. E bisogna lavorarci nel tempo e nello spazio, davanti a un pubblico con cui costruire ogni volta un rapporto di complicità e tensione – senza mai chiudere il gesto creativo in un’opera che resterà per sempre uguale a se stessa, ma ridandogli vita ogni volta, in ogni momento, con la stessa tensione, la stessa verità.
«Il punto di partenza per me è stata la pittura. Forse è meglio parlare di "visioni interne": tutti i miei lavori erano accompagnati da film interiori, come se per sostenere le situazioni sceniche mi fosse necessario lavorare sulla vivificazione di una serie di impulsi interni che possono dare ritmo, forza o comunque scansione del tempo nell’azione. La differenza è che nella pittura il processo avviene in solitudine e quindi lo spettatore si trova davanti la traccia di un processo; di lì lo spettatore risale a una serie di spinte, agli impulsi motori che hanno spinto il pittore a generare quell’immagine. In teatro invece questo percorso tenti di ricrearlo anche davanti al pubblico. Questa è la grande difficoltà: far sì che l’evento possa succedere in una maniera interessante.»
Danio e César iniziano a frequentare i centri sociali milanesi, soprattutto quello dell’Isola, dietro la stazione Garibaldi. E’ un quartiere popolare, all’epoca teatro di lotte per la casa, per la scuola, per il lavoro. E il teatro è anche, in quegli anni, attività nel sociale e militanza politica. Dopo lo sgombero dell’Isola, Danio continuerà a trovare accoglienza in altri centri sociali milanesi: prima al Leoncavallo, il più grande, noto e combattivo, dove però vive una incessante frizione tra le istanze politiche degli ospiti, che tendono a subordinare l’evento estetico alle esigenze della militanza, e la sua autonoma ricerca artistica. Poi, in maggior sintonia con la sua visione, alla fine degli anni Ottanta si trasferisce in un altro spazio milanese, l’Usi di viale Bligny, dove trova uno spazio in cui può provare in tranquillità.
Paradossalmente, in un’epoca e in luoghi dove il collettivo e il gruppo sono l’orizzonte di riferimento, mentre la colonna sonora sono gli slogan gridati in corteo e i concerti, Danio sceglie un itinerario quasi clandestino e individuale. Il suo segreto sono le lunghe prove solitarie, le mille improvvisazioni buttate via, le sequenze di gesti inanellate e poi smontate, sezionate e ricomposte. Un’attività quotidiana che prosegue per anni e anni, maniacalmente, asceticamente, alla ricerca della maestria tecnica e della conoscenza di sé – che sbocciano e trovano un momento di verità quando ci si incontra con il proprio limite fisico e psichico, oltre il confine della resistenza e della fatica.
In parallelo un’altra esperienza segna il suo percorso esistenziale: lavora a lungo come operatore presso Casa Nuova, una comunità che si occupa di malati psichici. Per anni, prima di essere sostituita dal teatro (in realtà più dai seminari che dagli spettacoli, che restano un lusso, un investimento anti-economico), questa attività sarà la sua principale fonte di reddito. La professione implica una lunga consuetudine con il mondo della follia e dell’emarginazione. Per Danio, per la sua sensibilità sottile ed esasperata, i matti non sono molto diversi da noi. Sono solo persone che vivono e sentono con troppa intensità sensazioni ed emozioni, e per questo sono insieme fragili ed eccessive, inquiete e instabili. Ai suoi occhi la follia, sembra di intuire, è una ferita che ci portiamo tutti dentro, ma che le regole e le convenzioni sociali riescono a occultare, a sedare, a consolare, un dolore che gli affetti possono farci dimenticare. Proprio su queste ferite non ancora rimarginate, su questa solitudine, sullo scontro tra il desiderio e i rapporti di potere, sui conflitti che attraversano insieme la nostra interiorità e le relazioni con gli altri, si fonda il suo lavoro. Il teatro, per certi aspetti, diventa un lungo viaggio nella diversità – in una diversità non riconciliata. O meglio, il teatro porta alla scoperta delle diversità di cui ciascuno di noi è portatore.
«Anch’io appartengo a una categoria sociale considerata diversa dentro la società, e quindi non posso ignorare questo fatto. E’ difficile staccarsi da te stesso, dagli argomenti che ti toccano. Ci sono queste categorie "diverse" ma poi ognuno, anche gli "uguali", hanno delle esperienze della diversità sociale. Forse per me c’era anche il bisogno di scoprire, dietro a tanti svantaggi, qualche vantaggio: cogliere comunque una qualità assolutamente pazza della vita, che la tua diversità spesso ti porta a scoprire. E far in modo che questa condizione un po’ pazza di esistenza, di incontri, di status, di modo di vivere gli incontri o la sessualità, non diventi solamente un segno di disperazione ma dia anche un senso di qualità della vita, o possa far nascere una poetica cruda, o comunque non una cosa da cancellare ma qualcosa che comunque ti permetta di fare un’esperienza che altri magari non fanno. Inoltre nella mia vita ho conosciuto delle persone che devono vivere nella società come diversi e che mi hanno molto colpito: perché questa possibilità di poter esistere è una lotta; e può anche essere interessante vedere come una persona cerchi di trovarsi uno spazio vivibile e una forma per vivere, anche se non è considerato uguale agli altri».
Questa dimensione personale, che affonda le radici nel vissuto, trova ben presto una serie di punti di riferimento artistici che resteranno costanti. In primo luogo, per quanto riguarda la visione del mondo, Jean Genet, Pier Paolo Pasolini e Rainer Werner Fassbinder, profeti della diversità e di una irriducibile tensione alla trasgressione. Poi la violenza del segno pittorico, le torsioni e gli oltraggi del corpo dei quadri di Francis Bacon. E, sul versante teatrale, l’immaginario poetico e visuale di Tadeusz Kantor e il training gestuale e i metodi di composizione drammaturgica che arrivano dall’Odin Teatret.
Il suo primo assolo, La crociata dei bambini, ispirato a una poesia di Bertolt Brecht, lo prova e lo rappresenta nella prima metà degli anni Ottanta all’interno del Centro Sociale Leoncavallo. Come negli spettacoli successivi, è impossibile fissare la data di debutto ufficiale: ci sono varie fasi di studio, private e pubbliche, versioni diverse dove le opere cambiano forma e struttura, fino ad arrivare a un punto fermo che può essere solo provvisorio. Nella Crociata dei bambini questo processo dura alcuni anni. Si tratta di mettere a punto un metodo di lavoro, di inventare una lingua teatrale e di offrirla al pubblico.
Lo spettacolo è breve e dichiaratamente povero – tre riflettori, un fondale grossolanamente dipinto a cielo, un solo interprete. Rivela una intensa efficacia e sorprende per la maturità del lavoro, sia nella precisione dei dettagli sia nella composizione. Con l’aiuto di un paio di pupazzi, di un elefantino a rotelle nel ruolo del cane, grazie all’uso preciso di pochi oggetti (una sciarpa rossa, una corda tesa a mezz’aria, un bastone, un siparietto bianco), Manfredini anima i vari personaggi di un testo pieno di pathos, dando corpo a un gruppo di bambini in fuga di fronte all’incalzare della guerra: si allontanano da una società dilaniata dalla violenza e cominciano a vagare seguendo i loro sentieri privati, in un ultimo e disperato sogno di libertà e di pace.
Le tecniche usate sono molteplici: molte richiamano l’area del Terzo Teatro anche nel riferimento folklorico ed etnologico, e non sarebbe difficile trovare altre ascendenze e precedenti. Tutti assimilati e ripresi con misura in un intreccio di immagini che si imprimono nella memoria: magari un piattino tenuto tra i denti o, nel finale, un pupazzetto che ruota all’infinito vorticosamente, appeso a un filo. Quello che maggiormente colpisce è la chiarezza con cui in scena convivono due linee opposte, radicalizzate e in apparenza inconciliabili: da una parte un’espressività immediata, quasi fastidiosamente viscerale, che sembra voler fare a meno di ogni mediazione intellettuale per esprimere la molteplicità di risposte istintuali che trascendono l’unità dell’individuo; dall’altra la ricerca di un linguaggio del corpo e del movimento, stilizzato e preciso come quello dei teatri orientali, un alfabeto di gesti di cui abbiamo forse perso il significato preciso.
Come se, cancellato il centro offerto dai punti di riferimento ideologici e corporei – quelli coscienti e quelli inavvertiti – non restasse che l’accentuarsi di due tendenze latenti, che spingono il lavoro sul versante della danza: quella dell’informalità dell’urlo, del puro impulso immediato e irriflesso; e quella verso l’astrattezza di un codice che tende a chiudersi su se stesso nella sua formale e inattaccabile purezza. Due tensioni che spingono, al limite, verso l’incomunicabilità: quella di un Io originario che ancora non riesce a trovare una sua unità e una sua mediazione interpersonale; e quella di un linguaggio senza più punti di riferimento, e per questo assolutamente trasparente.
E’ nelle oscillazioni tra questi due poli che La crociata dei bambini offre un’inedita versione dello straniamento brechtiano: se a tratti il risultato è volutamente frammentario, questa è la strada che porta alla costruzione di uno stile. Non vissuto come maniera, come formula rigida, ma come confronto tra due tensioni che si riflettono una nell’altra.
Anche il successivo assolo, Miracolo della Rosa, ha per protagonisti dei giovani isolati dalla società e dalla famiglia. Sono gli adolescenti del riformatorio di Mettray, il luogo terribile e splendido che ospitò il giovane Jean Genet, lo sfondo mitico di molti suoi romanzi. Nel testo s’intrecciano anche gli ultimi quarantacinque giorni di Harcamone, condannato a morte nella vicina prigione di Fontevrault (un’antica abbazia), che Genet – in una assoluta inversione tra bene e male – dipinge come un santo, incarnazione del male e della bellezza. L’inversione non riguarda solo la sfera etica e quella estetica, si riflette anche nel linguaggio: fin da un titolo che riecheggia le allegorie medievali, lo stile tradisce la fortissima tensione lirica e metaforica.
Filtrati da Genet, si esplicitano e precisano alcuni temi. Il teatro di Manfredini, del resto, può essere letto anche come una ossessiva «riflessione pratica» sull’opera dello scrittore francese. Danio non mette in scena i suoi testi teatrali (non è interessato alla regia, il suo è un teatro dell’attore-autore), piuttosto rivive nella propria carne le visioni di Genet, il rapporto con la diversità e la trasgressione, l’ansia lirica e metaforica, l’omosessualità, la pulsione di morte e il disperato bisogno d’affetto, la follia e la solitudine, la violenza e la tenerezza. Una ribellione che non prende le forme della politica ma quelle del desiderio.
Tuttavia c’è uno snodo che non si può trascurare. In un lavoro certo personale, quasi intimo, i primi assoli non sono mai autobiografici: preferiscono dare voce a una folla di personaggi e presenze, incarnare una alterità, che recupera magari brandelli di comportamenti osservati e memorizzati, gesti, frasi e inflessioni rubate alla vita. Resta sempre – e qui l’esordio brechtiano è rivelatore – uno scarto, la possibilità di una distanza tra l’attore e i personaggi che di volta in volta lo possiedono. Questa distanza può farsi talmente sottile da rivelarsi impercettibile – e tuttavia resta fondamentale sia per la creazione dei suoi lavori sia per determinare la sua parabola creativa.
Manfredini non si dedica solo agli one man show. Periodicamente lavora a spettacoli collettivi, che riflettono le sue ossessioni e il suo metodo di lavoro. In questa direzione l’esperienza più significativa e ambiziosa è, nella prima fase del suo percorso, La vergogna. Fonti principali sono Genet – ancora una volta – e Pasolini. Tema centrale, una trasgressione radicata da un lato nel mondo individuale dell’illuminazione e della ribellione poetiche; dall’altro in quello dell’insopprimibile senso di libertà dell’adolescenza, e nella linfa assorbita dal «popolare», nel senso più autentico del termine: un tessuto di vissuto ed esperienze in cui orientare i propri sentimenti e le proprie azioni.
L’ambientazione – il pavimento ricoperto di plastica trasparente, lo spazio circondato da precarie transenne di legno grezzo da cantiere edile – rimanda a una precarietà insieme reale e simbolica. Siamo al limite tra la città e la campagna, tra il costruito e l’incolto: i terreni devastati oltre l’ultima periferia, i palazzi incompiuti, abbandonati e già in rovina, le ultime ore della notte, gli amori febbrili e inquieti di chi elemosina o regala l’ultima briciola di sé.
Questa terra di nessuno non è ancora limite e confine: ma piuttosto margine, spazio di assenze e di vuoti, una smagliatura della realtà in cui può sopravvivere il diverso, il deviante, il nuovo, il luogo in cui le esperienze sfuggono a ogni definizione e gli affetti scivolano continuamente da un oggetto all’altro: intrappolati nella tenaglia di amore e di morte, sospesi tra la brama di un possesso totale e l’angoscia di un continuo abbandono. I tre interpreti hanno scelto per questa loro desolata parabola tre personaggi votati irrimediabilmente alla sconfitta e al fallimento. Ernestine, folle solitaria, ninfomane e stracciona, ma anche per paradosso beffarda e lirica incarnazione dello slancio rivoluzionario (impersonato con efficace rigore da Luisella Del Mar); Bruno, ragazzo di vita e di borgata di pasoliniana memoria (Paola Manfredi); e infine un immaginario Genet, cui presta la sua presenza Danio Manfredini: disperatamente cosciente dei suoi slanci e della sua spinta autodistruttiva, dello scarto irrimediabile tra la sua sensibilità e il mondo che lo circonda, intorbidito dai suoi intricati impulsi amorosi.
Il lavoro (che sconta qualche sfilacciatura, e in particolare un eccesso di movimenti non sempre indispensabili) ha il tono di una dissacrante liturgia: squarci di cerimoniali semplici ma misteriosi, lampi di immediatezza realistica, parentesi liriche, frammenti di un erotismo che è sempre – imprevedibilmente, di fronte alla violenza del mondo – estrema tenerezza, e forse per questo risulta ancor più atroce.
Nell’intreccio dispersivo e gratuito di queste tre sensibilità, costrette via via a rinchiudersi nel loro mondo segreto, si disegna una trama di incontri forse vaghi e inutili, ma che trasmettono istanti di fragile felicità e commoventi perturbazioni dell’animo, la nostalgia di una autenticità e di una libertà perdute, l’impossibile aspirazione all’accettazione di sé e della oscura diversità di ciascuno.
Il limite del lavoro è tuttavia proprio questo: i tre personaggi alla fine non si parlano, ciascuno rimane chiuso nel proprio orizzonte. Il percorso individuale di autoconsapevolezza di Danio Manfredini si specchia, per così dire, in altre declinazioni ed esemplificazioni, ma continua a restare un viaggio solitario che può solo sfiorare altre solitudini.
Nel successivo Tre studi per una crocifissione, un altro assolo, ci sono ancora tre percorsi individuali, ma tutti vissuti in prima persona. Manfredini racconta, per brevi monologhi, altrettante storie di diversità, emarginazione e sconfitta. La prima è una follia ironica e svagata, una sofferenza profonda ma vissuta con beffarda leggerezza, con una incoscienza che appare l’unica possibile difesa (ed è questo forse il brano più frammentario e sfaccettato, ma insieme più ricco di sfumature e più evoluto nella costruzione del personaggio). La seconda storia (almeno nelle prime uscite pubbliche del lavoro, in seguito l’ordine tra il secondo e il terzo pezzo sarà invertito), introdotta da una sorta di leggero tip tap al suono di Bach, riprende brani del monologo di Bernard-Marie Koltès La notte poco prima della foresta: è l’appassionata, struggente e tragica richiesta di aiuto di un immigrato, una toccante dichiarazione d’odio e d’amore per il mondo, che propone tra l’altro l’istituzione di un «sindacato internazionale per la difesa dei ragazzi non troppo forti». Infine, una sintesi di Un anno con tredici lune di Fassbinder, il fallimento della patetica storia d’amore di un travestito, traccia di una passione senza futuro, desolata e lucida.
Sono tre storie di sconfitta, come se solo indossando la maschera della sconfitta – rifutandosi alla sicurezza e all’arroganza dei vincitori – fosse possibile rintracciare ancora qualche brandello di umanità. Sono tracce di una umanità che può scoprire se stessa solo nella differenza, nella distanza, nell’impossibilità di un incontro reale. E che solo quando la ferita è aperta, solo quando la sofferenza è accesa, può dispiegare la gamma dei suoi colori, ora livida ora giocosa ora malinconica ora disperata.
Il trittico è dedicato, fin dal titolo, a Francis Bacon, al quale rimanda un certo uso del corpo e del movimento; ma siamo però lontani dall’isolamento assoluto, dalla straziante disperazione, dalla primordialità e dalla rabbia dell’urlo che esplode nelle opere del pittore inglese. Perché i personaggi riuniti in Tre studi per una crocifissione ribaltano immediatamente la loro solitudine in una urgente richiesta d’affetto e di contatto. Quel che c’è di metafisico nell’angoscia di Bacon (e che permette l’oggettivazione del gesto sulla tela), si risolve qui piuttosto nel sentimento, nella speranza d’una carezza, forse il deliro di una passione. Tanto è vero che i monologhi che compongono questi Tre studi sono in realtà dei dialoghi in cui il pubblico assume la parte del necessario interlocutore: prima confidente su cui riversare la propria con forzata disinvoltura il proprio disagio, e per il quale costruirsi una maschera di timidezze e esibizionismi, furbizie e ingenuità; poi destinatario d’un disperato appello, d’una richiesta di solidarietà e complicità; e infine, oggetto d’amore perduto, in un rapporto che stravolge e distrugge corpi e sessi, emotività e desideri. Sono passioni che il destino proietta verso la frustrazione e la prostrazione, e tuttavia possono rivelarsi esplosive: nella violenza, nella radicalità, nella capacità di sprigionare poesia.
Il successivo Al presente segna una ulteriore e importante evoluzione. Per la prima volta, in alcuni momenti la dimensione autobiografica emerge nella sua immediatezza, senza il filtro di altri autori o opere, senza la maschera di altri personaggi o figure. A sottolineare e al tempo stesso filtrare questo scarto di consapevolezza, nell’intero spettacolo accanto all’attore-protagonista c’è un manichino che ne riproduce le fattezze.
«In scena ci sono io, e un manichino che ho scolpito, uguale a me. Un doppio artaudiano. Avevo voglia di scappare, sentivo che in scena agivo moltissimo, mentre il mio punto di partenza era: "Io non ho niente da dire, niente da fare". Ma il teatro non è come il cinema, dove il silenzio è bellissimo, perché l’attore è figura su uno sfondo di paesaggio, in un contesto, e allora può anche tacere perché arriva tutto. Nel teatro la comunicazione è nell’attore, e se l’attore non agisce non arriva niente. È stata una lotta terribile. Mi dicevo: "Ma ho quarant’anni, perché faccio tutto quel casino? Devo cercare di avere un po’ di peso". Così ho avvertito la necessità di avere questo contrappeso fermo sulla scena. Questa presenza mi ha liberato, in modo da potermi muovere come quella parte di noi che continuamente viaggia, senza riuscire mai a soffermarsi. E poi resta quella parte lontana, dimenticata, che non dice niente, che non ha niente da dire, che ascolta, per la quale tutto è possibile, tutto cambia, niente è fisso, e che quindi non se la prende.
Paradossalmente io non gioco mai me stesso. Il "me stesso" è il manichino, mentre io gioco tutti quelli che mi girano intorno. Perché l’immagine della mia esistenza mi viene data da quello che io vedo: infatti, come tutti noi, io non vedo mai me stesso, se non ogni tanto allo specchio. Quello che io sento della vita è quello che gli altri mi fanno vedere. In questa rappresentazione, in Al presente, io agisco sempre gli altri.»
Come in tutti i suoi assoli, lo spettatore viene colpito e conquistato da un grumo di umiltà e orgoglio, di vulnerabilità e fierezza che traspare da ogni suo gesto. Orgoglio, perché si capisce che ogni gesto è assolutamente necessario, lì, in quel momento, e fa parte dell’integrità del suo lavoro, e che lui è pronto a difenderlo con tutte le sue forze. Umiltà, perché per distillare quel gesto è stato necessario un lavoro lungo, duro, difficile. Non è mai semplicemente un problema di tecnica (e la padronanza che ha del proprio corpo va oltre il virtuosismo), ma prima ancora una radicale messa in questione delle proprie certezze, in ogni istante. Vulnerabilità, anche perché la bellezza e la necessità di quel gesto sono un frutto fragile, e basterebbe un nulla per distruggerlo, per renderlo inutile. Fierezza, perché in questa vulnerabilità risiede l’unicità di ogni esistenza, il suo valore più prezioso.
Ma che cos’è l’esistenza per Danio Manfredini? È innanzitutto un dolore innominabile, una lacerazione originaria, una ferita che tende a cicatrizzarsi e irrigidirsi nel corpo che la ospita. Irrigidimento è tanto la normalità e le sue nevrosi (comprese le coazioni della danza), che sono solo una forma di anestesia. Lo è anche la follia, che pare cristallizzare quella ferita originaria nella ripetizione, nell’ossessiva e totale attenzione. E però nella follia (come nell’amore e nei suoi rituali, così spesso disperati) quella ferita è ancora possibile vederla e forse riaprirla. Ecco, Al presente è il continuo e ostinato tentativo di riaprire quella cicatrice e di mantenerla aperta, di vederla pulsare sospesi tra la fascinazione della morte e l’energia vitale.
C’è il terrore che nasce dalla sofferenza, e ce n’è uno forse più inquietante: quello che viene da una meccanicità di azioni, da una rigidità di sentimenti troppo simile alla morte. Con un atteggiamento insieme di repulsione e struggimento, di disgusto e pietà, Danio esorcizza quel terrore: perché quella ferita è una forza vitale, è ciò che dà a ognuno di noi la propria individualità e personalità. E’ anche la debolezza, la vecchiaia, la malattia, la demenza.
Al presente insegue il flusso infinito e lancinante di quelle ferite e di quella demenza, quasi a voler riscattare ogni minima briciola di dolore: una molteplicità infinita, che uno spettacolo non potrà mai esaurire. Danio pare impegnato nel compito impossibile di riscattarla tutta, di redimerla nella poesia. Trovando però due misure: la propria esperienza personale, magari ironicamente filtrata dalle ballate rock di Vasco Rossi, e la traccia di alcuni testi con cui misurarsi (Lo straniero di Camus, il Woyzeck di Büchner e Nostra Signora dei Fiori di Genet ma anche il Credo cattolico), passando magari per le ballate rock di Vasco Rossi.
È difficile catalogare questo teatro: è danza ma è anche pittura, è scavo su se stesso ma è anche maestria drammaturgica nel montaggio. È forma cristallizzata e interiorità incandescente. È riflessione sull’essenza dell’attore e schegge di vita, il rapporto tra l’esperienza e la forma, l’intimità e la comunicazione.
Cinema Cielo, finora il lavoro più complesso e ricco, segna una decisa maturazione artistica e si impone immediatamente come spettacolo di straordinaria potenza e fascino. Perché tutti i temi che venivano declinati individualmente, in soggettiva, rivissuti dall’attore-sciamano che li impersonava, vengono filtrati dal ricordo e per così dire oggettivati ed epicizzati attraverso una intera galleria di personaggi, fino a formare un universo imprevedibile e variegato.
Cinema Cielo è il frutto del desiderio di trarre un film da Nostra Signora dei Fiori di Genet. A un certo punto, mentre lavora con due attori, Patrizia e Giuseppe, Danio si accorge che quel progetto non si realizzerà mai. Quando Mario Martone, in una serie per Radiotre, gli chiede di presentare un suo «sogno nel cassetto», racconta di questo film impossibile: una pellicola che ha sempre desiderato fare e alla quale ha dedicato anni di scritture e riscritture. E’ venuto il momento di usare quel materiale, quegli appunti e sceneggiature. Ma non per il cinema: prima per un breve dramma radiofonico e poi per uno spettacolo teatrale che parta dal quel mondo e da quelle atmosfere.
Il testo di Genet – di cui restano solo alcuni frammenti e suggestioni – diventano la colonna sonora di un film porno che gli spettatori non vedranno mai. Questa pellicola invisibile viene proiettata al Cinema Cielo del titolo: una sala milanese che ormai non esiste più, smantellata dopo l’avvento delle videocassette e dei club privé. Il pubblico teatrale, sistemato esattamente lì dove dovrebbe esserci lo schermo, ne sente solo le battute, spiazzi di dialogo, e il rumore della pioggia che cade. Il palcoscenico è occupato dalla sgangherata e polverosa platea del cinema, con le sue file di poltroncine sbilenche, i frequentatissimi cessi sulla destra e poi, sullo sfondo, oltre le tende di velluto, verso la luce della strada, il foyer con le sue stralunate e divertentissime cassiere. Pian piano emerge il rapporto tra quello che dicono gli antieroi di Genet e quello che accade in sala: spesso un’associazione, a volte una complementarietà oppure in un ironico contrasto, in un continuo (e drammaturgicamente virtuosistico) gioco di rimandi.
La platea del Cinema Cielo è un inferno – o magari un paradiso – irrimediabilmente perduto, che può rivivere solo nella memoria, con la sua feccia improbabile e composita, una tribù ormai estinta con i suoi rituali spermatici. C’è il dolcissimo e stralunato travestito brasiliano, il tizio che si eccita solo se sente l’odore dei calzini, il sordomuto marchettaro che ulula e grugnisce di non essere omosessuale e che lo fa solo per i soldi, il paralitico in cerca di compagnia, il terzetto che s’incula al ritmo di Forever Young, il travestito in pelliccia e bikini che si scatena al ritmo della disco dance, l’immigrato che ormai abita in sala e si guadagna da vivere facendo lavoretti di mano e di bocca nei cessi, l’esibizionista che ti appoggia il cazzo sull’orecchia, l’uomo che solleva il vestito alla sua donna e la offre agli altri clienti, il Babbo Natale che in questa sconclusionata vigilia si scatena in una danza da giocoliere, il preservativo usato che s’appiccica alla suola della scarpa, lo studente in tuta e tacchi a spillo che si fa sodomizzare a raffica, il vecchio in giarrettiere che sbuca dai cessi, il marito che telefona alla moglie «Sono giù a mettere ordine in cantina, tra mezz’ora salgo» e s’infila nel cesso...
E’ una umanità eccentrica e meticcia, un variegato circo di ossessioni dove il Cristo è un acrobata sui trampoli che allarga le braccia. E’ fatta di manichini, immobili al loro posto oppure trainati, come negli spettacoli di Kantor, da piccoli carrelli. Ed è fatta naturalmente di esseri umani, infoiati dal meccanismo ossessivo della perversione, della coazione a ripetere, della forma che fissa e pietrifica il desiderio: burattini spesso più ridicoli che scandalosi, deboli e fragili come tutti noi, non appena ci liberiamo dall’ossessione della normalità. A dare vita a questa straordinaria galleria composta di decine di figure è un quartetto d’attori di straordinaria potenza e disponibilità: Danio Manfredini in primo luogo, e con lui Patrizia Aroldi, Vicenzo Del Prete e Giuseppe Semeraro. E’ grazie a questo moltiplicarsi di presenze, alla loro danza a volte grottesca e a volte struggente che le ossessioni private, personali di Danio, il suo sentimento della diversità e della bellezza, trovano per la prima volta una dimensione oggettiva e insieme collettiva.
Cinema Cielo è una Classe morta a luci rosse, un teatro della memoria e della devianza, una danza della morte e della perversione. Ma è sempre attraversato dall’ironia e da un sentimento di umana pietà che accomuna i personaggi, gli attori e gli spettatori, tutti ugualmente mostruosi e umani. Lo spettacolo diventa così una lancinante meditazione sulla natura umana, sulla sua fragilità, sulla possibilità di trovare la poesia dentro e oltre la pornografia. E’ una intricata meditazione sul corpo (sulla sessualità) e sullo sguardo: i corpi degli attori e quelli dei manichini con cui a volte s’accoppiano, lo sguardo della platea che s’incrocia con quello degli spettatori sulla superficie di uno schermo inesistente. Ci sono squarci di quotidianità quasi bozzettisica, con le esilaranti controscene delle cassiere, in grado di accettare e di far accettare qualunque pratica sessuale come il più banale fatto della vita. C’è la bellezza e il degrado dei corpi che si accoppiano nello squallore consunto del cinema. C’è un’ironia, e una autoironia, di fondo, che sdrammatizza e riporta ogni comportamento a una dimensione semplicemente umana, e dunque da accettare come tale.
Ma poi – alla fine di questo canto della diversità, dell’amore e della morte – c’è anche il sospetto che tutto questo rimandi a qualcos’altro, a una realtà più terribile e segreta, che non sappiamo dire, e men che meno definire, ma di cui sentiamo l’oscura potenza non appena ci abbandoniamo a noi stessi. Lo sottolinea in maniera addirittura eccessiva – almeno nelle prime versioni pubbliche dello spettacolo – il finale, con la danza dionisiaca scatenata e oscena che conclude il lavoro: uno scarto rispetto al realismo a tratti grottesco di tutto quello che precede, un rimando al mito, forse addirittura a una trascendenza.
Va ancora sottolineata, per Cinema Cielo, una novità: è il primo spettacolo che – almeno per la stretta finale – non è stato totalmente autoprodotto. Da un lato è un indizio delle scarse capacità del sistema teatrale italiano di cogliere gli elementi di valore e di novità. Dall’altro segna una possibile svolta – dopo le «partecipazioni straordinarie» a due spettacoli del Teatro della Valdoca e della Compagnia Pippo Delbono – nel rapporto con le istituzioni.
Anche se quello di Danio Manfredini è sempre stato e resta, anche in questa occasione, un teatro militante a cominciare dalle condizioni produttive, dalla povertà e dal rigore, dai lunghi tempi di prova, dalla rivendicazione del diritto di sbagliare e di continuare a modificare e modellare gli spettacoli anche dopo il debutto, come fossero creature vive.
Come artista (e non solo) Danio Manfredini si è formato nella Milano degli anni Settanta, in una fase di forti (e spesso violenti) conflitti sociali e politici. Ha sempre lavorato in luoghi dagli espliciti connotati di militanza. Tuttavia i suoi spettacoli non hanno mai avuto tematiche esplicitamente politiche. Anzi, ha sempre difeso la totale autonomia dell’arte rispetto alle necessità immediate della lotta e della propaganda.
Tuttavia, a un livello più profondo la sua è un’arte dalle forti implicazioni politiche, proprio nel suo nucleo centrale, nella possibilità di costruire uno spazio di autoconsapevolezza e di espressione – e in definitiva di assoluta libertà personale. Condizione necessaria della creatività resta una fondamentale anarchia.
«In qualche maniera il potere ti determina anche sul piano artistico, in quanto agisci sempre in reazione alla sua azione. A un certo punto io mi rifiuto di essere una reazione all’azione del potere, così come a volte mi rifiuto di leggere il giornale, se mi deve condizionare troppo l’esistenza, perché ci sono informazioni che ti condizionano. E’ come se il potere volesse tenere la tua mente su certe cose. E io mi ribello alla possibilità che la mia mente venga messa là dove vuole il potere, anche a costo di essere segnato e di trovare una serie di intoppi. Non sto parlando di un’estraneazione politica, ma della possibilità di tenere aperta una zona che non sia solo di reazione ma di creazione.»
Quello di Danio Manfredini non è solo teatro, o meglio la scoperta – quasi il «miracolo» – di uno degli infiniti teatri possibili. Dal punto di vista formale, è un’«opera d’arte totale» essenziale e immediata. E’ pittura, perché nei suoi gesti minimi e ineluttabili si condensano insieme la traiettoria della mano che traccia il segno e il segno stesso. E’ danza, nel ritmo e nella concatenazione dei movimenti, nell’occupazione dello spazio. E’ letteratura, nel dialogo costante con modelli come Genet e Pasolini. E’ poesia, negli squarci lirici e nella riflessione sulla marginalità e sul diverso che costituisce forse il filo rosso di tutto il suo percorso: sofferta e mai esibita, che rifugge da ogni sentimentalismo e banalità.
Il suo obiettivo – così come quello di Pippo Delbono, che non a caso in diverse occasioni ha lavorato sia con César Brie sia con Danio – resta la semplicità, senza mai rischiare la semplificazione. La popolarità, senza mai cercare l’applauso facile, anzi. E’ la ricerca di una comunicazione e di una comprensione immediata e trasparente, che non ha bisogno di strumenti culturali e di filtri intellettuali per essere decodificata, perché il suo linguaggio si basa sugli elementi fondamentali del nostro essere nel mondo: il corpo e il suo rapporto con lo spazio, il gesto come espressività immediata, il sentimento – l’amore e l’abbandono.
Così, quando questo artista, aristocratico e raffinato come i veri anarchici, afferma «Cerco la semplicità, la popolarità», dice il vero. A patto di non dimenticare che quella semplicità si può raggiungere solo dopo essersi perduti, solo dopo aver attraversato quella che per Jean Genet, nell’ultima frase del Diario del ladro, è «quella contrada di me che ho chiamato Spagna».
Questo testo è parzialmente basato su articoli e interviste pubblicati su «il manifesto» (La povera crociata dei bambini brechtiani, 20 febbraio 1985, Margini di vita precaria, 28 dicembre 1989, «Se siamo tristi abbiamo i nostri motivi». Tre studi di Manfredini, 8 luglio 1992, Leonka story. Il centro nel mirino, «suq», 3 ottobre 1993, Una diversità non riconciliata, 20 ottobre 1995, Un manichino sotto anestesia, 11 luglio 1998), «art’ò» (Il teatro è pesante, numero zero, aprile 1998), www.olivieropdp.it, www.ateatro.it («ateatro 54», 1° luglio 2003, «ateatro 55», 20 luglio 2003).
Dürrenmatt pittore in mostra a Bologna
Bologna, Galleria d’Arte Moderna, fino al 2 novembre
di Redazione ateatro
«Dipingo per la stessa ragione per cui scrivo: perché penso. La pittura intesa come l’arte di fare dei bei quadri non m’interessa, così come non mi interessa fare del buon teatro. Sono un dilettante del disegno. Anche quando scrivo non prendo le mosse da un problema, ma da immagini, perché all’origine c’è sempre l’immagine, la situazione –, il mondo»: così Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) sintetizzava il proprio rapporto con la pittura, passione coltivata quasi in segreto.

Friedrich Dürrenmatt, Il mondo degli Atlanti, 1975/78
I suoi quadri colorati, visionari e inquietanti sono in mostra a Bologna, alla Galleria d’Arte Moderna, fino al 2 novembre.
La famiglia Fo apre una televisione
Atlantide tv inizierà a trasmettere il 3 novembre
di Redazione ateatro
La famiglia Fo sta per lanciare la sua tv. Si chiamerà Atlantide tv. Dopo essere andata qualche giorno in onda su Iride tv, la televisione della Festa dell'Unità, Atlantide tv inizierà a trasmettere il 3 novembre - non si sa ancora se sarà in chiaro o su satellite. Ma, dice Jacopo Fo, figlio di Dario e Franca, "l'importante è se questa tv farà ridere e riuscirà a raccontare quello che i media dominanti tacciono". In questi giorni i promotori stanno raccogliendo filmati di vario tipo, mettendo a punto le sigle, le lezioni di teatro e le battute di Daniele Luttazzi.
Altre info sul sito di Jacopo Fo.
www.dramma.it di ottobre
Le novità del sito
di www.dramma.it
Le novità del mese di ottobre sono disponibili online su
Ultimi posti disponibili per la I sessione del
Corso base di drammaturgia
Il prossimo 24 ottobre al Teatro Nazionale Croato Ivan pl. Zajc di Fiume, sede del Dramma Italiano, debutta "Kren" di Francesco Randazzo, vincitore della prima edizione del premio Dramma in Rete.
Il dramma del mese è Orienti di Duccio Camerini, una trilogia composta da tre testi e tre spettacoli da vedere o leggere insieme o separati. Lo spettacolo debutterà al Teatro Belli di Roma il 28 ottobre prossimo con Duccio Camerini, Crescenza Guarnieri, Cristina Cellini, Daniele Natali, Camillo Arcangelo Iannace, Francesca Rocca, Emiliano Passaro. Musiche di Gianluca Cucchiara, scene di Tiziano Fario, costumi di Silvia Duranti. Una produzione "La casa dei racconti" organizzata da Duccio Camerini e Cristina Cellini, in collaborazione con la Rag Doll Produzioni e il Centro Culturale "G. Belli".
Nella sezione Drammaturgie, uno speciale sul Premio Riccione Teatro
nuovi articoli e recensioni.
In aggiornamento rapido la sezione dedicata ai
cartelloni dei teatri, dove si osserva un significativo incremento della presenza di testi contemporanei...
Scaricabili dalla home page i bandi di prossima scadenza.
Ecco gli ultimi arrivi della libreria virtuale.
E poi non dimenticare il forum, i comunicati stampa, i link a centinaia di siti teatrali, scrivi una scena del copione interattivo, le segnalazioni per il dizionario dei drammaturghi del 900, le scuole di scrittura teatrale...
Nasce FaQ, il coordinamento delle compagnie di produzione lombarde
Il documento delle 13 compagnie
di Redazione ateatro
Qui di seguito, il documento con cui si presenta il coordinamento delle 13 compagnie di produzione lombarde.
Le difficoltà del nostro teatro le conosciamo, ateatro ne ha parlato ampiamente, le iniziative Nuovo teatro vecchie istituzioni hanno cercato di offrire occasioni di incontro e proposta.
FaQ, l'iniziativa delle 13 compagnie teatrali lombarde, si muove nella stessa direzione. In una chiave che non è solo - ci sembra - di rivendicazione e difesa dei propri interessi di categoria, ma di stimolo e di proposta culturale.
FaQ
COORDINAMENTO DELLE COMPAGNIE DI PRODUZIONE LOMBARDE
Aia Taumastica, aida, Alma Rosè, Animanera, Associazione culturale Dionisi, A.T.I.R., delle Ali, Figure Capovolte, La Fionda Teatro, Macrò Maudit, Teatro Aperto, Teatro Inverso, Teatro Magro
Dopo approfonditi confronti avvenuti nell’ultimo anno, sia a livello regionale sia in un più ampio contesto nazionale, è nato in Lombardia un coordinamento indipendente, FaQ.
13 le compagnie teatrali fondatrici. Casualmente 13.
Siamo compagnie di produzione, non legate stabilmente alla gestione e/o alla programmazione di teatri e/o altri luoghi di rappresentazione, bensì impegnate nella creazione di eventi e spettacoli basati sull’innovazione dei linguaggi e delle poetiche teatrali. Da sempre, lavoriamo al di fuori delle logiche proprie di un’impresa teatrale commerciale, operando in ambito culturale in autonomia e con ampi margini di rischio.
Nel dicembre 2002, la Regione Lombardia ha invitato A.T.I.R. e Teatro Aperto, in prima rappresentanza delle stesse, a presenziare a un tavolo di discussione in cui sarebbero state elaborare proposte e suggerimenti in previsione di una nuova normativa regionale nel Settore Cultura e Spettacolo.
L’incontro al tavolo regionale con altre rappresentanze e il costante dialogo interno al coordinamento hanno prodotto come risultato un documento consegnato alla Regione che delinea contenuti e linee-guida relativi alle esigenze delle compagnie di ricerca e alle loro prospettive specifiche. Tale documento è la prima espressione del reale confronto e dell’azione comune in FaQ. In esso innanzitutto tracciamo una demarcazione, in relazione alla natura e ai parametri legislativi di valutazione, fra compagnie di produzione e altri soggetti (Teatri Stabili di Innovazione di Ricerca, Teatri Stabili Privati ecc.), che a oggi partecipano degli stessi articoli della Legge Regionale, sebbene abbiano caratteristiche e gestioni economiche non equiparabili alle nostre.
Non solo, constatiamo come siano rare, se non addirittura un’eccezione, le compagnie di ricerca sostenute dalla Regione Lombardia, malgrado il territorio lombardo sia uno dei più ricchi in Italia di fermento teatrale e malgrado molte compagnie abbiano pieno riconoscimento nel panorama nazionale.
Questo evidenzia la preoccupante lacuna che le istituzioni hanno spesso collaborato ad aggravare. Se da un lato infatti viviamo una sconfortante involuzione della politica culturale regionale che ha causato tagli del 30% alle risorse del settore, dall’altro le istituzioni hanno basato in questi anni la loro politica culturale su progetti e consuetudini storicamente inattaccabili senza considerare il sostegno alla proliferazione di un humus culturale vitale per il territorio e il ricambio generazionale.
Intendiamo rendere pubblica la nascita di FaQ e contestualmente annunciare il lavoro che ci prefiggiamo per i prossimi mesi. Nonché denunciare alcuni dati di preoccupante rilevanza di cui abbiamo avuto conferma in questo primo periodo di lavoro.
1) Dichiariamo l’indipendenza del nostro coordinamento, nato spontaneamente dalle 13 compagnie. L’intenzione comune è continuare a svolgere un lavoro autonomo, non etichettabile, non spendibile da altri.
In questo contesto, lavoriamo in prospettiva e al di là delle poetiche individuali.
Per conseguire e arrivare a garantire un livello di comune dignità professionale al nostro settore con scopi prevalenti di difesa degli interessi della categoria.
Per creare una rete di riferimenti organizzativi e legislativi che favorisca le compagnie che si affacceranno in futuro all’avventura produttiva.
Per mettere in moto un circolo virtuoso che favorisca realmente il ricambio generazionale e che sostenga concretamente i gruppi giovani usando i fondi per dar loro strumenti da utilizzare autonomamente piuttosto che relegarli, come è stato finora, in piccole e sporadiche rassegne basate su una visibilità comunque non garantita.
2) Denunciamo la mancanza di investimento sulle compagnie lombarde che andrebbero invece sostenute tramite teniture adeguate e un adeguato sforzo produttivo. Basta scorrere i cartelloni della stagione teatrale 2003/2004 a Milano per averne più che la percezione, la conferma.
Denunciamo, ancora, l’aberrante usanza ormai divenuta normalità di proporre ai "gruppi giovani" produzioni o coproduzioni di facciata che di fatto, è noto, si traducono in ospitalità a basso costo o a percentuale; o peggio di messa in agibilità al minimo garantito. Il che palesemente significa accumulo da parte degli enti organizzatori di giornate lavorative e borderò da spendere per la richiesta di fondi istituzionali.
Denunciamo, inoltre, l’inadempienza contrattuale di enti organizzatori che non rispettano termini di pagamento, che li dilazionano in anni nonostante le specifiche negoziazioni intervenute , che non danno risposte o si negano.
Per noi produzione è co-operare con istituzioni nate e finanziate per sostenere i giovani artisti; significa relazionarsi professionalmente, senza sentirsi menzionati come "giovani" in senso diminutivo; significa, neanche a dirlo, ricevere paghe dignitose e secondo gli accordi. Significa soprattutto poter investire e progettare con un respiro più ampio in un dialogo reale e concreto con il territorio.
Siamo a conoscenza delle esigue risorse finanziarie del nostro settore e degli obblighi legislativi a cui l’ultimo Decreto Ministeriale costringe i teatri, fortemente limitativi della libertà delle direzioni artistiche.
Nondimeno, è nostro dovere e diritto continuare a ritenere i Teatri Stabili di Innovazione i nostri interlocutori primi nella misura in cui riconosciamo loro, da statuto, il compito principale di porsi come punto di riferimento per l’ecosistema culturale monitorando i movimenti della propria regione e creando progetti tesi a vivificare le energie teatrali sul territorio tramite ospitalità, coproduzioni, collaborazioni, commissioni.
Il ruolo di Teatro Stabile di Innovazione comporta una forte responsabilità nei confronti degli artisti, che scongiuri al tempo stesso gli atteggiamenti antitetici di disinteresse e paternalismo divenuti consueti.
Atteggiamenti che purtroppo hanno caratterizzato e continuano a caratterizzare il modus operandi dei Teatri Stabili di Innovazione lombardi che non sono stati all’altezza del loro ruolo e dei loro compiti in passato né sembra lo siano ora.
A fronte di questo delicatissimo momento abbiamo avviato una serie di tavoli di lavoro per analizzare la situazione teatrale lombarda sotto i profili legislativo, organizzativo, distributivo e territoriale con l’intento di:
1. confrontarci con le istituzioni e gli enti teatrali
2. allargare il confronto a ulteriori compagnie di produzione del territorio lombardo
3. connettere in maniera stabile e costruttiva le compagnie lombarde con coordinamenti analoghi operanti in altre regioni italiane
4. organizzare in tempi brevi un incontro regionale (e successivamente nazionale) per rendere pubblici e condividere i risultati della ricerca verso una mobilitazione concertata.
Aia Taumastica
aida
Alma Rosé
Animanera
Associazione culturale Dionisi
A.T.I.R.
delleAli
Figure Capovolte
La Fionda Teatro
Macrò Maudit
Teatro Aperto
Teatro Inverso
Teatro Magro
Per contatti: FaQ.lombardia@libero.it
Il CdA del Piccolo censura Dario Fo?
Sergio Escobar sulla prima pagina del "Corriere della Sera"
di Redazione ateatro
Il solo annuncio della presenza di Dario Fo al Piccolo Teatro sta già innescando censure e scatenando polemiche.
Il Premio Nobel sarà ospite del Piccolo con una nuova commedia, L’anomalo bicefalo, che racconta un’operazione chirurgica che riguarda Berlusconi e Putin. A chi, nel corso di un incontro tenuto alla Sala Montanelli del «Corriere della Sera», gli ha chiesto se voleva attaccare «il potere in generale», Dario Fo ha subito precisato: «No, no io voglio proprio parlare di Berlusconi. Del resto anche Shakespeare nel suo ultimo lavoro Misura per misura volle colpire il re, succeduto a Elisabetta: e da allora non rappresentò più nulla, poi morì». Commento in sordina dalla prima fila, voce di Franca Rame: «Spero non succeda anche a noi».
Ma già si addensano le ombre della censura e del ricatto. Fo ricorda gli anni della Prima Repubblica: «Franca ed io avevamo difficoltà, come sempre, ma tutto sommato rimpiango la Dc. Nel mio Fanfani rapito ci andavo giù di brutto, ma non ci censurarono (adesso non ci fanno neppure andare in tv), non scattò il subbuglio provocato dalla mia nuova commedia L’anomalo bicefalo».
Le pressioni devono essere pesanti se il direttore del Piccolo, Sergio Escobar, ha sentito il bisogno di occupare ieri (17 ottobre) la prima pagina del quotidiano milanese per difendere l’autonomia del teatro, che già l’anno scorso si era ritrovato al centro di una feroce polemica per i manifesti usati da Ronconi per Le Rane a Siracusa (vedi ateatro 35).
«Dopo l’anticipazione che Fo ha voluto dare sulla sua presenza al Piccolo, sono cominciati ad arrivare i consigli a "lasciar perdere", "non è aria" e poi "in momenti di crisi economica", "si sa, i finanziamenti"... Tanto attivismo - ne sono certo - non viene neppure dal "potere vero", ma dalla solita zavorra di zelanti, la stessa che, oscillando da dritta a manca, ha sempre accompagnato la navigazione di ogni Governo, non rendendogli certo un buon servizio». Ma ora «i consigli amichevoli sono diventati attacchi pubblici: in democrazia è già un bel passo avanti».
La battaglia è appena iniziata, perché lo spettacolo non era stato inserito in stagione e deve ancora passare l’esame del CdA. Escobar gioca d’anticipo: «Ogni stagione, ai titoli presentati se ne aggiungono altri, che non sono inseriti in abbonamento (non lo sono neppure tutti quelli della stagione), titoli che seguono la normale prassi di approvazione. Anche lo spettacolo di Fo la seguirà: sono fatti suoi se ha voluto anticipare alla stampa il progetto in corso, per cui nulla è stato ancora formalizzato. Dunque sarà in consiglio a esprimersi. Se Fo è stato ospitato per 50 anni al Piccolo, compresa l’ultima stagione, per quale ragione avrei dovuto pensare - contro il mio senso etico - di ricorrere questa volta a un umiliante, quanto stupido, blitz? Cosa sarebbe cambiato? Perché avrei dovuto priva gli amici del Consiglio di Amministrazione del diritto di smentire il timore - scritto da pochi e pensato da molti - che l’omologazione politica del suo recente rinnovo avrebbe avuto come scopo quello di imbavagliare il Piccolo? E’ certo però che il Consiglio di Amministrazione non voterà solo su un fatto, non alzerà la mano su un titolo, ma per esprimerà su un principio: il diritto alla satira, alla libertà di pensiero. Personalmente non avrei nulla in contrario se questa discussione fosse pubblica, alla luce del sole, come voleva Cartesio. Anche il pubblico che riempie i nostri teatri capirebbe che non si tratta dell’ennesima bega».
Ma che dicono i membri del Cda? Ecco le dichiarazioni di alcuni di loro sul «Corriere della Sera» del 18 ottobre:
Roberto Ruozi (presidente, nominato dal Comune di Milano): Non conosco lo spettacolo. Non posso esprimermi. Dario Fo è 50 anni che fa teatro! Io da ragazzo lo trovavo sensazionale. Con l’andare degli anni forse ha perso un po’ di smalto. Valuteremo, per ora è un problema inesistente».
Emanuele Banterle (nominato dalla Regione Lombardia): «Non commento. Ricordo che Dario Fo è stato in cartellone anch el’anno scorso, su di lui è inutile fare valutazioni. Storiccamente, il CdA ha espresso riserve su alcuni spettacoli, ma non ne ricordo di non approvati.»
Rosa Giannetta Alberoni (nominata dalla Provincia di Milano): «Il problema non è Dario Fo o un altro drammaturgo. Non c’entra se la satira sia contro Berlusconi o D’Alema. Io mi batterò perché questi spettacoli non passino. Io dico di no. Portino in scena la creatività, se ce l’hanno, non tesi politiche. E’ giunta l’ora di dire basta. I drammaturghi si diano da fare: ci sono tanti libri di narratori italiani che potrebbero essere messi in scena: perché usare il teatro per insultare i politici? Che senso ha una cosa simile? Me lo chiedo anche per Dario Fo.»
Pieluigi Crola (nominato dalla Regione Lombardia): «Finche non ho visto la trama non posso dare un giudizio. Un problema analogo è successo nello scorso Consiglio, quando mi sono scagliato contro lo spettacolo Mai morti proposto da Teatridithalia, dove si paragonano i fascisti ai carabinieri coinvolti nella vicenda di Carlo Giuliani. Io ho votato contro, ma la proposta è passata con la programmazione in blocco. Io posso capire una posizione contraria, ma tutto ha un limite, non si può diffamare, ci vogliono dei paletti! Anche la satira può essere forte, ma non oltre un certo limite. Mi atterrò allo stesso principio per Dario Fo, ma prima devo leggere il testo! Non è una questione politica ma di correttezza. E non è una censura.»
Per la cronaca, in attesa che il dibattito si scaldi, può essere utile ricordare che Dario Fo e Franca Rame sono rimasti fuori dalla televisione della Prima Repubblica dal 1962 (anno della celeberrima censura allo sketch sulle morti sul lavoro di Canzonissima) al 1977, quando la Rai ha trasmesso il ciclo di commedie Il teatro di Dario Fo (e anche allora non fu facile mandare in onda Mistero buffo). Anche a Milano, la sua città, il Premio Nobel non ha goduto di grandi favori: a lungo i suoi spettacoli non sono passati per le sale gestite dal Piccolo Teatro. E in tutta la sua carriera l’unico teatro che l'autore-attore ha gestito direttamente è stata la Palazzina Liberty (ristrutturata da Fo, dalla sua compagnia e da moltissimi volontari): non a caso la Palazzina, corpo estreneo alla città ma frequentatissima, gli è stata ben presto scippata dal giunta comunale cittadina. Insomma, i tempi sono duri, ma c'è anche una solida tradizione italica, un vecchio copione che viene puntualmente riaperto.
Aggiornamenti e altre info sul forum Fare un teatro di guerra? (e potete anche dire la vostra...)
Shakespeare in movie
Il cinema shakespeariano in rassegna a Milano
di Redazione ateatro
E' in corso (fino al 2 novembre prossimo) alla Cineteca Italiana, ospitata dallo Spazio Oberdan di Milano, la rassegna Shalespeare in Movie, ovvero 14 pellicole ispirate a testi del grande drammaturgo inglese.
Fra i tanti capolavori presenti nella rassegna, il classico Amleto (1948) di e con Laurence Olivier e il rarissimo Gamlet (1964) di Grigorij Kozintsev, il Leone d'oro alla mostra di Venezia 1990 Rosencrantz e Guildestern sono morti, il Romeo e Giulietta (1968) di Zeffirelli al quale collaborò come sceneggiatore Franco Brusati, e le tre riduzioni di Welles Othello (1952), Macbeth (1948) e Falstaff (1966). Questi ultimi due film verranno presentati nelle versioni in lingua inglese.
Per il programma, cliccate qui.
Su William Shakespeare e il cinema, è possibile consultare il memorabile ateatro 47, tutto dedicato a Shakespeare, con il saggio Bardomovies e il mitico Bardofilm database, una ricca filmografia shakesperiana consultabile e ricercabile online.
Michele Sambin e Mario Martone a Invideo 2003
Il programma della rassegna milanese
di Redazione ateatro
L'edizione 2003 di Invideo, la rassegna milanese (con appendici oltralpe) di "video d'arte cinema e oltre", sotto il titolo di Istantanee riserva ampio spazio a Michele Sambin, presente con un seminario e una retrospettiva (al suo lavoro video e ai suoi intrecci con il teatro Anna Maria Monteverdi ha dedicato un ampio saggio, presente sul catalogo, che presenteremo in anteprima su ateatro 59).
In appendice a questa edizione numero 13 di Invideo, un'ampia retrospettiva dedicata a Mario Martone.
Qui di seguito il programma della rassegna.
Invideo 2003
ISTANTANEE
INSTANT IMAGES
Video d’arte e cinema oltre
Parigi, 4 novembre 2003
Milano, 5/9 novembre 2003
Parigi, Centre Wallonie-Bruxelles
Martedì 4 novembre
Ore 20.00
Anteprima di Invideo a Parigi
Vincent Pluss: la "nouvelle vague" svizzera tra cinema e video
L'heure du loup. Svizzera, 1987, 16', 35 mm
The Moebius Strip. Svizzera, 2002, 26' videodanza
The Greenhouse Infect. Svizzera, 2003, 9'45"
On dirait le sud. Svizzera, 2002, 66', 35m
Milano, Spazio Oberdan
Mercoledì 5 novembre
0re 21.00
L'exil à Sedan, Michaël Gaumnitz, Francia, 2003, 52' documentario/viaggio autobiografico (v.o. tedesco con sott. In francese) alla presenza dell’autore
Ore 22.05
Serial Flowers, Beniamino Borghi-Federico Gabbiani-Marilia Pederbelli, Italia, 2003,
10' 42" carrellata sulla serialità alla presenza degli autori
ore 22.25
Wings, Terry Flaxton, UK, 2003, 10' sulla pittrice Georgia O’Keefe/metamorfosi delle forme (v.o. inglese)
Cows, Gabriela Golden, Argentina, 2002, 4'10'' istantanea/fatto di cronaca in Argentina
Dialogo con Yves Klein, Theo Eshetu, Italia, 2003, 28' ritratto sull’arte di Yves Klein
Orange Factory, Seoungho Cho, USA, 2002, 11' 38" videoarte/evocazioni/suggestioni letterarie
Burst, Reynir Lyngdal, Islanda, 2003, 5' videodanza/lotta fra il serio e il faceto
Gestalt, Thorsten Fleisch, Germania. 2003, 5' animazione/evoluzione di forme
Giovedì 6 novembre
Ore 15.30
L'homme et la fenêtre, Chloé Leriche, Canada, 2002, 2'45'' ipotesi fra fantasia e realtà (v.o.inglese)
Les poètes hurleurs, Antonella Bussanich, Francia, 2003, 6’ performance di « poeti urlatori »
Vieni, Monica Petracci-Silvia Bottiroli, Italia, 2002, 3'30'' videoarte/viaggio poetico e fiabesco
Urge, Ulrik Wivel, Danimarca, 2003, 5' videodanza tra classica e moderna
Hear, Fan Ho-ki Kedy, Hong Kong, 2002, 6'30'' videoarte/immagini mentali guidate dall’udito
Time Streams, Stephanie Maxwell-Allan Schindler, USA, 2003, 5'30" sinfonia visiva tra pellicola e animazione al computer
21 04 02, Jean-Gabriel Périot, Francia, 2002, 9'44’ montaggio di immagini:arte, pubblicità, cinema
Passagers d'Orsay, Sandra Kogut, Francia, 2003, 52' documentario/visita al celebre museo (v.o. francese con sott in inglese)
Ore 17.00
La fine della morte del trionfo, Gianni Toti, Francia, 2002, 23' videopoema a partire del "Trionfo della morte" (v.o. francese e italiano)
Cum pane, Anna Linder, Svezia, 2002, 7'50'' fare il pane come una forma d’arte
Flirt, Liisa Lounila, Finlandia, 2002, 4' gestualità di una lotta
Papillon d'amour, Nicolas Provost, Belgio, 2003, 3' 30" elaborazione di un vecchio film giapponese
Ore 17.40
Europe en Shorts 8 : il cinema sperimentale
Nowa ksiazka (New Book), Zbigniew Rybczynski, Polonia, 1976, 10’
Routemaster, Ilppo Pohjola, Finlandia, 2000, 17’
Holding The Viewe, Tony Hill, UK, 1993, 1’
HONG KONG (HKG), Gerard Holthuis, Paesi Bassi, 1999, 13’
Home Stories, Matthias Müller, Germania, 1990, 6’
Kugelkopf, Mara Mattuschka, Austria, 1987, 6’
Work and Progress, Vivian Ostrovsky-Yann Beauvais, Francia, 1999, 12’24"
Alone, life wastes. Andy Hardy, Martin Arnold, Austria, 1998, 15’
Programma realizzato dal European Coordination of Film Festivals
Ore 18.50
Whizeewhig, Chihcheng Peng, USA, 2002, 3' metamorfosi sul traffico urbano e la vita in città
Bitofhuman, Giorgio Partesana, Nicola Smanio, Lucas Zanotto, Italia, 2002, 8'30'' punti di vista tra uomo e donna
Quai zéro, Anna Falguères, Belgio, 2002, 7' frammenti di vita nella metropolitana
The Essence of Ink and Wash, Fen Yang, Cina, 2002, 4'15'' sinfonia visiva sulla tradizione cinese
Ore 19.15
Foglie, Leonardo Carrano, Italia, 2003, 5’34" video-sinfonia naturalistica
alla presenza dell’autore
Ore 21.00
Poetronica III: un palinsesto creato da poeti e artisti
A cura di Carlo Isola, presenta Carlo Isola
Ore 22.05
Angelopoulos Backstage, Alberto Signetto-Piero Milanese, Italia, 2003, 28’30" making of
Alla presenza degli autori
Ore 22.45
Peter Russell, Guido Cionini, Italia, 2003, 25' video-ritratto d’artista
L'etreinte, Robert Cahen, Francia, 2003, 8' partitura sonoro-visiva
Vertebra, Milla Moilanen, Finlandia, 2003, 5' videodanza/dialogo di due danzatori
Venerdì 7 novembre
Ore 15.30
Carta bianca a Viper, International Festival for Film, Video and New Media
A cura di Annika Blunck, Rebecca Picht, presentano Annika Blunck, Rebecca Picht
Backwards:
Schelenget, Laurent Nègre, Svizzera, 2003, 7’
Zwischen Jetzt und Später, Claudia Schmidt, Svizzera, 2002, 6’20"
Atoll, Maria Iorio-Raphael Cuomo, Svizzera, 2002, 6’30"
Dresense, Marika Rakoczy-Uli Koscher, Svizzera, 2002, 5’30"
Introduction, Chapter I und Chapter II, Zilla Leutenegger, Svizzera, 2000, 17’50"
Wouldn’t It Be Nice, Emanuelle Antille, Svizzera, 1999, 14’
Couple, Hanspeter Ammann, Svizzera, 1998, 11’
Pickel Porno, Pipilotti Rist, Svizzera, 1992, 12’ 50"
Forwards:
Zielpunkte der Stadt, Jörn Staeger, Svizzera, 2003, 5’
Motion Sculpture Analysis, Ralph Heinson, Svizzera, 2003, 2’15"
Plan Fixe, Christoph Oertli, Svizzera, 2003, 7’
Terra Swarm 1_After Eno, Benjamin Aranda-Chris Lasch, Svizzera, 2003, 4’30"
Can You See Me Now, Blast Theory, Svizzera, 2001-2003, 8’30"
Ore 17.20
Quadro, Lotte Schreiber, Austria, 2002, 10' sinfonia urbana
Ore 17.30
Incontro
Video-omaggio a Luciano Berio
Krazy Kathy Le mille e una voce di Cathy Berberian, Carlo Ippolito, Italia, 1993, 35'
Sequenza III, Francesco Lupi Timini, Italia, 2002/03, 8'18"
Alla presenza degli autori
Ore 18.30
Duration, Claudia Quintieri. Italia, 200, 2’ riflessione visiva sulla morte alla presenza dell’autore
Ore 18.45
The Radicals, Joshua Simon, Israele, 2001, 23’ documentario/ritratto della gioventù di Tel Aviv (v.o. ebraica con sott. In inglese) alla presenza dell’autore
Ore 19.20
Oïo, Simon Goulet, Canada, 2003, 9'30'', 35mm. spettacolare cinepittura
alla presenza dell’autore
Ore 21.00
"Absurditties": performance dal vivo di Liz Aggis
Anarchic Variations, Billy Cowie -Liz Aggiss, UK, 2002, 7' 30" performance/videodanza
Ore 21.35
E. Hesse, Susanna Carlisle, USA, 2002, 6' 20" performance/ la pittura di Eva Hesse
Egon Schiele. Susanna Carlisle, USA, 2002, 6' 25 danza-pittura-video/omaggio a Schiele
alla presenza dell’autore
Ore 22.00
The Eye of Olympia, Börries Müller-Büsching, Germania, 2003, 11' evocazione di un racconto di Hoffmann alla presenza dell’autore
Ore 22.20
Corpi nel labirinto: i videoclip di Michel Gondry presenta Alessandro Amaducci
La Ville, Oui Oui, 1992
Les voyages immobiles, Etienne Daho, 1992
Close But No Cigar, Thomas Dolby, 1992
Human Behaviour, Björk, 1993
Lucas With the Lid Off, Lucas, 1994
Army of Me, Björk, 1995
Isobel, Björk, 1995
Protection, Massive Attack, 1995
Like A Rolling Stone, Rolling Stones, 1995
Hyperballad, Björk, 1996
Bachelorette, Björk, 1997
Around the World, Daft Punk, 1997
Jòga, Björk, 1997
Let Forever Be, Chemical Brothers, 1999
Knives Out, Radiohead, 2001
Fell in Love With a Girl, The White Stripes, 2002
Come Into My World, Kylie Minogue, 2002
Sabato 8 novembre
Ore 15.30
D’improvviso a Milano, Petra Weiss, Italia-Svizzera, 2002, 15’ performance in una piazza milanese
Foglie, Leonardo Carrano, Italia, 2003, 5’34" replica
Ore 15.55
Masse und macht, Veit-Lup, Germania, 2002, 9' 32" danza pittorica di immagini
alla presenza dell’autore
Ore 16.15
Incontro
Studio Azzurro: Nodi del Mediterraneo. Breve viaggio nella sapienza mediterranea in un percorso condiviso con gli spettatori.
Parole di Paolo Rosa e suoni di Ricardo Castaldi
Ore 17.15
Terminal Bar, Stefan Nadelman, USA, 2002, 22' 22" documentario fotografico (v.o. inglese con sott. in italiano)
World Trade Opera, Alain Pelletier, Canada, 2002, 29'30'' cronache dal mondo (v.o. francese con sott. in italiano)
Plus près de la fin, Alicia Ortiz, Francia, 2002,14'48'' racconto pittorico e metaforico (v.o. francese con sott in italiano)
Lift, Marc Isaacs, UK, 2003, 24' 27" frammenti di vita in un ascensore (v.o. inglese con sott in italiano)
Ore 18.50
La conversazione amorosa, Elisabetta Sgarbi, Italia, 2003, 40’ ritratto-ispirato al libro di Alice Ferney (v.o. francese con sott. in italiano) alla presenza dell’autore e di Luciano Emmer
Ore 21.00
Incontro
Vincent Pluss: la "nouvelle vague" svizzera tra cinema e video
L'heure du loup. Svizzera, 1987, 16', 35 mm microstoria del quotidiano (v.o. francese con sott. in italiano)
On dirait le sud. Svizzera, 2002, 66', 35mm fra improvvisazione e fiction (v.o.francese con sott. in italiano)
The Moebius Strip. Svizzera, 2002, 26' videodanza
The Greenhouse Infect. Svizzera, 2003, 9'45" performance
Ore 23.10
Interface, Pierre-Yves Borgeaud, Svizzera, 2003, 14’ videodanza alla presenza dell’autore
Ore 23.25
Vertebra, Milla Moilanen, Finlandia, 2003, 5' videodanza/dialogo di due danzatori
Domenica 9 novembre
Ore 15.30
Tra video, teatro e musica. Incontro-performance con Michele Sambin
Partecipazione di Anna Maria Monteverdi
Ore 18.00
L'etreinte, Robert Cahen, Francia, 2003, 8' replica
Anarchic Variations, Billy Cowie -Liz Aggiss, UK, 2002, 7' 30" replica
Voyage sublime au pays du Gafghanistan, Claude Baechtold, Svizzera, 2003, 9' viaggio fotografico in Afghanistan
The Diary (Rooznameh), Ali Mohammad Safoura, Iran, 2003, 6’ la quotidianità/il tempo che passa (v.o. arabo con sott. in inglese)
L'exil à Sedan, Michaël Gaumnitz, Francia, 2003, 52' (v.o. tedesco con sott. In francese)
replica
Ore 19.15
Petite mémoire, Mauro Santini, Italia, 2003, 6' videoarte/un viaggio interiore
alla presenza dell’autore
Ore 19.30
Untitled part 3b: (as if) beauty never ends…, Jayce Salloum, Canada, 2002 , 11' 22" documentario-immagini d’archivio (v.o.arabo con sott in inglese)
Ore 21.00
Incontro
_Assemble.audiovisual research in Milan
presenta Alessandro Amaducci
Albe Chiare in ambienti quotidiani, Italia, 2003, 4’39’’
New : Millennium: Poor 2002, Italia, 2003, 45’’
Drink It!, Italia, 2003, 45’’
If U’ Wanna be…Dj Ambrò – Nevrotype, Italia 2003, 5’20’’
W3.com, Italia, 2003, 50"
Fashion Player, Italia, 2003, 1'20"
Sine Tempore, Italia, 2003, 45’’
Nike Dunk : Però le Scarpe devono essere pulite. Spot Beta Test, Italia, 2003, 1’35’’
Accelerator02, Italia, 2002, 7’20’’
Interfer, Italia, 2002, 2'10"
XXXX, Italia, 2002, 5’16’’
Activate02, Italia, 2003, 1’08’’
Ultrassemble, Italia, 2003, 58"
Napoli Anthem – Nevrotype, Italia, 2003, 4'45"
Ore 21.55
You + Me, Tina Gonsalves, Australia, 2002, 2'33'' allegoria dell’aggressività
Love Loss. Tina Gonsalves, Australia, 2002, 5'11'' sulla memoria, sulla solitudine…
Now. Tina Gonsalves, Australia, 2002, 3'11'' riflessione sull’ora
Trust. Tina Gonsalves, Australia, 2002, 4'22'' metafora/favole personali
Alla presenza dell’autore
Ore 22.20
La fine della morte del trionfo, Gianni Toti, Francia, 2002, 23' (v.o. francese e italiano) replica
Ore 22.45
Disphase, Stefano Scarani, Italia, 2002, 11' 27" videoclipviaggio in un mondo simbolico
alla presenza dell’autore
Ore 23.10
Yes? Oui? Ja?, Thomas Draschan-Ulrich Wiesner, Germania, 2002, 4', controclip-materiali d’archivio 16mm.
Double Fiesta, Anney Bonney, USA, 2003, 6'13'' musica visiva
I Sing the Body Electric, Katerina Athanasopoulou, UK, 2002, 4'40'' controclip/da una poesia di Walt Whitman
Black Milk, Max Philipp Schmid- Beat Brogle, Svizzera, 2002, 4’ videoclip sperimentale
I am a Boyband, Benny Ramsay Nemerofsky, Canada, 2002, 5' 30" controclip-fenomeno delle "band" giovanili
Live to Tell, Benny Ramsay Nemerofsky, Canada, 2002, 5’30" controclip/performance da una canzone di Madonna
Per tutta la durata della manifestazione
Postazione schermo al plasma
Dall’archivio di Invideo
Monitor esterni
I video del Totem (video allestito nella colonna di monitor all’ingresso della mostra)
Orange, Gregg Biermann, USA, 2003, 5' incontro tecnologico tra un’arancia e il software del computer
Betty Ford, husain/klöfkorn/berger, Germania, 2003, 4' videoclip
Ensache, Frédéric Ollereau, Francia, 2002, 32' performance surreale
Zeno's Paradox, Robert F. Arnold, USA, 2003, 5' 40" metafora del paradosso di Zenone
Dress up, Cigdem Altuntas, Turchia, 2003, 6'50'' performance
Comptes à rebours, Nathalie Bujold, Canada, 2002, 4' micro eventi-conto alla rovescia
Cubica, m.ash, Austria, 2001, 4’ animazione astratta tridimensionale
Nel programma sono segnalati soltanto gli autori che hanno garantito la loro partecipazione
Catalogo italiano/inglese a cura di Simonetta Cargioli, A+G, Milano
INVIDEO è un progetto AIACE sostenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per il Cinema; Regione Lombardia, Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia; Provincia di Milano, Presidenza e Cultura; Comune di Milano, Cultura e Musei, Spettacolo e dalla Commissione Europea, Programma MEDIA Plus.
INVIDEO si avvale anche del contributo di: Agence Suisse du Court Métrage, Ambasciata di Israele, British Council, Centre Culturel Français de Milan, Centro Culturale Amici di INVIDEO, CCS-Centro Culturale Svizzero, Fondazione Cineteca Italiana, Goethe-Institut Mailand, Medialogo, Ondavideo e Pro-Helvetia.
INVIDEO aderisce al Coordinamento Europeo dei Festival – ECFF
Loghi: Centro Culturale Svizzero Parigi, Goethe, British, Ondavideo, Pro-Helvetia
Mario Martone, regista di frontiera
Milano, Cinema Gnomo
Via Lanzone, 30/A (vicolo Sant’Agostino)
Mercoledì 19 novembre
Ore 18.00
Morte di un matematico napoletano, Italia, 1992, 108’, 35mm
Ore 20.00
Lucio Amelio / Terrae motus. Italia, 1993, 53’, video
Veglia, Italia, 1993, 15’
Antonio Mastronunzio, pittore sannita (da "Miracoli-storie per corti") Italia, 1994, 15’, 35mm
Ore 22.00
Morte di un matematico napoletano, Italia, 1992, 108’, 35mm
Giovedì 20 novembre
Ore 18.00
L’amore molesto, Italia, 1995, 104’, 35mm
Ore 20.00
Nella Napoli di Luca Giordano, Italia, 2001, 18’, video
La salita (da "I Vesuviani"), Italia, 1997, 25’, 35mm
Una storia Saharawi, Italia, 1996, 30’, video
Ore 22.00
L’amore molesto, Italia, 1995, 104’, 35mm
Venerdì 21 novembre
Ore 18.00
Rasoi, Italia, 1993, 55’, 35mm
Nella città barocca, Italia, 1984, 18’, 16mm
Ore 20.00
Un posto al mondo, Italia, 2000, 76’, video
Ore 22.00
Rasoi, Italia, 1993, 55’, 35mm
Nella città barocca, Italia, 1984, 18’, 16mm
Sabato 22 novembre
Ore 18.00
Nella Napoli di Luca Giordano, Italia, 2001, 18’, video
La salita (da "I Vesuviani"), Italia, 1997, 25’, 35mm
Una storia Saharawi, Italia, 1996, 32’, video
Ore 20.00
I dieci comandamenti, Italia, 2001, 120’, 35mm
Ore 22.00
Teatro di guerra, Italia, 1998, 113’, 35mm
Domenica 23 novembre
Ore 18.00
Teatro di guerra, Italia, 1998, 113’, 35mm
Ore 20.00
Videoteatro: da Foresta Nera a Tango Glaciale, Italia, 2003, 60’, video
Montaggio curato appositamente per questa rassegna da Mario Martone di materiali provenienti dalle opere di videoteatro Foresta Nera (1980) Tango glaciale (1982) Perfidi incanti (1984) Il desiderio preso per la coda (1986).
Ore 21.00
Incontro con Mario Martone
A seguire: Videoteatro: da Foresta Nera a Tango Glaciale, Italia, 2003, 60’, video
Mostra Internazionale di video d’arte e cinema oltre
XIII Edizione
International Exhibition of Video Art and Cinema Beyond
13th Year
Parigi, Centre Wallonie-Bruxelles
46, rue Quincampoix
4 novembre 2003
Milano, Spazio Oberdan
Viale Vittorio Veneto, 2
(M1 Porta Venezia)
5/9 novembre 2003
Milano, Cinema Gnomo
Via Lanzone, 30/A (vicolo Sant’Agostino)
(M2 Sant’ambrogio)
19/23 novembre 2003
(per orari vedere il programma)
orari (sala proiezioni e schermo al plasma)
mercoledì 5: ore 21.00 – 23.30
giovedì 6 a domenica 9: 15.30 – 19.30 / 21.00 – 23.30
ingresso libero
Per informazioni
Telefono 02-76115394
info@mostrainvideo.com
www.mostrainvideo.com
Kantor in mostra a Torino
Video, teatro, disegno e fotografia
di Redazione ateatro
Per fortuna si continua a parlare di Tadeusz Kantor: dopo la manifestazione e la mostra di Firenze, Torino dedica una articolata manifestazione al grande regista polacco (mentre un’altra iniziativa è allo studio al Teatro Vascello di Roma).
Qui di seguito, il programma.
Il Mutamento Zona Castalia Associazione di Cultura Globale
Residenza Multidisciplinare "Teatro Europeo e Internazionale"
VERSO UNA POLONIA EUROPEA
T A D E U S Z K A N T O R – C R I C O T 2
rassegna di video, teatro, disegno e fotografia
16 - 31 ottobre 2003

PROGRAMMA
GALLERIA 41 artecontemporanea, via Mazzini 41, Torino
dal 16 al 4 novembre 2003
orario: da mart. a sab. 16-19.30, mattino su app.
Mostra dei disegni inediti di T. Kantor relativi allo spettacolo, in pubblicazione nel libro Tadeusz Kantor, La classe morta, Ed. Libri Scheiwiller, 2003.


L’ESPACE, via Mantova 38, Torino
dal 16 al 31 ottobre 2003
orario: 15.00 - 19.00
Mostra fotografica di Romano Martinis
Presentazione dell’installazione fotografica su La classe morta


CINEMA MASSIMO – Sala 3, via Verdi 18, Torino
16 ottobre 2003 - Orario: 19, 20.30, 22
Proiezione del film La classe morta (1976), regia di Andrzej Wajda
L’ESPACE - Sala Micrò, via Mantova 38, Torino
21-22 ottobre 2003
Open house - proiezioni video no-stop - 12.00-24.00
La classe morta (versioni diverse)
Où sont les neiges d’antan
Wielopole, Wielopole
Crepino gli artisti
La macchina dell’amore e della morte
Qui non ci torno più
Oggi è il mio compleanno
L’ESPACE - Sala Micrò, via Mantova 38, Torino
31 ottobre 2003 - ore 18.00
ALL THAT FALL/TUTTI QUELLI CHE CADONO
Presentazione dell'esito finale del seminario diretto dai gemelli Janiccy
ispirato al radiodramma di S. Beckett All That Fall (1956)
Il seminario si svolgerà da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre 2003
L’ESPACE - Sala Micrò, via Mantova 38, Torino
31 ottobre 2003 - ore 19.00
Presentazione del libro Tadeusz Kantor, La classe morta, traduzione di Luigi Marinelli, apparato iconografico a cura di Lech Stangret e Silvia Parlagreco, Ed. Libri Scheiwiller, 2003
Interverranno: Giordano Amato, i gemelli Janiccy, Pietro Marchesani, Luigi Marinelli, Silvia Parlagreco, Giovanni Raboni, Gianni Rizzoni.
Tutte le iniziative della rassegna Tadeusz Kantor-Cricot2 sono a ingresso libero
IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA
via P.D. Pinelli 23 - 10144 Torino
tel/fax 011 48.49.44
zonacastalia@libero.it - www.mutamento.org
L'armata a cavallo da Isaak Babel'
Un’internazionale di uomini buoni
di Moni Ovadia
Debutta a Bologna (Arena del Sole, 23 ottobre 2003) il nuovo spettacolo di Moni Ovadia, L'armata a cavallo, tratto dai racconti di Isaak Babel', accompagnato dalle foto di Maurizio Buscarino.
Qui di seguito il testo con cui l'autore, regista e attore presenta il suo lavoro. (n.d.r.)
Nei primissimi anni della rivoluzione bolscevica circolava questa storiella ebraica. Durante una riunione del comitato centrale ristretto del partito comunista, Trotskij bisbiglia all’orecchio di Lenin: «Aspettiamo che vada via il goy (Stalin) e poi possiamo pregare, c’è minian (quorum di dieci maschi ebrei adulti necessario per pregare)». Il raccontino umoristico ci dà conto di un fatto risaputo nel mondo ebraico russo, cioè che il gruppo di dirigenti bolscevichi che aveva deciso e messo in atto la rivoluzione era composto a soverchia maggioranza da ebrei e mezzi ebrei. I loro nomi sono celeberrimi Trotskij, Kamenev, Zinoviev, Radek, Sverdlov e, cosa meno risaputa, lo stesso Lenin era ebreo da parte di madre. Alcuni di essi avevano ricevuto anche un’educazione religiosa. Trotskij, che al secolo si chiamava Lev Davidovic Bronstein, era figlio di un rabbino. Ma questa singolarità non si limitava ai vertici della dirigenza bolscevica. I numeri della presenza ebraica in tutti i movimenti rivoluzionari socialisti, comunisti e anarchici è sconcertante. Il primo partito operaio rivoluzionario dell’est Europa, fu il Bund, organizzazione rivoluzionaria degli operai ebrei di Russia e di Polonia. In seguito dal Bund provenne la struttura di quadri del partito socialdemocratico russo, molti dei quali, dopo la rottura con i menscevichi, confluirono nel partito comunista bolscevico. Quale legame esiste dunque fra l’ebraismo e la rivoluzione? Sicuramente e ovviamente il linguaggio visionario e incendiario dei profeti di Israele che chiamano al dovere della giustizia sociale e alla liberazione dell’oppresso come prima istanza del messaggio ebraico. Ma c’è di più. Molto di più.

L’ebraismo è forse la prima grande rivoluzione della storia del mondo e lo è sicuramente nell’Occidente la cui vicenda inizia proprio con Abrahamo, il grande patriarca ineguagliato rivoluzionario che frantuma gli idoli di ogni specie, spezza lo scettro di ogni possibile tiranno. Il geniale "traghettatore" fonda l’essere umano e ne lancia il cammino nel tempo storico con una radicale sovversione dei fondamenti del mondo antico attraverso un patto di pari dignità fra creatura e creatore con il Dio del monoteismo. Ed è ancora a opera di un ebreo che prende avvio la prima liberazione contro un potere idolatra e imperiale, si tratta di un inedito e inaudito processo che procede dal basso. Un popolo di schiavi guidati da un "rinnegato" della classe faraonica al potere, Mosè, spezza le catene della schiavitù e della sua weltanschauung, per inaugurare una nuova visione della vita basata sulla libertà di cui è garante una dirompente e ineffabile concezione del divino. Mosè non si limiterà a guidare il cammino di liberazione, ma costruirà il passaggio all’istituzione della nuova società e dell’uomo nuovo con lo strumento di una legislazione potente che rimane paradigma ineguagliato di rapporto fra ethos e giustizia. La storia dell’Esodo costruisce in qualche misura il quadro dentro il quale si iscriveranno tutte le storie di liberazione del futuro. Ciò che non passerà tuttavia nelle storie rivoluzionarie vicine a noi è la complessità, la capacità paradossale e la fiducia nel tempo della Torah di Mosè. I grandi rivoluzionari del novecento crederanno nel potere taumaturgico della rottura rivoluzionaria e inventeranno un uomo immaginario e ipostatizzato per fare tornare i conti invece che costruire la rivoluzione per l’uomo reale con tutta la sua fragile e contraddittoria precarietà, con i suoi difetti e con la sua complicazione costitutiva che lo rende soggetto sociale tendenzialmente labile e di scarsa affidabilità. Queste e altre ragioni determineranno il tragico fallimento della più grande utopia della storia dell’umanità, il comunismo. Un revisionismo strumentale oggi vorrebbe fare credere, per precise motivazioni politiche, che quella fu solo una storia di orrori. Non è così, fu la storia di uomini, di idee, di sacrifici, di dedizione, di tradimenti, sofferenze e dolori che non può essere archiviata nel bidone della spazzatura della storia televisiva. Gli uomini che diedero la vita per l’utopia del grande riscatto meritano uno sguardo che ne ricordi l’umanità estrema, una pietas che non li trasformi in numeri. Milioni di rivoluzionari e di comunisti furono vittime del "dittatore insicuro" Jossip Vissarionovic Dzugasvili detto Stalin, fra di esse il grande scrittore ebreo sovietico Isaac Babel’. Il nostro spettacolo è liberamente ispirato al suo capolavoro L’armata a cavallo.

I racconti di Konnaja Armija nascono dall’esperienza viva dell’autore sul fronte russo-polacco della guerra civile seguita alla Rivoluzione Bolscevica. Babel’, che nella propria opera chiama se stesso Ljutov, fu al seguito della Prima Armata a cavallo del mitico generale cosacco Budionnij. Il piccolo intellettuale ebreo occhialuto educato alle dolcezze e alle profondità dell’ebraismo khassidico chiede di unirsi ai feroci cosacchi rossi che, pur avendo scelto di battersi per la rivoluzione, hanno iscritto nella propria cultura più profonda un selvaggio antisemitismo nutrito da una storia secolare di massacri di ebrei. Babel’-Ljutov è ciononostante attratto dalla forza primitiva e vitale di quei leggendari combattenti a cavallo in simbiosi amorosa con le proprie cavalcature e cerca un battesimo di violenza per ottenere una piena legittimità di rivoluzionario. Non ci riuscirà. Rimarrà sconfitto dall’insanabile contraddizione con il proprio ebraismo, dal comandamento "non…ucciderai!". Non troverà neppure la forza di caricare la propria arma durante le azioni di combattimento per non correre il rischio, Dio scampi, di togliere la vita a qualche essere umano, ancorché nemico. Il suo delitto più efferato sarà quello di sciabolare un’innocente oca e quell’orribile omicidio gli procurerà continui incubi e gli farà sanguinare il cuore. Babel’-Liutov, che combatté sul fronte polacco, l’unico che vide la sconfitta dell’Armata Rossa di Trotskij, ha lasciato a noi che lo leggiamo il dono di uno dei momenti più alti della letteratura di tutti i tempi. Dalle pagine di Babel’ emergono uomini piccoli e straordinari. Tutti, i deboli, i feroci, i folli, gli orgogliosi, le vittime, gli esecutori vengono visti nella loro lancinante e disperata umanità. Mai Babel’ si lascia andare alla perversione del giudizio. Fra tutti troneggia il robivecchi Ghedali, il cieco venditore di cianfrusaglie, rapsodo sui generis, che vuole conciliare ebraismo e rivoluzione e va gridando al vento: «dov’è la dolce rivoluzione? La rivoluzione è gioia e felicità. Noi lo sappiamo che cos’è l’internazionale, dateci un’internazionale di uomini buoni. Noi tessereremo ogni anima al partito e le diremo: siediti alla tavola della vita anima e gioisci!».
Lo spettacolo si dipanerà come una partitura di immagini, suoni, musiche, canti e parole con cui combatteranno i due grandi cori dei bolscevichi e degli zaristi. In mezzo ai due "eserciti" un drappello di musicisti cavalleggeri rossi suonerà l’epopea dei rivoluzionari mentre gli attori racconteranno e urleranno lo sgomento dei piccoli uomini sconfitti. La Rivoluzione danzerà il suo sogno-incubo di gloria e di sangue prima di morire.

Perché fare uno spettacolo così "demodé" con stelle e bandiere rosse, perché ascoltare la voce dei Ghedali, eroi della diaspora che sono passati per i camini trasformati in cenere da un mondo brutale e non più umano? Per gli uomini di buona volontà che non credono alla fine della Storia, che non vogliono essere definitivamente consegnati al dominio di Mamona, l’idolo dell’oro nel suo ultimo e subdolo travestimento del cosiddetto libero mercato che vuole il sacrificio dei nostri figli, e da ultimo per gli uomini che ancora credono alla possibilità di conquistare su questa terra libertà, giustizia, uguaglianza e bontà.
Se vuoi approfondire, su ateatro puoi leggere:
§ Conversazione con Moni Ovadia (1995)
§ La mia questione ebraica di Oliviero Ponte di Pino (sugli spettacoli di Moni Ovadia)
§ Sei spettacoli teatrali su Raidue di Oliviero Ponte di Pino (su Oylem Goylem)
§ La forza della tradizione, una testimonianza di Moni Ovadia
§ Ci sono cose che non si possono dire ai morti?, una lettera aperta di Oliviero Ponte di Pino a Moni Ovadia (a proposito di Tevjie e noi)
Il Bread & Puppet a Milano
Un po' di documentazione
di Redazione ateatro
Il Bread & Puppet, lo storico gruppo fondato da Peter Schumann, è in questi giorni in Italia con il suo ultimo lavoro, The Oratorio of the Possibilitarians, in scena al Teatro dell'Arte di Milano fino al 26 ottobre, per il progetto speciale curato da Eti & Crt.
Qui di seguito, uno dei testi chiave di questo lavoro, che coinvolge decine di giovani volontari sulla scena.
Manifesto dei Possibilitari
1) La dichiarazione universale della non importanza del denaro deve essere ridipinta sulle porte di abitazioni e istituzioni
2) La realtà attuale, che governa il sistema del Nemico-della-Natura deve essere ridefinita come irrealtà. Così, la irreale realtà del paradiso possibilitario deve essere la luce guida per tutte le nuove definizioni di realtà.
3) La sfiducia totale del consumatore deve essere la base di una nuova economia del non profitto
4) Lo slogan "richiedere vita e paghe più basse" deve essere urlato a tutte le manifestazioni possibilitarie.
5) Le mani, che sono state sottratte ai cittadini a favore del sistema digitale, devono essere restituite ai legittimi proprietari in condizioni migliori.
6) Il cielo deve essere restituito alla sua funzione illuminatrice per tutti gli aspetti della vita quotidiana.
7) Esercizi di paradiso, come la regolare celebrazione di colori quali il verde, il marrone e tutte le tonalità fangose del marrone devono essere nuovamente istituiti.
8) Università dei piedi devono essere fondate per compiere ricerche sulla storia dei piedi e le sue implicazioni rispetto allo stile di vita artificiale dei piedi nel sistema del Nemico-della-Natura.
9) L'interesse degli stomaci per l'accesso diretto a orti e/o frutteti del paradiso deve essere opportunamente sostenuto
Se volete approfondire, in ateatro45 speciale teatro di figura, si parlava molto del Bread & Puppet, in occasione del soggiorno e della mostra fiorentini dello scorso anno.
Cattedrale di Cartapesta
Il Bread & Puppet a Firenze
di Alessandra Giuntoni
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro45.htm#45and8
Guida alla lettura
Appunti sul Bread & Puppet e su Peter Schumann
di Andrea Mancini
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro45.htm#45and9
27 anni dopo
Incontro con Peter Schumann
di Massimo Schuster
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro45.htm#45and10
Uomini nudi nel nuovo logo di "ateatro"?
Decine di maschi disinibiti invocano il nuovo numero della strepitosa webzine
di Ufficio grafico ateatro
Stiamo pensando di cambiare il logo della nostra webzine, che ci pare ormai invecchiato.
Pensiamo di fare cosa gradita a buona parte dei frequentatori del sito inserendo nel logo una folta schiera di uomini nudi e allegri che inneggiano alla prossima uscita del nuovo numero di ateatro.
Quella che potete vedere in anteprima è ovviamente una versione beta. Stiamo pensando di chiedere a un coreografo di affinare i movimenti dei danzatori.
Pur rendendoci conto che si tratta di un trucco abbastanza vergognoso, contiamo anche di intercettare numerosi navigatori che digitano nei motori di ricerca paroline come "sesso", "nudo", "maschi nudi", "uomini nudi", "orgia", "carne cruda", "sesso di gruppo", "X", "XX", "XXX", "XXXX" &cc&t&ra (le abbiamo scritte apposta).
Arriveranno su ateatro arrapatissimi, ma verranno certamente conquistati dalle nostre dotte analisi sull’uso del video negli spettacoli di Sellars, sui rapporti genetici tra le diverse onde della ricerca italiana, sulle discussioni a proposito del futuro dei festival teatrali, e parteciperanno ai forum con maggiore impegno degli abituali visitatori, che sono così timidi e pudichi.
Il rischio è che i motori di ricerca più moralisti ci escludano dalle loro videate. Anche se, avendo già pubblicato saggi sulle versioni hard di Shakespeare, stroncature della Fura dels Baus & varie alcune scandalose polemiche sul sistema teatrale italiano, dovremmo già essere nelle loro blacklist.
Per vedere in ateprima il nuovo logo di ateatro clicca qui. La visione è rigorosamente vietata ai minori di 18 anni.
Attendiamo ovviamente suggerimenti e proposte alternative.

