L'editoriale di ateatro 57
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro57.asp#57and1
Il Mittelfest tra serie A e serie B
L'edizione 2003 dedicata alla comicità italiana e mitteleuropea
di Alessandro Romano
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro57.asp#57and20
Volontari dietro le quinte
Diario di una stagista da Santarcangelo a Castiglioncello a Arcidosso
di Noemi Quarantelli
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro57.asp#57and21
Le recensioni di "ateatro": Di animali uomini e dei
di Giorgio Barberio Corsetti, dalle Metamorfosi di Ovidio
di Clara Gebbia
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro57.asp#57and30
Anticipazioni: César Brie e il Teatro de Los Andes
L'introduzione del volume pubblicato da Ubulibri
di Fernando Marchiori
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro57.asp#57and40
Un teatro mandalico
Un mail a Giacomo Verde, Andrea Balzola & Co.
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro57.asp#57and50
L'ipertesto mandalico
Un mail a Oliviero Ponte di Pino
di Andrea Balzola
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro57.asp#57and51
Robert Lepage porta in Europa il nuovo allestimento della Trilogie des dragons
La recensione della prima edizione dello spettacolo (1991)
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro57.asp#57and60
Crescono i consumi culturali degli italiani
I dati Istat e l’indagine Astra Demoskopea
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro57.asp#57and80
Manifestival: la polemica su Santarcangelo 2003
Gli interventi di Gianfranco Capitta e Gianni Manzella sul "manifesto"
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro57.asp#57and81
Noccioline di Fausto Paravidino è la pièce straniera dell'anno
Il referendum di "Theater Heute"
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro57.asp#57and82
Il teatro delle donne all'Odin
Il festival e gli incontri a Holstebro, 15-25 January 2004
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro57.asp#54and84
Online www.ildramma.it di settembre
Il sommario
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro57.asp#57and85
Niente Teatro Lirico per Dell'Utri e Longoni
Il Tar della Lombardia dice no
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro57.asp#57and86
Che fare dei festival?
L'editoriale di ateatro 57
di Redazione ateatro
Quella del 2003 è stata insieme l’estate dei festival e l’estate della crisi dei festival - e non solo perché il blocco dei maggiori festival francesi da parte degli «intermittents du spectacle» ha conquistato le prime pagine dei giornali di tutta Europa.
Per fermarsi al nostro paese, da un lato - come ha testimoniato il forum dei Festival, che ha segnalato decine e decine di rassegne piccole e grandi - l’Italia è sempre più «il paese dei festival», dalle Alpi allo Ionio. Questa proliferazione testimonia una straordinaria ricchezza di proposte e di progettualità, in località e situazioni a volte imprevedibili. Dal punto di vista della diversità genetica, l’Italia dei festival ricorda la foresta amazzonica.
Di fronte al progressivo appiattimento delle stagioni invernali su modelli consolidati, il teatro estivo regala un maggiore margine di rischio, la possibilità di sperimentare terreni nuovi, soprattutto dal punto di vista della definizione dello spazio teatrale e del rapporto con il pubblico (nelle metropoli le norme della sicurezza vengono evidentemente applicate con burocratica ferocia). Queste caratteristiche hanno un forte impatto: attirano spettatori spesso curiosi e attenti, interessati a scegliere e fare una esperienza in qualche modo insolita, eccezionale, «festiva», che a inserire nei normali ritmi di vita urbani, «feriali», gli aspetti culturali e civili del teatro. A questo punto diventa interessante scoprire se chi affolla i festival estivi continui a frequentare le sale teatrali anche d’inverno. Insomma, se non comincino a delinearsi due gruppi (o tipi) di spettatori teatrali.
E’ però fin troppo facile cogliere i rischi di questa situazione: molte di queste iniziative hanno corto respiro (o un respiro vagamente turistico) e implicano uno spreco di risorse, energie e denaro che si disperdono in mille rivoletti. Nel meccanismo ha certamente un ruolo chiave quel «funzionariato intellettuale» (genericamente di sinistra) contro cui Goffredo Fofi si è scagliato con solito il rischio fare di ogni erba un fascio): un ceto alla continua ricerca di progetti da patrocinare e dunque di legittimazione, sempre sospeso tra le necessità e le lusinghe dell’impegno culturale e l’imperativo di costruire consenso con iniziative para-televisive. In secondo luogo, questa impostazione spinge verso la creazione dell’evento, di una eccezionalità irripetibile (e magari giocata sull’appeal di curiosità extra-teatrali, e su investimenti spesso ingenti) per pochi eletti.
Questa tendenza riflette più in generale la crisi della «forma festival», un problema su cui si dibatte da anni e che continua a trovare soluzioni diverse. Una rassegna gloriosa come il Festival dei Due Mondi di Spoleto sembra giunta alla fase terminale del proprio declino. La Biennale di Venezia cerca faticosamente di mettere a punto una forma credibile di direzione artistica. Sul ruolo e sul destino del Festival di Santarcangelo, da sempre punto di riferimento della ricerca italiana, si discute con passione (basta vedere il dibattito sul «manifesto», di cui «ateatro» rende ampiamente conto: nel forum, nel 56 e in questo 57).
La nostra cultura teatrale (e forse non solo) sembra vivere una sorta di schizofrenia. Da un lato una serie di esperienza di notevole impegno e peso culturale, che hanno a volte respiro internazionale, ma in genere marginalizzate dal sistema teatrale (ma senza la forza di costruire un sistema o un circuito alternativo). Dall’altro l’universo dei cascami della televisione, che pare colonizzare i diversi ambiti della cultura, dell’arte, della comunicazione. Il sistema teatrale e culturale, le istituzioni che avrebbero dovuto fare da cerniera tra questi due universi, pare aver rinunciato al proprio ruolo, cercando semplicemente di sopravvivere salvando orticelli sempre più miseri.
Qualche anno fa Leo De Berardinis aveva lanciato un manifesto per un «teatro popolare di ricerca». Ma il popolo non c’è più, cancellato dalla massa degli individui consumatori. Ci sono poi delle élite (non per censo, quanto per scelta, per affinità) che continuano a produrre (e cercare) cultura. Mettere in comunicazione questi due universi diventa ogni giorno più difficile. E’ molto più facile incanaglirsi seguendo l’audience oppure trovare identità e forza nella marginalità, rinchiudersi nel ghetto dei puri & duri. E tuttavia ci sono esempi di artisti che paiono aprire nuove strade, artisti in grado di misurarsi con queste due dimensioni senza perdere la loro identità.
In ogni caso non è solo un problema di crisi di identità dei festival. La situazione del teatro italiano - e in particolare quella del nuovo teatro - è molto difficile. Le risorse pubbliche stanno progressivamente diminuendo, e questo implica sia una sempre più complessa e difficile attività di ricerca di sostegno e di mediazioni presso gli enti locali (che spesso hanno un’idea assai diversa di politica culturale), e dall’altro impone il ricorso a fonti di finanziamento private che inevitabilmente finiscono per far sentire il loro peso anche sulle scelte artistiche. Così molte realtà semplicemente chiudono, e altre rischiano di cambiare la loro natura. In generale, le sempre più rare «isole felici» rischiano l’estinzione.
Gli stessi artefici dei festival italiani sono evidentemente consapevoli di questo intrico di problemi. Alcuni di loro hanno provato a creare un primo coordinamento, ma finora senza risultati apprezzabili.
Forse è il caso di aprire una riflessione su questi temi. ateatro ha chiesto ad alcuni operatori di contribuire alla discussione (speriamo di ospitare qualche intervento a partire dal prossimo numero), ma il dibattito è aperto agli interventi di tutti: lo spazio del forum NTVI è a disposizione.
Nel frattempo, in questo ateatro 57 offriamo alcuni spunti: oltre agli interventi di Capitta e Manzella sul «manifesto», la cronaca dal Mittelfest di Alessandro Romano e il diario di Noemi Quarantelli, che ha seguito come stagista tre festival tre (»ci vuole un fisico bestiale»...).
Ma in ateatro 57 non si parla solo di festival: ci trovate l’introduzione del libro dedicato a César Brie e al suo Teatro del los Andes, la recensione di Clara Gebbia alla seconda puntata del lavoro che Giorgio Barberio Corsetti sta dedicando alle Metamorfosi di Ovidio, il ritorno della Trilogie del dragons di Robert Lepage, una mail di Oliviero Ponte di Pino e la risposta di Andrea Balzola sulle Storie mandaliche di Giacomo Verde e del medesimo Andrea Balzola (ma intanto x capire un po' di cosa si parla guardatevi le animazioni flash della Storia del Mandorlo con il super-sound del mitico Lupone - basta cliccare & avere caricato flash6 o superiori). E ancora, molte molte news...
Il Mittelfest tra serie A e serie B
L'edizione 2003 dedicata alla comicità italiana e mitteleuropea
di Alessandro Romano
"Sorrisi d’Europa" è il titolo della dodicesima edizione del Mittelfest: svoltasi come consuetudine a Cividale del Friuli dal 19 al 27 di luglio, la rassegna ha rivisitato la comicità italiana e mitteleuropea con svariate produzioni nostrane e diverse provenienti da alcuni paesi del Centro Europa.
Ma partiamo dalla fine. Perché alla fine si traggono le somme, si fanno i conti e quasi mai tornano. Soprattutto quando si parla di teatro. Giorgio Pressburger, direttore artistico della manifestazione, ha fatto pubblica ammenda della sua decisione di creare due cartelloni, uno "ufficiale", e un altro di eventi "collaterali". "L’unità del festival va salvaguardata", commenta Pressburger, "e per il futuro sarà meglio evitare sdoppiamenti". Questa scelta, incoraggiata anche dalla presidenza del Mittelfest, ha creato qualche dissapore specie tra quegli artisti del territorio che si hanno visto il proprio lavoro relegato ad una categoria inferiore (di serie B), dimostrando invece, a conti fatti, di meritare ben altra collocazione. L’élite di Cividale ha comunque calorosamente applaudito le scelte del direttore artistico riempiendo le varie piazze della città, scenario di quasi tutti gli spettacoli di lirica, musica e balletto.
La prosa ha trovato invece spazio nel Teatro Ristori, mai gremito come nelle attese, eppure scenario degli spettacoli più intelligentemente articolati e riflessivi, anche se almeno in apparenza meno affini al tema proposto da quest’edizione: la comicità.
Il Teatr Ludowy con Un inverno sotto il tavolo di Roland Topor (tra i fondatori del Gruppo Panico assieme ad Arrabal, Jodorowsky e Sternberg), diretto da Krzysztof Rekovsky, ha ricreato la sensibilità e l’atmosfera, i modi e i ritmi della propria terra natale. È una disincantata visione di un paese, la Polonia, che si distende delicatamente su un racconto capace di emozionarci con un linguaggio semplice, umano. È il respiro di quell’Europa centro-orientale che ci alita addosso le amare speranze e le vane illusioni di vite umane disposte a cercare di guadagnarsi il diritto alla sopravvivenza, a combattere le proprie paure aggrappandosi, con il sorriso sulle labbra, a una qualsiasi mano protesa e acquietare così, almeno temporaneamente, l’angosciosa precarietà di una cruda esistenza. La vicenda è quella di un umile immigrato che cerca in Francia una via di fuga alla sua miseria. Trova asilo nella casa di una giovane traduttrice che lo accoglie mettendogli a disposizione l’unico posto della sua casa ancora abitabile. Ambientando la vicenda sotto un tavolo, spazio insolito, spazio angusto e intimo, nicchia e microcosmo, il regista trasferisce sul palcoscenico un difficile ed estremo episodio di convivenza, una bella e appassionante storia di solidarietà e d’amore. Dietro a uno spesso muro di pregiudizi, tabù, riserbo e costrizioni, si intravede lo spazio per un dialogo, magari affrettato o timidamente biascicato, che anima e rincuora l’esistenza di due disadattati, due vite diversamente colpite dall’ingiustizia della storia, che sopravvivono regalandosi la serenità di un affetto semplice, puro, vero. A non convincere del tutto è la costruzione scenica del testo: l’impressione è spesso quella di un collage di tante brevi scenette, quasi sempre interrotte prima che si risolvano drammaticamente. Sono le entrate improvvise degli attori, i repentini cambi di ritmo, le altrettanto rapide variazioni di tono a spezzare la rappresentazione in tanti vivaci ma incompiuti quadretti, che se da un lato danno freschezza e rapidità all’azione, dall’altro risolvono troppo frettolosamente alcuni episodi drammatici.
Il Teatro Nazionale del Montenegro, già ospite del Mittelfest nel 2000 con I Montenegrini, quest’anno ha optato per un’immersione nel mondo dell’assurdo. Ionescomania è il frutto di un’ampia e curata incursione nell’attività teatrale di Eugène Ionesco, drammaturgo che assieme a Adamov e Beckett ha messo in luce i paradossi e in dubbio le certezze di un secolo. Il regista Eduard Miler, che ha curato anche la scenografia, ha fedelmente rispettato le regole della poetica dell’assurdo con una messa in scena minimalista, essenziale. Gli attori hanno giocato ossessivamente con il linguaggio riflettendo sul valore della comunicazione nei rapporti umani.

Da La cantatrice calva, Delirio a due e Il rinoceronte, forse i tre testi più noti dello scrittore rumeno, il collage di temi, frasi e discorsi che hanno provocato frequenti e fragorose risate. Grande divertimento con uno dei classici della comicità goldoniana, Le baruffe chiozzotte, allestite dal Dramma italiano di Fiume assieme ad Atlantide Teatro di Verona ad A. Artisti Associati e Ateatri Aspa. Un allestimento vivace all’insegna del recupero delle radici culturali popolari, con un’attenzione particolare alla lingua vernacolare nei suoi variegati accenti. Una prova corale di grande effetto, orchestrata dal regista Pierluca Donin, grazie soprattutto all’entusiasmo, all’energia e all’affiatamento degli interpreti. Un lavoro stilisticamente impeccabile, ma sostanzialmente troppo artificioso e carente di verità, di umanità.
Da segnalare le quattro produzioni del Mittelfest, accomunate dall’intento di stupire il pubblico e meravigliarlo con adattamenti scenografici e dislocamenti spaziali inusuali e suggestivi. Scelte stilistiche che se da un lato hanno soddisfatto una poetica del bello, dell’immagine, dall’altro si sono rivelate pressoché prive di significazione drammatica. Allestimenti sfarzosi, ricercati, preconfezionati per un "divertimento facile e imbellettato".
La piazza San Francesco ha fatto da cornice all’apertura della dodicesima edizione della kermesse, ospitando lo spettacolo di danza Per la dolce memoria di quel giorno. Per l’occasione sono stati convocati artisti del calibro e della fama di Carla Fracci, Gheorghe Iancu e Lindsay Kemp.


Una scelta di sicuro esito ed effetto voluta dal direttore della manifestazione per rendere omaggio al compianto amico e musicista Luciano Berio. La partitura che ha scandito i rimi e le melodie dello spettacolo era stata da lui realizzata nel 1974 per il balletto di Maurice Bèjart, commissionato dalla RAI a celebrazione del sesto centenario della morte di Francesco Petrarca.
Un’altra piazza ha accolto la burletta per musica in un atto di Luigi Prividali L’occasione fa il ladro, apprezzando ancora una volta le diverse trovate scenografiche che hanno impreziosito la recitazione degli interpreti. Diversi i momenti della rappresentazione ravvivati dall’entrata in scena festosa e allegra di piccoli angioletti, impersonati dalle allieve della scuola di danza Erica Bront, capaci, con la loro spontaneità, di divertire e far sorridere il pubblico. Da evidenziare l’intelligente succedersi di proiezioni video (allestimento curato da Martina Kafol con la collaborazione dell’Università di Udine e il Corso di Laurea in Tecnologie Multimediali di Pordenone), che hanno alternato le cartoline di una Napoli settecentesca a ritratti femminili sul modello di quelli di Warhol, ad animazioni e ai primi piani dei cantanti colti nell’impegno di un acuto. Ancora distrazioni estetiche, immagini affascinanti per sbalordire, strabiliare, guadagnarsi il consenso del pubblico.
Altra produzione Mittelfest, Le Ballate di Petrica Kerempuh, progetto e regia di Giorgio Pressburger, interpretate da un esplosivo ed esilarante Bebo Storti e inscenate anch’esse in una piazzetta della cittadina friulana. Ancora una dislocazione anomala per raccontare i mille modi in cui la gente ha pianto, ha riso, ha gridato, invocato e imprecato i santi. Ancora una scenografia descrittiva, animata da movimenti coreografici disarmonici e gesticolazioni alquanto approssimative con l’intento, non proprio riuscito, di accompagnare visivamente la lettura di questi piccoli e vivaci componimenti nati dalla penna dello scrittore croato Miroslav Krleza. È senz’altro mancata una concezione organica e sciolta dei movimenti individuali di comparse e figuranti, plastiche silhouettes confinate in una dimensione pittorica più che veri corpi umani. Il proposito era quello di rappresentare un vivace affresco della cultura popolare, invitando lo spettatore a parteciparvi e persino a degustare del prosciutto e della birra. Il risultato è stato ben diverso visto che il pubblico ha assistito distratto e passivo allo svolgersi della lettura più disorientato che attratto da questi personaggi evocati dalla lettura che timidamente e goffamente animavano la piazza.
Ultimo dei quattro eventi prodotti dal Mittelfest, il Satyricon di Petronio, musicato dall’eccellente compositore Bruno Maderna, il cui importante lavoro di librettista l’amico Pressburger (assieme avevano fondato lo studio di Fonologia Musicale a Milano nel 1955) ha voluto ricordare a trent’anni dalla sua scomparsa. Purtroppo lo spettacolo è stato relegato, causa le bizze del tempo, al freddo e angusto spazio di una palestra. Un gorgheggiare orgiastico, volgarmente condito di cibo, danaro e voluttuosità, forse un eccesso di scoordinati e provocanti movimenti scenici che hanno danneggiato lo svolgersi dell’azione drammatica e messo ingiustamente in secondo piano le virtù canore degli interpreti. A questo va aggiunto un travestimento approssimativo e ridicolo voluto per far partecipare anche parte del pubblico alla cena di Trimalcione). Un risultato stilistico non certo pregevole salvato dalla bravura dei cantanti e dall’impeccabile esecuzione dell’Orchestra della Toscana, diretta da Luca Pfatt.
Numerose anche le iniziative musicali che hanno trovato quasi sempre spazio nell’accogliente piazza del Duomo: vale la pena menzionare il concerto del trombettista e compositore triestino Enrico Rava, accompagnato da jazzisti di primo livello come il trombonista Gianluca Putrella, il pianista Stefano Bollani, il contrabbassista Ares Tavolazzi e il batterista Roberto Gatto. Per loro tanti applausi. Applausi più contenuti invece per la rilettura del libro Cuore a cura di Paola Cortellesi. Diretta da Francesca Angeli e accompagnata dalla voce di Matelda Viola, dal pianoforte di Fabrizio de Rossi e dal contrabbasso di Gianfranco Tedeschi, la talentuosa ed esilarante attrice non ha potuto esprimere il meglio di sé, convincendo meno del solito nella personale rilettura interpretativa del libro di De Amicis. Infine il concerto di Eugenio Finardi che ha proposto alcuni pezzi del suo ultimo album L’uomo a metà, ma anche i suoi vecchi successi.
Sicuramente uno degli spettacoli più coinvolgenti e "intimistici" del Mittelfest è stato Cercivento. La terza replica inaspettatamente segna un nuovo tutto esaurito; all’inizio sono alquanto insofferente alla scomodità: costretto in piedi per un’ora e mezza, dubito di resistere sino alla fine. Ma basta qualche minuto per ricredermi, per lasciarmi travolgere. Carlo Tolazzi riscrive e riadatta il testo di Maria Rosa Calderoni La fucilazione dell’alpino Ortis. La storia è quella di quattro alpini fucilati dietro il cimitero di Cercivento dopo un processo per direttissima, rei di "rivolta in presenza del nemico", ovvero di essersi opposti a un’azione suicida. È il 1° luglio 1916, siamo nel bel mezzo della Prima guerra mondiale. Il controverso e oscuro episodio viene riportato alla luce dai parenti delle vittime, i cui sforzi per riabilitare le vittime non sono ancora andati a buon fine. C’è tanta rabbia nel testo, ma anche una lucida volontà di far sì che fatti tanto raccapriccianti si depositino nelle coscienze degli spettatori. Sono attento e nonostante il caldo infernale anche i ventagli hanno smesso di agitarsi; gli occhi di noi tutti sono fissi sulle azioni e sulle parole dei due interpreti della vicenda, il carnico Basilio Matiz (Massimo Somaglino) e il maniaghese Angelo Massaro (Riccardo Maranzana), i due protagonisti di questa triste storia. Sono loro a liberare la paura, la rabbia, le lacrime di chi è colpevole senza esserlo.

L’azione si svolge al centro di un cerchio, che è anche prigione, confine, un buco nero che si apre su un episodio di insubordinazione di due individui, uomini prima che soldati. Un caporale e un soldato semplice, condannati alla fucilazione, per non aver obbedito al comando di un superiore, che gli intimava una eroica, quanto avventata azione di sfondamento delle linee del nemico. In cella i due condannati trascorrono le ultime ore di vita alternando amare riflessioni a felici ricordi, scatti di rabbia ad abbracci teneri e solidali. È un fluire continuo di emozioni e lo spettatore lo percepisce, ne rimane contagiato. Un allestimento scenico essenziale e carico di significati storici e geografici: i due protagonisti sono accerchiati da diversi oggetti, citati e non, a riecheggiare immagini e visioni dell’epoca della Grande Guerra. Lo spettatore ha la possibilità di costruire il suo ricordo aprendo una nuova porta verso questo passato, recuperando immagini lette e rubate ai racconti dei suoi padri, dei suoi nonni, per scorrerle nuovamente accompagnato da un vibrante e appassionato dramma, quello che Basilio e Angelo rivivono per noi. Sono due caratteri diversi che esternano due reazioni in apparenza contrastanti di fronte alla condanna e alla morte imminente: disperato e rassegnato il primo, indomito e irascibile il secondo. Ma quando è ormai prossimo il momento dell’esecuzione i ruoli si invertono ed è proprio Angelo, in lacrime, a crollare tra le braccia dell’amico, svelando tutta la sua angoscia per una fine ingiusta e terribile. Basilio l’abbraccia nel più puro e leale gesto di amicizia. Le parole, le frasi, le speranze riversate in un fitto e serrato dialogo, motore di gran parte della rappresentazione, si condensano in un gesto di grande significato e valore. L’ultimo abbraccio di Basilio che rincuora l’amico pochi istanti prima della fucilazione. L’ultimo gesto di fratellanza e di solidarietà di fronte alla morte che accomuna tutti: il carnico al maniaghese, il nemico all’amico, il vicino al lontano, il nero al bianco, l’israeliano al palestinese. Risalta la grande fisicità della pièce che prevede un costante interagire fisico tra i due protagonisti quasi a voler rimarcare il significato di parole ed espressioni pronunciate troppo in fretta, soprattutto nei frangenti in cui lo scambio di battute si fa serrato, concitante.
L’ultimo atto del Mittelfest ha raccolto nel Chiostro della Chiesa di san Francesco il pubblico delle grandi occasioni. Nessuno ha voluto perdere le Microcommedie, sedici brevi testi teatrali commissionati ad altrettanti drammaturghi dell’Europa centro-orientale, recitati con bravura da un gruppo di dodici attori diretti da Giuseppe Rocca. Già due anni or sono i Microdrammi avevano decretato il successo di una bellissima edizione del Festival, venendo replicati in autunno alla Sala Tripcovic di Trieste, nell’ambito della stagione di prosa del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Anche quest’anno l’applauso è scoccato unanime verso gli autori e gli interpreti di questi racconti drammatizzati, rapidi e coinvolgenti sguardi sulla comicità mitteleuropea, formula vincente di una manifestazione che ha trovato nella ricchezza artistica e nello scambio interculturale le chiavi del suo successo.
Volontari dietro le quinte
Diario di una stagista da Santarcangelo a Castiglioncello a Arcidosso
di Noemi Quarantelli
C’era, questa estate, una Cinquecento verde, carica di bagagli, in giro per le strade italiane, e, alla guida c’ero io, Noemi, 25 anni, una laurea in Lettere, un Master in Teatro iniziato da pochi mesi, tante aspettative per il futuro e desideri di conferme.
Ora, dopo due mesi, al mio ritorno a casa, porto con me l’esperienza vissuta come stagista in tre diversi festival di teatro, e cerco faticosamente di tirare le somme di un periodo estremamente intenso e significativo.
"Santarcangelo dei Teatri", "Armunia, Festival Costa degli Etruschi", "Toscana delle Culture": queste le tre tappe del mio viaggio.
"Santarcangelo dei Teatri": la prima impressione
Ricordo la sensazione della prima partenza, da Pisa, in un pomeriggio torrido: negli occhi ancora brillavano i Lungarni illuminati per la festa di san Ranieri, e nella mia testa risuonavano le parole dell’ultima lezione del Master prima della pausa estiva.
Il viaggio iniziava con la netta percezione della necessità di pratica, dopo mesi trascorsi tra lezioni teoriche e libri. L’obiettivo era imparare a fare, capire cosa realmente fosse questa "organizzazione" per la quale avevo deciso di investire tutto il mio tempo e le mie energie.
Il Master si è interrotto con Andres Neumann che, all’aria aperta e a piedi nudi sull’erba, a una classe di studenti in partenza per gli stage ha riferito quel che anni prima gli aveva detto Peter Brook: in teatro bisogna saper conservare sempre "l’attenzione della spia in una città nemica", aggiungendo poi che non bisogna mai dimenticare il motivo per cui ci si trova in un posto, non perdere mai il contatto con ciò che si sta facendo.
Sono partita con gli occhi bene aperti, decisa a non lasciarmi sfuggire nulla.
Certo che tutto mi è sembrata fuor che una città nemica Santarcangelo di Romagna, prima tappa del mio viaggio, dove sono arrivata il 17 giugno e dove sarei rimasta per un mese, fino alla fine del festival.
L’impatto è stato spaesante, travolgente: mai visto il festival di Santarcangelo, in realtà mai visto un festival prima di allora. Difficile da immaginarne il clima: immediata è stata la percezione di transitorietà, necessaria l’accettazione di alcune condizioni chiare: flessibilità, adattabilità, assoluta disponibilità. E’ una realtà in cui gettarsi a capofitto, una macchina da cui lasciarsi risucchiare, assorbire, un mondo che ingloba ed esclude l’esterno. Si avverte da subito una compressione assoluta del tempo nella quale si bruciano in pochi giorni mesi di lavoro e per la quale tutto acquista un’accelerazione incredibile. Le conoscenze, le amicizie, le relazioni sono velocissime e innumerevoli, tutto si consuma nella frenesia, nell’adrenalina pura.
Un festival vive dell’effimero che lo sostanzia.
C’è stato bisogno di qualche giorno per ambientarmi, poi è iniziato il conto delle ore di sonno perso. Mai parole furono più profetiche di quelle che Oliviero Ponte di Pino mi disse il 16 giugno, quasi come avvertimento: "Ma tu lo sai che a Santarcangelo non dormirai mai?".
Il popolo degli stagisti
Forse si parla sempre poco di queste figure "marginali", ma credo che sia importante considerare il fatto che, soprattutto in clima di tagli e ristrettezze economiche, molto spesso i volontari sono una delle risorse più importanti che consente la realizzazione materiale di un evento complesso come un festival.
Uno stage è fondamentalmente un’esperienza a doppio scambio e un arricchimento reciproco: lo stagista si mette a disposizione di una struttura, lavorando gratuitamente; in cambio riceve vitto alloggio e tutta una serie di opportunità che, a partire dai propri interessi, deve riuscire a capire e carpire. Per questo motivo uno stage può tramutarsi in una grossa occasione per imparare a "fare", capire come funzionano realmente le cose sul campo; il fatto di essere quotidianamente circondati da giornalisti, operatori, critici, artisti, è sicuramente una condizione ideale per il confronto continuo. A livello professionale, chi non ha esperienza e tuttavia vuole intraprendere un certo mestiere, ha la possibilità di vedere da vicino alcuni modi di operare, alcuni metodi di lavoro (perché non c’è n’è soltanto uno): sta poi all’abilità di ognuno "rubare", selezionare e trattenere ciò che si ritiene funzioni e capire quali sono gli errori da evitare di commettere in futuro.
Io credo che l’apporto dato dagli stagisti al festival di Santarcangelo non sia trascurabile, anzi ritengo che sia materialmente indispensabile. Intorno a un nutrito organico di base, infatti, ruota circa un centinaio di ragazzi per la maggioranza provenienti da Università, corsi di formazione post-universitaria, scuole di teatro. Quel che ancora oggi mi meraviglia è come tante persone fra loro estranee possano riuscire a compattarsi in una squadra efficiente in così breve tempo. Credo che in questo stia il successo di un festival dal punto di vista organizzativo: quando si è in grado di dare un fine comune alle azioni di ognuno e suscitare un senso di appartenenza a un luogo e a un gruppo di lavoro.
Durante l’ultima edizione del festival, gli organizzatori hanno pensato di considerare in modo nuovo il ruolo di queste figure di "contorno". Poiché la realtà è che lo stagista arriva sempre a macchina già avviata e rischia di ritrovarsi a svolgere compiti che sembra non abbiano attinenza alcuna con l’organizzazione di un festival (vedi la tanto temuta e aborrita fotocopia…).
I giorni immediatamente precedenti l’inizio della kermesse sono stati dedicati anche ad attività che consentissero di avere da subito una visione globale e non parcellizzata di un ambiente lavorativo dalla struttura ben definita. In un’idea di progetto di tutoraggio per gli stagisti, è stata pianificata una serie di incontri con tutti i responsabili dei vari settori, finalizzata alla presa di coscienza dell’effettivo ruolo di ognuno e delle competenze di ciascun ufficio. In questo modo, abbiamo potuto comprendere più facilmente il funzionamento interno dell’intero sistema, riuscendo così ad avere una percezione esaustiva di quello che è un metodo di lavoro estremamente sfaccettato e di primo acchito spiazzante. Perciò, qualunque fosse l’incarico assegnato, abbiamo preso atto del perché della nostra presenza, compreso più facilmente i nostri compiti e gli obiettivi del nostro lavoro senza mai perdere di vista il risultato globale che è il fine anche della mansione più umile.
Quest’anno il progetto è partito informalmente: si è trattato di un esperimento pilota che non ha avuto una definizione ben precisa proprio perché si è adeguato giorno per giorno ai tempi e ai modi di un festival che devono e non possono non essere estremamente flessibili. In prospettiva, però, si è profilato un progetto formativo da istituzionalizzare anche in collaborazione con enti preposti alle attività di formazione. Pur non essendo ancora del tutto chiare le modalità di tale progetto, tuttavia era ben chiara l’intenzione di dare visibilità e maggior peso anche a quelle persone che spesso si limitano a svolgere mansioni di pura manovalanza e che probabilmente sono soltanto di passaggio.
Credo che sia un gesto di grande attenzione nei riguardi dell’enorme risorsa costituita dai volontari. Gli organizzatori hanno capito che se c’è consapevolezza c’è maggiore responsabilità, se c’è partecipazione c’è maggiore affezione, e, quando si lavora in gruppo, e per di più in teatro, la condivisione è tutto.
Un’esperienza fra le tante, la mia
Raccontare uno stage è compito assai arduo: ogni giorno dura un attimo e si conclude come una settimana a ritmo accelerato. Anche a distanza di poco tempo il ricordo è una fitta nebulosa attraversata da flash improvvisi: la lucidità della vita regolata è assolutamente inconciliabile con quel coacervo di impressioni, sensazioni, incontri che è stata la mia esperienza al festival.
Quel che mi resta è un profondo senso di arricchimento, la consapevolezza di essere cambiata, di aver acquisito nuovi strumenti, di avere ancora tanto, tutto da imparare, il desiderio e l’entusiasmo di andare avanti, sostanzialmente una serie di conferme: adesso, nel passaggio dalla teoria alla pratica, so finalmente quale sarà il mio mestiere.
Ho iniziato senza un ruolo ben preciso, e questo mi ha dato la possibilità di guardarmi attorno e di ritagliarmi un posto tra gli altri.
Durante i primi giorni ho svolto i compiti più disparati: telefonate, fotocopie, traduzioni in inglese di schede di spettacoli, ritaglio di articoli di giornale per la rassegna stampa, creazione delle plance. Ho stretto le prime importanti amicizie: le prime serate trascorse in "cantinetta" con le mie coinquiline della foresteria (quando ancora non aveva aperto il Circo) spesso per me erano vere e proprie "lezioni" perché, davanti a un bicchiere di vino, Sonia (la vulcanica responsabile del Circo Inferno) e Alessandra (la responsabile dell’Ufficio Stampa) mi hanno raccontato a lungo e con grande disponibilità la loro esperienza ai festival degli anni passati, elargendo preziosi consigli e suggerimenti.
Sono state loro a parlarmi per la prima volta della dimensione totalmente altra che si vive durante il festival e a farmela desiderare; e sono state loro a contagiarmi con la "malattia" da cui tutti prima o poi ci si ritrova affetti, quando già paventavano con precoce nostalgia il senso di panico e "lutto" in cui sarebbero cadute alla fine del festival.
Nel clima prefestivaliero c’è stato da fare l’ingente trasloco dalla Contrada dei Fabbri alle scuole elementari di Piazza Ganganelli con l’allestimento di tutti gli uffici. Poi ci sono stati gli spettacoli del Premio Scenario con il Lavatoio gremito di ragazzi. Il lavoro preliminare in ufficio procedeva a ritmi sempre più incalzanti. Ricordo la fuga di una mattina in moto con "Pollo" (Paolo Rodighiero, direttore tecnico) per lo spettacolo dei Fanny & Alexander.
Poi il Circo ha aperto i battenti, dato il via alle danze, e il festival è cominciato.
Giornata tipo: Inizio dei lavori: ore 9. Fine delle attività: ore 4 (di mattina…)
Il mio ruolo si è definito: in Ufficio Organizzazione la mattina, la sera "responsabile di spazio", ovvero la persona che si occupa di gestire uno spazio spettacolo e tutto quello che vi accade prima durante e dopo una rappresentazione.
Ho lavorato per cinque sere al Teatro Petrella di Longiano per I canti del caos di Teatro Aperto: lo spazio era bellissimo, un piccolo teatro all’italiana del 1870, con un’acustica fantastica.

Canti del caos di Teatroaperto.
E nella confusione di quei giorni capita di conoscere finalmente Oliviero, sedersi una mattina al bar e intavolare una discussione con lui, Antonio Moresco, Renzo Martinelli e Federica Fracassi.
Ricordo le sere delle repliche e l’ansia per l’ingresso in sala del pubblico, i giornalisti, gli operatori, il desiderio che tutto si svolgesse senza imprevisti,
l’incubo delle casse informatizzate che si inceppano all’ultimo minuto e non emettono più biglietti,
Il direttore organizzativo del festival che viene a salvarti sul suo "motore",
La tesa concentrazione e poi l’abbraccio del regista che ti ringrazia per aver lavorato ogni sera durante le repliche del suo spettacolo,
e il sorriso di gratitudine della compagnia
E ogni sera l’odore di quel teatro, l’odore del teatro che mi si attaccava addosso, forte e indelebile, me lo porto ancora dentro.
E nel frattempo passavano le mattine assonnate in ufficio
Le riunioni e gli innumerevoli "punti della situazione" da fare
I pranzi a mensa, i caffè shakerati al Caffè Commercio
La foresteria di Sant’Ermete con la signora matta del piano di sopra
Le lunghe notti del Circo Inferno, le minacce quotidiane dei carabinieri, e i kebab e le fette di cocomero delle 3 del mattino
Un’attrice della Valdoca che una notte ti legge in macchina le poesie di Fuoco centrale…
Dopo il Petrella, sono stata assegnata a un nuovo spazio, il Teatro degli Atti a Rimini, dove si prevedevano momenti difficili per uno degli spettacoli di punta del festival, Cinema Cielo di Danio Manfredini.
Forse è stata la situazione più difficile da gestire, sicuramente una bella sfida da affrontare.

Cinema Cielo di Danio Manfredini.
La gratificazione vera viene dalla sola ragione
Per la quale valga la pena di fare questo mestiere
L’emozione
Che ogni volta si ripete
Ti scuote dentro
Ti tocca le corde più profonde
La senti nella pancia
E poi montare su
Sudore e lacrime
Struggente poesia di Cinema Cielo
Sconcia e pura
Squallida e immacolata.
Cinema Cielo di Danio Manfredini
Ho visto Cinema Cielo quattro volte, sempre in piedi e sempre con una torcia in mano (da brava Responsabile di Spazio), a controllare la sala.
Ne ho visto l’evoluzione, giorno dopo giorno, ho capito perfettamente cosa significhi l’unicità e l’irripetibilità di un evento: forse è lapalissiano, ma posso dire di aver visto quanto diversa sia una replica dall’altra, quanto parziale e arbitrario sia quindi il giudizio, quanto peso abbia la presenza del pubblico. Ogni sera la risposta è stata diversa e, al sentire diverso di un uditorio, corrispondeva un diverso agire degli attori.
Uno spettacolo del genere è, secondo me, la dimostrazione di come sia superflua la spiegazione razionale di un metodo e dell’intenzione artistica quando un’idea si traduce in atto che non necessita di alcuna rielaborazione teorica.
Spesso alcune operazioni sono poco chiare, spesso gli stessi registi hanno bisogno di spiegare e chiosare in sede preliminare e di sopperire alla mancanza di immediatezza con lunghi programmi di sala e glosse al proprio lavoro.
Altre volte, invece, il messaggio arriva senza mediazioni, superfetazioni, anche irrazionalmente, e l’illustrazione di un metodo può soltanto aiutare al riconoscimento di un qualcosa di cui si è avuta un’esperienza diretta, può soltanto essere una conferma a ciò che si era intuito a prescindere da tutto il resto.
E’ una questione di ingredienti dosati nel modo giusto: l’emozione arriva quando tutto, gesto parola luce musica, è misurato alla perfezione, un po’come una pozione per la quale la magia riesce. A volte è inspiegabile, ma la ritualità del teatro è davvero misteriosa.
Dopo aver visto lo spettacolo, ho letto la Conversazione con Danio Manfredini, pubblicata su "ateatro". Leggerla mi ha fatto annuire, mi ha aiutato a dare una veste razionale e intellettuale a un’insieme di sensazioni che erano arrivate comunque, ad un altro livello, e attraverso altri canali di percezione.
Dice Danio che "inizialmente hai una sensazione, che come tale esiste e ti dà un ritmo, ti offre una possibilità di azione, di densità fisica nello spazio, di presenza. Però non sai necessariamente come ricrearla, quella cosa; ma puoi attingere a un immaginario che è un deposito di esperienza personale. E quando suoni un certo tasto, si genera una determinata sensazione: a quel punto hai attinto a una consapevolezza di tipo immaginativo-esperienziale per ricreare quella sensazione, che magari originariamente era una pura sensazione, data dal corpo. E’ come se il corpo facesse un movimento e quel movimento ti procurasse una sensazione, e tu avverti che quella è la sensazione sulla quale dovresti lavorare".
E’ un po’ quello che diceva anche William James: "Il sentimento è il risultato dell’espressione corporea": se per la legge della "pars pro toto" la "pars" suscita il sentimento del tutto, è possibile suscitare un’emozione adottando i moti e gli stati d’animo che le sono propri e quindi può rivelarsi paradossalmente vero l’assunto per il quale "noi non piangiamo perché siamo tristi, ma siamo tristi perché piangiamo".
Questo per quanto riguarda "il lavoro dell’attore su se stesso".
Ecco che però si può andare oltre questo paradosso quando si passa alla relazione tra attore e pubblico: l’evento che accade crea un’esperienza da attraversare e da condividere. Per dirla con Manfredini, "il corpo ha la possibilità […] di scandire momento per momento il passaggio delle sensazioni, dei livelli e degli stati d’animo", rende visibile un processo sensoriale e percettivo che diventa osmotico nel momento in cui si instaura la "relazione tra l’attuazione di quell’esperienza e il pubblico".
Si arriva così a condurre il pubblico a uno stato quasi "patologico" in cui l’emozione è priva di un oggetto preciso, perché lo spettatore parte da stati d’animo per lui immotivati per arrivare a uno stato emotivo necessario. E’come una maieutica che estrae, riuscendo ad attingere al patrimonio emozionale di tutti.
Questo il mio maldestro tentativo di trovare il perché di un’emozione, e spiegare, con parole razionali, l’intensa esperienza di Cinema Cielo…
Il festival poi è finito, con una festa su una collina,
il direttore artistico, scalzo, danzava con i pantaloni arrotolati al polpaccio.
Il giorno dopo sono ripartita.
Castiglioncello, "Armunia, Festival Costa degli Etruschi", sezione "Inequilibrio"
Altro festival, altro stage.
In viaggio dall’Adriatico al Tirreno valicando l’Appennino.
Ho salutato il Circo da smontare che ogni anno lascia visibile per giorni la sua orma impressa sul terreno, e sono partita. L’effimero di cui parlo sta anche in questo: nella necessità della partenza, dei saluti.
Ho imparato che bisognerà abituarsi alle partenze, ma ho anche scoperto che ci si perde per ritrovarsi. E’ proprio vero che il Teatro è una "grande famiglia": perché può capitare di passeggiare per il bosco del Castello Pasquini e sentirsi chiamare dalla voce familiare di Pollo che è in giro con Virgilio Sieni;
rivedere gli spettacoli vincitori del Premio Scenario e fare amicizia con Amal e Samir di Progetto Aisha, assistere insieme allo spettacolo di Federico Tiezzi con Silvio Castiglioni e ripensare al giorno della premiazione a Santarcangelo proprio sulla scenografia di In fondo a destra;

In fondo a destra di Raffaello Baldini con Silvio Castiglioni.
ritrovare Massimo Marino, rispondere alla prima telefonata in ufficio e parlare con Cristina Ventrucci, incontrare di nuovo la solare Frie Leysen a caccia di spettacoli da esportare a Bruxelles…
Tutto torna.
Purtroppo 11 giorni sono pochi per riuscire a capire un altro festival, soprattutto quando si è reduci da un’esperienza coinvolgente come quella vissuta a Santarcangelo. E’ difficile rendersi nuovamente disponibili, riazzerare e ripartire da capo. Il confronto è inevitabile e spesso non consente una visione obiettiva delle cose.
Sono arrivata a Castiglioncello e il festival "Inequilibrio" era appena cominciato: ho dovuto fare un grande sforzo per saltare su una macchina già in moto e mettermi alla pari. E, arrivando in ritardo, mi sono dovuta accontentare dei ruoli rimasti scoperti.
Sono stata maschera la sera durante gli spettacoli, accompagnatrice sul bus navetta, hostess durante un convegno della DBM (Danse Bassin Méditerranée), ancora traduttrice di testi, "volantinatrice". Tuttavia, anche il lavoro di volantinaggio e affissione mi ha consentito di comprendere meglio i meccanismi della promozione (aspetto quanto mai importante), tastare il polso del potenziale pubblico, valutare la strategia promozionale migliore da adottare a seconda degli spettatori, del luogo e dell’offerta degli spettacoli.
Non è poi mancata l’occasione per approfittare di alcune circostanze favorevoli: un’esperienza estremamente interessante è nata grazie alla fortuna di saper parlare l’inglese. Ho infatti collaborato con i tecnici del festival come interprete simultanea aiutandoli a comunicare con un regista americano durante l’allestimento di uno spettacolo: Untitle me di Random Scream. Per un giorno e mezzo sono stata l’aiuto regista di Davis Freeman e la consulente di tre tecnici poco ferrati nelle lingue straniere. Per la prima volta ho assistito allo smontaggio di una scenografia, di notte, e poi all’immediato allestimento della successiva, la "nostra". Ho visto un aspetto che non conoscevo affatto: il lavoro dei tecnici, che è quello che c’è dietro, il lavoro pesante, fatto di sudore e arrampicate ad altezze vertiginose su traballanti elementi sospesi. Quanto mi è sembrato affascinante anche questo lato nell’ombra, nascosto, profondamente materico del lavorare in Teatro… Ho lottato con le difficoltà che i termini tecnici comportavano, cercando al mio meglio di mediare fra l’intenzione dell’artista e la sua realizzazione materiale. Negli intervalli ho rubacchiato qua e là, facendo domande con curiosità inesauribile e costante stupore, su filtri, luci, effetti, suoni.
Abbiamo lavorato in squadra per ore, fino allo spettacolo che ho seguito insieme ai "miei ragazzi" dalla cabina di regia.
Anche da Castiglioncello riporto una profonda esperienza a livello umano, tanti incontri con persone che spero di non perdere.
Il Castello
La realtà del Castello Pasquini è unica. Alla forza centrifuga e irradiante di Santarcangelo corrisponde la forza centripeta e accentrante del Castello, luogo in cui si concentra tutto: uffici, spazi per gli spettacoli, foresteria per artisti e stagisti.
A volte il castello può apparire una "turris eburnea" scollata dalla realtà in cui è inserita, da un territorio che forse non trasmette la necessaria linfa vitale.
Il luogo, dalle enormi potenzialità molte delle quali ancora da scoprire, risente di una scarsa attenzione da parte dell’opinione pubblica, è ostacolato anche a causa di motivi politici ed economici, comunque poco valorizzato proprio da chi dovrebbe invece considerarlo una ricchezza e una risorsa, e questo contro le intenzioni di una direzione artistica dalle grandi idee e dai grandi sogni. E’ un posto che può tramutarsi in una vera dimora, grazie ai progetti di residenze che si svolgono durante l’inverno e ai festival estivi durante i quali si popola di artisti e stagisti.
La residenza è una soluzione incredibilmente interessante: chi ospita offre sostegno logistico, tecnico, a volte economico, dà alle compagnie la possibilità di dormire mangiare e provare, mettendo a disposizione il laboratorio di scenotecnica, le luci, l’ufficio stampa. In cambio gli artisti ospitati mostrano il loro lavoro: prove aperte, training, anteprime, conferenze spettacolo, materiali scenici.

Zero spaccato di Leonardo Capuano.
Zero spaccato di Leonardo Capuano, sicuramente uno degli spettacoli più interessanti del festival, è una nuova produzione nata durante una residenza nel castello, e già mostrata al pubblico nelle diverse fasi di elaborazione. L’ultima edizione di "Inequilibrio" ha presentato lo spettacolo finito, frutto di un lavoro nel quale una direzione artistica sensibile ha fortemente creduto e che ha sostenuto con entusiasmo.
Durante il festival, il terzo piano del castello è la foresteria per le compagnie e gli stagisti. Se la socievolezza non è dote di tutti, tuttavia alcune presenze non si possono dimenticare: Massimo Schuster (la "mamma" delle stagiste), protagonista indiscusso di tutte le colazioni del mattino; Roberto Abbiati, compagno fedele durante le lunghe file per il bagno, Giacomo Verde prima del suo spettacolo in cucina alla ricerca di pane raffermo per le "mollichine" di Hansel e Gretel, e poi Francesco Niccolini, la famiglia Brie al completo…

Hansel e Gretel di Giacomo Verde.
E’ un’esperienza intensa e positivamente demistificante l’incontro con le persone, e non solo con i personaggi sul palco.
I pochi giorni a Castiglioncello sono trascorsi velocemente: il festival finiva e mi sfuggiva ancora qualcosa. Così, dopo l’ultimo spettacolo, è successo che uno spontaneo colloquio con Massimo Paganelli al quale confidavo il mio dispiacere per non essere stata in grado di integrarmi completamente, abbia dato lo spunto al Direttore artistico per intavolare un dibattito estemporaneo. Sull’installazione colorata di Toni Ulivieri, è iniziato un discorso al quale hanno partecipato tutte le persone che hanno lavorato al festival: è stata una riflessione finale, un bilancio, un riepilogo dei successi e degli insuccessi. Interventi vari si sono susseguiti su molti argomenti: dalla qualità degli spettacoli, ai problemi con la stampa locale, le questioni politiche ed economiche, i sogni del "Conte Pasquini" (Paganelli) che romanticamente continua a credere in un ideale utopistico e che conserva ancora negli occhi il guizzo di un ventenne entusiasta della vita.
Ricordo, tra le tante, le belle parole di Paolo Maier e quelle di Gian Maria Tosatti. Quel momento forse è valso tutto il festival, e ne conservo un ricordo vivido e indelebile.
Abbiamo visto il sole sorgere sull’installazione e, quello stesso giorno, anche il mio secondo stage è finito.
La tappa successiva è stata Arcidosso, il festival "Toscana delle Culture" (dove, per inciso, ho incontrato ancora una volta Pollo…).
Ora che sono tornata a casa sono già pronta per una nuova partenza.
Il mio viaggio sembrava appena finito, e invece mi trovo nuovamente e inaspettatamente a partire con la mia Cinquecento, la mia casa viaggiante, guscio di lumaca, ora alla volta di Riccione, per il mio primo lavoro, premio Riccione Teatro, premio Tondelli, prima edizione di una rassegna teatrale.
E’ una coazione a ripetere, è un bisogno ormai innescato: mi tornano alla mente le parole scelte per il progetto del Circo Inferno 2003, quelle di Josè Saramago: "Il viaggio non finisce mai… La fine di un viaggio è solo l’inizio di un altro".
Le recensioni di "ateatro": Di animali uomini e dei
di Giorgio Barberio Corsetti, dalle Metamorfosi di Ovidio
di Clara Gebbia
Dal 2 settembre si è aperta a Villa Borghese la II edizione di "Metamorfosi – Festival di confine fra teatro e circo", ideato e diretto da Giorgio Barberio Corsetti.
Il festival, che si preannuncia davvero interessante, ha avuto inizio con lo spettacolo Di animali uomini e dei, firmato dallo stesso Barberio Corsetti, e proseguirà il 23 e 24 settembre con Bascule della compagnia Anomalie, e il 27 e 28 settembre con Baiser les anges et tenter le diable di e con Marie-Anne Michel.
Lo spettacolo di Barberio Corsetti, con gli attori della compagnia Fattore K e il gruppo di circo contemporaneo Les Colporteurs, ha debuttato a Siracusa in occasione del Festival di Ortigia ed è il secondo tratto dalle Metamorfosi di Ovidio (dopo quello presentato lo scorso anno alla Biennale di Venezia, di cui abbiamo parlato in ateatro 42).
Le parole di Ovidio, con le quali si apre lo spettacolo, ci avvertono: tra tutte le età possibili, ci sta toccando di vivere in quella del ferro, epoca di guerre ed empietà.
Cerere, in cerca di Proserpina, ne compie e ne subisce; Erisittone divorato dalla fame, in cambio di un po’ di cibo (patatine, merendine… l’ironia non manca) baratta la figlia con sconosciuti, e lei per fuggire è costretta a tramutarsi con l’aiuto di Nettuno in uomo, vacca e uccello. Poi divora se stesso. E poi ancora incontriamo Aracne, Nettuno, Giove e Medusa, una mandria di cavalli selvatici, mentre amori, scontri, uccisioni, stupri e parti avvengono sotto i nostri occhi.
Tutto scorre e cambia, tutto fluisce in queste Metamorfosi di Barberio Corsetti, e ancora una volta gli acrobati mutano sotto i nostri occhi attraversando tutti gli stati della materia: diventano liquidi per essere assorbiti dal terreno, aerei per volare, si deformano, ruotano le teste, camminano in orizzontale, con la sapienza che solo l’arte circense è capace di donare ad un corpo, e con l’aiuto di funi e strutture esili che solo l’incanto del teatro può far sparire. Anche lo spazio, che improvvisamente si apre in fenditura, si richiude, si capovolge, muta di continuo.
Barberio Corsetti utilizza magistralmente la grandezza dei circensi, che sta proprio non nell’essere poetici, ma nel fare dell’azione poesia, ed essere quindi poesia in atto; proprio attraverso loro, le parole di Ovidio diventano realtà: le età del ferro di tutte le ere possibili (compresa la nostra), hanno una possibilità di riscatto: l’arte.
Di animali uomini e dei
di Giorgio Barberio Corsetti
Roma, Villa Borghese
Anticipazioni: César Brie e il Teatro de Los Andes
L'introduzione del volume pubblicato da Ubulibri
di Fernando Marchiori
E’ da alcune settimane in libreria César Brie e il Teatro de Los Andes, a cura di Fernando Marchiori. Il volume raccoglie, oltre agli scritti di César Brie e del curatore, interventi di Giuliano Scabia, Iben Nagel Rasmussen, Roberto Perinelli, Germán Aráuz Crespo e Antonio Attisani, oltre a numerose illustrazioni. Sono 224 pagine per 19,50 euro, lo pubblica la Ubilibri.
César Brie (Buenos Aires 1954) è arrivato in Italia dall’Argentina, a 18 anni, con la Comuna Baires. Nel 1974 è costretto a fuggire dall’Argentina dei generali e sceglie Milano, dove si è insediata la Comuna. La lascia l’anno dopo: lavora nei centri sociali milanesi e fonda il Collettivo Teatrale Tupac Amaru. Nel 1980, dopo l’incontro con l’Odin Teatret, si trasferisce in Danimarca: vivrà a Holstebro per nove anni (ma per i primi sei restando fuori dal gruppo e di fatto parteciperà a un solo spettacolo dell’Odin, Talabot, 1988), lavorando con il Gruppo Farfa fondato da Iben Nagel Rasmussen: realizzeranno diversi spettacoli, tra cui Matrimonio con Dio (1984), dedicato alla figura di Vaclav Nijinskij, e Il paese di Nod (1986, l’anno che segna lo scioglimento del Gruppo Farfa). Alla fine degli anni Ottanta, dopo un breve passaggio in Italia, dove con Naíra Gonzales realizza un insolito Romeo e Giulietta (1991), si stabilisce in Bolivia, a Yotala, vicino a Sucre, dove nel 1991 fonda il Teatro de los Andes, con il quale realizza tra l’altro Colón (1992), Solo gli ingenui muoiono d’amore (1993), Ubu in Bolivia (1994), I sandali del tempo (1995), Iliade (2000).
Per gentile concessione dell’autore e dell’editore, qui di seguito l’introduzione al volume.
Gli scritti e le immagini qui raccolti presentano al pubblico sempre più vasto che anche in Italia - come in tutta Europa, in America Latina e negli Stati Uniti - segue gli spettacoli del Teatro de los Andes la storia di questa comunità teatrale nata in Bolivia nel 1991 e il percorso artistico del suo fondatore, César Brie. Un percorso che, pur rimanendo fedele alla propria vocazione nomade e ribelle, incrocia questioni e protagonisti dell’arte e della cultura contemporanee. Dalla Comuna Baires agli spettacoli realizzati nei centri sociali milanesi nei primi anni dell’esilio, dall’esperienza dell’Odin Teatret di Eugenio Barba e Iben Nagel Rasmussen al sodalizio con Naira Gonzáles, fino alla straordinaria avventura boliviana, il viaggio dell’argentino César Brie ha infatti attraversato le vicende, i sogni, le contraddizioni comuni a una generazione del cosiddetto ‘terzo teatro’.
Raccontando i suoi spettacoli, nella prima parte del libro, si è dunque fatto anche della biografia laddove ciò è sembrato rivelare qualcosa di quel particolare modo di vivere e di guardare il mondo che è il teatro, coerentemente del resto con un linguaggio teatrale come quello di Brie, spesso universale in quanto autobiografico. La pluralità di voci che ha contribuito alla ricostruzione dichiara non tanto una presunta oggettività storiografica, quanto piuttosto la condivisione di una storia e di una passione.
Nella seconda parte vengono tradotti e raccolti per la prima volta i più importanti scritti teorici di Brie, testi generosi di riflessioni sull’attore e sulla messa in scena, di indicazioni pedagogiche, di interrogazioni sull’arte e il mestiere teatrali. Teatro povero, il suo, per virtù prima che per necessità; teatro onesto, che si dichiara facendosi e svela il trucco perché vuol essere creduto; trasparente perché rivolto a tutti, a differenti profondità, perché vuol essere capito; politico, prima di tutto nel senso che cerca di cambiare i rapporti al proprio interno, poi perché non dimentica mai che ‘il segreto del teatro non si radica nelle sue forme ma in ciò che alimenta le forme’.
La terza parte, infine, alterna saggi critici e testimonianze inedite di alcuni compagni di strada dell’attore argentino. Come in tutto il libro, gli sguardi ‘da qui’, da un’Europa che deve opporre tutto il proprio disincanto alla fascinazione di un’esperienza così radicalmente altra, si incrociano con gli sguardi ‘da lì’, da un Sudamerica che rimane una delle periferie più drammaticamente vive dell’Impero. E soprattutto dal suo cuore meticcio pulsante: la Bolivia. Come ha scritto Octavio Paz, ‘L’arte è irriducibile alla terra, al popolo e al momento che la producono: ciò nonostante è inseparabile da essi’. Quella terra, e la sua storia, il Teatro de los Andes le ripercorre a passo d’uomo, tastando il terreno, usando soltanto las abarcas del tiempo che danno il titolo a un suo spettacolo folgorante: i sandali del tempo che dicono anche il gesto di tenere insieme (abarcar), di contenere, quasi abbracciandolo, questo tempo. Di farlo proprio, di assumerlo.
Ma d’altra parte non si deve dimenticare che tale esperienza nasce dall’esercizo di un’arte apolide, e che Brie ha vissuto la maggior parte della propria vita in un esilio che è diventato scelta esistenziale e intellettuale. Anche per questo César Brie - che sia sull’altipiano andino o in una metropoli europea, in un villaggio della giungla o in un teatro del ‘primo mondo’ - continua a voler parlare alle persone che ha intorno: oggi, non nella pseudo eternità di un’arte effimera. Perciò i suoi lavori testimoniano una ricerca nella quale l’attore non perde mai di vista la propria e l’altrui umanità, ed elaborano un linguaggio e una pratica teatrali che dialogano con la tradizione novecentesca proprio nel mentre la mettono radicalmente alla prova ad altre latitudini geografiche e mentali, mentre verificano la necessità stessa del teatro ‘nella sua urgenza, nel qui e ora in cui si realizza’.
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
Un teatro mandalico
Un mail a Giacomo Verde, Andrea Balzola & Co.
di Oliviero Ponte di Pino
«Come possiamo distinguere tra le tecnologie che sono essenzialmente estensioni, accelerazioni, anche se spettacolari, di mezzi già esistenti - come fu la stampa a caratteri mobili - e quelle che costituiscono un "salto quantico" e aprono nuovi orizzonti su un ordine diverso da qualunque altro precedente?»
(George Steiner, Grammatiche della creazione, Garzanti, 2003, p. 269)
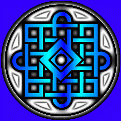
Il logo di Storie mandaliche, con link al sito dello spettacolo.
Storie mandaliche 2.0 (che ho visto al Castello Pasquini di Castigliocello il 29 agosto, in una prova aperta) mi ha incuriosito & interessato, per due motivi. In primo luogo perché mi sembra che stiate lavorando sui confini del teatro (e non solo del teatro, ma anche della tecnologia e del racconto) per spostarli un poco più in là. E (secondo) perché lo fate lavorando su uno snodo chiave come il rapporto tra la narrazione e l’icona (con la mediazione del corpo), che mi sembra uno dei temi centrali di questi tempi.
Dal punto di vista della narrazione, è subito chiaro il superamento di un percorso unico e sequenziale (la forma classica del racconto, con un inizio e una fine predeterminati), a favore di una struttura a rete, più complessa e articolata. Non esiste un unico percorso predestinato (anche se nelle singole storie ciascun personaggio segue il filo del proprio, mi pare: non credo che il Ragazzo, per esempio, possa scegliere se amare la sua Principessa), ma una moltitudine di percorsi possibili, ogni sera diversi. Così ogni replica lo spettacolo è radicalmente diverso e non esaurisce la totalità delle storie. Siamo dunque più vicini al videogame - con i suoi sentieri biforcati e le scelte che impongono a ogni bivio o incontro - che a un romanzo o a un testo teatrale.
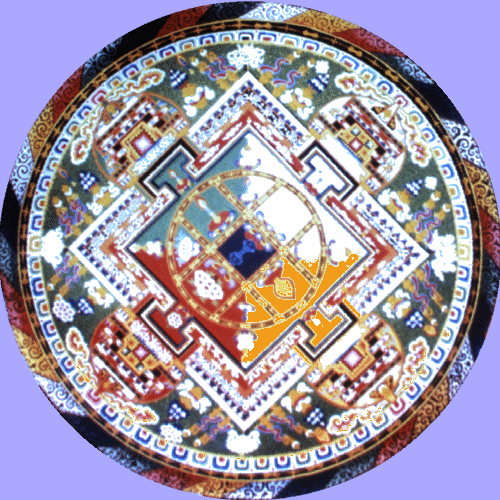
In Tibet, per insegnare ai bambini a utilizzare i Mandala, li fanno percorrere con delle pedine come se fosse una sorta di gioco dell’oca: seguendo un percorso determinato dal caso (dal lancio di un dado, per esempio), imparano il significato dei diversi luoghi e al tempo stesso ripercorrono nel microcosmo lo schema del macrocosmo.
In Storie mandaliche il coinvolgimento interattivo del pubblico (di volta in volta attraverso le indicazioni di un singolo spettatore) è un elemento essenziale. Evidenzia e rende palpabile l’esistenza dei link - gli incroci e le biforcazioni. Peraltro questo metodo di scelta, né predeterminata né casuale, riflette la logica complessiva del lavoro: la decisione di imboccare una strada piuttosto che un’altra dipende dalle affinità-curiosità-associazioni dello spettatore con il suo personaggio, ovvero con il simbolo che rappresenta (la Pietra, il Mandorlo, il Ragazzo, il Cane...). Lo spettatore sceglie, ma in qualche modo viene scelto dalla storia.
Ovviamente il modello letterario per un’opera di questo genere è Italo Calvino, che non a caso accoppiava alla ricerca sulle possibilità combinatorie della letteratura quella sulle sue radici antiche e profonde (la fiaba, il mito...), con le regolarità strutturali delle loro figure e dei relativi intrecci.
Come in Calvino, una struttura narrativa non lineare si contrappone implicitamente all’idea di storia come progresso unidirezionale, che cattura le molteplici sfaccettature del reale per ricondurle a un destino unitario. Per lo «scientifico» Calvino l’alternativa a questa narrazione unidimensionale divenne quella della «narrativa come processo combinatorio»: un meccanismo per esplorare ed esaurire «matematicamente» (e dunque «disumanizzando» la macchina narrativa) tutti i possibili stati della realtà (del racconto). I «navigatori» Verde & Balzola, invece, per catturare la molteplicità del reale aprendosi alla bidimensionalità e utilizzano la rete, inserendo - come si è detto - il principio della scelta: il racconto si muove su due dimensioni incrociando altri racconti (la terza dimensione, se si vuole usare questa metafora, nascerebbe dalla possibilità di scelta dei singoli personaggi della fabula: se per esempio il Ragazzo potesse scegliere se innamorarsi della Principessa o no, scegliendo dunque di entrare in uno dei due mondi paralleli, quello dove ama e quello dove non ama...).
E’ una scelta con evidenti implicazioni ideologiche: la rete pare oggi anche l’alternativa a un sistema di potere autoritario e piramidale. Se nel corso di una serata si assiste a quel racconto, unico e irripetibile, resta aperta e sempre presente l’esistenza di altre storie possibili. E’ il qui e ora del teatro, è la presenza dell’osservatore che tra le numerose storie fa «collassare» quella effettivamente raccontata, facendola passare dal virtuale al reale.
Ma a questo punto mi interrogo: nella struttura del vostro Mandala, esistono infiniti percorsi possibili, o solo un numero finito di percorsi? (un numero finito) Ed esistono percorsi infiniti? E se esiste un percorso infinito, si tratta di loop o di un percorso a-periodico? (Mi immagino una replica infinita delle Storie mandaliche, con il narratore e il pubblico persi labirinticamente nel racconto, come nelle Mille e una notte). E poi, esistono (come nell’eterno ritorno buddista) percorsi ouroborici che ritornano al punto di partenza? (forse lo spettacolo dovrebbe finire così, al punto di partenza, dove tutto è uguale e al tempo stesso diverso, mentre in effetti in Storie mandaliche i percorsi vanno dai sei punti d'ingresso verso il centro, come nei percorsi seguiti normalmente nel corso della meditazione sui Mandala).
Credo in ogni caso che Storie mandaliche sia una delle prime occasioni in cui una struttura narrativa così complessa viene utilizzata sulla scena con tale efficacia e leggerezza (ovvero senza mai far pesare, nel corso della narrazione, il meccanismo narrativo e tecnologico che la sottende). Ma questo è solo uno degli aspetti del lavoro. Perché questa «ipertesto mandalico» prende sostanza in due medium che interagiscono: da un lato il racconto orale, dall’altro uno schermo popolato di icone (ai quali andrebbe aggiunta la colonna sonora di Mauro Lupone).
Il rapporto tra la narrazione e l’icona è uno degli snodi centrali dell’attuale scenario comunicativo: basti pensare al fragile equilibrio che trovano sullo schermo dei nostri pc. Lo specifico di Storie mandaliche risiede proprio nell’interazione tra la dimensione narrativa e quella iconica, nello «spazio mentale» che crea nello spettatore (e qui siamo per molti aspetti vicini al fumetto, nel connubio della narrazione con una visualità semplificata, codificata).
Anche se il ruolo dello schermo con le animazioni flash in Storie mandaliche è assai più complesso. Dal punto di vista della tradizione teatrale, lo schermo con le animazioni flash è un elemento scenografico: quanti sono gli spettacoli che usano come sfondo proiezioni cinematografiche o televisive... Ma in realtà l’interazione dell’interprete con questa «scenografia» è assai più intensa: per certi aspetti ricorda gli attrezzi usati dai giocolieri, fino quasi a diventare una estensione del corpo dell’attore-narratore (che peraltro sullo schermo si materializza nel puntatore del mouse - il fulcro o il punto cieco del rapporto tra lo schermo e il reale). Ancora, le immagini sullo schermo, come nelle tele dipinte dei cantastorie, costituiscono in qualche modo una «illustrazione» della storia (danno un equivalente visivo del racconto) e al tempo stesso ne sono il motore: offrono un supporto mnemonico al narratore (come i quipus andini, fatti di cordini colorati e annodati che stenografano i punti chiave del racconto e che il narratore, facendosi scorrere tra le dita, utilizza come memoria), e spesso - quando appunto s’incontra un nodo - diventano il motore della narrazione.

|

|
Inoltre quello schermo è esso stesso un teatro, popolato di icone animate o in movimento. Sulla metafora dello schermo del computer come teatro ha insistito Brenda Laurel; e sulla strada che ha tracciato, c’è stato chi ha assimilato al teatro anche le animazioni flash attualmente usate in Storie mandaliche.
«Un sito Flash viene sviluppato come un microcosmo che sboccia in un macrocosmo. Il medium internet è la "scena" /stage/ -- la piattaforma dove l'animatore Flash /flashanimator/ importa, incolla e scolpisce "simboli" (personaggi /charachters/) cui vengono assegnate "azioni" (ruoli /roles/) in una trama /plot/ grafica multidimensionale. L'animatore Flash è l'autore di un dramma /play/ sulle verità visuali della vita. La gamma espressiva della grafica in movimento è incredibile, dalla serenità all'ansia». (Nate Burgos, Flash Fetish, in "ctheory")
Va sottolineato che la scelta di usare animazioni flash (che con le loro semplificazioni rimandano all’ideogramma) si contrappone decisamente alla ricerca del realismo perseguita dal cinema e dai videogame. La scelta è, al contrario, di spingersi verso la dimensione simbolica - verso il mito o la fiaba. E in questa direzione vanno anche, ovviamente, le storie narrate.
Credo che la scommessa di Storie mandaliche sia quella di costruire un’esperienza comunicativa complessa a partire da elementi semplici e immediatamente decodificabili (anche da un bambino, e in questo sta l’apparente ingenuità «fiabesca» dei racconti), con un robusto supporto tecnologico usato consapevolmente e senza feticismi. La consapevolezza riguarda soprattutto la ricerca sugli effetti di una tecnologia sul nostro rapporto con il mondo e sulle nostre modalità comunicative. In questo caso la possibilità di creare link e dunque una rete si oggettiva ovviamente in primo luogo nel Mandala, che è insieme un’icona visibile (la prima, che all’inizio della serata viene «spiegata» come in un documentario in termini storici e filosofici) e la struttura nascosta dello spettacolo. Successivamente i link (le scelte) diventano anch’esse un elemento narrativo - anzi, il principale elemento narrativo:
La tecnologia viene utilizzata con grande naturalezza, tanto da risultare praticamente «invisibile»: il narratore utilizza con grande scioltezza il mouse, clicca tranquillamente sui link, lancia le animazioni flash senza che questo causi nel pubblico sorpresa e meraviglia - tutto questo fa già parte del nostro mondo. Per questo mi sono molto piaciuti i momenti in cui qualcosa non ha funzionato: perché in questi momenti di verità tutta la complessità del meccanismo diventa visibile (e si capisce anche che sulla tecnologia è in qualche modo possibile intervenire per correggere, riprendere eccetera - forse si potrebbe addirittura inglobare nella trama dei racconti qualche incursione nel cuore del meccanismo, anche se l’«effetto verità» dell’attore alle prese con il problema tecnico è un’altra cosa). Sono quelli i momenti in cui lo spettatore capisce quello che c’è oltre la cornice (è curioso come l’equivalente del teatro nel teatro corrisponda in questo caso all’errore tecnico).
Per valutare il senso complessivo di questa fase della ricerca (al di là di squilibri e aggiustamenti di minor peso), credo sia utile fare un esperimento mentale: pensare di vedere unicamente le animazioni flash (come un cartone animato), oppure pensare di ascoltare unicamente il racconto (radiofonicamente). Ciascuna di queste «versioni» delle Storie mandaliche rischierebbe di apparire non solo povera ma sostanzialmente incomprensibile: le icone sono semplici, le animazioni non sorprendono mai con i loro effetti speciali; e il racconto per ora rischia spesso di scivolare nel fiabesco oppure, nel finale, in astrazioni intellettualistiche (ma qui si tratta probabilmente di trovare il giusto equilibrio, e di restituire nella narrazione i diversi livelli di lettura del racconto, evidenziando i nodi simbolici).
Ma non è questo l’importante: la chiave del lavoro non è tanto la bellezza delle immagini o la tenuta del plot. L’importante è che le immagini non sono solo illustrazione del racconto, il sonoro non è solo commento delle immagini. Accoppiando immagini e sonoro, potrebbe nascere un cd-rom (e un sito internet) dove alla fisicità dell’attore e all’esperienza collettiva del pubblico si sostituisce l’interattività più immediata del singolo utente. Perdendo inoltre le risonanze con la narrazione popolare che la versione teatrale suscita immediatamente. Ecco, credo proprio lavorando sull’indispensabilità reciproca di icone e racconto da un lato, oltre che sui momenti di verità nello svelare i segreti della macchina, le Storie mandaliche possono continuare a crescere e trovare la loro specificità e credibilità.
Non so se con questo «sistema narrativo» sia davvero possibile creare uno «spazio mentale» alternativo, più aperto alla dimensione simbolica da un lato e in grado di cogliere con maggior sottigliezza le potenzialità dei «mondi paralleli». Va anche tenuto conto che la dimensione ludica («Quale strada imbocchiamo?») può avere risonanze assai diverse quando a compiere la scelta è un unico utente che usa un cd-rom di fronte allo schermo di un pc, oppure un gruppo di persone unite di fronte a un narratore-sciamano. Tuttavia mi pare che il senso profondo della scommessa dia proprio questo: attivare zone che si trovano in profondità (nell’hardware dei nostri meccanismi percettivo-emotivi, o attivando contemporaneamente diverse funzioni mentali, o se si preferisce interagendo con strati dell’anima
L’animazione del mandorlo (Flash 6): eventualmente cliccare sul pulsante destro e poi "Riavvolgi".
Altre info su Storie mandaliche 2.0 in ateatro 56.
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
L'ipertesto mandalico
Un mail a Oliviero Ponte di Pino
di Andrea Balzola
Ciao Oliviero,
ho letto adesso le tue riflessioni su Storie mandaliche che mi ha inoltrato Anna, stavo per scriverti anch'io e di pochissimo mi hai preceduto.
Per quanto riguarda la struttura del nostro Mandala, abbiamo preso a modello il senso tradizionale del mandala buddhista (io ho studiato soprattutto quello tibetano, non solo sui libri ma con maestri tibetani) e l'interpretazione junghiana, dove il Mandala ha radici archetipiche universali (si manifesta spontaneamente nei sogni individuali e nelle rappresentazioni artistiche-rituali di molte civiltà)ed è veicolo simbolico e strumento della trasformazione (purificazione delle negatività e loro trasformazione, funzione simbolica che avevano anche i labirinti delle cattedrali gotiche cristiane), orienta la frammentazione della psiche e dell'identità verso un centro. Questo centro per Jung è il Sé, quindi la porta d'accesso del singolo alla dimensione universale e trascendente, per i Buddhisti è la consapevolezza realizzata e risvegliata, la consapevolezza del Vuoto (ovviamente da non confondere, come spesso si fa in occidente, con il Nulla nichilista): «Il vuoto è forma e la forma è vuoto».
Sulla base di questa struttura ho creato l'ipertesto narrativo, si entra nel Mandala da 6 punti cardinali o porte (est, nord, ovest, sud, nadir, zenith) e si giunge a un centro unico. I punti cardinali corrispondono anche agli elementi e ai quattro regni: minerale, vegetale, animale, umano maschile e femminile, il centro è il regno divino. In questo centro dove tutte le storie confluiscono, si sciolgono e si trasformano si apre la porta dell'irrapresentabile, ecco perché l'ermafrodito, sintesi dei contrari e di tutti i regni. Il linguaggio qui deve cambiare registro, non più narrativo ma poetico, non più descrittivo ma dichiaratamente simbolico ed ermetico.
Questa struttura, in cui tutti i percorsi si intrecciano in più punti (i link delle storie), presenta molte (non infinite) varianti che possono rendere la narrazione sempre diversa nella combinazione - decisa dal pubblico - dei sentieri da seguire e montare tra loro. Il finale non può essere circolare (sarebbe una soluzione simbolicamente altrettanto significativa e legittima, ma richiede un'altra struttura di partenza) e deve essere unico, cioè portare sempre al centro, come nel Mandala classico. Tutte le storie hanno diversi link durante il percorso, non appena compaiono nuovi personaggi protagonisti oppure in loro successive apparizioni. L'unica storia che ha link solo alla fine è la pietra perché è cronologicamente (e simbolicamente) antecedente alle altre, è sul piano simbolico la pietra angolare della narrazione così come nel racconto è la pietra angolare del tempio di Gerusalemme. I fatto che la pietra sia un passato che si può raccontare dopo il presente mi sembrava una distorsione temporale interessante, se risulta troppo lunga come porzione narrativa si può pensare di abbreviare la narrazione teatrale.
Il rapporto tra narrazione e icona che tu hai giustamente rilevato come centrale (ma aggiungerei anche il sofisticato lavoro sul sonoro di Lupone, che deve ancora essere valorizzato appieno) si snoda proprio attraverso lo schema dei link, che era già progettato e presente nella scrittura delle storie e che è stato perfezionato e arricchito nel lavoro di messa in «icono-scena». In effetti noi, per sincronizzare i linguaggi e mettere alla prova la loro forza singola abbiamo fatto durante il laboratorio quello che tu ora ci consigli, cioè provare separatamente la narrazione e la sequenza animata. Il risultato ci era parso soddisfacente, con aggiustamenti che faremo nel prossimo e ultimo laboratorio (probabilmente ancora a Castiglioncello) prima della Prima.
Quando tu dici che ti sono piaciuti gli errori che fanno vedere la «macchina» tecnoteatrale ti capisco bene e sono d'accordo, é nella strategia interattiva di Giacomo fingere almeno una volta di sbagliare per rilanciare attenzione e curiosità (vecchio trucco della commedia dell'arte), ma è anche interessante far vedere al pubblico e percorrere esplicitamente con il mouse le iconcine nascoste dei link, in questo modo si rivela, senza ostentarlo, la struttura ipertestuale delle sequenze animate.
Io credo, diversamente da te, che sia "la bellezza delle immagini" (forse alcune le avrei preferite più artistiche e meno videogame) sia la "tenuta del plot" siano necessarie per reggere e "slanciare" l'insieme. Per questo non sono d'accordo ( o per lo meno mi preoccupo) quando dici che le storie sarebbero deboli senza immagini, perché rischiano di "scivolare nel fiabesco oppure, nel finale, in astrazioni intellettualistiche".
Per quanto riguarda l'intellettualismo dell'ermafrodito, io e Giacomo siamo convinti che sia una sensazione provocata dal fatto che quella parte (non essendo stata ancora studiata e interiorizzata da Giacomo) è stata letta, e quindi non modulata da un salto di registro che ci deve essere anche nella narrazione, inoltre c'erano dei problemi sul volume del sonoro e sulla sincronia stessa delle immagini che hanno fatto risultare troppo lunga e artificiale una parte che dev'essere soprattutto, aldilà del simbolismo, follemente poetica e sintetizzare l'esito dei vari personaggi.
Il rischio del fiabesco è invece un rischio calcolato, il racconto mitologico si rivolge tanto agli adulti quanto ai bambini, ovviamente con diversi livelli di lettura e di coinvolgimento. Il mio tentativo di scrittura è stato quello di sviluppare una narrazione apparentemente semplice, quasi elementare, come una specie di favola metropolitana (una favola con tematiche adulte e contemporanee), sostenuta però da una struttura simbolica profonda e da una sofisticata (generata non però a freddo, a tavolino, ma tramite un viaggio interiore) tessitura di associazioni e corrispondenze. Non è necessario che siano colte tutte e subito, ma comunque agiscono, come una sorta di mappa segreta della narrazione, nella quale ognuno (sia chi la fa che chi la sente) potrà perdersi e ritrovarsi a modo suo. E in effetti è quello che, da molte reazioni che abbiamo avuto alle prove di Castiglioncello (e alle precedenti versioni), sembra accadere, chi è disposto a entrare nel Mandala (come ci ha detto un attore spettatore, chiediamo allo spettatore una partecipazione non distratta) si perde nei rivoli o nel fiume della storia, a proprio modo, ciascuno sognando uno spettacolo diverso. Con la sapiente orchestrazione narrativa da cybercantastorie di Giacomo, che secondo me sta trovando il registro sempre più giusto per raccontare, tra l'antico cantastorie, l'illusionista digitale e lo sciamano (alla fine, la guida che amichevolmente ed anche misteriosamente conduce nel teatro di un ipersogno. Non appena sarà rodata l'intera macchina e interiorizzate le storie, Giacomo potrà gestire gesti, suoni, pause, parole e animazioni come un direttore d'orchestra.
Ti ringrazio ancora moltissimo per il tuo contributo, così articolato e generoso, un'altra caratteristica di questo nostro progetto è che non ci interessa tanto avere dei critici che ci concedono un'ora del loro prezioso tempo per vedere la Prima, ma trovare dei compagni di strada come te che interagiscano creativamente e intellettualmente con il lavoro di costruzione dello spettacolo, con stimoli, suggerimenti, letture personali, critiche sincere e costruttive, perché non crediamo più nel teatro catena di montaggio dello spettacolo che domina le nostre scene, ma nel laboratorio antropologico del teatro (non a caso lavoriamo a questo progetto da tanti anni).
Un caro saluto
Andrea Balzola
Robert Lepage porta in Europa il nuovo allestimento della Trilogie des dragons
La recensione della prima edizione dello spettacolo (1991)
di Oliviero Ponte di Pino
Robert Lepage riallestisce la sua Trilogie des Dragons (1987), il mini-kolossal teatrale che in quasi sei ore racconta una storia lunga ottant’anni: uno dei suoi spettacoli più belli ed emozionanti, un capolavoro di complessità e semplicità che nel 1991 passò anche in Italia.
La nuova edizione della Trilogie ha debuttato al Festival des Amériques nel maggio di quest’anno; lo spettacolo sarà in Europa nelle prossime settimane; in particolare sarà a Berlino, e poi, il 4 e 5 ottobre prossimi, a Limoges per il festival Les Francophonies en Limousin, per passare infine a Madrid.
Qui di seguito la recensione della prima edizione dello spettacolo, in occasione del suo passaggio milanese dodici anni fa.

Una spianata coperta di sabbia, un misero gabbiotto di legno, un palo della luce, pochi oggetti scelti con cura, di immediata efficacia: questo è tutto quel che serve a Robert Lepage e ai suoi otto attori per raccontare, in sei ore, una vicenda che dura ottant’anni, dal 1910 ai giorni nostri, attraverso tre città (Québec City, Toronto, Vancouver), nella Trilogie des Dragons, spettacolo saga del Théâtre Repère.
Il nome del gruppo nasce dalla sigla che condensa il suo metodo di lavoro, vagamente manageriale - più o meno, esame delle risorse, obiettivi, valutazione, rappresentazione. Anche se poi il risultato finale è lontanissimo da ogni freddezza e calcolo, raccontando piuttosto per sensazioni un romanzo teatrale di ampio respiro, costruito intorno alla vicenda di due cugine, Jeanne (Marie Michaud) e Françoise (Marie Gignac). Nella prima scena le vediamo, bambine, giocare con scatole di scarpe che si trasformano, per incanto, nelle case e nelle botteghe del loro quartiere. Via via questo universo si popola di altre presenze: il barbiere (Richard Frechette), padre di Jeanne, brutale e beone, il bel Charles dai capelli rossi (Normand Bissonette), e poi William Crawfort, cittadino britannico nato a Hong Kong, e l’enigmatico Mr. Wang (Gaston Hubert), lavandaio cinese e trafficante d’oppio. Molti eventi hanno un sapore romanzesco: nella prima parte, Il drago verde, Jeanne si farà sedurre da Charles, suo padre la scoprirà, e la perderà in una partita a poker (una delle scene più evocative dello spettacolo); così la ragazza, seppure incinta, finirà per essere costretta a sposare il figlio di Wang. Ma il racconto procede più per invenzioni teatrali, per sintesi e metafore, per ellissi spesso costruite intorno a un gesto. E’ questo un secondo piano della Trilogie des Dragons, una ininterrotta danza dei corpi e delle cose, che scorre aldisotto della trama, e insieme la muove, sospingendola di situazione in situazione, per passare con facilità e leggerezza dalla comicità alla tragedia, dal frammento realistico o psicologico a brani coreografici, che ricordano a volte Pina Bausch.
Si avverte inoltre la presenza di un livello ancora più profondo: perché raccontando ottant’anni di storia del Canada, facendo interagire personaggi con origini e radici diversissime (canadesi francofoni e anglofoni, un cittadino britannico déraciné, immigranti cinesi e giapponesi), la Trilogie des Dragons traccia anche la storia di un possibile incontro tra culture, di una possibile integrazione. Tanto che alla fine della serata si creerà una situazione speculare e opposta a quella dell’infelice matrimonio di Jeanne, con l’amore tra Pierre, figlio di Françoise, e Yukali (Marie Brassard), figlia di una geisha e di un ufficiale americano.
E ancora, vengono evocate ciclicità e simmetrie di raggio più ampio, nello spazio e nel tempo, come se gli oggetti e le situazioni chiave che scandiscono la Trilogie fossero segni di incommensurabili destini. E’ un effetto che Lepage e soci riescono a raggiungere senza alcuna sottolineatura, con la messinscena di una vicenda molto complessa ma utilizzando i mezzi espressi più essenziali. Il risultato è uno spettacolo che scorre come un fiume, trascinando con il suo ritmo personaggi e situazioni, atmosfere e sentimenti, in una narrazione di respiro cinematografico, quasi da telenovela, eppure con una immediatezza e una concretezza teatrali. Ecco dunque le allusioni ai grandi eventi del secolo, ma anche le trasformazioni sociologiche, riflesse dal mutare di psicologie e atteggiamenti; ecco gli amori, e gli abbandoni romantici, ma anche drammi e sketch da commedia dell’arte (Françoise e la sua prima macchina da scrivere), esplosioni festose (la danza dei draghi, nel finale, con l’emblematico serpente piumato che si morde la coda) e riflessioni sul rapporto tra Oriente e Occidente, attraverso i diversi atteggiamenti di Pierre (Robert Belle Feville), artista concettuale e autore di installazioni nelle gallerie d’arte di Vancouver, e di Yukali, che nei suoi dipinti rappresenta draghi colorati e sentimenti personali. E, soprattutto, emerge un gioco di simmetrie discrete, appena accennate, che permettono di ritrovare in questa selva di eventi i fili rossi che li attraversano e forse possono dare loro un senso.
Peccato che lo spettacolo, presentato all’Ansaldo nell’ambito di «Milano Oltre», abbia richiamato poche decine di spettatori a replica, messi per di più a dura prova da una temperatura quasi artica.
(«il manifesto», 24 ottobre 1991)
Crescono i consumi culturali degli italiani
I dati Istat e l’indagine Astra Demoskopea
di Redazione ateatro
Negli ultimi dieci, i consumi culturali degli italiani sono in crescita. Il dato si ricava sia dai dati Istat sia dalla ricerca Astra Demoskopea «Seven to Seven», sui comportamenti degli italiani dalle 7 alle 19.
Dal 1994 al 2000, secondo l’Istat sono aumentati gli italiani che vanno al cinema (da 62,4 al 69,5%) e a teatro (dal 17,8 a 21,4%), che leggono libri (dal 47,5 al 48,3%). In compenso, guardano un po’ meno la televisione (dal 96,7 al 93,9%). Conferma il sociologo Enrico Finzi (Astra Demoskopea): «Il concetto di tempo libero è mutato, si supera l’individualismo superficiale, la tv non è più al primo posto, è stata finalmente spodestata dagli interessi culturali».
Conferma Linda Laura Sabbadini (Istat): «Negli ultimi anni è cresciuta la passione per la cultura da parte di giovani e adulti, soprattutto la fascia dei ragazzi e delle persone colte fruisce maggiormente di un ampio spettro di attività che va dalla lettura agli spettacoli sia in casa che fuori».
Così, per usare una delle categorie in cui l’Istat ha sezionato la popolazione italiana, raggiungono addirittura il 25% gli «impegnati poliedrici», laici, benestanti, adulti-colti, urbano metropolitani, curiosi e instancabili. Sono loro che leggono giornali (57%), libri (54%), non limitano i loro interessi alla sfera del lavoro (25%), partecipano a dibattiti e conferenze (25%), scrivono (23%). E naturalmente quando escono vanno al cinema (44%), a bere un drink (41%), seguono concerti (31%), visitano musei (28%) o vanno a teatro (26%).
Secondo Finzi stiamo assistendo a «un drastico ridimensionamento del disimpegno e a un inedito bisgono di profondità, una sorta di rigetto del consumismo oggi frenato dalla sensazione di incertezza».
Manifestival: la polemica su Santarcangelo 2003
Gli interventi di Gianfranco Capitta e Gianni Manzella sul "manifesto"
di Redazione ateatro
Si riaccende la polemica sul Festival di Santarcangelo, o meglio sull'articolo che Gianni Manzella sul "manifesto" ha dedicato alla rassegna. Un estratto del pezzo di Manzella lo trovate nel forum "Nuovo teatro vecchie istituzioni".
Nel sito, in "ateato 56", trovate anche la lettera che Claudio Meldolesi e Oliviero Ponte di Pino hanno scritto al giornale, in dissenso con quell'articolo.
Il manifesto di oggi, 27 agosto 2003, dedica una pagina alla "questione festival": un pezzo di Gianfranco Capitta, la lettera di Mledolesi e Ponte di Pino, la replica di Gianni Manzella.
Qui di seguito i due articoli, con l'invito ad aprire il dibattito. Inutile aggiungere che "ateatro" seguirà gli sviluppi della discussione.
Si avvia ormai a conclusione l'estate dei festival, ma rimangono vive le discussioni sulla loro funzione e su quello che rappresentano, o su quella che secondo alcuni è la loro minore incisività. Dopo un articolo di Gianni Manzella che dava una valutazione conclusiva del Festival di Santarcangelo 2003 chiusosi a metà luglio, era arrivata in redazione l'adesione di un lettore emiliano che sollecitava a rivedere l'intero impianto e le modalità di quel glorioso festival (pubblicata nella rubrica delle lettere) e pochi giorni dopo un'altra di segno diverso da parte di Oliviero Ponte di Pino e di Claudio Meldolesi (che pubblichiamo oggi qui, assieme alla risposta di Manzella). Può sembrare curioso o tardivo discutere di un festival che si allontana già nella memoria, anzi viene «sepolto» dal fatto che probabilmente si è già iniziato a pensare al prossimo. È che quello della «forma festival» diviene un problema di primo piano nella organizzazione e nell'economia generale dello spettacolo italiano. Lo dimostrano l'eco e le turbolenze che già giungono dalla Mostra del cinema veneziana, e perfino il tormentone di Sanremo oggetto di scambio con la direzione dell'Istituto italiano di cultura di Los Angeles, fino a quando quando quando Tony Renis sarà amico e intrattenitore privilegiato del capo di governo... Se ci teniamo al teatro, la chiusura del Festival d'Avignone è già stato un botto impressionante, l'esplosione più forte di quest'anno nella cultura non solo transalpina ma europea. Anche perché la Francia ha un sistema teatrale (e culturale) forte, dove la politica non è mai entrata così sfacciatamente come da noi, e dove l'abitudine e la familiarità del pubblico con le proprie rappresentazioni è per noi semplicemente inimmaginabile: ad Avignone vanno in massa, durante il mese del festival, non solo gli operatori e gli addetti del settore, ma moltissimi spettatori in ordine sparso (nella bellissima campagna provenzale) e a proprie spese, arrivando a contendersi i biglietti fino all'ultimo sforzo possibile.
Da noi tutto questo non c'è, ma pure negli ultimi venti o trent'anni, i festival estivi sono stati la frontiera della creatività e della libertà artistica, i luoghi dove di fatto si sono potute sperimentare nuove formule produttive ed espressive, che hanno costituito poi la linfa minima indispensabile alla sopravvivenza dei carrozzoni invernali, privati e pubblici. Il luogo dove nuove generazioni di artisti hanno potuto emergere e farsi apprezzare, senza pagare lo scotto e lo sbarramento dei teatri che pigramente si lasciano oberare fino al totale immobilismo dal ricatto di abbonati ancor più pigri, o dalla scarsa fantasia del burocrate o del politicante che quel teatro, per i motivi più disparati, si trova a curare. Qualcosa evidentemente si è inceppato in questo meccanismo a circuiti paralleli. Non gli ha giovato certo l'arrembaggio alle sedi del potere da parte della Casa della libertà, fatta per altro di desideri ingordi e improvvide sgrammaticature, soprattutto per lo scarso materiale umano a disposizione della destra (e sanzionato comunque dalla drastica riduzione dei contributi ministeriali). Ma non si può dire che molto di più abbia fatto nel settore il passato governo di centrosinistra. Le manifestazioni si sono sempre più localizzate, ovvero finite in balìa di amministratori e autorità turistiche, hanno spesso abbassato il tiro quanto a fantasia e coraggio, e anche a quella che qualche anno fa si definiva «professionalità». Molti calendari sembrano promozioni amatoriali, o suddite del gusto televisivo che è ovviamente un'altra cosa (l'eterno dilemma su quanto possono far ridere i comici...). Perfino Mittelfest quest'anno ha voluto privilegiare la comicità, per altro mandando in scena poi coreografie sui Trionfi del Petrarca: sarà comico o mitteleuropeo? L'aspetto quantitativo finisce col rendere molti festival del tutto simili a un supermercato dove ci sia tutto e il suo contrario, rischiando talora di finire nel discount dell'usato. Parlare di un progetto sarebbe forse chiedere troppo per una programmazione che, chissà perché, spesso si intestardisce a richiamare pubblici davvero eterogenei, infilando l'intrattenimento nell'interlinea dei calendari. Poi certo ci sono i festival ricchi (a parte le spoglie famigliari di Spoleto), ma quelli sembrano concessionari patinati dove gli agenti forniscono tutto «chiavi in mano».
Insomma il problema non è solo di Santarcangelo. Semmai è quello di una qualità non troppo esuberante (o di novità, se si preferisce), e delle difficoltà sempre maggiori a dare a quelli che lo meritano una maggiore visibilità. Senza limitarsi a volerci mettere «il cappello» sopra. Partitico e campanilistico che sia. Per questo varrebbe la pena ricominciare a discuterne.
Gianfranco Capitta
Cari amici, solo una lettura molto superficiale della mia cronaca da Santarcangelo (l'articolo dal titolo «Santarcargelo, un festival a rischio di `siccità'. Creativa» pubblicato sul manifesto del 20 luglio) può spingere a credere che io abbia voluto lanciare un sasso contro il festival. E perché mai? Mi lega a questo luogo una frequentazione più che ventennale e un tenace affetto. A meno che anche il semplice manifestare un senso di dubbioso scontento per questa estate festivaliera non sia considerato un gesto offensivo, ma sarebbe un gran brutto segnale.
Preferisco pensare che si voglia ancora discutere, e certo anche dissentire da quello che ho scritto. Che intanto partiva dal riconoscimento del fatto che Santarcangelo è da tempo il più importante festival teatrale dell'estate italiana, e questo però comporta anche una responsabilità. Mi sembrava del resto che anche le parole introduttive al programma di Silvio Castiglioni e la stessa immagine di un teatro distrutto dalle bombe, scelta come sigla iconografica, indicassero la consapevolezza di essere di fronte a una sfida progettuale. Se così non è, certo lo potete sapere meglio di me. Non sono, a differenza di voi, fra i consiglieri dei direttori del festival di Santarcangelo. Vi ho partecipato soltanto da spettatore, credo attento. Ho assistito a spettacoli e incontri, fatto tardi la notte, in piazza, discutendo con tanti. Tanto è vero che gran parte delle vostre considerazioni sono presenti nel mio pezzo. La riuscita della prova di Danio Manfredini, che diventerà certo un lavoro importante una volta che abbia completato il proprio percorso creativo, a cui il manifesto aveva per altro già dedicato in precedenza tutto lo spazio che meritava.
I pochi soldi a disposizione. La partecipazione di molti operatori (termine orrendo ma significativo). La presenza di spettacoli di apprezzabile qualità, anche se spesso già passati nella normale programmazione dei teatri o in altri festival delle vicinanze, e di cui si era dunque riferito in altre occasioni. E qui sta forse uno dei nodi della questione. Senza polemica: altre cronache hanno liquidato il festival in maniera ben più sommaria, trattando in poche righe le sue principale produzioni. Non vi sembra che dovrebbe essere rivolta altrove la vostra protesta? Non so sinceramente quali spettacoli notevoli posso aver perso. Può essere capitato, certo. Ma non è questo il punto, non è cioè una questione di spettacoli riusciti o meno, non è una questione di gusto. Su cui è normale avere opinioni diverse. C'è invece una questione di senso e di necessità di questo (e altri) festival. Per chi e come farlo, per quale pubblico, per lasciare quali tracce. Un festival è un singolare evento che concentra in uno spazio e in un tempo limitati una quantità di teatro normalmente impensabile, che consente di mettere a confronto artisti di provenienze e generazioni diverse, di aprire una finestra su geografie lontane da quelle usuali. Richiede fantasia progettuale, volontà di scoperta, capacità di scarto rispetto alla norma. Se deve essere una vetrina di spettacoli per i qualificati operatori stranieri, una sorta di mostra mercato della produzione locale, personalmente non mi interessa.
Mi sembra che Santarcangelo abbia progressivamente perduto negli ultimi anni la spinta che ne aveva fatto un laboratorio e un crocevia d'esperienze, laddove ad esempio ci si interrogava sul rapporto fra innovazione e tradizione e si ricercava una nuova forma di teatro popolare. Per rinchiudersi in quella logica difensiva che traspare anche dalla vostra lettera, da periodica riunione di famiglia. Una fase di autointerrogazione dei gruppi teatrali italiani, dite. Verrebbe da dire piuttosto di autoreferenzialità. E poi se i gruppi sono ogni anno sempre quegli stessi cinque o sei emilianoromagnoli, che bisogno c'è di fare un festival?
Da ultimo, accennate al festival di Spoleto. Ma se Spoleto è diventato quel che è diventato, cioè niente, di chi è la responsabilità? Chi ha lasciato che scomparisse dalla vita culturale di questo paese? Troppo facile prendersela ora con Pippo Baudo. Sarà la nuova destra, ma almeno so chi ho di fronte. Mi mette più in allarme chi cerca di approfittarsi dei miei buoni sentimenti di sinistra per spacciare una politica culturale di tutt'altro segno.
Gianni Manzella
Noccioline di Fausto Paravidino è la pièce straniera dell'anno
Il referendum di "Theater Heute"
di Redazione ateatro
Ogni anno, l’annuario della rivista "Theater Heute" seleziona le migliori produzioni del teatro tedesco, in base a un referendum tra 38 critici (insomma, tipo Premi Ubu...).
Su Paravidino, vedi per esempio Diarioateatro: venerdì, sabato e domenica di Anna Maria Monteverdi; ma prova anche a cercare nel forum del teatro di giuerra...
Per la stagione 2002-2003, la migliore pièce straniera dell'anno è Peanuts di Fausto Paravidino, allestito con grande successo nel gennaio 2003 nella traduzione di Georg Holzer e Laura Olivi (che firma anche lo studio drammaturgico alla messinscena) alla Haus der Kunst del Bayrisches Staatschauspiel, assieme ai Kammerspiele, il più importante teatro di Monaco. La regia è firmata dalla giovane Tina Lanik.
Il testo tradotto è stato pubblicato nel numero di marzo 2003 di "Theater Heute".
La prima austriaca è prevista per novembre 2003, allo Schauspielhaus di Graz; nell'aprile 2004 un’ulteriore messinscena al Maxim Gorky Theater di Berlino. Altre produzioni di testi di Paravidino sono in allestimento in Germania e in altri paesi .
Il teatro delle donne all'Odin
Il festival e gli incontri a Holstebro, 15-25 January 2004
di Redazione ateatro
Si terrà nel prossimo gennaio a Holstebro in quarto incontro internazionale sul teatro delle donne. Qui di seguito le info essenziali.
IV Women's International Theatre
Festival and Meeting
ROOTS IN TRANSIT
Holstebro, Denmark 15-25 January 2004
Roots are usually imagined sinking into the ground and going backwards in time. Roots in Transit IV would like to propose a different image: active, germinating, sprouting roots that point outwards, forwards and upwards. Many young women search for a technical base and a professional identity among people whose social behaviour and habits are different, and in places where their mother tongue is not spoken. Theatre allows those of us who belong to a community of uprooted individuals to chose the mould where new and different roots will grow. Even women who strongly identify with their culture and ancestors rediscover the wisdom passed on from a living past.
The image of a network is made up of crossing lines and empty spaces. The experience of the women meeting within The Magdalena Project tells us that important information is contained in the spaces opened by the intersecting lines. Roots in Transit will give particular attention to geographical diversity, and to the simultaneous presence of women working in theatre, music and dance. The programme consists of two parts: the first with practical workshops, demonstrations and performances; and the second with vocal and physical training (Cultivating), workshop demonstrations (Sowing), presentations (Origins), videos, lectures, discussions, concerts and performances. (Julia Varley)
Workshops, meetings and performances with
Gilly Adams, Wales - Hasna el Becharia, Algeria - Margarita Borja, Spain - Luisa Calcumil, Argentina - Ileana Citaristi, India - Claudia Contin, Italy - Gilla Cremer, Germany - Brigitte Kaquet, Festival Voix de Femmes, Belgium - Jill Greenhalgh, The Magdalena Project, Wales - Geddy Aniksdal, Grenland Friteater, Norway - Deborah Hunt, Puerto Rico - Magdalena Segunda Generación, Argentina - Magdalena Aotearoa, New Zealand - Magdalena Australia, Australia -La Musica Theatre, Egypt - Nomad Teatro, Spain - Maria Ficara, Teatro Proskenion, Italy - Odin Teatret, Denmark - Raysa Fatima Taba'marante, Morocco - Teatret Om, Denmark - Topeng Shakti, Bali - Uhan Shii Theatre Group, Taiwan - Voix Polyphoniques, France - Anna Yen, Australia - Yuyachkani, Peru - Carran Waterfield, Great Britain
Participation fees
For participation in two workshops (or in the production process) and in the whole festival including all meetings and performances, food and lodging (4 persons per room), daily transportation between the lodging quarters and Odin Teatret, from the 15th to the 25th of January 2004, DKK 7000. For a Festival Card giving admittance only to performances from the 20th to the 25th of January 2004, DKK 900.
Applications
Applications should be sent to: TRANSIT, Odin Teatret, Box 1283, 7500 Holstebro, Denmark, or by email to: transit@odinteatret.dk. by October 1st 2003, naming the priority choice of workshops.
Please enclose a short curriculum vitae with your address, telephone, email/fax. A total of fifty participants will be accepted. For further information on Roots in Transit see the web site www.odinteatret.dk/evatodin/schema.htm and www.themagdalenaproject.org
ODIN TEATRET
NORDISK TEATERLABORATORIUM
SÆRKÆRPARKEN 144 POSTBOX 1283
DK-7500 HOLSTEBRO
TELEPHONE 97 42 47 77 (9-15)
TELEFAX 97 41 04 82
EMAIL odin@odinteatret.dk
Online www.ildramma.it di settembre
Il sommario
di Redazione ateatro
Uno speciale dedicato al Festival di Nuova Drammaturgia Tramedautore dell'Outis di Milano giunto alla terza edizione.
In particolare segnaliamo: L'attentato di Luigi Gozzi prodotto dal Tne/Teatro delle Moline
in collaborazione con Teatro dell'Argine/ITC
e
Rovescio della Medaglia di Marcello Isidori in scena al Teatro Franco Parenti il 19 settembre ore 21,30.
Il dramma del mese è Sul confine di Leonardo Franchini, un esempio di Teatro d'impegno civile datato 1989, quando fu rappresentato con grande successo al Festival di Todi e poi trasmesso più volte da Rai 3 qualche anno dopo.
Il sito del mese è "Teatro civile" punto di riferimento su internet per seguire le iniziative e gli spettacoli del gruppo romano.
Il premio Dramma in rete 2004 è in scadenza (30 settembre) potete partecipare cliccando qui
Scaricabili dalla home page i bandi di prossima scadenza.
Per visitare il sito, clicca qui.
Niente Teatro Lirico per Dell'Utri e Longoni
Il Tar della Lombardia dice no
di Redazione ateatro
Tre mesi fa, il Comune di Milano aveva affidato la ristrutturazione e la gestione del Teatro Lirico di Milano alla cordata Ati (composta da Milano Festival e Gestioni Teatrale e guidata dall’impresario Gian Mario Longoni), che aveva affidato al direzione artistica della sala al manager di Mediaset nonché senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri, suscitando discussioni e polemiche (ne trovate traccia nel forum sul teatro di guerra in questo sito).
Il Tar della Lombardia, con una sentenza depositata il 9 settembre, ha accolto il ricorso del secondo classificato, i fiorentini di Bobotheatre (che gestiscono tra l’altro il Teatro Puccini).
Il problema sarebbe nato nell’ultima fase del concorso, quando sono stati precisati i costi della ristrutturazione della sala: l’ATI avrebbe previsto "un importo parti a oltre 13 milioni di euro, rispetto ai 3,5 milioni inizialmente previsti", mentre i rivali non si sarebbero discostati dalla cifra inizialmente proposta. Ma secondo Lorenzo Luzzetti (Bobotheatre) le irregolarità sarebbero state più d’una: una esperienza teatrale minore di quella richiesta dal bando, una eccessiva presenza del musical nella programmazione e, appunto, un diverso e più costoso progetto di ristrutturazione.
A questo punto, si vedrà se per riaprire il Teatro Lirico, chiuso ormai da anni, sarà necessario passare per un nuovo ricorso, questa volta al Consiglio di Stato.
