La fine della cultura come servizio pubblico
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro55.htm#55and1
Verso una nuova convocazione Vecchio teatro nuove istituzioni
Un resoconto dell'incontro di Santarcangelo del 12 luglio a cura
di Mimma Gallina
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro55.htm#55and2
Le notizie
In libreria Le vie dei festival
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro55.htm#55and3
La lingua cancerosa del teatro
I “limiti” di Enzo Moscato
di Concetta D’Angeli
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro55.htm#55and9
Ossimori
Intervista a Enzo Moscato (Livorno, 7 aprile 2003)
di Concetta D'Angeli con Anna Barsotti
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro55.htm#55and10
La lingua, il corpo, la politica
Un ritratto di Cada Die Teatro
di Anna Maria Monteverdi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro55.htm#55and15
Al lavoro con Rodrigo García
Il diario dell'allestimento di Historia de Ronald el payaso de McDonald (La Storia di Ronald il pagliaccio del McDonald) a Intercity
di Alessandro Romano
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro55.htm#55and20
Le recensioni di "ateatro": In fondo a destra
di Raffaello Baldini, regia di Federico Tiezzi
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro55.htm#55and50
Le recensioni di "ateatro": Cinema Cielo
Ideazione e regia di Danio Manfredini
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro55.htm#55and51
Le recensioni di "ateatro": Ada, cronaca familiare. Ardis I (Les Enfants maudits)
di Fanny & Alexander
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro55.htm#55and52
Le recensioni di "ateatro": Braccianti. La memoria che resta di Armamaxa
di e con Enrico Messina e Micaela Sapienza
di Anna Maria Monteverdi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro55.htm#55and53
Le recensioni di "ateatro": Apparizioni
di Alfonso Santagata
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro55.htm#55and54
Le recensioni di "ateatro": Imparare è anche bruciare
del Teatro della Valdoca
di Alessandra Giuntoni
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro55.htm#55and55
Il set teatrale di Flicker
Lo spettacolo multimediale di Caden Mason (Big Art Group) a Inteatro
di Anna Maria Monteverdi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro55.htm#55and60
Il teatro tra televisione e cinema
Flicker del Big Art Group
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro55.htm#55and61
Telestreet toscane: inzia la corsa
con un approfondimento su Minimal tv
di Anna Maria Monteverdi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro55.htm#55and79
Per un'arte della connessione
Recensione a Marco Deseriis e Giuseppe Marano, NET.ART. L’arte della connessione, Shake Edizioni
di Tatiana Bazzichelli
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro55.htm#55and80
tnm news
E' uscito "Neural 20"
di Redazione tnm
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro55.htm#55and87
Launderette Soap
Un progetto teatrale
di 'O Zoo No
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro55.htm#55and90
L'editoriale
La fine della cultura come servizio pubblico
di Redazione ateatro
Siamo (quasi) tutti cresciuti in un’epoca in cui la cultura veniva considerata un bene pubblico, in base a quanto recita l’articolo 9 della Costituzione (tuttora in vigore, e adottato da "ateatro"). Dunque, si ragionava, se la cultura è un bene pubblico, essa deve anche essere un servizio pubblico, di cui l’intera collettività deve poter usufruire, indipendentemente dalle condizioni economiche e dalle situazioni geografiche. Questa convinzione animava, alla fine, anche una vocazione e una pratica pedagogiche. Intorno a questo sentire si sono strutturate alcune importanti istituzioni: dal sistema scolastico alla rete dei musei e delle biblioteche, dalle varie normative a sostegno del cinema alla Rai degli anni Cinquanta e Sessanta. E, in campo teatrale, nel dopoguerra, il Piccolo Teatro e gli altri stabili, e in generale il meccanismo delle sovvenzioni ai teatri lirici e di prosa, e poi i circuiti teatrali, nati all’insegna del decentramento.
Quello a cui stiamo assistendo in questi anni è l’erosione del concetto di cultura come bene collettivo e patrimonio comune e dunque come servizio pubblico. In questi decenni l’enfasi si è spostata dal collettivo, dalla società nelle sue varie articolazioni, all’individuo consumatore. Il "nazional-popolare" è stato soppiantato da un lato dal pubblico generalista, dall’altro da nicchie, da frammenti diversificati per interessi (e mercato). A ruoli sociali precisi e immediatamente identificabili si è sostituita un’identità frammentata e mobile, in cui la scelta individuale ha un ruolo significativo. Il benessere economico e la diffusione dei mezzi di comunicazione di massa e della scolarizzazione hanno messo in secondo piano la necessità di facilitare l’accesso alla cultura delle fasce più disagiate.
L’enfasi sull’economia porta a considerare i beni culturali un patrimonio finanziario (vedi la recente impostazione del ministro Tremonti), una risorsa (in primo luogo turistica e di marketing), un’opportunità di consumo (in competizione con mille altre, ma in costante ascesa con l’allargarsi del tempo libero), uno strumento per costruire la propria personale identità (attraverso un meccanismo di scelta), un’opportunità occupazionale (con il proliferare di corsi di laurea, master e quant’altro). Insomma, anche la cultura sembra entrata a pieno titolo nel mercato. Anche se poi un’impresa culturale (se vogliamo adottare questa nomenclatura) non può ridursi a essere solo questo: senza una autonoma progettualità si autodistrugge.
In questo scenario non sorprende che le risorse pubbliche per la cultura e per il teatro tendano a diminuire drammaticamente (in valore reale) e a concentrarsi sulle istituzioni maggiori, le più note e costose (e progressivamente sempre più costose). Così la lotta per le scarse risorse si fa sempre più feroce, la spartizione tra gruppi di potere sempre più soffocante.
Per produrre uno spettacolo è ormai necessaria un’opera di faticosa raccolta di finanziatori. Accade ai livelli più vari: accade al Piccolo Teatro, che da solo (pare) non ha più le risorse per produrre gli spettacoli di Luca Ronconi e si affratella dunque a altre realtà ricche di mezzi finanziari; accade a giovani gruppi come Motus e Fanny & Alexander, che raccolgono co-produzioni dai festival di mezza Europa; accade ai "teatri della memoria" che si costruiscono attraverso percorsi laboratoriali radicati nel territorio e a contatto con le sue istituzioni (vedi i casi esemplari di Ascanio Celestini o di Armamaxa). Ovviamente sono percorsi produttivi che rischiano di imporre una serie di mediazioni e alla lunga di limitare l’autonomia del percorso artistico.
Insieme, diventa sempre più difficile difendere i pochi spazi ancora "aperti" (le poche isole felici, che poi tanto felici non sono, e si rivelano ogni giorno più precarie). E diventa un’impresa immaginare, sostenere e animare progetti di ampio respiro.
Non mancano, in questa penuria di denari e di idee, ripicche e piccole vendette, che possono avere conseguenze disastrose: perché se si rompono i fragili equilibri che sostengono l’economia e gli equilibri politici delle rare istituzioni aperte al nuovo, il risultato può essere solo quello di una deriva conservatrice.
Certo, lobby, combriccole e clientelismi sono sempre esistiti: ma quando si perde l’orizzonte del bene collettivo e restano solo i meccanismi di potere, quando si perde il senso delle battaglie culturali in corso a favore di una indistinta marmellata in cui tutto si equivale (o si riduce a livello di gusto personale), il sistema è destinato a degenerare rapidamente. Quello a cui stiamo assistendo è proprio questo: la degenerazione sempre più rapida del sistema teatrale, il suo saccheggio da parte di gruppi di potere sempre più affamati (in un quadro di risorse decrescenti) e dunque più feroci, e qualche irresponsabile regolamento di conti.
Di questa degenerazione è complice anche la sinistra, che spesso si arrocca su antichi privilegi e non è ancora riuscita a immaginare nuovi assetti di sistema.
Così si assiste a un progressivo spostamento dell’attenzione. Le stagioni invernali paiono sempre più asfittiche, non presentano quasi più alcun margine di rischio. Invece d’estate (testimone anche l’affollatissimo forum di "ateatro" dedicato ai Festival) proliferano festival, rassegne e manifestazioni. E’ un moltiplicarsi di iniziative molto spesso minime, disseminate sul territorio, complice qualche assessorato, che tendono a portare il teatro fuori dal teatro, a costruire l’evento - magari su scala «mini». Non a caso anche in questo settore però sono in crisi finanziaria e di identità le istituzioni maggiori, più consolidate e prestigiose, mentre pullulano le iniziative dal basso, speso con un ampio margine di rischio creativo). E’ uno spostamento dal tempo del lavoro e della polis (della politica) a quello dello svago, del nomadismo, della scelta. Dalla rappresentazione di sé (e dei conflitti nei quali siamo coinvolti) si passa alla costruzione di sé - attraverso affinità elettive ed esperienze che ci plasmano.
E’ in questo teatro in mutazione, attraversato da battaglie estetiche e politiche, che si muove questa webzine, cercando di gonfiare le vele a ogni refolo di vento, tenendo fissa la barra del timone. Così ateatro 55, che doveva essere uno svelto numero estivo, si è via via arricchito di materiali, interventi, suggestioni.
Per cominciare, un grazie di cuore a Concetta D’Angeli, alla quale dobbiamo uno «speciale Moscato» con un saggio sulla «poetica dell’ossimoro» e un’ampia intervista all’autore-attore napoletano.
Per chi ama il dibattito, c’è il verbale sull’incontro del 12 luglio a Santarcangelo, con un appuntamento a fine anno a Castiglioncello per un nuovo round Nuovo teatro vecchie istituzioni (ma intanto gustatevi anche i forum, dove si discute degli intermittens du spectacle che hanno fatto saltare la stagione dei festival in Francia e della crisi dell’ETI).
Alessandro Romano segue Rodrigo García mentre allestisce a Firenze per Intercity la Historia de Ronald el payaso de McDonald.
Anna Maria Monteverdi scatta una fotografia-intervista al Cada Die Teatro.
Siamo ovviamente andati a vedere alcuni degli spettacoli che animano questa estate dei festival: Cinema cielo di Danio Manfredini, In fondo a destra di Baldini-Tiezzi-Castiglioni, Braccianti di Armamaxa, Apparizioni ovvero il ciclo degli Atridi secondo Alfonso Santagata, Ada di Fanny & Alexander, Imparare è anche bruciare del Teatro della Valdoca (e altre recensioni seguiranno).
Sono molti i pezzi in cui si discute delle forme della rappresentazione, ma Flicker degli americani Big Art Group aiuta a mettere a fuoco alcuni interessanti snodi teorici.
Su tnm Tatiana Bazzichelli parla di net.art, Anna Maria Monteverdi dell’incontro delle telestreet toscane e di minimal tv. Infine c’è la presentazione di una nuova soap teatrale...
Verso una nuova convocazione Vecchio teatro nuove istituzioni
Un resoconto dell'incontro di Santarcangelo del 12 luglio a cura
di Mimma Gallina
"Il gruppo di lavoro per lo spettacolo contemporaneo", che si era informalmente riunito a Prato in occasione di "Contemporanea 03", ha promosso un secondo incontro a Santarcangelo per approfondire i temi del documento elaborato (vedi ateatro 54) e in particolare per avviare - come ci si era proposti - una serie di incontri aperti che sollecitassero "i rappresentanti delle forze politiche impegnate a livello nazionale e locale sui temi della cultura, intellettuali e artisti, altri operatori del settore a riflettere su questi temi, sul ruolo strategico dello spettacolo contemporaneo, anche uscendo dai canali consolidati (organizzativi, legislativi, di finanziamento)". La discussione, pur partendo dal tema specifico, si è di fatto allargata a temi più generali, cogliendo l'occasione della presenza e della disponibilità dell'onorevole Giovanna Grignaffini dei DS, esponente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati) e di alcuni funzionari della Regione Emilia Romagna (unici - o meglio primi - obbiettivi raggiunti, per ora, del confronto auspicato).
La preoccupazione di fondo, sottolineata ancora una volta da tutti, è risultata quella che nel documento indicavamo come "l'avvenire della nostra scena, minacciata dalla superficialità, da mancanza di regole certe, da concezioni che vogliono la cultura direttamente produttrice di consenso, strettamente legata alla politica e alle sue alternanze, sempre più appiattita dal consumo televisivo".
Da parte degli operatori, si è insistito sulla necessità che la cultura (e in particolare la cultura della contemporaneità) venga rimessa al centro della battaglia politica, come condizione di "tenuta" del tessuto democratico e di espressione delle giovani generazioni, appropriazione e condivisione di valori. Alla rappresentante DS si è chiesto di confermare questa centralità e collegare a questa dimensione di "alta" politica, le fondamentali questioni di riforma legislativa e definizione di competenze che riguardano il teatro di prosa.
A questo proposito si è ancora una volta sottolineata l'assoluta inadeguatezza dello strumento "FUS" (argomento più volte emerso negli incontri "Nuovo teatro vecchie istituzioni"), e la contrazione di finanziamenti che il settore ha subito nel tempo a livello statale e, da alcuni anni, anche a livello locale.
Si è anche sottolineata l'importanza di "vigilare" ed esercitare le necessarie forme di controllo e denuncia sui diffusi livelli di degrado istituzionale (e il più delle volte formalmente "legittimi") che sta caratterizzando la situazione organizzativa del teatro italiano: dal "nuovo" regolamento (e dall'ampio margine di arbitrio che ha introdotto) alla gestione dell'ETI (con i suoi 5 consiglieri di amministrazione tutti di nomina governativa e i suoi "bandi" non proprio trasparenti), alla politica di molte amministrazioni locali sempre più orientate a contenere le forme di sostegno al teatro (e al teatro contemporaneo in particolare) e a proiettare la propria "politica culturale" verso la raccolta del consenso (grandi concerti, "eventi spot": i vecchi assessorati "per la" cultura sono qua e là diventati assessorati ai "grandi eventi"), o anche significativi orientamenti o investimenti strutturali, spesso ignari di implicazioni gestionali.
La presenza di un unico interlocutore politico rappresentante dei DS e dei funzionari della regione Emilia Romagna ha portato a sottolineare da parte di molti la percezione di un calo di qualità, competenza e sensibilità politico-culturali, anche da parte degli amministratori della sinistra: sono state fatte insomma - e ascoltate con eleganza - molte critiche (e forse ne è stata taciuta qualcuna fra quelle emerse a Castiglioncello, ad esempio). Questo punto (cioè l'importanza dell'amministrazione locale per la "tenuta" del sistema democratico, e la sopravvivenza di quello teatrale, e il suo -presunto o reale - calo di tensione e qualità) è forse quello che è emerso con maggiore insistenza dalla discussione.
Da parte di alcuni operatori presenti, di fronte al rischio di un pessimismo poco costruttivo di molti colleghi, si è voluto sottolineare lo sviluppo e il forte valore innovativo di realtà "minori" in termine di dimensione aziendale, "provinciali" come collocazione, ma abbastanza diffuse a livello del territorio, come anche l'importanza e i risultati raggiunti attraverso collaborazioni informali (il modo di lavorare "a rete" che ha consentito in questi anni la realizzazione di importanti progetti anche a livello internazionale), infine l'affacciarsi al settore di giovani molto motivati e preparati a livello delle diverse professioni. E' stata però sottolineata anche la "differenza" e la difficoltà di percepire le nuove modalità di espressione delle giovani generazioni (al di là dei generi e dei modi canonici) in assenza di strutture, mezzi etc. (tornando così al punto di partenza del gruppo di lavoro: i cui obiettivi non vanno comunque trascurati).
Indubbiamente i problemi sollevati sono stati colti con sensibilità e disponibilità (di cui credo si debba essere grati all'on. Grignaffini anche perché i nostri "cahiers de doléances" sono durati un paio d'ore), ma anche sottolineando alcuni limiti e difficoltà da parte politico-amministrativa non adeguatamente colte dagli operatori: in particolare l'obiettiva contrazione delle disponibilità finanziarie, statali e locali (che può forse far riflettere sulla opportunità di considerare la cultura e lo spettacolo nell'ambito di un ragionamento più generale di politica fiscale: solo un accenno in proposito che meriterà di essere approfondito), una lettura diversa del tanto odiato "consenso" (cioè la necessità di partecipazione). Dai funzionari della Regione Emilia Romagna è arrivata la significativa ricostruzione del rapporto conflittuale fra stato e regioni sulle questioni delle competenze, e anche la segnalazione delle difficoltà gestionali delle leggi regionali. Fra gli altri, è emerso il problema dell'"ascolto" del settore, cioè di come si debba e possa, pur confermando l'importanza fondamentale delle rappresentanze sindacali delle imprese (cioè le diverse articolazioni interne all'AGIS), individuare, almeno a livello della discussione politica generale, anche forme meno mediate, che costituiscano un'espressione più diretta di operatori, artisti, gruppi e delle diverse generazioni.
In coda (e nei corridoi, cioè al ristorante), è emersa la proposta di promuovere per novembre un prossimo appuntamento di "Vecchio teatro nuove istituzioni" (a proposito di rappresentanza informale ma reale!) che sia incentrato proprio sul CONFRONTO FRA OPERATORI TEATRALI da un lato (artisti, organizzatori), e POLITICI E AMMINISTRATORI dall'altro.
Potrebbe essere per novembre (forse a Castiglioncello: Massimo Paganelli ha rinnovato la sua disponibilità ad ospitare la "convention"); dovrebbe, grazie anche all'aiuto di Grignaffini per DS e Ulivo, poter contare su presenze al massimo livello, e affrontare i problemi emersi (e da precisare), a partire dal ruolo della cultura nella politica, per arrivare al rapporto fra teatro e amministrazioni locali. Un piccolo spazio potrebbe anche essere dedicato a ricostruire come e perchè si creò negli anni Settanta il processo che portò allo sviluppo esponenziale del settore (e alla nascita delle politiche culturali locali): forse capendo di più di quegli anni, riusciremo a gestire meglio questi.
Le notizie
In libreria Le vie dei festival
di Redazione ateatro
E' in libreria l'edizione numero 10 delle Vie dei festival, la guida ai festival estivi di cinema, teatro, danza e musica in Italia e in Europa.
E' un vademecum prezioso per tutti quelli che amano lo spettacolo e la cultura live: negli scorsi anni è stato allegato al "manifesto" e a "Diario", ora cammina solo sulle sue gambe. Un bravo (e un grazie) a Natalia Di Iorio & soci! Ah, dimenticavo, costa solo 5 euro.
La lingua cancerosa del teatro
I “limiti” di Enzo Moscato
di Concetta D’Angeli
Anche quando si aggira fra antiche superstizioni popolari, canzoni di repertorio partenopeo, dialetto napoletano, recupero di vecchie tradizioni teatrali, l’opera di Moscato riesce a cogliere vivamente il senso della modernità sia nei suoi aspetti formali sia in quelli contenutistici. E’ il risultato di una persuasione, che non è eccessivo definire filosofica, sottesa alla scrittura dell’autore napoletano, che lo porta a fare della contraddizione il centro del suo teatro - delle sue pièces e della sua poetica, come pure della sua pratica attoriale. A voler trovare un equivalente linguistico-retorico a questa caratteristica sostanziale della attività artistica di Moscato, si può affermare che l’ossimoro è la figura che ne interpreta adeguatamente la poetica e la visione del mondo, del teatro e dell’arte.
Egli stesso definisce il suo un teatro “sul limite”, un teatro cioè che si fonda sulla antinomia e sulla dissonanza e che, senza mai tentare minimamente di conciliare i termini oppositivi della contraddizione, al contrario li alimenta, li tiene in vita, e di essi si sostanzia. Allo stesso modo nell’ossimoro, i due termini che lo costituiscono rimangono visibili e attivi e l’antinomia, assunta come tale, non si risana.
Provo adesso a riflettere su alcune delle principali dicotomie che possono essere individuate come “i limiti”, i confini fra territori antitetici, sui quali si gioca tutto il teatro di Enzo Moscato.
1. Uno degli aspetti che in esso maggiormente colpisce fin dal primo approccio è la lingua, amalgama di frammenti provenienti da diverse strutture e da sistemi contraddittori. La sua base, o “grado zero”, è un parlato plebeo e duro, non imborghesito e di struttura arcaica, che Moscato lega a un momento fondamentale della sua biografia: alla sua infanzia di ragazzino povero, trascorsa nei vicoli dei Quartieri Spagnoli di Napoli. Questa base linguistica si arricchisce però in modi imprevedibili e copiosi in conseguenza di un’altra fase biografica: grazie alle sue capacità intellettuali e a prezzo di un apprendimento difficile e vissuto spesso come sradicamento e rischio di spossessamento e perdita di personalità, Enzo Moscato si emancipa, almeno in parte sebbene mai definitivamente, dalla sua iniziale identità scugnizza e compie un oggettivo salto sociale che gli permette di acquisire la successiva qualifica di insegnante e intellettuale. L’apprendimento scolastico significa anche, in campo linguistico, la capacità di padroneggiare correttamente l’italiano-standard, che tuttavia non diventerà mai l’unica lingua, la lingua-madre di Moscato: essa coesiste, a pari dignità, con il dialetto e si intreccia con le lingue straniere o antiche, successivamente apprese in modi non dissimili da come è stato appreso l’italiano, durante l’esperienza scolastica.
Avviene così, nel momento della scrittura, una sorta di processo di diffrazione: sulla lingua d’origine, il grado-zero dialettale, si innestano una terminologia, delle strutture sintattiche, delle espressioni, che hanno provenienze e livelli stilistici molto diversi, pescati in bacini espressivi appartenenti indifferentemente al livello “sublime” e a quello basso della comunicazione linguistica, e sempre perseguendo una ricerca espressiva che si caratterizza per lo stridore stilistico e l’antitesi delle forme. Insieme a frammenti di lingua colta e letteraria, infatti, Moscato usa le lingue classiche e le lingue straniere moderne (il francese, l’inglese, lo spagnolo, il tedesco); introduce il linguaggio patetico e ingenuo della letteratura rosa accanto a sofisticati linguaggi tecnici (quello psicanalitico, quello semiologico), a loro volta mescolati con spezzoni della prosa quotidiana diffusa dai peggiori programmi televisivi, scadente e ai limiti della correttezza, e, all’opposto, con filastrocche, canzoncine, nenie, proverbi della tradizione popolare. Su un tale disparato mélange linguistico e stilistico opera infine una specie di “antichizzazione” (come fanno i restauratori di mobili o tappeti), recuperando la lingua arcaica, secentesca, di Giovanni Battista Basile.
Non a caso ho insistito sulla incidenza della biografia a proposito della definizione e della caratterizzazione della lingua teatrale e poetica2 di Moscato: nata dal centro e dalla concretezza materiale e esperienziale della vita, la sua lingua teatrale (o poetica, come Moscato preferisce dire), per quanto sofisticata e raffinata, ha in realtà una caratterizzazione poco intellettuale, ed è piuttosto fisica invece, più legata alla realtà, affine alla concretezza dei parlanti e in sostanza alla tangibilità dei corpi. Questa proprietà, sempre evidente, si rafforza in modi clamorosi dopo la “svolta lirica” inaugurata da Partitura nel 1986-87 ma già ampiamente presagita con Compleanno, nel 1986: si definisce meglio, da allora, quel concetto di lingua “cancerosa” che, sia nell’espressione sia nell’immagine, tiene ben presente il riferimento alla peste di Antonin Artaud, la metafora della quale lo scrittore francese si serve per esprimere le più caratterizzanti funzioni del teatro.
Il teatro essenziale è come la peste, non perché è contagioso, ma perché come la peste è la rivelazione, la trasposizione in primo piano, la spinta verso l’esterno di un fondo di crudeltà latente attraverso il quale si localizzano in un individuo o in un popolo tutte le possibilità perverse dello spirito […]
In esso, come nella peste, c’è una sorta di strano sole, una luce di anormale intensità, dove sembra che il difficile e persino l’impossibile divengano d’un tratto il nostro elemento normale […]
Si può dunque dire che ogni vera libertà è nera e si dentifica immancabilmente con la libertà sessuale, anch’essa nera senza che se ne sappia bene il perché […]
Ed è per questo che tutti i grandi Miti sono neri, e che fuori da una atmosfera di strage, di torture e di sangue versato, non si possono immaginare le splendide Favole che raccontano alle folle la prima divisione sessuale e il primo massacro di essenze che appaiono nella creazione.
Il teatro, come la peste, è modellato su questo massacro, su questa separazione essenziale. Scioglie i conflitti, sprigiona forze, libera possibilità, e se queste possibilità e queste forze sono nere, la colpa non è della peste o del teatro, ma della vita.3
La sessualità nei suoi risvolti “neri”, le stragi psicologiche e spesso anche fisiche sono elementi che percorrono il teatro di Moscato e trovano il loro esatto riflesso nella lingua che egli usa: quella lingua “cancerosa”, equivalente del male, autodistruttiva - una lingua che divora se stessa e si afferma solo per potersi corrodere. E’ una lingua, anche, intemperante, lontanissima dalla misura classica e dalle norme che sovrintendono alla scrittura letteraria: emerge così, a livello espressivo, quel gusto per la dismisura, che indurrà la critica a parlare di “barocco degradato”4, per sottolineare i legami che il teatro di Moscato intrattiene con il Seicento e che riguardano non solo la sua scrittura e la sua lingua, ma tutta la sua opera teatrale, nel complesso caratterizzata dall’eccesso, dalla profusione, dalla commistione di generi e stili, dalla ricchezza smodata delle situazioni e delle immagini.
2. C’è un modello per il barocchismo di Moscato, ed è la città di Napoli: multipla, sovrabbondante, enfatica, barocca per antonomasia. E dunque il legame che ho sopra individuato fra la lingua e la biografia va in qualche misura rettificato: la lingua non è solo una eredità biografica, per Moscato, ma costituisce un luminoso indizio di appartenenza alla dimensione antropologica, culturale, sociale di Napoli. Perciò l’operazione linguistica che nella sua scrittura Moscato compie, così sofisticata da ricevere talvolta l’accusa di intellettualismo, a me pare soprattutto un originale tentativo di sprovincializzare il dialetto, conservandone però, allo stesso tempo, il vigore che gli deriva dall’essere una lingua viva e parlata: una qualità non ovvia per l’italiano letterario, che è artefatto e di tradizione prevalentemente scritta e che, proprio a causa della sua astrattezza e artificiosità, mantiene una rigidezza espressiva che lo rende strumento poco plasmabile e molto condizionante per l’espressività creativa.
Napoli stessa può essere considerata un altro “limite” del teatro di Moscato: la “città soglia”, luogo di confine tra la razionalità e una dimensione misterica e segreta, che la fantasia popolare ha sempre coniugata alla morte. Numerosissimi sono considerati a Napoli i palazzi affatturati, dove “ci si sente”, dove cioè vivono, secondo credenze molto condivise, gli spiriti, i fantasmi; il sottosuolo napoletano è pieno di grotte, catacombe, camminamenti sotterranei, un mondo che si è sviluppato parallelamente a quello di superficie, favorendo nella gente una forma di “sensibilità trascendentale”5, che spesso prende l’aspetto della superstizione. Ma in realtà si tratta della conseguenza di un rapporto costante tra il mondo della luce e quello delle tenebre, di un ininterrotto dialogo con la morte. E’ questa antica cultura, che pone al centro l’oltretomba, il mistero e l’irrazionale, quella che, repressa perché sconfitta da una “modernità” colonizzatrice, riemerge nella forma degradata della superstizione e pervade, spesso innescando altre contraddizioni, tutto il teatro di Moscato.
Ma Napoli è anche erede di una tradizione culturale e teatrale fra le più alte d’Italia: tuttora attraversata da un fervore intellettuale vitalissimo, la città è d’altra parte oppressa da un profondo degrado socio-economico, politico, ambientale, antropologico, e inevitabilmente anche culturale. Proprio con questa contraddizione, che permea ogni aspetto della città, si può forse spiegare una singolarità delle opere di Moscato: sebbene siano state scritte tutte a partire dagli anni Ottanta e sebbene l’esperienza dell’autore non possa essere stata quella della guerra, per ragioni di cronologia (Enzo Moscato è nato nel 1948, a guerra appena finita), in molte sue pièces, soprattutto quelle degli inizi, si parla moltissimo della guerra, di Napoli occupata dai tedeschi e poi dalle truppe alleate, bombardata dal cielo e dal mare, con gli abitanti costretti a prostituirsi in mille modi agli invasori… Mi spiego questo assillo proprio con un uso simbolico dell’immagine (non dell’esperienza) della guerra: voglio dire che la guerra non solo ha fatto precipitare una decadenza che già aveva largamente corroso la città e il popolo napoletano, ma soprattutto che essa è stata, per Napoli, occupazione di eserciti stranieri che l’hanno contraffatta, manipolata, le hanno sottratto identità e storia. Perciò “Napoli-durante-la-guerra” diventa immagine-simbolo di qualsiasi altro snaturamento, linguistico o morale o spirituale o intellettuale o materiale - uno snaturamento e una degradazione che non accenna a cancellarsi, perché sembra che sempre Napoli sia in guerra, che sia diventata un territorio di conquista ininterrotto.
Napoli campeggia dunque nella scrittura di Moscato in modi perfino ossessivi, e tuttavia la sua immagine non prende mai la forma descrittiva: sono le allusioni a strade, piazze, vicoli, palazzi, che fanno emergere una mappa precisa della città e ne equiparano l’architettura e la topografia a un corpo umano. In questo senso esiste una fortissima prossimità tra la Napoli che si delinea nei testi di Moscato e il corpo del travestito; ed è un’analogia che rende vivo e altrettanto affranto e sofferente e inquieto, come il corpo del travestito, anche il corpo della città. La componente autobiografica, che indubbiamente sostanzia l’immagine di Napoli, in tal modo si oggettiva, decantandosi da qualsiasi sfumatura di sentimentalismo nostalgico, verso il quale Moscato manifesta sempre profonda irritazione, e caricandosi invece di una carnalità che della città conserva il fascino e insieme ne porta in superficie le asperità, i problemi irrisolti, il rischio della decadenza totale e del completo oscuramento di identità - la tragedia insomma di un luogo che è stato grande centro di civiltà e di cultura ma che non riesce più a trovare il passo della modernità né a mantenere una fedeltà adeguata all’alta tradizione del suo passato. E’ una città in perenne, inquieta metamorfosi, che mostra le sue duplicità e le contraddizioni che ne alterano l’identità del passato, senza mai farle raggiungere un punto fermo. Di queste continue trasformazioni il terremoto, quello che nell’80 ha contribuito potentemente ad accentuare la precarietà e il decadimento cittadini, costituisce il tragico, conforme e molto reale equivalente.
3. Anche il travestito è un’immagine di metamorfosi: non possiede infatti una precisa identità, o comunque non accetta una identità sessuale (quella “naturale”, biologica, cioè quella maschile), ma non ne ha acquisita in modo definitivo una nuova (quella femminile). Ferdinando Taviani mette in evidenza il ruolo assunto dal travestito nelle opere dei drammaturghi napoletani degli anni Ottanta: il personaggio del travestito o del prostituto, che ritorna di commedia in commedia, appare come “il nuovo ‘tipo’ d’una nuova tradizione”6. Nel teatro di Moscato esso si lega dunque non tanto al tema dell’omosessualità (che peraltro è largamente presente nella sua drammaturgia ma in un modo, secondo me, meno significativo), quanto piuttosto al fatto che il travestito acquista un valore simbolico, media un rituale di mascheramento, interpreta un cerimoniale funebre, una liturgia che ha a che fare con la morte. In filigrana il travestito di Moscato rivela le linee del suo modello: quel femmeniello che, almeno fino alla metà del Novecento, mantiene un importante ruolo sociale nella vita del vico napoletano. Il femmeniello vive di preferenza fra le donne e partecipa strettamente alla loro vita, spesso adornato in modi femminili, con gli orecchini, il trucco, i colori degli abiti delle donne; era considerato indispensabile soprattutto nei giochi di fortuna (il lotto, la tombola), nella persuasione che proprio la sua diversità, il suo essere “sulla soglia”, né donna né uomo, lo renda il tramite con le potenze metafisiche, con il mondo della magia - che perciò egli abbia un rapporto singolare con la realtà ultraterrena e con la morte.
Dopo la seconda guerra mondiale, tra le molte cose che a Napoli sono cambiate, anche il ruolo del femmeniello si è modificato: il travestito ne ha preso il posto, ma introducendo nella tradizione del femmeniello importanti trasformazioni antropologiche, e prima di tutto lo sradicamento e la solitudine, in opposizione alla socialità di vicolo che un tempo si aggregava intorno alla sua figura. Resta però il senso del confronto con il “diverso”: anche nella modernità del teatro di Moscato, il travestito rappresenta infatti la possibilità di misurarsi con la parte oscura e profonda della propria individualità e soprattutto interpreta al meglio quella attitudine agli sconfinamenti, che appartengono a Moscato come suo particolare modo di essere, ma che sono anche importanti elementi semantici e formali del suo teatro.
A proposito dei travestiti Moscato parla anche di figure retoriche, che rappresentano l’esigenza di cambiamento, di trasmutazione, di viaggio dovuto al tedio di sé e alla nostalgia dell’altro: essi interpretano dunque una esigenza di completezza, all’inseguimento di una realtà complessa e metamorfica. In questo senso l’immagine del travestito corrisponde efficacemente ad un credo filosofico che sostanzia il mondo artistico di Enzo Moscato e che egli definisce coincidentia oppositorum. Si tratta del fondamento della sua teoria del limite e dunque della sua proposta poetica di “teatro sul limite”: essa riposa sulla assunzione del corpo e del pensiero come due differenti aspetti della stessa realtà, entrambi contemporaneamente presenti nella manifestazione dell’essere. In questa persuasione filosofica, che fonda la poetica oltre che la pratica teatrale di Enzo Moscato, si riconosce il concetto della “coniunctio oppositorum” elaborato da Carl Gustav Jung nei suoi ultimi studi di psicologia del profondo, in analogia con la fase del processo alchemico nel quale si cerca “non solo di visualizzare insieme gli opposti, ma anche di esprimerli insieme”7. Moscato trova un equivalente teatrale a queste teorie di Jung8 in una prassi dove la scrittura è insieme corpo e parola e l’attore, recitando, matericamente attraversa la parola con il suo corpo e trasforma in esperienze fisica l’avvenimento intellettuale della scrittura. Si impone così, soprattutto nelle più recenti produzioni di Moscato, la presenza di quel corpo-parola dentro il quale è impossibile distinguere i due elementi che lo compongono e che occupa, come una singola unità fisico-psichica, non solo lo spazio scenico ma anche il testo drammaturgico: la sensualità della parola, anche quella scritta, dell’autore napoletano si spiega proprio con la sua duplice scaturigine, frutto di un percorso cerebrale non più che di un’esperienza fisica e materiale.
Del resto, la doppiezza mediata dall’immagine del travestito ha strettamente a che fare con il teatro: è Jean Genet, il cui nome è stato più volte accostato a quello di Moscato soprattutto per le prove drammaturgiche dell’inizio, che riconduce in modo esplicito l’ambiguità sessuale alla prassi teatrale. Genet ritiene che l’attore debba esprimere la natura mitica rappresentata da Tiresia il quale, avendo visto nuda Diana, venne punito dalla castissima dea con la cecità e con l’obbligo di alternare, ogni sette anni, l’identità femminile e quella maschile. Così deve essere l’attore: privo di specificità sessuale, capace di assumerle tutte e di sconfinare ogni volta che le necessità teatrali glielo richiedano, e soprattutto senza riposo, cioè senza un punto fisso, nemmeno l’identità sessuale, su cui fermarsi e concedersi pace9.
In termini meno filosofici e più teatrali, il travestitismo ha a che fare con l’innaturalismo, che è argomento centrale dell’opera di Moscato. Il suo frequente ricorso alla recitazione en travesti è solo in parte l’allusione colta e snobistica a modalità teatrali abbandonate ma dotate di una lunga tradizione, che passa dagli attori dell’antica Grecia a quelli shakespeariani ai belcantisti del teatro in musica, dal Seicento all’Ottocento. Se il recupero di una simile eredità attoriale è in parte un modo “prezioso” di recitare, è vero però che il preziosismo di Moscato si rinnova radicalmente per il fatto che i suoi travestiti sono tutti connotati da una sessualità ambigua: il loro travestimento è dunque un territorio di confine non solo nella dimensione teatrale ma anche nello spazio della realtà.
La sostanziale ragione che ispira e vivifica l’adozione del travestimento nel teatro di Moscato risiede però nell’intenzione polemica verso il naturalismo teatrale, cioè verso una idea di teatro troppo semplicisticamente assimilato a specchio della vita. E’ su questo punto che trova una effettiva giustificazione la distanza critica sempre mantenuta verso le commedie di Eduardo, verso il quale esprimono riserve sia Moscato sia tutto il gruppo che la critica ha chiamato della “Nuova Drammaturgia”: la diffidenza nasce proprio dai modi eduardiani troppo uniformati alla misura del realismo, nel rappresentare a teatro il mondo, i personaggi, la lingua.
Il fatto è che per Moscato il teatro è artificio e visione. Non che il rapporto con la realtà non esista: anzi, molti aspetti del disagio della modernità sono presenti in modi incisivi e manifesti nelle sue opere, i cui protagonisti sono spesso personaggi emarginati, gli estromessi e i penalizzati dai processi produttivi, gli infelici, resi tali dal rifiuto sociale o dal disadattamento personale, dal sogno di un’umanità diversa. Però il loro disagio non è rappresentato attraverso i modi piani del racconto realistico, ma attraverso la violenza dell’eccesso, attraverso l’esibizione dell’interdetto, del sogno, del delirio. In questo senso il teatro di Moscato è esperienza di conoscenza: un percorso che attraversa la realtà, ne osserva gli aspetti molteplici, ne esprime gli sconfinamenti e le metamorfosi, che mette a giorno e assume come principale materia creativa.
4. Il piano stilistico sul quale è corretto ascrivere la maggior parte del teatro di Moscato è quello tragico: spesso letali sono infatti gli esiti delle vicende rappresentate, e è indubbio che, a caratterizzare la natura tragica, concorre un elemento di irreparabilità che quasi sempre sfocia nella catastrofe. Ma soprattutto, ad accampare sul terreno tragico la materia oggetto del drammaturgo napoletano, vale la caratterizzazione di tutto il suo teatro, e cioè quella lacerazione fra due tensioni opposte che non si ricompongono mai, nella quale appunto viene individuato il nucleo essenziale della tragedia.
Non si tratta tuttavia di un tragico puro, per così dire, perché sempre esso si unisce alla dimensione comica e a quella lirica, secondo una predilezione per le mescolanze stilistiche e linguistiche che caratterizza tutta la modernità. Ma bisogna precisare che il comico di Moscato, anche quando mostra di avere alle spalle la tradizione più consolidata dell’avanspettacolo e della farsa napoletana, non è disteso né facile: prende piuttosto forme ironiche, sarcastiche, aggressive; è coperto e amaro; spesso è adottato come elemento di rassicurazione contro i fantasmi della morte e l’ossessione della sessualità, i due aspetti tematici forse più significativi e più persistenti dell’opera di Moscato.
Ancora più interessante è l’altra dimensione formale con cui il tragico si intreccia e che, soprattutto negli esiti più recenti, caratterizza in particolare la scrittura di Moscato: parlo della lirica, attraverso la quale viene in luce per l’ennesima volta la relazione con Napoli, e perfino con un abusato luogo comune della napoletanità, e cioè la musica e le canzoni che lo stesso Moscato interpreta, recuperandole preferibilmente dalla tradizione canora partenopea, ma anche da repertori di altri cantanti, italiani o stranieri:
in realtà io ho sempre cantato… insieme al latte materno, il dire la vita con una canzonetta, dalle mie parti come in Italia penso sia una cosa normale. Tra l’altro un mio fratello, il più grande di tutti, è stato cantante, per questo il cantare l’ho sempre avuto dentro, nell’accezione più banale, non parlo del canto come poetica, metafora di scrittura più alta. Negli spettacoli, da Scannasurice in poi, c’è sempre stato il canto […] io come Viviani abbiamo sempre concepito la parola poetica uguale, proprio democraticamente uguale, al verso della canzone, della canzonetta.10
Da queste parole di Moscato prende forma una connessione che, mentre da una parte nobilita la canzonetta, stabilisce d’altra parte una vitale apertura sull’altra accezione di “lirismo”, che ha portata più aristocratica, ma fruibilità più contenuta, essendo legato ad aspetti più letterari della cultura italiana. Mi riferisco al legame con la poesia lirica, che possiede in Italia un’ascendenza sì illustre, ma certo poco adatta a produrre linguaggio teatrale. L’esito assolutamente innovativo che Moscato consegue sul piano stilistico è di adeguarsi alle prescrizioni della poesia lirica, adottando un linguaggio e una forma colti e sostenuti, e contemporaneamente di accostare loro, nello stesso contesto, modalità espressive prosastiche, colloquiali e volutamente sciatte: la rigidità dello stile lirico in tal modo si stempera in una spezzatura di registri che è anche acquisizione del dinamismo linguistico necessario alla comunicazione teatrale. Così la lirica che, in quanto sinonimo di poesia, appartiene nel profondo a Enzo Moscato, di cui esprime il pensiero e la percezione del mondo, diventa anche una risolutiva possibilità formale, perché finisce per costituire uno degli ingredienti più raffinati per riproporre la tensione e il contrasto stilistico che fanno parte sostanziale dell’espressività del drammaturgo napoletano.
Lo spazio prevalente acquisito dalla lirica nella sua recente produzione, a partire dalla “svolta lirica” di Partitura, va di pari passo con il ruolo sempre più ampio assunto dal monologo. Nella drammaturgia di Moscato si trovano, per la precisione, due tipi di monologhi: in parte sono i consueti monologhi che, collocati all’interno dei testi a impianto tradizionale11, vi svolgono la normale funzione di interrompere l’azione drammatica rappresentando i pensieri, le impressioni o i commenti intorno a eventi che sono accaduti o stanno per accadere, da parte di un personaggio che, solo in scena, li comunica unicamente al pubblico, e in tal modo media una dimensione intima che di solito non ha voce nell’azione drammatica. Più recentemente però Moscato scrive pièces che sono in larghissima misura monologhi12, mettendosi così nel solco di una evoluzione che sembra appartenere a tutto il teatro contemporaneo: voglio dire la diffusa propensione a formalizzare l’intero testo drammatico nella direzione del monologo.
Ma rispetto alle proprietà generali che il monologo possiede nella comunicazione teatrale, i monologhi di Moscato sono dotati di caratteristiche molto singolari e specifiche: essi infatti non esprimono l’uniformità di un solo parlante ma sembrano nascere in riferimento a molte voci di fondo che, trasparenti in filigrana in quella che monologa, intrecciano una sorta di dialogo mascherato - o travestito, per usare una metafora già indagata. Le voci implicite nel parlato monologante, che, pur prive di autonomia, tuttavia vi si delineano e alle quali spesso è affidato il compito di far affiorare la memoria o le immagini e i suoni del passato, diventano i motori di una tessitura dialogica, o meglio di una partitura nella quale di fatto il monologo consiste.
Ne risulta una modalità espressiva di grande interesse, che produce due conseguenze ricchissime di sviluppi potenziali. In primo luogo, la tensione fra le voci, quella espressa e le numerose implicite, permette il recupero, attraverso le norme formali e organizzative del discorso e attraverso la dialettica del linguaggio, di quel dinamismo e di quella attitudine all’azione che il testo drammatico, per sua natura, dovrebbe esprimere, ma dei quali il monologo risulta in genere privo. Inoltre il fatto che le voci si intreccino in una relazione per la quale lo stesso Moscato propone la definizione di “partitura” impone un immediato riferimento alla musica. In effetti i monologhi di Moscato sono strutturati secondo una misura che recupera e utilizza come sua caratteristica compositiva e come proprietà formale di base il valore propriamente ritmico della lirica. Viene così introdotto di nuovo, ma per una via diversa e attraverso un processo di intensa rivitalizzazione, quel legame con la musica e in particolare con la canzone, che a sua volta contribuisce a annodare insieme Napoli e la scrittura di Enzo Moscato. Una frequentazione, anche solo episodica e superficiale, del suo teatro mostra come la musica sia un ingrediente essenziale per farlo esistere; e soprattutto come i suoi testi drammatici tengano sempre conto dei tempi musicali, che ne costituiscono un fondamentale elemento compositivo, anche là dove mancano le vere e proprie parentesi musicali. Non diversamente dagli spettacoli in palcoscenico, del resto, il cui fascino principale consiste proprio nell’adozione di un ritmo che con tutta evidenza sottende quasi sempre un trasparente rimando musicale.
5. La filologia dei testi di Moscato è un puzzle arduo da risolvere sia perché per larghissima parte essi sono inediti13 sia perché l’autore napoletano scrive in modo “stratificato”, spesso scomponendo i testi, anche quelli già pubblicati, per farne spettacoli in cui sono accorpati testi diversi. In altri casi alcuni pezzi compaiono in testi più antichi e poi vengono recuperati più tardi, oppure crescono su se stessi, soprattutto per obbedire a esigenze di spettacolo. E’ lui stesso ad affermare:
Seguirmi sul piano dei testi è difficile; i vari testi depositati alla SIAE sono spesso confluiti l’uno nell’altro: Compleanno si chiamava Tatuaggio, parte di Compleanno è confluito in un altro spettacolo, ad esempio in Teatri del mare, che a sua volta viene da Partitura, da qui è confluito in altri ancora.14
Sembrerebbe dunque che la linearità della scrittura sia scombinata dall’interferenza della messinscena, quando Moscato deve conciliare due delle sue diverse identità teatrali, quella di drammaturgo e quella di regista. Il fatto è che anche qui giocano fra loro i termini di un conflitto, dal momento che l’autore napoletano ha sempre professato la necessità dell’infedeltà del regista nei confronti del testo scritto da mettere in scena. Allineandosi a una posizione vagamente brechtiana, Moscato sostiene infatti che solo la libera e perfino selvaggia riappropriazione della tradizione consente di salvarne la vitalità e che dunque solo un confronto non filologicamente rispettoso né timoroso né mitizzante o passivo - in una parola, un confronto che mette da parte la fedeltà acritica per porsi in una posizione dissonante e polemica ma intelligente e propositiva, sarà capace di riconoscere, e dunque di salvare il nucleo vitale tanto della tradizione nel suo complesso, quanto di ogni singola opera che il passato ha consegnato alla modernità. Credo che in effetti nel determinare la manipolazione dei testi di Moscato intervenga un tale ennesimo conflitto di cui la personalità dell’autore è portatrice; ma a questa ragione essenziale un’altra se ne aggiunge - ed è una sorta di rapporto fisico ininterrotto che Moscato maniene con la sua produzione. Sembra che egli riesca a trovare solo con difficoltà la forma definitiva, la chiusura dei suoi testi; i quali peraltro, letti di seguito, trasmettono una singolare sensazione di fluidità vitale, che nasce proprio (o così pare) dalla fatica a staccarsi dal corpo del loro autore - analoghi, sebbene siano testi scritti, alla provvisorietà del teatro, al suo continuo scomparire e rinascere, alla sua impossibilità di trovare un punto fermo sul quale consistere definitivamente. In questo senso l’attitudine compositiva di Moscato assomiglia a quella di alcuni musicisti di ricca vena creativa: valga per tutti il caso di Gioacchino Rossini, che non si faceva scrupolo a trasferire brani anche di ampie proporzioni da una composizione all’altra, senza rispettare in nessun modo i limiti di genere, per esempio adattando per la musica sacra pezzi di musica profana o anche amorosa. Si tratta di una tecnica affine anche a quella della commedia “all’improvviso”, che pesca in un repertorio di uso consolidato e di genere, per così dire, neutro i tasselli di una struttura mobile e sempre in trasformazione. Certo può suonare singolare e forse provocatorio accostare alla approssimazione linguistica e formale delle tecniche del teatro “all’improvviso” l’attenzione espressiva così raffinata e la lingua così calibrata, colta e lungamente pensata di Moscato; tuttavia la libertà con la quale il drammaturgo napoletano si muove all’interno della sua produzione, la spregiudicatezza che manifesta nel ricomporre e riaggregare diversamente e secondo montaggi alternativi o anche oppositivi i frammenti della sua materia creativa mi pare proprio che trovino il loro modello nell’artigianalità pratica, e subordinata alle necessità concrete, delle compagnie d’arte. In questo modo l’intellettualismo delle raffinate operazioni linguistiche e culturali di Moscato acquista una materialità che, oltre a provenirgli dal suo modo corporeo di figurarsi i processi del pensiero e della creatività, potrebbe dipendere anche dalla riutilizzazione, sia pure in modi alterati e poco riconoscibili, e dal mantenimento della tecnica che per secoli ha fatto parte del bagaglio degli artigiani del teatro.
E’ bene precisare che la produzione poetica e drammaturgica di Moscato è accompagnata da una serie di interventi critici, che comprendono saggi, riflessioni teoriche su questioni teatrali o più generalmente culturali, problemi più ampi, legati al nostro tempo. Non si tratta di un pensiero astratto: esso si configura piuttosto come un corpo/pensiero, dotato di fisicità o comunque mai avulso dalla materialità del corpo. Il suo funzionamento è analogo a quello della parola poetica di Moscato, capace di rappresentare i percorsi intellettuali e ideali senza staccarsi dalla materialità fisica che la produce.
6. L’ultimo limite al quale voglio accennare è la morte: prima ancora che nel conflitto insanabile che gli aspetti deteriori della modernità hanno aperto nel cosmo arcaico meridionale, il pencolare pericoloso e affascinato sopra il baratro della morte nasce in Moscato dalla attrazione per ciò che esiste ma non appare - il doppio, l’ombra della vita.
Nel definire le ragioni di una tale attrazione si incrociano i due fondamentali punti di riferimenti teorici di Moscato: in primo luogo Artaud, che rettifica l’immagine di specchio o doppio da sempre attribuita al teatro spostandola dal territorio realistico alla dimensione metafisica:
Mentre l’alchimia, grazie ai suoi simboli, è come il Doppio spirituale di un’operazione che risulta efficace soltanto sul piano della materia reale, il teatro deve essere a sua volta considerato il Doppio, non di quella realtà quotidiana e diretta di cui è a poco a poco divenuto soltanto la copia inerte, vana quanto edulcorata, ma di un’altra realtà rischiosa e tipica, dove i principî, come i delfini, una volta mostrata la testa, s’affrettano a reimmergersi nell’oscurità delle acque.15
In secondo luogo Genet, che individua il territorio d’ombra nel regno della morte e esplicitamente collega la morte al teatro:
Si nous opposons la vie à la scène, c’est que nous pressentons que la scène est un lieu voisin de la mort, où toutes les libertés son possibles.16
Anche per Moscato la morte e il teatro sono unite nel concetto di Assenza, che entrambe interpretano.
Il teatro è solo Assenza, anche quando ci propinano spettacoli pieni zeppi di cose, scene, attori, carne, sangue, il vero referente è sempre fantasmatico, è sempre il fantasma, in questo senso Amleto è un testo affascinante, straordinario, perché comincia con la Cosa, le Phantôme, lo spettro del padre di Amleto, ed è una grande metafora di ciò che il teatro è.17
Molto significativo e emozionante risulta il modo in cui l’Assenza viene assunta in Compleanno, il monologo scritto dopo la morte di Annibale Ruccello, come tentativo di esorcizzare o almeno controllare l’angoscia di morte. Strutturato intorno alla coppia Presenza/Assenza (l’assenza definitiva è ovviamente quella della morte), esso compie però un gioco sapiente con i due termini del binomio, che è lo stesso Moscato a descrivere in un saggio, Un sì luttuoso show (o slow?), che funziona da introduzione e commento al dramma:
In Compleanno si rimemora, come per una festa fissa, una stabile ricorrenza di calendario del dolore umano, il ritorno ciclico di un avvenimento che aspettiamo, che conosciamo, che ri-conosciamo, ogni volta nei suoi tratti, nei suoi contenuti, nelle sue spettrali forme: l’Assenza, e insieme all’Assenza, la speranza, il sogno, l’utopia che l’immenso insondabile vuoto che essa trascina, possa essere illusoriamente, magicamente colmato, sia pure per un momento, dalla pratica del ricordo, dal rosario, sempre più inatteso e sempre più lacunoso, delle cose fatte e dette un tempo.18
Il modello della doppia e contemporanea operazione di avvicinamento e allontanamento è la straordinaria illustrazione che, in Al di là del principio del piacere, Sigmund Freud dà del gioco che un bambino di un anno e mezzo faceva instancabilmente con il rocchetto del filo:
questo bravo bambino aveva l’abitudine […] di scaraventare lontano da sé in un angolo della stanza, sotto un letto o altrove, tutti i piccoli oggetti di cui riusciva a impadronirsi […] Nel fare questo emetteva un “o-o-o” forte e prolungato, accompagnato da un’espressione di interesse e soddisfazione; secondo il giudizio della madre, con il quale concordo, questo suono non era un’interiezione, ma significava “fort” [“via”]. Finalmente mi accorsi che questo era un giuoco, e che il bambino usava tutti i suoi giocattoli solo per giocare a “gettarli via”. Un giorno feci un’osservazione che confermò la mia ipotesi. Il bambino aveva un rocchetto di legno intorno a cui era avvolto del filo. Non gli venne mai in mente di tirarselo dietro per terra, per esempio, e di giocarci come se fosse una carrozza; tenendo il filo a cui era attaccato, gettava invece con grande abilità il rocchetto oltre la cortina del suo lettino in modo da farlo sparire, pronunciando al tempo stesso il suo espressivo “o-o-o”; poi tirava nuovamente il rocchetto fuori dal letto, e salutava la sua ricomparsa con un allegro “da” [“qui”]. Questo era dunque il giuoco completo - sparizione e riapparizione - del quale era dato assistere di norma solo al primo atto, ripetuto instancabilmente come giuoco a sé stante, anche se il piacere maggiore era legato indubbiamente al secondo atto.19
Il gioco del bambino terrorizzato dalla perdita amorosa e consapevole di dover controllare la sua angoscia viene assunto in modo mirabile da Moscato, e sublimato attraverso la scrittura e il gioco teatrali, nella persuasione che per conoscere l’Assenza-Morte-Alterità sia necessario “avvicinarcisi, osservarla, talvolta respirarla, per poi prendere a giocarci, to play, jouer, recitare”20.
NOTE
1 Questo mio lavoro è ampiamente debitore a due tesi di laurea, che sono state entrambe discusse presso l’Università di Pisa e delle quali, a diverso titolo, ho seguito il percorso: la tesi di Martina Rossi, Il travestimento in alcuni testi di Enzo Moscato (anno accademico 2000-2001) della quale sono stata prima relatrice; e la tesi di Melanie Gliozzi, Enzo Moscato. Per un teatro “sul limite” (anno accademico 2001-2002), della quale sono stata seconda relatrice, mentre prima relatrice è stata la prof. Anna Barsotti.
2 Per Moscato non c’è differenza fra teatro e poesia. Come egli stesso si esprime in una intervista condotta da Anna Barsotti a Torino, il 7 luglio 2001: “Arriviamo all’86-87, con la mia svolta lirica, scrivendo Partitura ho dichiarato il mio amore per la poesia, prima ancora che per il teatro, ma credo che il teatro e la poesia siano la stessa cosa, e quindi non c’è problema”. L’intervista è riportata in appendice alla tesi citata di Melanie Gliozzi.
3 Antonin Artaud, Il teatro e la peste, in Il teatro e il suo doppio, Torino, Einaudi, 1968, pp. 148-9.
4 Si veda in particolare Enrico Fiore, Il rito, l’esilio, la peste. Percorsi nel nuovo teatro napoletano, Milano, Ubulibri, 2000, pp. 74 sgg.
5 Si vedano ad esempio le descrizioni di Antonio Emanuele Piedimonte, Napoli segreta, Napoli, Edizioni Intra Moenia, 1997, pp. 41 sgg.
6 Ferdinando Taviani, Uomini di scena, uomini di libro, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 197-8.
7 Carl Gustav Jung, Mysterium coniunctionis, in Opere, vol. 14, tomo I, Torino, Bollati Boringhieri, 1989, p. 45
8 Non è irrilevante, nella assunzione così produttiva del pensiero junghiano, un altro elemento autobiografico: dal 1985 Moscato ha, come documenta Maria Nadotti (Enzo Moscato. Di teatro si vive, in “Linea d’ombra”, n. 108, 1995), iniziato un’analisi di tipo junghiano.
9 Jean Genet, Lettres à Roger Blin, in Oeuvres complètes, vol. IV, Paris, Gallimard, 1968, p. 257
10 Sono parole di Moscato nella intervista, già citata, a cura di Anna Barsotti.
11 Sono i testi più lontani nel tempo che, innovativi sul piano espressivo ma anche contenutistico, lasciano invece inalterato l’impianto strutturale, che dunque si articola nella consueta divisione in atti: penso, ad esempio, alle pièces raccolte in Angelico bestiario.
12 Sono, tra gli altri, Little Peach, Fuga per comiche lingue tragiche a caso, La psychose paranoiaque parmi les artistes, Ritornanti, Aquarium Ardent…
13 E non credo che ciò avvenga per indisponibilità delle case editrici verso il drammaturgo italiano attualmente più noto o comunque più stimato dalla critica.
14 Nella intervista citata, a cura di Anna Barsotti
15 Antonin Artaud, Il teatro alchimistico, in Il teatro e il suo doppio, cit., p. 165
16 Jean Genet, Lettres à Roger Blin, in Oeuvres complètes, cit., p. 222.
17 Intervista cit.
18 Enzo Moscato, Un sì luttuoso show (o slow?). “Compleanno” e il passaggio in scena della “todes-trieb” , p. 3: il testo, inedito, si trova presso l’Archivio Moscato.
19 Sigmund Freud, Al di là del principio del piacere, in Opere. L’Io e l’Es e altri scritti. 1917-1923, vol. IX, Torino, Bollati Boringhieri, 1989, pp. 200-201.
20 Enzo Moscato, Un sì luttuoso show, cit., p. 5
Ossimori
Intervista a Enzo Moscato (Livorno, 7 aprile 2003)
di Concetta D'Angeli con Anna Barsotti
Questa intervista, condotta da Concetta D’Angeli insieme a Anna Barsotti, costituisce l’inizio di un laboratorio, La scrittura di scena, tenuto a Livorno, fra il 7 e l’11 aprile 2003, da Enzo Moscato e Concetta D’Angeli. Esso rientra di un più ampio Progetto per un Teatro Studio denominato "La Casa del Teatro", che il Comune di Livorno, il CEL Teatro di Livorno e il Dipartimento di Storia delle Arti dell’Università di Pisa hanno promosso, avvalendosi della cura e della direzione di Fernando Mastropasqua, e della collaborazione dei DAMS di Torino e Bologna.
Concetta D’Angeli Comincerei da una curiosità che ho sempre nei confronti di chi scrive: quando tu incominci a scrivere, che cosa ti prende forma per prima? Voglio dire: la tua scrittura muove da una ispirazione, come dicevano i Romantici? Oppure da un ricordo o un racconto o un’immagine, un sogno o un personaggio?
In particolare poi, dato che i nostri incontri si concluderanno con la tua rappresentazione di Compleanno (il testo e lo spettacolo nascono per "decantare", in qualche modo, la morte di Annibale Ruccello, che avvenne nel 1986, quando Ruccello aveva trent’anni), vorrei che tu ci parlassi delle emozioni da cui è nata questa opera, che secondo me servono molto per capire fino in fondo il senso dello spettacolo.
Enzo Moscato Ogni volta che vengo strappato dal mio carnaio del fare teatro, per essere messo di fronte a una riflessione su quello che faccio sono sempre contento; però rispondere alla prima domanda, cioè che cosa mi succede quando mi metto a scrivere un testo, forse è la cosa più difficile… Qualche giorno fa, terminavo di leggere La montagna incantata di Thomas Mann, un libro che ho aspettato vent’anni per leggere perché ero spaventato dalla mole! Poi alla fine ce l’ho fatta, ho seguito il consiglio dell’autore: "Non vi preoccupate se ci mettete una vita a leggerlo, leggetelo". Alla fine del libro c’è una piccola appendice, che Mann scrisse quando era in America, nel 1939, già esule dalla Germania, e doveva parlare della Montagna incantata agli studenti di Princeton. A proposito delle critiche ricevute (non solo per La montagna incantata) afferma: "Benemerita sia la critica, perché ha uno scopo per me, che è quello di ricordare l’autore a se stesso". Spesso l’autore è infatti la persona meno indicata a parlare del proprio lavoro; e io sono perfettamente d’accordo con Thomas Mann.
Certo che dirvi questo all’inizio di uno stage è un po’ disperante…
Quando scrivo, non so bene che cosa nasca per prima cosa: se l’immaginazione scenica o una scrittura a sé stante. Certe volte è successo che ho iniziato a immaginare cosa volevo mettere in scena e altre volte è successo il contrario, cioè ho immaginato solo la partitura grammaticale, sintattica, stilistica, contenutistica, tematica… Perché la faccenda che riguarda me è estremamente complessa: io non possiedo solo una identità doppia, ma una identità molteplice: autore, regista, attore, cantante, spesso anche capocomico.
All’inizio della mia attività, forse, esisteva la scrittura, cioè la mia propensione a voler scrivere quello che provavo e che immaginavo, quello che mi accadeva dentro. Però la cosa si è complicata, perché questa scrittura mi è stato chiesto subito di metterla in scena, e con me dentro, non solo come attore ma anche come direttore di me stesso. Questa è un’esperienza unica, molto particolare, che sia io sia Ruccello abbiamo vissuto: nell’universo teatrale napoletano esistono dei drammaturghi puri, ma a noi è capitato, per destino e per necessità economica, di essere invece anche gli esecutori di quello che scrivevamo. E ormai non mi posso più permettere, per un anno o per dieci anni, di non fare più questo, di mettermi a fare il teorico del teatro. Magari potessi! Perché io sento fortissima l’esigenza di riflettere su quello che faccio. Perciò è benemerito questo incontro, che mi concede di poter riflettere almeno per un po’.
Certe volte ho proprio il semplice desiderio di scrivere una certa cosa, senza neanche tanto immaginarmela… C’è solo la scrittura, la mano che si muove, che segna la prima parola che affiora. E poi a una parola segue una frase, a una frase un periodo, a un periodo una pagina, a una pagina il profilo di una storia, e poi dopo capisci se è una cosa che devi destinare al teatro oppure se vuole restare nel cassetto. Ci sono tantissime cose che ho scritto e non ho messo in scena, magari perché non erano destinate al teatro. Ma per quelle destinate al teatro devo fare un distinguo. Alcune tra le cose che ho scritto hanno una veste, un abito, che, alla prima occhiata, sembra avere poco a che fare con il teatro. Questo succede soprattutto per quello che ho scritto negli ultimi anni: questi testi hanno una veste davvero poco teatrale: non c’è didascalia, non c’è indicazione di personaggi, ci sono solo delle parole, dei frammenti: qualche volta mi limito ad aggiungere per me, solo per chiarire a me stesso, dei piccoli snodi di significanza. Sono testi che potrei chiamare poetici, ma è una definizione che non dice niente… Comunque non si tratta di prosa, né di narrazione; o forse invece sì, si tratta di prosa e di narrazione, ma in un’altra chiave. A volte è stata un’avventura di scrittura; e questa caratteristica è evidente nella composizione del testo. Faccio qualche esempio: La pyichose paranoiaque parmi les artistes del 1993 nasce come un saggio di semiologia, è proprio un saggio di semiologia che poi è diventato spettacolo. Perché diventasse spettacolo, ho dovuto fare un lavoro di teatralizzazione di quella saggistica. Il testo è dedicato a Lacan, che è uno dei miei Maestri, non in senso fisico, ma nel senso che ho adorato questo filosofo e psicanalista. L’ho studiato quando facevo filosofia e ho voluto scrivere un omaggio alla semiologia e alla psicanalisi di Lacan, trasferendolo però, teatralmente, nell’universo-Napoli con tutto quello che il trasferimento significa: c’è dentro il mio corpo, la mia eredità culturale popolare, quello che so del teatro... A chi legge il testo, che è stato edito [da Flavio Pagano Editore], esso potrebbe sembrare costituito da una serie di aforismi, ma invece in scena succedono tutt’altre cose.
Oppure a volte il mio testo nasce dalle immagini o dai desideri. Perché sapete che noi, noi teatranti, siamo schizofrenici: ognuno di noi è in realtà un’assemblea di persone. Una mattina tu, teatrante, ti svegli e dici "Voglio essere questa cosa"; in questo caso il testo nasce non tanto come una scrittura, ma come un desiderio corporeo. Poi da questo desiderio corporeo, nasce l’esigenza di metterlo su carta. Quindi: è il desiderio che dice questo, è il desiderio che si muove in un certo modo, eccetera…
Nel caso mio non è applicabile lo schema del drammaturgo che si mette là e scrive per sé e per gli attori e poi mette in scena. Un punto da sottolineare è per esempio l’esplicito tradimento che io faccio compiere ai miei attori nei riguardi di me autore e l’esplicito tradimento che io attore faccio nei riguardi di Enzo Moscato drammaturgo; e l’esplicito tradimento che io compio rispetto alla mia eredità culturale teatrale napoletana, rispetto a Eduardo, rispetto a Viviani, a Petito, a Scarpetta, a Patroni Griffi, a De Simone, a chi volete; insomma rispetto a tutti gli autori di teatro che ci hanno preceduto e che ci hanno lasciato una qualche eredità. Per quanto riguarda Annibale e me (parlo di Annibale perché lo conoscevo meglio e perché avevamo la stessa età e la stessa formazione - filosofo lui, filosofo io; e poi perché eravamo entrambi capocomici, avevamo delle piccole compagnie), c’è una spezzatura molto forte fra noi e la tradizione che ci ha preceduto. Questo però a livello molecolare. A livello atomico invece, sotterraneo, a ben guardare ci sono delle continuità, soprattutto con Viviani, ma in fondo anche con Eduardo. È un tradimento, ma con una grande fedeltà di spirito dentro.
Concetta D’Angeli Il discorso del tradimento autorizza a tradirti. Attenzione, visto che i gruppi poi lavoreranno a un’ipotesi di messinscena di un tuo testo…
Enzo Moscato Ti dirò che mi è capitato che mi abbiano chiesto delle traduzioni da alcune opere classiche; io le ho fatte, anzi dal ’91 in poi una porzione del mio lavoro è stata dedicata alla traduzione. Ma siccome io non sono capace di ubbidire alla lettera delle cose, ho ragionato sulla metafora: ho tradotto Burgess, Jarry, Molière, e altri (testi tutti messi in scena, ma da altri registi e altre compagnie), tradendoli, nel senso che mi sono affidato alla metafora, e non alla lettera, dei loro discorsi. In primo luogo, perché non sono uno specialista delle diverse lingue dalle quali traducevo e quindi non potevo praticare la strada della filologia della parola. Inoltre ho visto quei testi con il mio sangue, con la mia capacità di vedere il mondo, e dunque di interpretare il discorso fatto da quegli autori. Perciò preferisco non parlare di traduzioni, ma di trad-invenzioni, cioè di invenzioni che tradiscono quei testi: sono insomma dei tradimenti che partono dall’invenzione di quel testo; ma all’interno di queste invenzioni e di questi tradimenti sussistono delle plaghe di fedeltà letterale.
Il tradimento, dicevo, prima di tutto è nato per necessità, perché io non posso essere un traduttore letterale. Anche se traduco devo essere me stesso; e comunque i committenti mi chiedevano proprio questo, cioè di trasferire un determinato testo nel mio sangue. In genere, poi, trovo che chi non tradisce fa un cattivo servizio all’autore, soprattutto se gli autori da tradurre sono cronologicamente lontani da noi. In effetti stiamo parlando di ‘600, di ‘800: in questi casi le operazioni strettamente filologiche non hanno molto senso… Solo tradendo si restituisce la vita che l’autore ha messo in un testo.
Anche alcuni testi miei sono stati messi in scena da altri; e poi mi hanno chiesto, sempre con un po’ di perfidia, se ero contento di quelle regie. Sì, ero contento; ma non l’ho detto per una piaggeria. Io mi metto nei panni di chi fa quella operazione di messinscena: innanzitutto ritengo che non sia facile mettere in scena un testo mio; poi c’è il problema che io sono vivente, il pubblico mi ha visto recitare… Le messinscene degli altri le considero sempre un gran regalo: perché un altro regista, nel mettere in scena un mio testo, può imboccare una strada completamente opposta alla mia: se io sono dentro una logica onirica, un altro regista può lavorare sul contrario, su una logica narrante, realistica, oggettiva. Va tutto bene, purché ci sia coerenza, dal principio alla fine. Quello che mi può portare a qualche critica è quando uno imbocca una strada e poi non la percorre fino in fondo con radicalità. Agli altri, come a me stesso, io chiedo solo la radicalità della via intrapresa: che insomma il tradimento sia consumato fino in fondo.
Il tradimento non è un’invenzione qualunque: esiste anche a livello biologico, nel passaggio dal padre al figlio, perché il figlio, pur riproponendolo, tradisce il padre nel genoma, così che si ottiene una sorta di discontinuità nella continuità. Ritornando al discorso di me e di Annibale, direi che in questi termini bisogna vedere la nostra avventura drammaturgica: noi operiamo una rottura all’interno di una grande tradizione. Però attenzione: io mi vedo come un autore tradizionale, non mi ritengo fuori dalla tradizione. Tradizione infatti non è convenzione: la vera tradizione è sempre qualcosa che fa male, che spiazza e tradisce ciò che la precede. Penso di non essere affatto un autore troppo innovativo o estremo; penso di essere tradizionale, ma nel senso vero della parola. Così come I Dieci Comandamenti di Viviani furono un fortissimo ribaltamento della tradizione che lo precedeva; e così pure, all’epoca, nel 1945, Napoli Milionaria di Eduardo. Domani può darsi che anche quello che ho scritto io diventi convenzione e allora noi dobbiamo essere pronti al tradimento.
Anna Barsotti Alcuni studenti presenti a questo incontro hanno seguito il mio corso di "Storia delle poetiche e delle teoriche del teatro", conoscono quindi la tua opera, il tuo pensiero ed in particolare lo spettacolo Compleanno, che abbiamo analizzato e commentato in video. Anche perciò mi piacerebbe farti una domanda che riguarda il linguaggio del tuo teatro: comunque si declini, è stato sempre un teatro connotato da un uso linguistico molto speciale, fin dall’inizio, anche se forse Compleanno è il testo in cui comincia a manifestarsi con evidenza la commistione dei codici e delle lingue. Vorrei che tu mi parlassi di questo aspetto della tua produzione drammaturgico-scenica.
E poi un’altra domanda a proposito di Isa Danieli, che ha avuto grande importanza nel tuo teatro e in quello di Ruccello. Vorrei che tu parlassi del rapporto fra te attore, fra te corpo, fra la tua opera ed un altro corpo d’attore. Luparella per esempio, inizialmente, la facevi tu. Poi l’ha fatta Isa Danieli…
Ecco, queste due domande, secondo me, sono collegate dall’uso del linguaggio.
Enzo Moscato In effetti convergono… Be’, comincerei da Compleanno, quindi dal rapporto e dall’esperienza condivisa con Annibale… Alla questione dei linguaggi ci arriverei dopo.
Ritorno a quello che diceva T. Mann: chi fa qualcosa ha poco tempo, o ha poca possibilità di meta-rifletterla. Poi, alla distanza, la guardi meglio e riesci a vedere le connessioni…
Inizialmente, con Annibale… in effetti le nostre esperienze teatrali sono nate quasi insieme. Il 1980 è la data che solitamente si pone come nascita della cosiddetta "nuova drammaturgia" (è un nome, questo, sul quale io non sono mai stato d’accordo): c’erano in giro Le Cinque Rose di Jennifer di Annibale e c’era il mio Scannusurice, il testo che mi ha fatto conoscere alla critica napoletana. Sia io sia Annibale eravamo visti molto male dall’ambiente teatrale, perché passavamo come due conservatori, dal momento che facevamo un uso massiccio della parola, in un’epoca in cui in Italia quasi nessuno usava più la parola a teatro. Poi con il tempo si è vista la radicalità con la quale noi usavamo la parola. Basta leggere uno qualsiasi dei nostri testi per rendersi conto della differenza tra il nostro uso della parola e quello che veniva fatto in precedenza e soprattutto con quello che facevano i contemporanei. In seguito, per me, si è passati dalla parola ai linguaggi. Parlo di linguaggi anche se essi possono essere variegati in relazione alle lingue che adotto, oppure, al contrario, sono monolitici, nel senso che uso solo il napoletano. Lo stesso Compleanno ha dentro di sé linguaggi diversi, sebbene sembri omogeneo; invece contiene delle stratificazioni, delle rotture, delle cristallografie linguistiche.
Non so perché l’ho fatto. Stranamente Bordello di mare con città e Compleanno vengono da una stratificazione di piccoli frammenti che avevo già composto; poi c’è stata la morte di Annibale, che mi ha dato il filo conduttore per mettere insieme questi piccoli tasselli testuali. Bordello l’ho scritto dall’ottobre ’86 al gennaio ’87, che è il periodo dopo la morte di Annibale. Direi che questa circostanza si sente nella struttura del testo: si sente un prima e si sente un dopo. Il primo tempo è caratterizzato in una maniera, nel secondo tempo succede la rivoluzione copernicana… Il prima per me era la speranza, il lavoro in comune, il progetto; e il dopo… be’, in quel momento lì non capivo proprio che cosa sarebbe accaduto. Se se ne va uno di ottant’anni, non dico che non si provi dolore, ma è un po’ come se se ne andasse il passato; se se ne va uno che di anni ne ha trenta è diverso. E infatti così è stato per la morte di Annibale. Questo prima e questo dopo sono l’uno la faccia dell’altro, uno è monolitico e l’altro è variegato; uno è giocato su una sola figura e l’altro su molteplici figure; e poi c’è il gioco del maschile e del femminile, come assenza o come attesa.
Tornando alla questione dei linguaggi, posso dire che ho abbandonato il pensiero della parola a sé stante forse proprio nell’85-’86. Ci sono state varie fasi nella mia vita drammaturgica: forse i primi cinque anni, come mi facevi notare tu, Anna, c’era un rapporto più ravvicinato con la tradizione, a parte Scannasurice che è un testo singolare. Ma da Trianon a Bordello di mare a Ragazze sole io mi colloco, più o meno, lungo un’asse che si mantiene vicino a ciò che mi aveva preceduto. Però già in questa fase introduco dei trabocchetti, dei trompe-l’oeil: una sorta di naturalismo fittizio che invece apre altre strade. Questa fase si può definire il periodo poetico; e poi, verso il ’92-’93 all’incirca, mi sono spostato su temi che potrei chiamare antropologici. Le cose che si vedono ancora in giro, di me, sono i monologhi; mentre non si è visto (o si è visto molto poco) il lavoro che ho fatto con il molteplice, cioè su molti attori.
Agli inizi l’incontro tra me e Annibale ha realizzato una condizione di specularità: appartenevamo alla stessa generazione, avevamo quasi gli stessi gusti teatrali, forse lui con un amore maggiore per la narrazione. Annibale amava molto Eduardo, io un po’ meno (specie come drammaturgo). Ma lui aveva una vera passione per le mitologie napoletane: aveva studiato con De Simone, quindi amava molto l’antropologia della maschera e il folclore (che poi ha fatto entrare nei suoi testi in una maniera originale e depistante), mentre a me questi aspetti non hanno mai interessato tanto. Abbiamo anche scritto delle cose a quattro mani, e spesso abbiamo recitato insieme. Infine siamo stati scoperti insieme, al festival di Montalcino nell’86, un mese prima che Annibale morisse: io facevo Occhi gettati e lui Mamma. Ci hanno scoperti allora, anche se io l’anno precedente avevo vinto il Premio Riccione e lui aveva vinto l’IDI. Prima, coi nostri monologhi estremi, finivamo in paesini sperduti, dove abbiamo rischiato di essere linciati; se andavamo in un teatro a Napoli per rappresentare le nostre opere, non ci davano credito. Oggi mi meraviglio di quanti vogliono vedere i nostri spettacoli.
Quello che mi sembra interessante, per chi si occupa di teatro, è la concretezza dell’atto teatrale, che ci ha messi subito in grado, me e Annibale, di capire come si fa il teatro e quindi anche di avere un effetto di feed-back sulla scrittura. Scrivere per il teatro deve avvenire a posteriori dell’atto scenico. Se non conosci il palcoscenico, non c’è niente da fare, rischi di scrivere un’altra cosa.
Tornando a Compleanno ho sentito personalmente l’esigenza di fare un’operazione di abreazione del dolore, di allontanamento, di distanziamento del dolore.
Concetta D’Angeli Vorrei farti ancora una domanda a proposito della lingua e in relazione a Compleanno. C’è una particolarità formale in questo testo che mi colpisce molto e vorrei che tu ce ne parlassi perché penso che essa faccia "lievitare" il livello emotivo del testo e dello spettacolo; mi riferisco al rapporto tra te e Annibale Ruccello come traspare dalla tessitura linguistica di Compleanno. Bisogna che premetta che l’operazione che spesso Enzo Moscato fa sulla lingua delle sue opere presuppone un riferimento stretto alla tradizione, a ciò che la tradizione consegna della scrittura teatrale. I suoi testi sono costituiti spesso da intarsi di citazioni, rimandi, riferimenti, eccetera; se si vanno a guardare da vicino, ci si caccia in un gioco di riconoscimenti, divertente ma pericoloso, perché uno si possono fare delle figuracce tremende, dal momento che Moscato è molto colto e perciò il gioco dei riconoscimenti, con lui, è molto difficile. Nel caso di Compleanno l’operazione linguistica di rimandi, riferimenti, allusioni riguarda l’opera di Annibale Ruccello. Anche questo mi sembra, in qualche misura, sia un modo per controllare il lutto, sia per ridare voce teatrale a chi ormai non ce l’ha più.
Vorrei che queste allusioni, questi riferimenti tu ce li mostrassi, Enzo, che ci facessi qualche esempio. E anche che tu ci spiegassi come questi riferimenti e allusioni hanno funzionato per te, nella testimonianza di amicizia e di lutto nei confronti di Ruccello, che tu hai voluto esprimere con Compleanno.
Enzo Moscato Con Compleanno io credo di aver fatto come sempre ho fatto: mi sono procurato un’apertura con me stesso, cioè una situazione psichica emozionale passiva - "Voci, aggreditemi". Mi sono messo nella posizione del medium. E per prima cosa sono venuti fuori dei frammenti di esperienze che io e Annibale avevamo vissuto insieme, parole che avevamo sentito, questioni su cui avevamo riflettuto o riso o su cui ci eravamo incazzati o addolorati. E questa è una parte delle voci. Altre voci sono le voci drammaturgiche di Annibale, i suoi deliri, le traiettorie che lui seguiva per costruire i suoi testi, e che io conoscevo molto bene.
Compleanno è un testo aperto, polisemico; nel presentarlo, anche all’estero, ho dichiarato a volte che lo spettacolo è dedicato al mio gemello drammaturgico, Annibale Ruccello appunto. Ma ho notato spesso che avrei anche potuto non fornire questa avvertenza, perché si capisce immediatamente che si parla di una cara presenza, di un caro fantasma che non c’è più e che vuole ritornare. Tant’è vero che di solito chi ha visto lo spettacolo mi fa domande su tutto, non solo sulle parole (che significano, perché sono dette in quel modo), ma anche sul senso delle musiche che ho scelto. In particolare, c’è una musica che uso da sempre in Compleanno: è Tu quieres volver, una bellissima canzone spagnola dei Gipsy Kings – dice: "Tu vorresti ritornare".
Uno spettacolo (qualunque spettacolo) si fa indipendentemente da te e come un fiume raccoglie tutti i detriti che trova sul suo fluire. Sono 17 anni che rappresento Compleanno: chi lo ha visto più di una volta ha sempre l’impressione che sia uno spettacolo diverso. A parte le varianti che nel tempo ho introdotto, è proprio la struttura aperta dell’opera che permette di fare questo. Certamente la prima volta ho fatto piangere tutti: la sera della "prima" chi conosceva Annibale si è liberato, assistendo allo spettacolo, del dolore della sua morte. Però poi come si fa a continuare a dare quella stessa emozione per 17 anni? Il fatto è che non si riesce a dare per così tanto tempo un’emozione del genere se non ti mantieni aperto. E questo significa rischiare di perdere ad ogni momento quello che hai accumulato.
Vi sto dando un’indicazione di metodo che mi sento di dare a qualsiasi attore o drammaturgo.
Questo spettacolo si rinnova ogni volta, ma sempre rimanendo uguale a se stesso: io non muto una parola! Addirittura gli snodi vocali sono uguali! Però lo spettacolo è sempre diverso. E’ che dal pubblico che ti guarda, dai luoghi dove fai lo spettacolo, ogni volta ti arrivano delle sollecitazioni che fanno emergere alla luce alcuni pezzetti che sono pronti a emergere e che poi confluiscono nello spettacolo. In alcuni punti mi sposto indietro di 30/40 anni: in quei casi non si tratta di ricordi o emozioni miei o di Annibale, ma per esempio dei racconti di vecchie signore, che ho sentito quando avevo 3-4 anni e che mi hanno parlato, mettiamo, dei bordelli. Io non ho mai conosciuto un bordello, ma evidentemente questi racconti mi si sono fermati nella testa e di lì, per esempio, si è generata Pièce Noire. Ogni testo è solo una parte della vitalità che acquisirà in seguito; e da questo punto di vista è molto importante il momento in cui lo si mette in scena, sia la prima volta sia nelle repliche. In genere io sono un autore fedele a se stesso; ma come attore sono invece un gran traditore dell’autore. Ripetendo tante e tante volte una determinata performance, io, come attore, provo delle idiosincrasie verso alcune zone del testo e degli amori, invece, verso altre zone: dipende anche dai momenti o dalla tua situazione psicologica di quel momento. Certe volte a me degli spettacoli piacciono soltanto le sbrodolature, le schiume. In Compleanno, c’è il secondo monologo di Pagnottella, che è molto comico, la gente ride, e a me certo questo fa piacere; ma magari a me piacciono altre zone del testo, dove intervengo, cambio, senza avvertire. A me piace molto il momento dello spogliarello, che è fasullo e stilizzato naturalmente, dedicato al fantasma; di questo momento approfitto per tirarci dentro alcune frasi di un altro mio testo che si chiama Little Peach.
Concetta D’Angeli Enzo Moscato fa spesso queste operazioni di smontaggio, trasferimento di pezzi di testi precedenti a testi successivi. Effettivamente la tua, Enzo, sembra un’opera continua, un’opera che non si chiude mai. Questa mi pare una caratteristica importante della tua opera, una sorta di predilezione per il "non finito": potrebbe trattarsi di una difficoltà a staccarsi dai testi che scrivi, come una volontà di mantenere una continuità fisica con loro? Mi sembra in effetti la riproposizione di una precarietà che appartiene propriamente al teatro.
Enzo Moscato Devo di nuovo premettere che tutti i miei convincimenti teorici, tutte le considerazioni su quello che ho realizzato derivano dal fatto che gli altri me lo hanno fatto notare; oppure io ho avuto il tempo e la distanza per ragionarci su quello che faccio. Appena finisco una scrittura e realizzo la sua eventuale messinscena (dico "eventuale", ma di solito alla mia scrittura segue sempre la messinscena), io mi distacco dalla mia opera, me ne allontano, essa appartiene agli altri e io non la penso più come mia. Poi col tempo, magari mentre scrivo qualcosa d’altro, riemerge, attraverso percorsi sotterranei che mi sfuggono, una parola, un suono, una significanza; e mi dico "guarda questo che cosa vuol dire…". E comincia così una qualche consapevolezza, che io acquisto guardando da lontano. Del resto, anche se guardate un quadro dovete guardarlo da lontano per vedere tutte le connessioni.
Devo dire che io non sono molto affezionato a quello che ho scritto, soprattutto le cose teatrali. Perciò la riutilizzazione di frammenti di testi che passano da un’opera all’altra, sembrerà paradossale, ma in sostanza nasce da disamore e dalla mia distrazione nei riguardi di quello che faccio a teatro. Io nego a queste cose un’identità precisa; anche perché tutto il mio teatro è giocato non sull’identità ma sulla disidentità, a partire dal mio essere napoletano. Cioè, io nego la mia napoletanità affinché affiori una vera identità di napoletano. Quei frammenti insomma rientrano nei nuovi testi che scrivo in primo luogo per una distrazione. Come una madre o un padre, che non hanno mai guardato troppo i figli e poi si dicono "Però, avrei potuto guardarli di più". Così a volte mi capita di pensare, di una mia frase, per esempio, "Ma guarda questa frase come è bella…". Mi capita perfino che, se sento un attore dire una frase mia, non la riconosco e gli chiedo "Chi l’ha scritta questa roba?", e loro si stupiscono: "Ma come! Questa è una frase tua!".
C’è insomma una mia volontà di dimenticare quello che scrivo, e poi uno sguardo da lontano, che recupera quello che ho scritto, o una parte. Lo sguardo da lontano è molto importante. Io dico che una situazione d’amore può nascere solo da uno sguardo da lontano. Lo sguardo da vicino è quasi sempre miope, è distorcente. Non è che, quando guardo da lontano e recupero quello che ho scritto, lo recupero per intero: prendo solo quello che mi serve in quel momento; del resto, nulla si crea, nulla muore e tutto ritorna. Come Beckett, penso che non facciamo altro che girare intorno allo stesso punto e dire sempre le stesse cose; se siamo fortunati, lo facciamo da angolature differenti. Ma in sostanza siamo prigionieri di un linguaggio, siamo prigionieri di un passato… La cosa più giusta forse è cercare di essere consapevoli di questa prigionia e farla diventare un fatto deliberato.
Scannasurice, che vuol dire "ammazzatopi", nasce perché, quando ci fu il terremoto a Napoli, si diceva che i topi (una certa leggenda - o forse una verità - vuole che a Napoli ci siano 6 topi per ogni abitante), sotto l’urto del terremoto, si erano messi a migrare: mettiamo, i topi del porto erano saliti al Vomero, i topi del Vomero se ne erano scesi da qualche altra parte... Con Annibale ci facevamo un sacco di risate su questo… In Scannasurice volevo che i topi tornassero ad essere il punto cardine. Io credo nella migrazione, cioè nel fatto che le cose si devono muovere anche all’interno dello stesso sistema. Se le cose si muovono, questo ti permette di vederle anche da angolature differenti. Per esempio, se tiro fuori una frase da Scannasurice e la metto in Occhi gettati’, come è davvero successo, non è per pigrizia, ma è anche, se volete, un esercizio della memoria, un ricordarsi a se stessi; ma non con narcisismo (cioè non perché quello che ho fatto è prezioso e va salvato a tutti i costi) perché non c’è nessuna logica di economia borghese, del tipo "salviamo le cose, non le gettiamo via, sennò sono guai o porta male…". Il fatto è che bisogna essere legati al passato; e la mia scrittura è legata al passato, il rapporto col passato per me è molto forte. Direi anzi che sono più legato al passato che al presente o al futuro. Naturalmente è un passato visto con una lente presente, che non può non essere distorcente. E’ questo che mi ha portato a fare dei lavori specifici sulla storia: Luparella per esempio, Sull’ordine e il disordine dell’ex-macello pubblico.
Certo che per i filologi queste "migrazioni" interne alla mia scrittura sono un vero rompicapo; ma che importanza ha! Mi piace molto una frase di Eduardo, forse apocrifa, che ho usato nel finale di Recidiva, un testo dedicato a Copi, che è uno scrittore di teatro poco conosciuto e direi anche rimosso. A Eduardo piaceva mettere tutto in ordine, era un cartesiano; ma prima di morire pare che abbia detto: "voglio lassa’ tutte ‘e ccose ‘mbrugliate, ropp’a mme non s’ha da capi’ niente". È bello, un autore deve fare così; i grattacapi sono di chi resta, chi resta ha il compito di mettere a posto… Che tutto sia sempre perfettamente a posto non fa bene neanche alla vita di un’opera. Anche Anna Maria Ortese, uno dei miei miti, faceva così e la filologia delle sue opere è un grande rompicapo: non si capisce da dove nascono, dove stanno… Anche la vita, d’altra parte,è così, è caos…
E poi il teatro è perdita, non è acquisto. Anche se è vero che le cose vanno tenute anche in un certo ordine: un ordine/disordine, ecco!
Anna Barsotti Da parte di Eduardo c’era anche una certa malignità nel sovvertire il luogo comune. Non per niente ha seminato date contraddittorie dappertutto. Secondo me, proprio perché era tanto razionale, aveva il gusto di mettere in crisi l’ordine apparente, di mostrarne la "confusione" nascosta! "Mo se sono imbrogliate le lingue", dice un personaggio di Le voci di dentro.
Per questa via vorrei ritornare al problema delle lingue, che mi interessa particolarmente, ed anche al problema del passaggio dei corpi. Quel tuo linguaggio teatrale contaminato di lingue differenti, il napoletano sì, però anche tutte le lingue della modernità, canzoni, fumetti, televisione, inglese, spagnolo, tedesco, per ritornare magari al latino (in Arena Olimpia citi Virgilio), come è nato? È nato tutto insieme? Sei partito dalla reinvenzione del dialetto … ma come base dove hai innestato la combinazione babelica delle "voci" oppure sei partito proprio da una visione caleidoscopica del linguaggio?
Lo stesso discorso vale forse per i corpi, non so…
Enzo Moscato La mia risposta sarà un po’ improvvisata perché su questo argomento rifletto adesso per la prima volta. Allora: è evidente che il sostrato di base che io uso nelle mie opere teatrali è il napoletano, anche se un certo tipo di napoletano. E qui è necessario che io aggiunga qualche cosa. Intanto il napoletano è per me la lingua materna: da bambino ho avuto la fortuna di apprendere il dialetto come prima lingua e poi la gran fortuna successiva di continuare a parlarlo, in casa, con tutti. E poi, a 6 anni, come i bambini del popolo dell’epoca, quando in tutta Italia si parlavano ancora tanti dialetti, ho imparato l’altra lingua, più castigata, l’italiano insomma.
Dico forse una banalità, ma è come se si fosse creata in me una personalità doppia, una persona ambivalente, che parlava un "vernacolo nazionale". Forse sarebbe stato diverso se, invece che nei quartieri Spagnoli, fossi nato in un quartiere di Napoli più borghese, al Vomero o a Posillipo. La cultura che ho appreso da bambino però non è soltanto cultura linguistica o quella pseudo-cultura mediata dal patrimonio canzonettaro; c’è anche una componente che chiamerei "cultura vista". Ricordo per esempio gli anni passati nei Quartieri Spagnoli, dove abitavo… e certo vedevo tante cose, e non avevo bisogno che me le spiegassero: le capivo, le sentivo. Questo mi ha dato una certa apertura rispetto agli altri. Poi mio padre decise di trasferirci a Fuorigrotta, che era un quartiere operaio perbenino. Lì non si poteva fare vita di strada… Poi ho fatto gli studi superiori, mi sono laureato... E poi, un bel giorno, è venuta fuori la possibilità di fare l’attore…
C’è anche da dire che la dimensione dello spettacolo è sempre stata un po’ presente in casa mia, mi sembra di averla sempre vissuta, perché un po’ di spettacolo lo facevamo, noi fratelli; anche i miei fratelli più grandi di me avevano avuto esperienze teatrali, il maggiore ha fatto avanspettacolo con Isa Danieli... Anche per questo quando è venuta fuori l’opportunità di fare teatro non è che ci sono stato a pensare troppo: l’ho fatto e basta. Poi ho avvertito lo scarto tra la teatralità naturale della mia famiglia (a Napoli tutti si sentono un po’ attori) e il vero lavoro in teatro. Il teatro vero e proprio è arrivato tardi: prima ho fatto l’insegnante, e la prima volta che ho visto il teatro avevo 25 anni, la mia formazione, in quanto uomo di spettacolo, è semmai cinematografica. Questa informazione forse può interessare: voglio dire, il fatto che la mia prima formazione è stata cinematografica, non teatrale. Infatti direi che la mia opera è molto poco teatrale; è più cinematografica, oppure teatrale ma non nel senso prosastico della parola.
Torniamo alla mia lingua. Non c’è mai stato un momento in cui ho pensato "ora scrivo in napoletano". Sta di fatto che il primo titolo che mi è venuto in mente, per una pièce, è Carcioffolà, che è il titolo di una vecchia canzone napoletana. E’ significativo: significa che rimane comunque una sonorità di base, natale direi, che è il napoletano. L’ultima cosa che ho fatto, per esempio, Kindertraumseminar, il "Seminario sui sogni dei bambini", è derivata dalle mie letture psicanalitiche, da Jung soprattutto; questo lavoro risulta (e questo lo dico riferendo l’opinione di molte persone) è più comprensibile di altri lavori miei. Qui c’è molto napoletano, ma c’è anche molto italiano, e anche molto tedesco. Mi hanno chiesto perché. Dal punto di vista testuale, questo mio ultimo è un grosso lavoro, ci ho messo tre anni per raccogliere il materiale, tradurlo, re-inventarlo, scriverlo: ho usato la letteratura sacrificale, ho dato ascolto a tutte le voci (da Primo Levi a Etty Hillesum a Kantor…) che hanno parlato dell’olocausto. Avevo a disposizione testi in italiano, e quindi è stato inevitabile che la mia scrittura, molto sostanziata di citazioni, fosse in italiano. La maggiore comprensibilità di quest’ultimo testo (almeno al primo approccio) dipende dal fatto che, mentre al nucleoo significante di un testo come Compleanno, per esempio, tu devi arrivare per percezioni e intuizioni, stavolta ci arrivi immediatamente, se non altro perché si sa a che cosa è dedicato lo spettacolo.
Io sto sempre molto attento a integrare le varie lingue che uso: scrivendo, faccio un lavoro di caratura, nel senso che sto attento a carare il peso delle varie incidenze linguistiche. Ci sono dei lavori che ho fatto interamente in italiano, nei quali non ho mai ceduto al ricatto del farmi comprendere, e in cui sentivo che la comprensione (che è uno dei livelli dell’atto teatrale, poi ci sono altri livelli: l’intuizione, l’emozione…) la affidavo al corpo: in Compleanno, quello che non si capisce da un punto di vista semantico-linguistico, si capisce da un punto di vista prossemico. Sono sicuro che, se facessi Compleanno in Cina, in qualche modo risulterebbe comprensibile.
La presenza dei corpi, e poi i gesti, i movimenti, sono essenziali; e qui si apre un altro problema importante, che è il modo in cui mi relaziono agli attori che sono capitati nel mio teatro, a parte gli attori che lavorano con me. Potrei parlare di Isa Danieli… Lei è una donna straordinaria, anche dal punto di vista delle capacità umane… Nella mia vita si potrebbe dire che Isa c’è stata da sempre, e anche nella vita di Annibale: ricordo che io facevo (e c’era anche Annibale fra gli attori) Caffè di notte e giorno e Toledo di notte, due atti unici di Viviani: io facevo Saponariello, un personaggio bellissimo, che deve anche cantare. Era un personaggio di solito interpretato dallo stesso Viviani, e sua figlia, quando vide lo spettacolo, rimase molto commossa dalla mia interpretazione. Ricordo che c’erano pochissimi spettatori e fra loro c’era Isa Danieli, che noi tutti conoscevamo, perché aveva fatto Amore e Magia nella Cucina di Mamma della Wertmüller, aveva fatto la Gatta Cenerentola… E’ stata lì attentissima, disponibile... E’ raro che un’attrice così nota vada a vedere degli sconosciuti. Ecco, questa è lei: ancora oggi porta in teatro un testo di una scrittrice pressoché ignota, Letizia Russo, perché ha un grande senso del teatro e grande attenzione e rispetto per le persone che fanno teatro. Dopo averci conosciuti in quella occasione, Isa cominciò a frequentare soprattutto Annibale; si entusiasmò al suo Ferdinando. Annibale mi diceva spesso: "ma vai a trovare Isa, è curiosa di te, ti vuole conoscere"; ma io avevo un po’ paura di questa maga. "Vai, vai", mi spronava Annibale, "portale Luparella". Alla fine ci andai: lei aveva perso da pochissimo tempo il fratello, era vestita di nero, una bellissima donna. Lesse Luparella e si mise a piangere. Disse: "Questo testo, qualsiasi cosa tu mi dica, prima o poi io l’aggi’a fa’". Lo ha fatto nel ’97, una quindicina di anni dopo.
Con Isa, come con un’altra grande attrice della tradizione teatrale napoletana, Angela Pagano, bisogna stare attenti, perché avere a che fare con loro significa in pratica confrontarsi con tutto il patrimonio culturale. Io credo che sia presuntuoso mettersi a dire a Isa o a Angela: tu devi fare così o cosà. Isa possiede una grande visionarietà e io, nel relazionarmi con lei, assumo quasi un atteggiamento buddistico, mi dico: "vediamo che succede", aspetto... Solo che "vediamo che succede" non è l’unico atteggiamento che si può assumere quando si deve realizzare un lavoro teatrale; però mi pare corretto assumere un atteggiamento di estrema delicatezza, bisogna avere una disposizione di grande apertura, bisogna essere disposti alla perdita insomma. Sono stato a guardare come il grande amore di Isa per Luparella passasse per tutte le fasi alchemiche: entusiasmo, denigrazione, disperazione. Può succedere che inizialmente ci sia un fraintendimento; ma a me non è successo quando ho lavorato con Isa in Luparella. Annibale invece ha avuto dei problemi, a un certo punto era disperato: sebbene fosse molto innamorato dell’attrice Isa Danieli, non sapeva proprio come comportarsi. Io assumo un atteggiamento di distanza, come vi ho detto, di attesa; invece Annibale si dava, e più si dava più naturalmente diventava imperiosa, da parte di Isa, la richiesta successiva di darsi. Immaginate come si deve trovare un ragazzo di 26 27 anni... A me la richiesta di Isa di farle la regia è venuta quando ero in età più matura; e poi io sono diverso da Annibale. Isa mi accusava di trascurarla: "Ma tu te ne fotti proprio, ma tu non mi guardi proprio"… E’ che io penso che bisogna mettersi da lontano e far accadere quel che deve accadere. E infatti alla fine qualcosa è accaduto; però attraverso una serie di passaggi che forse un altro regista al posto mio non avrebbe giudicato positivi. L’effetto finale che si è verificato tra me e Isa è stato una vera simbiosi: in Trianon lei era me, non nel senso "copiativo" della parola, ma nel senso che (non saprei dirvi come ha fatto) Isa è riuscita a trasmettere al pubblico, insieme alla sua, anche la presenza fisica del regista.
Dunque per me è molto importante la distanza. E questo rientra bene nel nostro discorso sulla messinscena. L’unico punto imprescindibile per me è la coerenza (che poi è incoerenza, se volete). Per coerenza io non intendo l’atteggiamento caparbio di uno che, pur accorgendosi di aver sbagliato, va comunque fino in fondo alla sua strada. Questa non è coerenza per me. Coerenza è sì tenere fede a dei principi, ma con una certa mutabilità interna, con una certa elasticità. Se prendo la strada A, devo tener presente che esiste B. Lo sbaglio, la nevrosi stanno nella unilateralità.
Distanza, d’altra parte, non vuol dire freddezza o disinteresse. La distanza è uno sguardo da lontano, con le giuste angolature. Il teatro è un mass-media freddo, nel senso che è giocato su due sensi: la vista e l’udito, che, come tutti sanno, funzionano sulla distanza. Io ho visto moltissimi esempi di persone che si sono chiuse e infine bruciate in quello che fanno, perché non adottano un momento di allontanamento, che è fondamentale. Se ti allontani, se guardi altro, questo altro ti arricchisce, e questa ricchezza poi ti ritorna in qualche forma. Io non vado quasi mai a teatro; anche quando facevo l’insegnante e mi chiamavano di pomeriggio per le riunioni o con le famiglie, lo dovevo fare ma lo trovavo una delle esperienze più brutte del mio lavoro. Perché due volte nello stesso posto non ci volevo tornare. Mi dico: se faccio una cosa che già mi uccide la salute, perché devo avere l’obbligo di ripeterla anche quando non sono obbligato? Secondo me bisogna affacciarsi su qualcosa di altro; e infatti io credo che sia molto più interessante, per uno che fa il mio lavoro, andare al cinema o in un pub, insomma essere nella vita, cercare di evitare la tautologia del proprio lavoro. E anche questo può essere un consiglio per un’ipotetica messinscena.
[domanda dal pubblico] Questi discorsi valgono anche per un ragazzo o una ragazza che vuole entrare nel mondo del teatro?
Enzo Moscato Qui è necessaria una chiarificazione a monte. Quando io faccio gli stages con aspiranti attori, chiedo sempre se vogliono fare teatro o se vogliono fare spettacolo. Sono due cose completamente diverse su cui spesso le persone si ingannano. D’altra parte, non è facile rispondere a questa domanda. Io stesso inizialmente non sapevo cosa volevo fare, sapevo solo che sentivo l’esigenza di esprimermi. Non è detto che frequentando continuamente il teatro si abbia una maggiore possibilità di fare bene questo lavoro. A volte è possibile il contrario, perché potrebbe incontrarsi solo con gli aspetti più negativi del teatro.
Comunque il problema sollevato è grosso; io penso che il problema di come rispondere al desiderio di fare teatro è in parte lo stesso problema della formazione del pubblico. Chi lavora in teatro si lamenta molto perché il teatro interessa a pochi; però nessuno si pone il problema della formazione del pubblico.
Per tornare alla tua domanda: se un giovane ha desiderio di teatro (e non solo di spettacolo), ho sempre pensato che debba studiare profondamente. Se tu non conosci a fondo ciò di cui ti vuoi occupare, non puoi neanche sapere quale potrebbe essere il tuo apporto personale, lo spazio e il ruolo che ti puoi assumere nel lavoro che farai. Penso infatti che non esiste il teatro, ma i teatri: il che significa che non c’è nessun limite alla soggettività. Voglio dire che il teatro è dei soggetti, mentre, per esempio, il cinema è dei registi. Chi ha fatto sia cinema sia teatro sa che come si è soggetti in teatro non si può essere soggetti in un film. Nel teatro l’attore è autore: non nel senso che si scrive da sé il testo, ma nel senso che metabolizza il testo. A un ragazzo che ha il desiderio del teatro bisognerebbe dare subito da leggere gli scritti teatrali di Artaud, per capire se è portato al teatro.
Secondo me il teatro lo dovrebbero fare tutti, non dovrebbe essere relegato solo al professionista. Il teatro è desiderio di auto-espressione, e dunque chiunque dovrebbe avere il diritto, prima o poi, di salire sul palcoscenico: perché si tratta di un’esperienza unica, anche solo per conoscere lo sconvolgimento organico che succede. Se nelle scuole ci fosse il teatro praticato, noi avremmo qualche livello in più di consapevolezza.
Peraltro devo aggiungere che la vita quotidiana del fare teatro, in una società che di teatro sempre più non ne vuole sapere, è molto tosta. Quindi, soprattutto per onestà, bisogna informare un giovane anche di questi aspetti pratici. Prendersi in una scuola di recitazione un ragazzo, per cinque anni per esempio, impartirgli una serie di insegnamenti tecnici, assicurargli che poi, alla fine dei cinque anni, diventerà un attore… be’, questo è criminale.
[domanda dal pubblico] Nelle sue risposte è venuto fuori due volte un riferimento non troppo implicito ad una maschera che per me rappresenta una delle chiavi interpretative del suo lavoro: Pulcinella. Ha detto in precedenza che tra lei ed Annibale Ruccello c’erano delle forti differenze: ad esempio Annibale era molto più legato alla tradizione teatrale napoletana, amava molto l’antropologia della maschera e il folclore, mentre a lei questi aspetti non sono mai interessati tanto. Poi ha detto che ha sempre odiato le "pulcinellerie" e con questo termine penso intenda la trasposizione negativa della maschera di Pulcinella in semplice burattino privo dei connotati originari. A me sembra di notare però in Compleanno, che purtroppo è l’unica sua opera che ho visto, una massiccia presenza della maschera di Pulcinella, che sappiamo essere un medium tra la vita e la morte, tra il mondo terreno e quello ultraterreno, tra il maschile ed il femminile, …tutti questi aspetti, potremmo dire antropologici, ricorrono nel suo spettacolo…
Enzo Moscato C’è un aspetto deleterio nelle "pulcinellerie"; ma io ci tengo a ricordare di avere fatto Orfani veleni, che è uno spettacolo interamente dedicato a Pulcinella. Agli inizi della mia carriera Pulcinella non mi interessava, perché agli inizi urgono altre cose. Solo nel ’90 ebbi una sollecitazione esterna a scrivere qualcosa su Pulcinella, e è nato così Fuga per comiche lingue tragiche a caso, un monologo dedicato a Pulcinella. Dopo tredici anni e dopo aver accumulato altri materiali, è venuto fuori Orfani veleni. Secondo me Pulcinella, il vero Pulcinella, non ha niente a che fare con il personaggio insignificante a cui è stato ridotto, perché davvero Pulcinella è stato trasformato da divinità a burattino. Ma Pulcinella non è Arlecchino, non è solo una maschera comica popolare! E anche in tempi moderni, ha ispirato tutti i più grandi artisti. Pulcinella è la terribilità dell’inconscio: se si mette la maschera, è per proteggersi.
Quando ero ragazzino, sui Quartieri c’erano ancora le cosiddette guarattelle, cioè i teatrini fatti coi pupi, le marionette insomma. Adesso se ne vedono pochi, bisogna andare nei musei per vederli. Pulcinella nelle guarattelle piglia sempre un sacco di botte, muore e risorge centinaia di volte. Da bambino ne avevo paura, ho odiato Pulcinella; non mi faceva ridere, mi era antipatico. Evidentemente già da allora io vedevo dell’altro, dietro la marionetta: quella maschera era inquietante, per me, e me ne rendevo conto. Più tardi, in età adulta, leggendo, ho scoperto che Pulcinella rappresenta la morte, e per di più una morte metamorfica, cioè una morte terribilmente collegata alla vita. E’ un’immagine di morte di cui la nostra società avrebbe molto bisogno, perché noi vediamo troppa morte nel senso brutale della parola.
In Compleanno si fa un esercizio catartico di contenimento del dolore per arrivare alla vita. Direi che è questo pensiero ciò che Pulcinella ha sempre veicolato e che sempre ha fatto paura: e cioè che possano saltare i confini tra vita e morte, tra sanità e follia…
Questo io voglio mettere in evidenza nella maschera di Pulcinella; e lo faccio in aperta polemica con quello che di Pulcinella normalmente si fa: nient’altro che burattiname. In questo senso polemico parlo di pulcinellerie. E invece Pulcinella è la lava, è la possibilità che tutto sia sterminato da un momento all’altro; è la possibilità della sovversione, quando il servo potrebbe mettersi al posto del padrone; e poi è una figura che si apre al Mediterraneo, è in qualche modo il tragico visto di spalle. Assomiglia in questo a Totò, che è stato un grande inventore di lingue. Totò non ha mai fatto Pulcinella, pensate che grande umiltà! Totò mi fa ridere per la sua straordinaria capacità di invenzioni linguistiche. Sere fa ho rivisto un suo film, insieme a Peppino De Filippo. Anche Peppino era un grande sconvolgitore di lingue e secondo me, come attore, era molto più grande di Eduardo.
Concetta D’Angeli Su questa linea ti volevo chiedere qualcosa a proposito del comico che c’è nei tuoi testi ma anche nelle tue messe in scena. Però è un comico che non si oppone all’altra dimensione, che è quella tragica. Mi pare che il tuo comico spesso nasca da una manipolazione linguistica, come se tu trattassi la lingua allo stesso modo di come stavi rappresentando adesso la lingua di Totò, come fanno a volte anche i bambini, quando giocano con le assonanze, le analogie (è stato Gianni Rodari a mettere in luce l’importanza di questi modi di giocare col linguaggio sia per acquisire competenza linguistica sia per divertirsi).
Ecco, vorrei che tu parlassi del tuo comico, che non è mai staccato dall’altra sua faccia, quella seria e addirittura quella tragica, secondo la grande lezione shakespeariana. Mi piacerebbe infatti che nel lavoro di gruppo dei prossimi giorni questo aspetto non venisse ignorato, anche là dove è prevalente la morte, la tragedia…
Enzo Moscato Innanzitutto c’è un pregiudizio che io voglio sfatare a proposito del mio teatro. Siccome sono considerato un autore di ricerca, si pensa che sono pesante, noioso, troppo serio; mentre chi ha visto i miei spettacoli sa che io, col corpo e la voce, cerco di far volare, di alleggerire le parole, che in effetti possono essere pesanti. Una parola leggera può essere pesantissima, se detta in una certa maniera, così come tante battute comiche "non arrivano" al pubblico perché non c’è levità; io cerco di raggiungere la levità, sul palcoscenico, attraverso il corpo. Uso il palcoscenico come un altare. Vedere e fare teatro è un atto di estrema discrezione: mi fa orrore quando un attore fa rumore, sul palco, mi pare che non sia un attore. Ma soprattutto cerco di praticare l’ossimoro; non credo né di essere una persona tragica né una persona comica, penso di essere una persona grottesca. Ci sono dei lavori che ho fatto, come Cartesiana, che sono esplicitamente comici, anche se il testo nasce da un problema gravissimo, quello dell’identità. Ma penso che sia un testo molto divertente, anche lo spettacolo è divertente, soprattutto se lo si vede più di una volta, perché allora si capiscono meglio gli snodi drammaturgici e linguistici. Ma mentre lo faccio io sono fra le persone più infelici di questo mondo, perché recitarlo con i ritmi che tengo è davvero molto difficile. È uno spettacolo comico per gli altri e tragico per me. In questo senso parlavo di ossimoro.
Un attore che, per eccellenza, usa l’ossimoro è Eduardo; pensate alla disciplina, che definirei orientale, alla quale, da occidentale, sottopone il suo corpo. A monte c’è una concezione artaudiana. Eduardo diceva sempre che l’attore deve recitare col gelo.
La lingua, il corpo, la politica
Un ritratto di Cada Die Teatro
di Anna Maria Monteverdi
Cagliari, 24 giugno 2003, ore 11.
Appuntamento alla sede amministrativa del Cada Die Teatro nella zona Casteddu di Cagliari, in via dei Genovesi 94, nella città vecchia, vicino al Bastione. Ci aspetta Giancarlo Biffi bresciano che ha dato vita con altri compagni sardi al gruppo dopo aver frequentato l'Ista di Volterra diretta da Eugenio Barba. Ci porta nella sala prove, la "stanza più fresca di tutta Cagliari".
Cada Die è una compagnia di teatro di ricerca riconosciuta dal Ministero per i Beni e le attività culturali. Vicina ai temi del teatro popolare e della narrazione, attinge al patrimonio della cultura e della lingua sarda con attenzione a una sua riproposizione in chiave attuale. Il gruppo si forma a Cagliari nel 1982; nel 2001 l'Associazione nazionale dei critici di teatro gli ha assegnato il Premio speciale della Critica e numerose sono state negli anni le premiazioni, i riconoscimenti e le segnalazioni al Premio Ubu; La Soffitta di Bologna ha dedicato una personale al Cada Die, nel 2001, come omaggio ai (quasi) vent'anni di attività.
Cada Die ha la sua storica sede teatrale presso la vecchia vetreria nel quartiere di Pirri, in Via Italia, da loro riadattata a spazio teatrale. Il Comune di Cagliari nel 1999 ha iniziato i lavori di ristrutturazione dell'intero edificio, e ha deciso di affidarlo per concorso pubblico ad associazioni locali che ne facessero domanda. Nonostante la lunga attività intrapresa nella sede però la "cordata" che faceva capo al Cada Die non ha vinto, anche se poi la compagnia continuerà di fatto a lavorare all'interno della struttura:
"Si tratta di uno spazio che abbiamo tirato su noi dieci anni fa, non esisteva un teatro a Pirri, la scommessa è stata proprio farlo nascere lì, in quella periferia. La vecchia vetreria era una vera struttura di archeologia industriale, aveva mattoni in tufo, il giardino interno. Sono convinto che più teatri ci sono, più c'è buon teatro, più trovi la fiducia del pubblico. E il pubblico veniva sino a qua a vedere gli spettacoli, fidandosi delle nostre programmazioni anche se non conoscevano le compagnie. In quello spazio abbiamo portato Le Albe, la Raffaello Sanzio e Fanny & Alexander e i Motus all'epoca dei "Teatri sommersi". Là hanno realizzato quattro edizioni di Contaminazioni, rassegna di teatro di ricerca in cui hanno ospitato tra gli altri, Pierangela Allegro e Michele Sambin con il Tam teatromusica, Davide Enia, Marco Baliani, Leonardo Capuano, Enzo Moscato, Danio Manfredini, Pippo Delbono. Importante anche la rassegna Custodi del tempo, spettacoli e incontri sull'arte del narrare giunta quest'anno alla terza edizione."
Contemporaneamente Cada Die gestisce anche uno spazio per Teatro ragazzi, un ex oratorio che è stato ampliato ad accogliere 200 posti, non senza sforzi dal gruppo stesso.
Giancarlo Biffi è sardo acquisito, ma parla della Sardegna come fosse un nativo: "Credo che qui in Sardegna ci sia un patrimonio da tirar fuori, una memoria più profonda, un legame con la terra che è più stretto. Questa sardità non è solo la "limba"(=lingua), qua ci sono le radici antropologiche che tocchi con mano, il mare che è una risorsa importante, sei in un'isola e vivi quotidianamente questa dimensione di "nazione". Ovunque ti muovi non c'è altro che Sardegna. Abbiamo messo in piedi uno spettacolo Sos sinnos da un testo di un autore sardo Michelangelo Pira, con musica e e introduzione narrativa; l'ha visto Soru di Tiscali e lo vuole portare a Berlino. Non bisogna temere di non essere compresi: se io parlo del mio paese divento universale".
Sulla Sardegna Cada Die sviluppa da anni un importante filone di narrazione con l' interpretazione e la regia di Giancarlo Biffi, Alessandro Lay, Pierpaolo Piludu, Alessandro Mascia; tra i lavori più significativi ricordiamo il progetto La bella gioventù che comprende Tzia Teresa, Famiglia Puddu, Federico, tre storie con momenti di canto e poesia in sardo, con un unico denominatore: gli anni Quaranta, la fine del fascismo e della seconda guerra mondiale; Posidos e Sos Laribiancos dal romanzo Quelli dalle labbre bianche di Francesco Masala, libro ristampato e distribuito con l'Unione sarda proprio in questi giorni. I protagonisti di Posidos sono le narratrici e narratori di Scano Montiferro, un paese della Sardegna centro-occidentale e il loro insostituibile patrimonio di cultura orale: "Il narrare è una pratica e come tale trae forza dal suo continuo ripetersi... Esplorare storie, attraversarle, infilarsi nelle sue pieghe per poter trovare o incontrare lo sconosciuto: c'è qualcosa che ci appartiene in questi racconti, che ci spinge davanti alle nostre domande, senza per forza darci delle risposte".

Posidos.
I contos antigos con sas ànimas e su dimoniu con storie che raccontano di agattare unu posidu (trovare un tesoro) raccolti da Pierpaolo Piludu dopo una antropologica "ricerca sul campo" vengono portati oggi nei teatri e nelle classi e raccontate alla maniera antica.
Sos laribiancos è la storia di dieci ragazzi partiti da Arasolé nel 1940 su un carro bestiame per andare in guerra, raccontata in parte in italiano in parte in sardo-lugudorese.

Unità 7.
La nuova produzione, Unità 7. Notizie dal deserto di Mandras ha avuto un'anteprima nazionale al Teatro delle Saline a Cagliari nel novembre 2002 e ottime recensioni su "La nuova Sardegna" e "Unione sarda".
"Unità 7 è un lavoro sul corpo, sull'immagine, è di impatto, a livello visivo è godibile anche se è un po' difficile da collocare nei teatri perché ha bisogno di spazi particolari. Parla di scorie e abbiamo previsto i tempi recenti (la Sardegna è stata da qualche settimana dichiarata Regione adatta a smaltire scorie radioattive a causa della bassa densità abitativa; se la cosa dovesse essere approvata significherebbe che obbligatoriamente verrebbero rovesciati annualmente sull'Isola tonnellate di rifiuti. L'Unione sarda intitolava questi giorni: Sardegna pattumiera d'Italia e distribuiva la bandiera "No alle scorie", amm). Cinque uomini vengono abbandonati alla deriva in un posto deserto che è la loro prigione, dove per avere uno sconto di pena devono stoccare materiale radioattivo; ma nessuno va più a prenderli, neanche il carceriere è recuperato e condivide così con loro la pena. Non c'è sipario, c'è una rete metallica e gli attori guardano sempre in avanti nell'illusione che qualcosa stia arrivando. Ma il mondo ti guarda e non ti vede".
Cristolu. Vita di un frate bandito adattato da Alessandro Lay dal romanzo di Salvatore Niffoi di Orani, considerato uno dei migliori narratori della Sardegna, è nato in collaborazione con Bocheteatro di Nuoro, tra parole e musica (da Monteverdi e Pergolesi). E' la storia di un frate che si macchia di omicidio, del "dovere di sangue" per vendicare la sorella violentata e uccisa dal figlio del potente del paese, di un "agnello che diventa lupo". Walter Porcedda ne "La nuova Sardegna" scrive che "nello spettacolo tutto est pretzisu. Dove su bandidare è segno disperato e ancestrale di rivolta che si coniuga all'illusione di riscatto, di voglia di giustizia, de iustitia".

Cristolu.
"Cristolu è la storia di una faida barbaricina. Uno spettacolo con due attori Giovanni Carroni e Pierpaolo Piludu. Volevamo fare la Sardegna e fare "scantonamenti" leggeri, "contaminazioni": Pergolesi "sporcato"dalla lingua sarda".
L'altro filone della compagnia è quello del teatro ragazzi: "Abbiamo presentato quest'anno con successo Radio cipolla a Vimercate, al festival "Una città per il gioco". Non è la "Melevisione". Partiamo da una Apixedda (=l'Ape car) in scena. I Supremi e le loro guardie i lupantropi cercano di togliere i sentimenti, vogliono togliere la musica. Impossibile far piangere e far ridere, tutto è vietato. Il popolo dei boschi sopravvive grazie a un giradischi che tiene lontano i lupantropi ma presto rimangono senza scorte di energia. Riusciranno a sconfiggere i lupantropi diffondendo la musica attraverso onde radio".
Mariposa la farfalla meccanica, finalista allo Stregagatto 2000 ha ottenuto il Premio Ribalta 2002-sezione miglior attore per Mauro Mou e ha avuto significative e positive critiche (V. Ottolenghi, M. Marino).
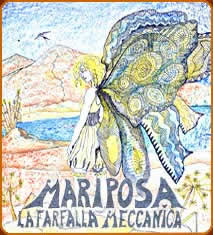
Mariposa la farfalla meccanica.
Giancarlo Biffi lavora anche a un suo progetto personale basato sulle storie dei ragazzi di strada di Managua. Un'amica, Zelinda Roccia, è ancora là a lavorare con i ninos de la calle ad un progetto per il recupero dei bambini di strada. Nasce Los locos del calvario: "Il Calvario è il nome di una chiesa che sorge presso il Mercado Oriental, il loro rifugio. Ricordo quei giorni a Managua stretto ai ragazzi lungo i viottoli, ricordo le parole, gli odori i colori. Nulla di ciò che viene narrato è frutto di fantasia, tutto è spietatamente reale. Quei ragazzi di cui parlo esistono davvero."
Uno dei progetti speciali a cui Cada Die si sta dedicando è Migranti, laboratorio teatrale permanente indirizzato verso l'area del disagio fisico, psichico e sociale ideato diretto da Alessandro Mascia con Alessandro Lay e vede il coinvolgimento di vari comuni della Sardegna (Monserrato, Sinnai, Dolianova, Donori e Soleminis). Il laboratorio è confluito nel 2002 nello spettacolo Migranti, popolo in cammino e quest'anno in Pronto soccorso ospedali riuniti Cada Die ha dato vita recentemente e con grande successo di pubblico, anche alla manifestazione Ogliastra teatro (che si disloca nell'arco di tutto l'anno tra Lanusei, Perdasdefogu, Jerzu) in cui è inserito Jerzu teatrofestival - in punta di bicchiere. Nella terra dell'Ogliastra, patria del vino Cannonau, ogni anno ad agosto il festival anima il paese di Jerzu con spettacoli, incontri e iniziative in collaborazione con la Cantina Antichi poderi. Scena e vino. I luoghi sono le case del paese, il Centro di aggregazione sociale e naturalmente su magasinu. Il progetto è promosso dall'Eti (per la diffusione della cultura teatrale in aree disagiate) e dalla Regione Autonoma della Sardegna: "La nostra attività in Ogliastra non si vuole limitare a una organizzare una manifestazione con un inizio e una fine precisa. La nostra è una scelta di intervento teatrale permanente, per vitalizzare e mantenere alto l'impegno in una delle più belle zone della Sardegna", racconta Biffi al quotidiano di spettacoli in Sardegna on line "Godot".
Cada Die Teatro
Via dei Genovesi 94/A
09124 Cagliari
tel. 070 662994
Al lavoro con Rodrigo García
Il diario dell'allestimento di Historia de Ronald el payaso de McDonald (La Storia di Ronald il pagliaccio del McDonald) a Intercity
di Alessandro Romano
Il Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino ha accolto con entusiasmo e ammirazione l’ultimo guizzo artistico dell’autore e regista ispano-argentino Rodrigo García. Ospite dell’ultima edizione del Festival Intercity, anticipata quest’anno a giugno, e appena conclusa, è stata proprio la Carniceria Teatro, compagnia teatrale fondata da García nel 1989. Dal festival delle Colline di Torino, dove ha presentato After Sun, pièce con la quale la compagnia ha calcato già diversi scenari europei, a Sesto per presentare al pubblico fiorentino la Historia de Ronald el payaso de McDonald (La Storia di Ronald il pagliaccio del Mcdonald). Prima assoluta in Italia, dopo aver già riempito per diverse settimane la sala Cuarta Pared di Madrid, scenario nel quale la compagnia è solita presentare le sue nuove creazioni al pubblico e alla critica nazionali, anche nelle due giornate di Sesto Rodrigo ha fatto il tutto esaurito.
Ho avuto la fortuna e il piacere di lavorare per una settimana a fianco di un gruppo espansivo, eterogeneo, vivace che, per l’occasione, ha unito, attori e tecnici con alle spalle esperienze diverse ma profondamente convinti della validità e della forza di questo "teatro diferente", che García pensa, scrive e disegna sulla scena. Ecco come è maturata quest’esperienza collettiva di cui mi sono sentito parte.

16 giugno.
Madrid-Valencia-Belgio-Francia-Canadà-Svizzera-Italia-Svizzera-Francia e ancora Italia. Rodrigo García e la Carniceria, si fermano solo davanti a un buon piatto di tortelli alle noci e rucola. Per ridisegnare l’ultimo piano di lavoro sulle tovagliette che riportano la via Dante Alighieri. Si parla già del prossimo appuntamento: il Festival di Avignone. Siamo a Sesto Fiorentino e nel primo week-end d’estate andrà in scena, al Teatro della Limonaia, in prima nazionale, l’ultimo lavoro dell’esuberante autore e regista ispano-argentino: La istoria de Ronald el payaso de Mc Donald. Rodrigo non la smette di dire che è emozionato. Ritorna a Sesto dopo nove anni, un paesino di cui ricorda ancora il bar dell’aperitivo serale e il parrucchiere dove si era recato per un taglio decisamente estivo. Ricorda l’ospitalità di Silvano Panichi, che gli aveva offerto vitto e alloggio, quell’afa insopportabile della Limonaia, che nemmeno quest’anno gli darà tregua. Ogni tanto si estranea, sposta il suo pensiero a quella prima esaltante esperienza creativa, quando non ancora trentenne, aveva scritto e rappresentato quel Patè di ragazza, in spagnolo Notas de cocina, con gli attori della Limonaia. É subito a suo agio davanti a un bicchiere di rosso e a una bistecca di maiale. È contento di Torino, dove hanno appena rappresentato After Sun ma dice che il pubblico era un po’ "soso", letteralmente "insipido". Juan, che lavora con Rodrigo ormai da cinque anni, è silenzioso, posato, sembra fermarsi sulle cose un attimo più degli altri. Non è è il solito attore estroverso e spigliato. Ha addosso la discrezione e l’umiltà di chi il suo lavoro lo fa con passione e professionalità. Alex, il suo giovane tecnico francese, aggregatosi al gruppo da qualche mese, è invece frenetico, assorbe, parla con un forte accento francese, sfoglia anche a tavola la sua grammatica italiana. Tre ritmi totalmente distinti amalgamati in un’unica passione, quella per un "certo teatro". Rodrigo è estroverso fa amicizia con tutti persino con un cagnone che coccola a lungo. E le due ore che trascorro con loro volano. Sono desto, vigile. Ascolto, domando, mi intrometto. Voglio capire sentire, vedere. Si parla di pesce, delle Asturie, regione bellissima del nord della Spagna dove Rodrigo vive quando non è in viaggio, ma si parla anche della compagnia che non ha una propria sede - "En los últimos dos años es el avión nuestro lugar de ensayos" (negli ultimi dieci anni è l’aereo la sede delle nostre prove) -, di Torino, delle gelaterie e delle bilance. Si parla dell’indomani… si parla. Rodrigo serve il vino a tutti. Si sente di casa. Si arriva all’albergo. Per qualche minuto Rodrigo è in estasi. Continua a ripetere "Esto es una pasada, tio" "è proprio una figata qui!" A domani allora... "Mañana màs"!
17 giugno
Arrivo in teatro nel pomeriggio. Rodrigo non c’è. Alex vigila il montaggio della sua installazione, studia l’italiano. Lavora con García da novembre, sta imparando, mi dice. Sta crescendo. Nel pomeriggio un forte nubifragio si abbatte su Sesto allagando il giardino antistante al teatro. Barbara Nativi, direttrice artistica del Festival teme, per due ore si ferma tutto. Poi arriva Diego con la mitica "furgoneta" e tutto il materiale di scena direttamente da Madrid. Ma è già ora di andare a cena. È li che Rivedo Juan, uno dei tre attori, e Rodrigo. La mia giornata finisce qui. Li lascio davanti a un buon piatto di pasta alla amatriciana.
18 giugno
Rodrigo è rimasto anche oggi in albergo. Sta organizzando le prossime tappe di questo interminabile peregrinare della Carniceria, lottando per ricevere dei contributi dall’INAEM (Istituto nazionale delle Arti Performative e Musicali). Un lavoro che non gli piace molto. Lo stanca, gli toglie un sacco di energie, ma dice che nel gazebo del giardino dell’hotel si lavora bene. Uno dei pochi posti dove sta al fresco. È rilassato quando lo vedo, anche se mi dice che il caldo lo tormenta, non lo fa dormire. Sono già le cinque del pomeriggio. Nel frattempo io e Juan stiamo preparando i sottotitoli dello spettacolo. Juan è un ragazzo di quarantatre anni. Limpido, deciso, una presenza forte ma discreta. C’è feeling, si ride, si fanno commenti, si lavora. Alex ha già preso confidenza con l’ambiente. A Torino si è innamorato e gli si vede in faccia. In teatro si muove con leggerezza, familiarità e discrezione. Chiede, poi ringrazia sempre. Mi racconta i suoi progetti, le sue ultime esperienze con la Carniceria. Juan è ormai un veterano. Lavora con Rodrigo da quattro anni ed è con Patricia Lamas il più presente nelle sue creazioni. Condivide con lui questo teatro di immagini suoni, parole, tematiche sociali, intriso di energia. Un teatro critico, ironico, dissacrante, irriverente, così umano da sfiorare l’animalità, così vivo che è già due notti che lo sogno a occhi aperti. Un racconto tempestato di riferimenti estrapolati da una realtà così visibile, che nessuno si rende conto di esservi effettivamente parte. Lui ci mette davanti a ciò che non vogliamo credere possa circondarci, prenderci alle spalle, di sorpresa, farci soffrire. Ci invita a stare in guardia da tutto e da tutti quelli che ci possono imbrogliare, con l’onestà e la schiettezza di chi questo lavoro lo fa perché crede ancora nelle sue pulsioni, asseconda con sincerità i suoi impulsi creativi. Evviva l’arte per l’arte. … Il momento più bello e sereno della giornata è l’aperitivo: un panino alla salciccia diviso in tre e gustato di fronte allo stadio di Firenze. Rodrigo mi fa prendere un spavento quando vede questo chiosco in prossimità di un incrocio. Balza giù dalla macchina e come un ragazzino grida di gioia. Parliamo di calcio. Lui lo guarda per rilassarsi. Allo stadio ci va due o tre volte all’anno. Lì si carica, "se la pasa de puta madre!" Più tardi a cena c’è anche Carlos Marquerie, il direttore tecnico della compagnia, appena atterrato a Firenze. Ci dice che il presidente del Real Madrid ha comprato Beckamp con i soldi della sua impresa di costruzioni che si occupa di "ricostruire l’Iraq". Nuovo materiale per Rodrigo: c’è da scommetterci. Ci saziamo di chiacchiere… "Mañana mas"!
19 giugno
Appuntamento con Juan. Sono le undici. Alle undici e due minuti arriva. Rodrigo è già tornato in albergo a sbrigare le sue faccende burocratiche e artistiche. La Limonaia è isolata dal mondo. Telefoni e Internet sono fuori uso. Ma Juan e io riprendiamo a lavorare sui sottotitoli. Simuliamo una rappresentazione. Pian piano acquisto confidenza con power point e con la velocità e il ritmo della sua voce. Alex è alle prese con i filtri dei fuochi e a predisporre il materiale arrivato da Barcellona. Carlos lavora sul suo portatile dirigendo i tecnici per il montaggio delle luci. In ufficio c’è molta agitazione. Il pomeriggio scivola via inesorabile, la stanchezza incomincia a farsi sentire. Ecco pronte le cartelline per l’arrivo del resto della compagnia. Guido fino all’albergo e conosco gli altri due attori: Ruben, l’altro Juan e la sua famiglia. Guarda caso anche loro simpaticissimi. Gli do le prime istruzioni, le ultime della giornata. Domani è un giorno ricco di appuntamenti. Conferenza stampa ore 11.30. Registrazione voci per lo spettacolo. Spesa per lo spettacolo. E ancora prove con Ruben e Juan Navarro e poi la banda. La prima è dietro l’angolo… Confesso che sono già emozionato. È forse perché mi sento coinvolto? O semplicemente l’amore per qualcosa di straordinariamente umano come il teatro?
20 giugno
In mattinata è prevista una breve conferenza stampa. Rodrigo questa volta è in teatro già verso le dieci. Comincia a prendere confidenza con la cabina di regia, poi con simpatia e entusiasmo si mette a disposizione dei giornalisti. Dopo una breve introduzione di Barbara Nativi, che ricorda con affetto e un pizzico d’orgoglio di aver scoperto già nel 1994 il talento dello scrittore argentino, naturalizzato spagnolo, la parola passa all’autore. Con semplicità ed essenzialità illustra le principali caratteristiche della sua ultima produzione. Poche e brevi frasi, è attento e abituato a facilitare il compito del traduttore. Non devo nemmeno prendere appunti. Alla presentazione della Historia de Ronald el payaso de McDonald segue quella del testo di Borges, tradotto e riletto in modo personale da Luca Camilletti, attore e amico di Rodrigo. Sotto analisi sono l’Argentina del periodo della dittatura del generale Videla e la figura di Jorge Luis Borges, lo scrittore ammirato e messo sotto accusa dell’autore per la sua silenziosa complicità con il regime. Luca ci racconta la sua personale rilettura del testo, ambientata all’interno di una macchina che, durante tutta la durata della rappresentazione viene lavata da sei ragazze in bikini. Poi è la volta dell’installazione Vasos de agua para sonar, basata in un suo personalissimo ricordo d’infanzia, quando ogni sera la madre gli portava in camera un bicchiere d’acqua prima che s’addormentasse. E infine il video in collaborazione con la coreografa e amica madrilena Helena Cordoba, con la quale ha lavorato in diverse mise en éspace.
Un panino e poi di corsa a registrare nomi di marche, personaggi della TV spazzatura e cibi precotti, tutti ingredienti essenziali dello spettacolo. Ecco che pian piano lo spettacolo prende forma dietro a queste piccole azioni di routine che coinvolgono più persone. C’è complicità, entusiasmo. Poi viene il momento della spesa! Tre carrelli non bastano. Ne servono quattro. Assieme agli attori recuperiamo quintali di cibo e di bevande, svariati oggetti di scena destinati a finire sul palcoscenico della Limonaia. Dal latte al vino, dai cereali alle uova, dai polli alle interiora del maiale. Tutto questo e ancora altro per disegnare una scenografia quantomeno singolare e di notevole impatto visivo.
Non ci sono prove, gli attori si limitano a ripetere il proprio testo, a raccontare la propria storia a voce alta, in modo che anch’io possa esercitarmi con i sottotitoli. Il testo che recitano è assai più ampio di quello tradotto e pubblicato per l’occasione dalla Ubulibri, infarcito da improvvisazioni e divagazioni che nascono in scena durante ogni singola replica. A tal proposito mi chiedono di insegnargli qualche parola in italiano per rivolgersi in maniera più simpatica e diretta al pubblico. Se la scrivono sul palmo della mano, la ripetono a voce alta, mimano l’azione che prevede l’utilizzo della parola in questione. Mi chiedono ripetutamente se va bene, se la pronunciano in modo corretto. Anche questa giornata volge al termine. Il ristorante li aspetta e Rodrigo è il primo ad abbandonare il teatro. Apprezza molto la cucina italiana, il buon vino e la grappa.
21 giugno
È arrivato il giorno della prima. L’appuntamento è alle undici per recuperare al mercato di Sesto gli ultimi generi alimentari per la scena. La giornata scivola via rapida. C’è grande attesa per lo spettacolo che avrà inizio dopo l’incontro con l’autore organizzato per presentare la raccolta di alcuni suoi testi uscita con il titolo di Sei pezzi di teatro in tanti round edita da Ubulibri. A Franco Quadri, giunto a Sesto per l’occasione, il compito di presentare García al pubblico e ai giornalisti accorsi numerosi e curiosi, con domande e riflessioni sulle caratteristiche della sua scrittura teatrale e sulle peculiarità della sua forma di rappresentazione. Un teatro che attinge alle diverse espressioni dell’arte e della cultura per raccontare, con immagini, forme, oggetti e suoni, le più palesi contraddizioni della vita quotidiana, le ingiustizie di cui siamo ciechi testimoni e vittime inconsapevoli. Finalmente si comincia. Le luci si accendono su una colonnina che sorregge una "scultura iperrealista" (una Coca Cola e un "Big Mac"), tre monologhi, tre storie, tre bambini che raccontano la loro prima volta al McDonald. E intanto gli attori, rimasti in slip, si agitano e si contorcono nel vino e nel latte. I loro corpi si ergono a indiscussi protagonisti per buona parte della rappresentazione, invadendo di energia una platea attonita, attenta e, almeno in parte, "accaldata". Veicoli di azioni, racconti, rivelazioni, riflessioni, creano una progressiva e inscindibile interazione con il pubblico che si spezza solo al termine della funzione. Veniamo persino coinvolti direttamente nello spettacolo quando ci incitano a spostare in avanti il palcoscenico con delle funi agganciate alle pareti. Ma manca la fede, abbiamo perso ogni illusione con il passare degli anni, ogni speranza. Il palcoscenico non si sposta. È questo uno dei più forti e diretti messaggi di Rodrigo che prende di mira la pigrizia e l’inerzia della gente che, sfiduciata, rassegnata, si aggrappa alla fragile speranza che qualcuno dall’alto possa risollevare le sue sorti, che qualcosa possa cadere dal cielo! E dal cielo cadono realmente generi alimentari e non, (detersivi, cereali, barattoli di conserva, uova etc.) schiantandosi sul palco, davanti agli occhi increduli e meravigliati degli spettatori. Uno spavento che scuote il pubblico più assopito, lo ridesta nuovamente caricando l’atmosfera già elettrizzante di nuova energia. Il ritmo oscilla in continuazione, rallenta quando sono i video i protagonisti del racconto. Cartoni animati, personaggi della televisione spagnola (c’è anche la nostra Raffaella Carrà), ma anche Jorge Rafael Videla, immagini di morte (il ragazzo di Genova), povertà, malattia. C’è spazio per una critica feroce alle più diverse manifestazioni dell’ingiustizia nel mondo. Dalle violente repressioni durante la dittatura in Argentina, alle forme di violenza gratuita, che si celano anche dietro le spensierate e divertenti gag dei cartoni animati. Anche i bambini apprendono che c’è una legge naturale che stabilisce chi picchia e chi deve essere picchiato. I più forti, i più autorevoli i più potenti nascono per picchiare. I più deboli, i più indifesi, i più emarginati nascono per essere picchiati. Sullo sfondo un incessante e violenta critica ai prodotti del consumo di massa. In particolar modo a quella "scatolina prodigiosa" chiamata Happy Meal che García, per bocca di Juan, si riserva di analizzare scientificamente, dimostrando i gravi danni cerebrali che il suo contenuto provoca al bambino che lo ingerisce. Ma all’autore preme ricordarci, ironicamente, che sono più in pericolo i bambini italiani, che lo ingeriscono una o due volte alla settimana, o quelli americani, che lo fanno quasi ogni giorno, rispetto ai bambini cubani che invece "succhiano il cazzo a un turista italiano", o a quelli africani costretti a cucire palloni per la Nike. Le quasi due ore di spettacolo si avvicinano al termine e mentre i tre attori si vestono da pagliacci, contemporaneamente li vediamo sullo schermo divertirsi con un barbecue di cultura e carne, abbrustolendo libri e hamburger, in una scenetta esilarante scandita da voci che declamano i nomi di intellettuali e personaggi della televisione spazzatura.
22 giugno
Si replica. E ancora una volta riprovo le stesse emozioni di ieri. Mi porto lo spettacolo addosso. Non mi si leva. Ormai ne sono impregnato… l’odore del teatro. Ho il sonno agitato. Domani ripartiranno tutti.
23 giugno
Li aspetta una settimana di vacanza prima della prossima destinazione. Porto prima Rodrigo, Juan e Alex a Peretola, poi il resto della compagnia a Pisa. È andato tutto per il meglio. Sono contenti.
A distanza di giorni ci penso ancora. Racconto la mia esperienza a tutti. Molti mi guardano e non capiscono, in effetti non possono capire.
Le recensioni di "ateatro": In fondo a destra
di Raffaello Baldini, regia di Federico Tiezzi
di Oliviero Ponte di Pino
In fondo a destra è il primo testo teatrale in lingua italiana di Raffaello Baldini, dopo un significativo percorso poetico, con liriche che hanno spesso per protagonisti personaggi dall’immagine e dal destino già teatrali, e due testi nel dialetto della natia Santarcangelo di Romagna. E’ il ritratto dell’alienazione di un intellettuale metropolitano, giocato su una invenzione vagamente kafkiana (o buzzatiana): il protagonista si perde in un labirinto sotterraneo che sembra raccogliere una folla di individui come lui, di varia provenienza geografica, tutti intrappolati in un limbo dove non accade nulla, se non un ossessivo girovagare alla ricerca dell’uscita e un altrettanto incessante e vano incontrarsi e riperdersi. Il tono, a nascondere l’angoscia di fondo, è delicatamente ironico (nelle gag delle conversazioni tra questi dannati senza colpa) o velatamente lirico (nei monologhi interiori dei protagonista).
Sul versante della drammaturgia, Sandro Lombardi (per una volta al lavoro solo fuori scena)e Silvio Castiglioni (che come direttore del Festival di Santarcangelo in questi anni si è meritatamente concesso questa scorribanda d’attore) hanno condotto un meticoloso lavoro di sottrazione, operando una serie di microtagli interni che tolgono molte notazioni realistico-descrittive, per indirizzarsi piuttosto verso l’astrazione: insomma più vicino a Beckett che dalla parte del realismo magico, in una dimensione freddamente mentale: la scelta che riflette anche il contenuto del prologo e dell’epilogo, scritti per l’occasione, dove si lascia intuire che il labirinto in cui si perde il protagonista può anche essere quello delle parole e del linguaggio.
Dal punto di vista visivo, Federico Tiezzi (che negli ultimi vent’anni ha spesso innervato con la presenza dei Magazzini diverse edizioni del Festival, dai tempi di Sandinista! al famigerato affaire del cavallo fino ai recenti Bernhard e Testori) utilizza alcune icone dell’alienazione contemporanea: come i quadri di Magritte o i pannelli di Gilbert & George. Ingessa i due protagonisti di vesti formalmente impeccabili, imbozzolandoli in abiti scuri, cappotto, giacca e gilé e scarpe robustamente eleganti.

Gilbert & George, Bloody Faith, 1976.

Silvio Castiglioni in In fondo a destra, foto di Marcello Norberth.
Ma lo sfondo è di un magenta incandescente, che le raffinate luci di Gianni Pollini utilizzano per raggiungere quasi un effetto di solarizzazione (come in certi pannelli di Gilbert & George, per l’appunto). E così come le immagini dei due artisti inglesi sono spesso composte di più pannelli accostati in composizioni di grande formato (vedi They, 1986, un doppio autoritratto composto di sedici pannelli fotografici), qui lo spettacolo si compone per brevi sequenze, frammenti di monologo intervallati da lampi di buio (i tagli del testo), come se fossero strip di fumetti accostate l’una all’altra.
Lo sfondo è geometricamente disegnato dalle cornici di due grandi porte. Tra loro pende dal soffitto una gigantesca lampadina. Lì sotto solo un divano, che costituirà il fulcro del lavoro gestuale degli attori. Nel prologo e nell’epilogo le parole s’avvitano giocosamente su se stesse: ma in questo gioco, nella sua gratuità, c’è una crepa destinata a trasformarsi in una voragine e a sforare nell’incubo. Massimiliano Speziani, cui tocca di dare inizio e fine allo spettacolo, tradisce una precisione nevrotica nella quale risolve tutti i rovelli del protagonista, salvo proiettarli nel suo doppio onirico. Silvio Castiglioni esegue il compito con assoluto controllo e cronometrica precisione, nelle intonazioni e nei gesti, con momenti di sorprendente bellezza: come quando cui s’appoggia sul bracciolo e s’adagia sul divano. Ma pian piano da quel corpo ingabbiato nell’abito più convenzionale iniziano a riemergere, come da un passato geneticamente inscritto nel corpo e incancellabile, il profumo della terra e la fatica del contadino.

René Magritte, Il figlio dell'uomo, 1964.

Silvio Castiglioni in In fondo a destra, foto di Marcello Norberth.
Nel testo di Baldini, il protagonista ha sufficiente buonsenso per non cedere alle illusioni di fuga che gli vengono prospettate via via dai suoi compagni di sventura, per non credere alle loro facili soluzione; ma non ha sufficiente intelligenza, o follia, per inventare la via della fuga. Nella carne di Castiglioni questo buonsenso pare rimandare a una radice bertoldesca, quasi contadina (con spazzi ormai quasi impercettibili di comicità arlecchinesca, magari nella piega del labbro), mentre una intelligenza "urbana", con tutti i suoi galatei, sembra quasi incatenarlo al labirinto del linguaggio. Proprio in questo doppio movimento dal paese alla città e ritorno, dalla terra alla metropoli e ancora alla terra sta lo scarto ambiguo, lo snodo vitale della messinscena.
In fondo a destra
di Raffaello Baldini
Regia di Federico Tiezzi, con Silvio Castiglioni e Massimiliano Speziani
Santarcangelo, Lavatoio
Le recensioni di "ateatro": Cinema Cielo
Ideazione e regia di Danio Manfredini
di Oliviero Ponte di Pino
Cinema Cielo di Danio Manfredini è una Classe morta a luci rosse, un teatro della memoria e della devianza, una danza della morte e della perversione. Ma è sempre attraversato dall’ironia e da un sentimento di umana pietà che accomuna i personaggi, gli attori e gli spettatori, tutti ugualmente mostruosi e umani.
Siamo in un cinema a luci rosse che non esiste più, il Cinema Cielo del titolo, ormai smantellato dopo l’avvento delle videocassette e dei club privé. Stanno proiettando una pellicola porno, tratta dal romanzo di Jean Genet Nostra signora dei fiori: ma noi spettatori, sistemati esattamente lì dove dovrebbe esserci lo schermo, di quel film sentiamo solo le battute, spiazzi di dialogo, e il rumore della pioggia che cade. Di fronte a noi il palcoscenico è occupato dalla sgangherata e polverosa platea del cinema, con le sue file di poltroncine sbilenche, i frequentatissimo cessi sulla destra e sullo sfondo, oltre le tende di velluto, verso la luce della strada, il foyer con le sue stralunate e divertentissime cassiere.

Pian ci accorgiamo che tra quello che dicono gli antieroi di Genet e quello che accade in sala che un rapporto: spesso un’associazione, a volte una complementarietà oppure in ironico contrasto, in un continuo (e drammaturgicamente virtuosistico) gioco di rimandi.
E’ un inferno - o magari un paradiso - irrimediabilmente perduto, che può rivivere solo nella memoria, con la sua feccia improbabile e composita, una tribù ormai estinta con i suoi rituali spermatici. C’è il dolcissimo e stralunato travestito brasiliano, il tizio che si eccita solo se sente l’odore dei calzini, il sordomuto marchettaro che ulula e grugnisce di non essere omosessuale e che lo fa solo per i soldi, il paralitico in cerca di compagnia, il terzetto che s’incula al ritmo di Forever Young, il travestito in pelliccia e bikini che si scatena al ritmo della disco dance, l’immigrato che ormai abita in sala e si guadagna da vivere facendo lavoretti nei cessi, l’esibizionista che ti appoggia il cazzo sull’orecchia, l’uomo che solleva il vestito alla sua donna e la offre agli altri clienti, il Babbo Natale che in questa sconclusionata vigilia si scatena in una danza da giocoliere, il preservativo usato che s’appiccica alla suola della scarpa, lo studente in tuta e tacchi a spillo che si fa inculare a raffica, il vecchio in giarrettiere che sbuca dai cessi, il marito che telefona alla moglie "Sono giù a mettere ordine in cantina, tra mezz’ora salgo" e s’infila nel cesso...

E’ una umanità eccentrica e meticcia, un variegato circo di ossessioni dove il Cristo è un acrobata sui trampoli che allarga le braccia. E’ fatta di manichini, immobili al loro posto oppure trainati, come negli spettacoli di Kantor, da piccoli carrelli. Ed è fatta naturalmente di esseri umani, infoiati dal meccanismo ripetitivo della perversione, della coazione a ripetere, della forma che fissa e pietrifica il desiderio: burattini spesso più ridicoli che scandalosi, deboli e fragili come tutti noi non appena liberi dall’ossessione della normalità. A dare vita a questa straordinaria galleria composta di decine di figure è un quartetto d’attori di straordinaria potenza e disponibilità: Danio Manfredini in primo luogo, e con lui Patrizia Aroldi, Vicenzo Del Prete e Giuseppe Semeraro. E’ grazie a questo moltiplicarsi di presenze, alla loro danza a volte grottesca e a volte struggente che le ossessioni private, personali di Danio Manfredini, il suo sentimento della diversità e della bellezza, trovano per la prima volta dopo i suoi memorabili assoli una dimensione oggettiva e insieme collettiva.
Cinema Cielo diventa così una lancinante meditazione sulla natura umana, sulla sua fragilità, sulla possibilità di trovare la poesia dentro e oltre la pornografia. E’ una intricata meditazione sul corpo (sulla sessualità) e sullo sguardo: i corpi degli attori e quelli dei manichini con cui a volte s’accoppiano, lo sguardo della platea del Cinema Cielo che s’incrocia con quello degli spettatori sulla superficie di uno schermo inesistente. Ci sono squarci di quotidianità quasi bozzettisica, con le esilaranti controscene delle cassiere, in grado di accettare e di far accettare qualunque pratica sessuale come un banale fatto della vita. C’è la bellezza e il degrado dei corpi che si accoppiano nello squallore del cinema. C’è un’ironia, e una autoironia, di fondo, che sdrammatizzano e riportano ogni comportamento a una dimensione semplicemente umana, e dunque da accettare come tale.
Ma poi - alla fine di questo canto della diversità, dell’amore e della morte - c’è anche, seppure eccessivamente sottolineato nel finale, il sospetto che tutto questo rimandi a qualcosa d’altro, a una realtà più terribile e segreta, che non sappiamo dire, e men che meno definire, ma di cui sentiamo l’oscura potenza non appena ci abbandoniamo a noi stessi.
Cinema Cielo
Ideazione e regia di Danio Manfredini
Rimini, Teatro degli Atti
Per approfondire:un'intervista a Danio Manfredini (1955).
Le recensioni di "ateatro": Ada, cronaca familiare. Ardis I (Les Enfants maudits)
di Fanny & Alexander
di Oliviero Ponte di Pino
René Magritte usava tutti gli elementi della grammatica della pittura per destrutturare e distruggere la rappresentazione pittorica.
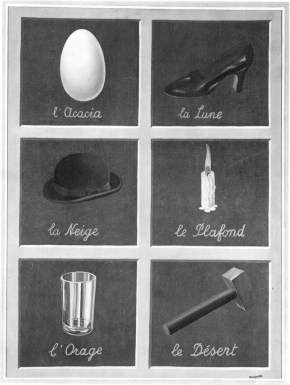
René Magritte, La chiave dei sogni, 1930.
Fanny & Alexander utilizza i meccanismi della rappresentazione teatrale, in tutti i suoi formalismi (la definizione dello spazio scenico che determina il limite tra realtà e finzione e il rapporto con il pubblico, l’equilibrio tra attore e personaggio, la drammaturgia), per destrutturare e distruggere la rappresentazione teatrale, rimandando ogni volta a una realtà che trascende sia il mondo sensibile sia quello della finzione scenica. Non è un caso che sia per Fanny & Alexander sia per Magritte (che nel programma di sala di questo Ada funge da Leitmotiv visivo) la cornice - ovvero il limite che separare la rappresentazione dal mondo reale - sia in ogni caso il fulcro dell’operazione concettuale che si dispiega poi nell’opera, per aprire a una quinta dimensione, oltre lo spazio e il tempo.

In Ada, cronaca familiare Fanny & Alexander riprendono ed enfatizzano l’adesione alle regole implicite della rappresentazione e la loro disarticolazione che aveva segnato i precedenti lavori: da Ponti in core, fiaba goethiana d’amore e morte ambientata in un teatrino anatomico, dove la rappresentazione si dà dunque come dunque postuma, in una sorta di autopsia del teatro, a un Romeo e Giulietta che si poteva cogliere solo oltre un candido diaframma da macchina fotografica, fino al Requiem, ovvero il mito di Orfeo narrato alle soglie degli inferi in forma di opera.

Questa volta la scena è una stanza dalla carta da parati a strisce gialle, con la parete di fondo disseminata di cornici cieche: buchi e pertugi con evidenti rimandi erotici, oltre i quali ci dovrebbe essere il nulla, il vuoto e che invece innescano un meccanismo di seduzione e perversione del desiderio. A destra, oltre la quarta parete immaginaria del teatro naturalista, una sedia. Ci si accomoderà Luigi De Angelis, arrivando dalla platea, a costituire un doppio del pubblico, muto e immobile spettatore-ascoltatore delle presenze evocate da quello spazio. Perché quella stanza è animata da presenze vive e pulsanti, da un racconto, da una storia: quella dell’amore incestuoso tra Ada e Van, abitanti di un’altra galassia, di un’altra dimensione.

Attraverso quelle cornici emergono frammenti dei corpi dei protagonisti della vicenda: una bocca o un’orecchia, parole sperdute (diascalie...), immagini... Sono frammenti visivi e vocali di una vicenda dove riecheggiano le ossessioni care al gruppo ravennate: la fiaba dell’infanzia, il mito dell’incesto tra fratelli, il sottofondo ossessivo e pulsante dell’intreccio di amore e di morte.
In questo «cinema da camera» (e però sospeso anche tra romanzo, teatro e pittura) a innescare i meccanismi ossessivi di Fanny & Alexander è il romanzo sottilmente erotico di Vladimir Nabokov Ada (appunto), che narra l’amore sensuale e metafisico tra Ada, appunto, e Van, sbocciato fin dall’infanzia. Ed è come se, nel trasporre il romanzo su questa virtuosistica "non scena", dove tutto si coglie solo per frammenti feticisti e isterici, Fanny & Alexander avesse usato su Nabokov gli stessi metodi che lo scrittore russo-americano - grandissimo critico - applicava ai grandi capolavori della letteratura: in cerca di segni ricorrenti o rivelatori (sintomi). Ma per spostare subito questo metodo fuori dalla pagina scritta, fuori dal saggio critico, per restituirlo alla materialità, alla fisicità del teatro. Così come la lettura di Nabokov seziona i testi per coglierne frammenti di realtà, così Fanny & Alexander restituisce il testo per frammenti di corpo, di fisicità; e questi frammenti vengono trasformati dunque in segni, in linguaggio, innescando un gioco di seduzione prima intellettuale che carnale. Anche qui (per restare a una delle passioni di Nabokov, il suo amore tassonomico per le farfalle) con freddezza e lucidità da entomologo: per fissare e raggelare la forma vivente in uno sforzo di analisi che insieme è pulsione di morte.

La staticità cinematografica dello spettacolo (con la parete-schermo spezzata in diversi frame) è la conseguenza di questo radicale partito preso: il rifiuto della rappresentazione, lo slittamento della narrazione (della sua capacità di portare senso) in uno spazio "altro", che il rituale del teatro può evocare, l’ingranaggio di curiosità voyeuristica e frustrazione che condanna lo spettatore al suo ruolo.
Così Ada - primo appuntamento di un percorso in sette tappe dedicato al romanzo di Nabokov - sposta la rappresentazione e il racconto oltre lo spazio della scena, in un altrove irraggiungibile, che possiamo cogliere solo per schegge visive e vocali, che rimandano a una pienezza che possiamo solo evocare. Anche se è proprio in quella dimensione che, alla fine, Van-Luigi De Angelis approderà, compiendo il gesto sacrilego di entrare nella cornice, per rompere il tabù, e al tempo stesso annullarsi in quanto presenza reale. Accanto a lui, o meglio oltre la parete di fondo di questa Wunderkammer, in una macchina scenica di implacabile perfezione formale, offrono frammenti di sé Chiara Lagani, Paola Baldini, Marco Cavalcoli, e Sara Masotti.
Ada, cronaca familiare
Ardis I /Les Enfants maudits
Cinema da camera per voci, pianoforte, ondes Martenot e macchine del suono
Ideazione di Chiara Lagani e Luigi De Angelis
Regia, scene e costumi di Luigi De Angelis
Drammaturgia e costumi di Chiara Lagani
Fanny & Alexander
Ravenna Festival, poi Santarcangelo dei Teatri, Longiano
Le immagini sono tratte dal video di Ada. Ardis I.
Per approfondire: Casuali frammenti
da una conversazione con Fanny & Alexander
(ovvero Chiara, Luigi e Stefano) (1998).
Le recensioni di "ateatro": Braccianti. La memoria che resta di Armamaxa
di e con Enrico Messina e Micaela Sapienza
di Anna Maria Monteverdi
Braccianti. La memoria che resta della compagnia Armamaxa, ideato e interpretato da Enrico Messina e Micaela Sapienza (in collaborazione con Tracce di Teatro d'autore e La Corte Ospitale di Rubiera diretta dal regista Franco Brambilla e presentato il 4 luglio al Festival di Santarcangelo), è liberamente ispirato a La memoria che resta. Vissuto quotidiano, mito e storia dei braccianti del Basso Tavoliere (a cura di G. Rinaldi e P. Sobrero).
"Braccianti è un progetto teatrale, culturale e politico, fortemente legato al presente", ricorda Federico Toni (direttore artistico di Tracce di teatro d'autore) nella presentazione al volume che raccoglie i risultati di questo lungo lavoro artistico. Si tratta di un progetto non solo artistico, ma anche politico e sociale perché tale è la tematica prescelta, che richiama alla mente sfruttamento, povertà, ma anche lotte di movimento, quelle lotte che raramente troviamo rappresentate nei Musei della civiltà contadina o della civiltà materiale, che ricostruiscono archeologicamente gli strumenti della fatica, trascurandone però spesso i drammi e le vicende storiche. Oltre che allo spettacolo, il progetto Braccianti ha dato vita a un volume che raccoglie i frammenti di una "ricerca sul campo" svolta negli anni Settanta da due antropologi, Giovanni Rinaldi e Paola Sobrero, in un percorso intorno alla memoria (intesa non come "deposito chiuso ma come capacità personale sociale di utilizzo e traduzione continui di esigenze e motivazioni del presente) della comunità di Capitanata, contenente tra le altre, le storie raccontate da Michele Balducci, Alfredo Casucci, Savino Totaro, Lucia Barbarossa, Maria Manzi, veri protagonisti di questo mondo bracciantile. Al progetto sono anche associati una mostra fotografica e un sito web www.progettobraccianti.it.

Lo spettacolo prevede una struttura di narrazione, tra parole, coreografie e gesti (semplici, antichi e rituali) dei due attori seduti uno di fronte all'altro, contrappuntati da immagini fotografiche in bianco e nero proiettate sullo sfondo e da suoni che fanno eco. Le immagini sono le fotografie dei braccianti o dei luoghi del Tavoliere delle Puglie; i suoni, le parole e il canto sono le registrazioni di vecchie cantilene e storie in dialetto pugliese, scelti sapientemente a raccontare lo scandire delle ore della giornata di lavoro e i momenti della festa - sebbene si avverta in alcuni momenti il rischio di una caduta nel naif. Il sottile velo che accoglie quella luce che si fa immagine trasporta in un'atmosfera senza tempo; immagini attraversate anche fisicamente dai corpi degli attori che letteralmente se ne ricoprono, vi si confondono, mescolandosi tra la folla del popolo di Cerignola convocato nella Piazza nel 1920, perdendosi in mezzo al grano tagliato delle terre del Tavoliere, o seguendo la manifestazione bracciantile in Capitanata (rimandando alla nostra memoria la marcia de Il quarto stato di Pellizza da Volpedo), dormendo nella lettèra, accompagnando i contadini sui campi. Il lavoro del bracciante è l'inferno in terra, si ricorda con una storiella in dialetto: anche i diavoli lo hanno capito. Lo aveva capito anche Giuseppe Di Vittorio di Cerignola, uomo di temperamento, che si imponeva sui proprietari terrieri e chiedeva la diminuzione di ore di lavoro e aumento di salario perché "era brutale, era animalesco sfruttare un uomo dalla mattina che spunta il sole sino a quando tramonta il sole." Nello spettacolo Di Vittorio diventa l'icona di questo mondo contadino in lotta. Ma il tempo dello sfruttamento per i lavoratori stagionali della terra non è finito, e a pagare sono i braccianti di oggi che non vengono dalla terra che coltivano.

Quello di Armamaxa è un teatro etnografico che scava con commossa partecipazione dentro le radici della sofferenza contadina per scoprirne paesaggi umani. Di grande intensità le coreografie di Micaela Sapienza e Enrico Messina a "rifare" la durezza della vita bracciantile, gesti che raccontano un mondo fatto di terra e fatica, di sopraffazione ma anche di riscatto.
Lo spettacolo si inserisce in quella onda della memoria che vede come protagonisti autori-narratori come Ascanio Celestini e il giovanissimo Davide Enia mentre Dario Marconcini in Scene da Arturo Ui (in programma per il Festival di Radicondoli) mette in scena attori e maggianti contadini.
Braccianti. La Memoria che resta
liberamente ispirato a La memoria che resta. Vissuto quotidiano, mito e storia dei braccianti del Basso Tavoliere di G. Rinaldi e P. Sombrero
di e con Enrico Messina e Micaela Sapienza
Santarcangelo, Teatro Supercinema, 4 luglio 2003
Le recensioni di "ateatro": Apparizioni
di Alfonso Santagata
di Oliviero Ponte di Pino
Da anni Alfonso Santagata esplora la tragedia greca (così come il suo ex socio Claudio Morganti sta lavorando su Shakespeare). Nel suo teatro d’attore il presupposto è che le passioni estreme evocate da Eschilo, Sofocle ed Euripide, nella loro esplosiva potenza, possano fornire un trampolino ottimale per il lavoro dell’attore. E se teniamo presente che per Santagata il lavoro sull’attore presuppone per prima cosa uno scavo, un assottigliamento fino al nucleo centrale dell’ossessione - e dunque della verità - del personaggio, i grandi eroi tragici, ridotti ai loro sentimenti elementari di amore e tradimento, vendetta e follia, rappresentano un perfetto trampolino di lancio. Allo stesso tempo quelle tragedie familiari possano far risuonare degli echi dell’attualità e della attuale cronaca nera.
Con alcuni spettacoli itineranti - come questo Apparizioni, liberamente ispirato al ciclo degli Atridi e riallestito in diverse manifestazioni estive, come Da vicino nessuno è normale all’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini di Milano - questa ricerca di verità ed essenzialità, più che esplorata nel lavoro d’attore, viene proiettata sul pubblico, in uno spettacolo-esperienza che si snoda nelle oscurità della notte. Il ciclo eschileo è ridotto ad alcuni frammenti che gli spettatori colgono nel corso di uno itinerario che è insieme la scoperta di uno spazio di cui enfatizzare le qualità evocative (come per esempio l’ex ospedale psichiatrico Paolo Pini a Milano). Sono brevi flash che nell’arco di un’ora condensano una mezza dozzina di situazioni, o meglio i punti forti della tragedia: in sostanza, dopo un prologo affidato a un indovino-profeta che ammonisce il pubblico sulla natura degli dei, l’omicidio rusticano di Agamennone, la danza profetica (ma di maniera) di Cassandra, il matricidio da parte di Oreste ed Elettra, e l’ultimo saluto dei due fratelli, portavoce di un nuovo ordine certamente diverso dal precedente ma non per questo migliore.

L’operazione implica una serie di radicali semplificazioni: ogni sviluppo psicologico resta escluso, a favore di apparizione che hanno il fascino del mistero; la riflessione politico-filosofica si riduce a qualche accenno all’attualità. La comunicazione che passa dunque più per allusioni che per analisi, più per immagini che per emozioni: abbaglia sull’immediato con le sue suggestioni, poi lascia un senso di incompiutezza e infine continua a lavorare nel profondo, nel corso del tempo.
Apparizioni
ideazione e regia Alfonso Santagata
con Rossana Gay, Johnny Lodi,
Francesco Pennacchia, Massimiliano Poli
Milano, «Da vicino nessuno è normale», all’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini di Milano
Le recensioni di "ateatro": Imparare è anche bruciare
del Teatro della Valdoca
di Alessandra Giuntoni
Nella serata afosa di Cesena, dove il Festival di Santarcangelo si allunga in estrema propaggine, è la voce graffiante di Janis Joplin a darci il benvenuto e ad annunciare, sulle note struggenti di Summertime, tutta la vitalità disperante di Imparare è anche bruciare. Lo spettacolo costituisce la tappa conclusiva di un percorso di formazione per attori durato sei mesi, sostenuto dall’ERT e guidato da Cesare Ronconi e Mariangela Gualtieri che rappresentano l’anima e l’essenza poetica dello storico gruppo cesenate.
Di questa esperienza pedagogica si conservano, sulla scena, tutta la freschezza e l’ingenuità, tutto l’impeto di un universo giovanile in subbuglio, il tormento e la passione che si accompagnano alla ribellione contro il mondo degli adulti: "I nostri padri ci hanno nutriti di menzogne. Adesso io guardo ogni menzogna e la risaputo". Ha così inizio una vorticosa parata di clown stralunati, di folletti danzanti a ritmi rabbiosi, i corpi dipinti con colori violenti, insanguinati come vittime di un sacrificio, adornati con fiori e rametti da iniziazione tribale. Affascinanti marionette - archetipi riconoscibilissimi dell’universo figurale del Teatro Valdoca - si alternano sotto i riflettori manovrati a mano, producendosi in siparietti più o meno irriverenti a base di pernacchie e sberleffi, cadute funamboliche e pagliacciate circensi. Indimenticabile la scena in cui la metà dei ragazzi funge da operatore-burattinaio dei rimanenti, dando loro voce e movimento secondo una prassi straniante che separa gesto e parola e conferisce ad entrambi maggior spessore ed espressività.
Come spesso accade negli spettacoli della Valdoca, l’elemento ludico e quello tragico-rituale fatalmente convivono e la parola poetica, scavata sino al suo "punto di rottura", liberata dai vincoli della convenzione, modulata come un canto antico sulle più disparate inflessioni dialettali, ritrova il suono puro dell’inaudito. Il rapporto totale con lo spazio, la dimensione essenziale da scena primaria, ricordano certi quadri di Chagall in cui spropositati violinisti verdi fluttuano in una tormenta di strumenti musicali o dove insoliti danzatori si disciolgono in coreografie di esagoni e sezioni di cerchio. Si respira un clima onirico da circo, da vecchie giostre di paese, da luna park abbandonato e la musica, eseguita live dall’orchestrina sul palco, non manca di sottolinearlo con polche e mazurche da balera romagnola che spezzano i ritmi tiratissimi del rock di Aidoru. I passaggi serrati dell’azione scenica si sostanziano di un’energia corporea incandescente che promana dal cuore pulsante della vita, da un magma di dolore esistenziale che chiede essere ascoltato. I giovanissimi interpreti inciampano nelle scarpe troppo lunghe, si rialzano e riprendono la loro folle corsa e la loro invettiva contro il mondo dei grandi: "Gli adulti sono ragazzi morti". E’ una ferita aperta che continua a sanguinare, che parla di offese inflitte alla bellezza innocente, di speranze affossate dal cinismo e dalla volgarità, di un mondo che ha perduto la capacità di sognare: "Voglio parole gloriose da dire in ginocchio", "Voglio fratelli integri con cui fare il mio sogno".

Suona davvero come un inno alla vita questo ultimo lavoro del Teatro Valdoca, un gioiosissimo e commovente inno alla vita che ci piace riassumere con le battute conclusive del testo, ottenuto da Mariangela Gualtieri rielaborando gli scritti degli stessi allievi: "In questo terribile tempo, in questo terribile spazio, voglio anche fallire, sbagliare mille volte, ma restare sempre attaccata al cuore selvaggio della vita".
Imparare è anche bruciare del Teatro della Valdoca
Santarcangelo dei Teatri (Luglio 2003)
Per approfondire: http://www.trax.it/olivieropdp/valdoca88.htm
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
Il set teatrale di Flicker
Lo spettacolo multimediale di Caden Mason (Big Art Group) a Inteatro
di Anna Maria Monteverdi
Il Festival Inteatro di Polverigi, diretto da Velia Papa, si è garantito l'esclusiva nazionale di Flicker dell'americano Caden Manson (Big Art Group), e come da previsione, lo spettacolo, insieme con O Divina la commedia -Inferno del Teatro del Silencio, è stato l'evento catalizzante dell'intero Festival. Tre giorni di tutto esaurito e una folla di giovani si è riversata al Teatro della Luna per il giovane gruppo che gode già di grande fama internazionale (soprattutto dopo il successo di Clearcut, Catastrophe!) per le spettacolari manipolazioni tecnologiche in scena.

Parodia divertente e distruttiva dei reality show televisivi, delle dirette sui luoghi della tragedia, delle cronache in tempo reale, che imperversano in ogni Tv, ma anche dei format che sfruttano una visione voyeristica della vita, Flicker è costruito come un "real time film", un film che mentre si realizza è già proiettato o in onda. Sopra un palco sono posizionate tre telecamere, le riprese realizzate nella parte superiore della scena (una sorta di upper stage) vengono mostrate in diretta su tre schermi posti perpendicolarmente in basso. Alle tre telecamere corrispondono tre postazioni e 8 attori che gestiscono a turno e "personalmente" il proprio "occhio digitale" e contemporaneamente incarnano un personaggio della storia e imprestano braccia, testa e busto per l'inquadratura di un altro. Tre schermi contigui in pratica, trasmettono tre riprese diverse che danno l'illusione di ricreare un'unica immagine. Gli attori recitano in continuità, senza interruzioni, senza stacchi, appunto come a teatro ma l'elemento sorprendente dello spettacolo è che pur con telecamere fisse, la macchina predisposta da Manson gioca abilmente a creare "artigianalmente" la sensazione di movimenti di ripresa, alternarsi di campi e controcampi, carrellate e primi piani, effetti still o mirror, disorientando lo spettatore.

Disorientamento prodotto anche dalla visione contemporanea dei tre schermi che restituiscono un'unità nella frammentazione originaria, e dalla visione degli attori che recitano in questo piccolissimo spazio-palcoscenico "recintato" dai confini rigidissimi, senza mai poter permettersi di andare fuori scena-ovvero fuori campo. Il palcoscenico teatrale diventa un set cinematografico in cui gli esterni sono ricostruiti con trucchi ed effettacci: cartelli, fotografie di alberi attaccate alla telecamera mentre la visione continua spazio-temporale è quell'inganno che il gruppo attacca sistematicamente nel corso dello spettacolo con manipolazioni "alla luce del sole" ed inganni ottici. Viene in mente Rope (Nodo alla gola), interamente girato da Alfred Hitchcock in un unico piano sequenza, come fosse cioé in diretta (film che secondo Liborio Termine "può suggerire una via per il teatro televisivo"). Lo scarto tra immagine e azione che l'ha generata è il tema dello spettacolo, ovvero lo smontaggio e il rimontaggio continuo della storia, la cui trama da film horror non è altro che un "rifacimento" in 5 metri di palco di situazioni alla Blair Witch Project di cui ritornano in modo caricaturale, nello spettacolo, gli incubi di studenti diretti ad una festa e persi nel bosco, di ragazzi in luoghi isolati con la macchina in panne, preda di maniaci notturni. Una ragazza cerca di scappare, una corsa affannosa, un uomo la insegue, la telecamera la riprende, dal corpo sgorga un cangiante smalto rosso... Il passaggio, la transizione da una situazione narrativa all'altra è un fade to black creato con cartoncini scuri avvicinati all'ottica della videocamera da servi di scena vestiti in calzamaglia nera per rendersi invisibili, come nel teatro giapponese di burattini, il bunraku. Si gioca sullo spiazzamento continuo: abbiamo sotto gli occhi il set, le riprese e il film ma anche i trucchi adoperati per provocare la nostra ingenuità e la nostra credulità e darci invece un'altra visione dei fatti. Insomma, l'interrogativo è: fiction o non fiction?

Un modo divertente per ricordarci, se ancora ce ne fosse bisogno, che il vero più vero spacciato dalla televisione è frutto di una totale invenzione/deformazione della realtà. La ripresa non registra solamente ma riscrive, struttura. Nessuna immagine è obiettiva. L'incondizionata fiducia che accordiamo alla nostra scatola quotidiana e a chi la manovra non ha senso. Trattasi né più né meno, di una scatola da prestigiatore con il quale il conjurer fa apparire, scomparire, fa a pezzi oggetti e persone a suo piacimento. Così appare ma così non è: la televisione rende credibile la finzione.
Certamente il giocattolo Flicker impressiona nella sua sorprendente narrazione teatrale oltre il teatro, che scardina modelli narrativi e mostra l'artificialità di ogni rappresentazione, proponendo infine una (tiepida) critica all'universo mediatico, giocando con le profondità di campo, i trucchi e gli artifici del teatro e del video come un abile prestigiatore.
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
Il teatro tra televisione e cinema
Flicker del Big Art Group
di Oliviero Ponte di Pino
Dal punto di vista del rapporto tra l’evento spettacolare e lo spettatore, il teatro accade qui e ora; il cinema invece è accaduto in un altro luogo (il set cinematografico e poi la sala di montaggio rispetto alla sala cinematografica) e in un altro tempo (è stato ovviamente realizzato in precedenza ed è stato riprodotto chimicamente sulla pellicola); la diretta televisiva accade in un altro luogo (lo studio o il luogo dell’evento televisivo) e ci giunge ora (trasmesso attraverso la riproduzione elettronica nel luogo in cui si trova lo spettatore, in genere nel salotto di casa).
Con il suo "Real Time Film" Camden Manson e il Big Art Group mescolano e intrecciano allegramente queste tre diverse prospettive. Il loro Flicker, visto al Festival di Polverigi, è senz’altro uno spettacolo teatrale, che accade qui e ora, con attori e spettatori riuniti in un unico spazio. Il problema è che gli attori, in realtà, occupano due spazi vicini ma diversi: in carne e ossa, occupano una pedana sopraelevata, davanti a una parete bianca con alcune strisce orizzontali che ricordano i codici ISBN; la loro effigie elettronica occupa invece i tre schermi che si trovano appena davanti alla pedana, leggermente più in basso: ci arriva grazie a tre telecamere che ovviamente riprendono quello che accade di sopra, ma con un piccolo trucco.

A un primo sguardo, la pedana superiore e l’infilata dei tre schermi sembrano rappresentare lo stesso spazio: ci sono gli stessi attori, la solita parete bianca e le identiche strisce orizzontali. Ma poi ci si accorge che in realtà lo spazio reinventato sugli schermi è fittizio, che quelle righe creano solo l’illusione di una continuità inesistente, perché tra uno schermo e l’altro c’è un altrove invisibile, un vuoto, uno scarto. Insomma, più che di film vero e proprio, sono il teatro e il video che interagiscono per svelare i trucchi della produzione di realtà a opera di cinema e televisione.
Flicker racconta, a livello di plot, una improbabile vicenda di genere: un serial killer appostato in un bosco che massacra gli incauti che ci si fermano nonché gli eventuali soccorritori, in un crescendo di effettacci e situazioni terrificanti (che ovviamente fanno molto ridere, non appena inserite in un meccanismo demistificante).
Per lo spettatore il godimento consiste nel far oscillare lo sguardo tra il teatro e il video, per vedere l’ingegnosità e a volte l’irridente comicità con cui viene simulata la tecnica cinematografica. Il taglio a nero è un cartoncino posto davanti agli obiettivi. Il controcampo si realizza invertendo le posizioni degli attori che si trovano a destra e a sinistra. Per lo zoom basta avvicinare o allontanare il volto dalla telecamera. Per alcuni effetti speciali è sufficiente allontanare rapidamente una fotografia dall’obiettivo: può raffigurare una macchina che corre veloce sulla corsia opposta o la testa dell’ennesima vittima spiccata dal corpo. E così via, in un crescendo di trovate comicamente efferate.
Viene anche scardinato il rapporto tra l’attore e il personaggio: infatti capita spesso di vedere sui tre set altrettanti attori che interpretano il medesimo personaggio (grazie a vestiti e parrucca identici, mentre i volti vengono "uniformati" da calze di nailon bucato su occhi e bocca). Sullo schermo vediamo un braccio che brandisce un coltello avvicinarsi alla vittima: il braccio può essere quello di un attore, la mano quella di un altro.

Perciò se quello che si vede sugli schermi tende ad avere una qualche coerenza narrativa, quello che accade nel reale, sul set, è un guazzabuglio narrativo, con una sarabanda di frenetici cambi di costume e posizioni, raddoppiamenti continui di gesti e personaggi. Chi guardasse solo quello che fanno i nove scatenati attori in carne e ossa, non capirebbe assolutamente nulla, perché il codice per interpretare il loro linguaggio è altrove (ovvero nelle regole cinematografiche che presiedono al montaggio del film proiettato sui tre video).
Con scanzonata allegria Manson e compagni applicano il più classico meccanismo di straniamento alla trama e ai luoghi comuni dell’horror, ma soprattutto al linguaggio cinematografico, a quel flusso di immagini che ci travolge quotidianamente, senza che siamo consapevoli dei meccanismi che generano quella realtà fittizia. Si tratta dunque di uno spettacolo che vuol insegnare divertendo (per usare una definizione classica), un giocattolo tecnologico che smonta la tecnologia.
L’effetto è reso ancora più efficace (sia sul versante comico sia su quello della demistificazione della sacralità dell’immagine fittizia) dalle inevitabili imperfezioni e grossolanità del meccanismo, ovviamente volute e sfruttate dalla regia. Freudianamente, è proprio dall’errore e dal lapsus che Flicker va a cercare la verità.
Flicker
Regia di Caden Mason
Scritto da Caden Mason e Jemma Nelson
Big Art Group
Polverigi, Teatro della Luna
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
Telestreet toscane: inzia la corsa
con un approfondimento su Minimal tv
di Anna Maria Monteverdi
Il 3 luglio scorso a Tassignano nella campagna lucchese, si è riunito un primo gruppo di telestreet toscane. L'appuntamento era presso il circolo Il mattaccio, antico casale ristrutturato grazie all'impegno di tutti gli abitanti del paese, ristorante e luogo di ritrovo dove si mangia e si beve "equo e solidale" e dove tutte le sere vengono organizzati spettacoli (un Festival del teatro dialettale), incontri, concerti o proiezioni nella corte. L'organizzazione era del gruppo Lu_cia, immagini appese, gruppo di comunicazione e informazione alternativa di Lucca legata a Giacomo Verde.
Chi "frequenta" la lista Telestreet o il sito collegato (www.telestreet.it) nati sotto l'egida della prima telestreet italiana, Orfeo Tv di Bologna, sa dell'attuale fermento e moltiplicarsi di tv di quartiere; così alcuni rappresentanti di Tv di strada della Toscana hanno deciso di riunirsi per confrontare le reciproche esperienze.
Numerosa la rappresentanza di Livorno. Il nome della Tv neocostituita è il risultato di un sondaggio lanciato via Internet: si chiamerà Tilt Tv. Il progetto nelle loro intenzioni è di fare una TV di movimento "che racconti quello che i mezzi di comunicazione ufficiale nascondono o deformano."
E' Francesca, pubblicista di un noto quotidiano toscano laureata in Scienze politiche e specializzanda in Linguaggio politico all'Università di Pisa a raccontarci la sua storia: "Siamo andati all'inaugurazione di Teletovaglie di Giacomo Roberto a Pisa. E' venuta fuori poi l'idea di mettere in piedi una telestreet da alcune personalità che gravitano intorno al C.S.O. Godzilla di Livorno. Poi la cosa si è estesa ai Cobas; Giacomo Romboli è il referente territoriale dei Cobas, lui si è entusiasmato all'idea della Tv di quartiere, ha coinvolto altri membri che si sono prestati per fare un po' di pubblicità, promozione e raccolta fondi all'interno delle fabbriche. Gli operai ci hanno dato i soldi, abbiamo fatto cene di autofinanziamento e in meno di due settimane abbiamo raccolto 1.400 euro, quello che ci serviva per comprare l'attrezzatura, fondamentalmente l'antenna. La sede è in centro, presso gli uffici dei Cobas. Tra i collaboratori per adesso ci sono giornalisti, cameramen di TV private, tecnici informatici, attivisti, videomaker".
Alessandro, mediattivista formatosi ai corsi del Cineclub "Arsenale" di Pisa, ha fatto un video sul referendum per l'Articolo 18 che è andato in onda sulle tv locali, ci dice che "Vogliamo aprire le porte ai contributi.che ci può dare il cittadino. Deve sapere che c'è questo spazio, se hai qualcosa da dire e vuol dirlo. Abbiamo pensato di organizzare dei workshop per fare in modo di mettere la gente nelle condizioni di essere autonoma, di poter riprendere col video e fare il montaggio."
Michele di Livorno ha fatto un video su Camp Darby a nome del Cso Godzilla che è stato proiettato nel corso della serata: "Riprendendo l'articolo del Corriere della Sera che definiva camp Derby il più grande arsenale americano all'estero, ho vouto raccontare a livello storico la funzione di Camp Derby dal dopoguerra ad oggi, fino all'epoca della guerra in Iraq e al movimento sviluppatosi contro la guerra che ha indirizzato molti pacifisti a manifestare contro quest'area".
All'incontro erano presenti due dei rappresentanti di Anelli mancanti Tv di Firenze. La Tv ha sede in Via Palazzuolo 8, che corrisponde alla sede legale dell'associazione omonima che si occupa di servizi per gli immmigrati, assistenza legale e dove lavorano molti volontari. Federico, fotografo: "Sono di Bologna, ho visto nascere Orfeo Tv ed eravamo a Firenze per la Global Television; a Firenze ho iniziato a fare volontariato per l'associazione e da lì abbiamo pensato a come fare per valorizzare il lavoro degli immigrati, far conoscere il loro mondo". Marco: "Ho collaborato alle attività culturali dell'associazione e tra queste la Tv. Ognuno porta il proprio contributo indipendentemente dalla sua specificità. Ci si arrangia. La redazione è aperta. Per l'attrezzatura abbiamo avuto un bel culo. Abbiamo avuto un amplificatore che ci ha regalato una Tv locale tra i nostri primi sostenitori. Come modulatore usiamo un videoregistratore. Alcuni ragazzi dell'associazione sono tecnici, montatori con mezzi e competenze proprie. La Tv è in centro storico, dietro la stazione di S.M.Novella e trasmette su UH F60 per 500 metri in una sola direzione. Per fare delle verifiche abbiamo fatto un test "psicologico": suonavamo campanello per campanello e chiedevamo come ricevevano il segnale. Il quartiere è abitato da immigrati, non ha un consiglio di quartiere, loro stessi hanno piccoli esercizi commerciali" "Volevamo fare 48 ore di girato, andando in giro per ristoranti, il negozio di barbiere di un ragazzo nigeriano. Abbiamo realizzato il numero zero in febbraio e il 27 giugno lo abbiamo mandato in onda Non stop in piazza in occasione della grande festa con maxi schermo per l'inaugurazione della Tv. Abbiamo chiesto alla gente del quartiere di mettere le Tv sintonizzate sul nostro canale vicino alla finestra, la notizia è uscita anche su Indymedia news. E' stata una grande festa, quella piazza dal Rinascimento in poi non la utilizzavano più perché c'era già il parcheggio!
Il numero zero prevedeva un palinsesto con programmi sportivi, culturali (alcune letture poetiche in lingua albanese o marocchina, sottotitolate in italiano), intervallo, cucina multietnica, usando le persone del quartiere come presentatori o lettori dei telegiornali.
Federico: "Io ero a Palermo a Termini Imerese nella postazione di Telefabbrica il 31 dicembre. L'inaugurazione di Anelli mancanti Tv è stata una grande festa, Avevamo pensato a un programma di calcio per il palinsesto; l'associazione aveva organizzato un campionato tra gli immigrati, Camerun-Marocco, Turchia-Senegal ecc, così andavamo in giro a chiedere alla gente di farci un pronostico o di commentare la partita che ovviamente non potevano aver visto. Abbiamo chiesto al ragazzo dell'autogrill e a Daniele Sepe che abbiamo incontrato casualmente. La prima trasmissione è stata sperimentale, ma crediamo che le immagini siano una scusa per andare più a fondo a livello sociale. L'idea di trasmettere in piazza, ti obbliga a scendere, a partecipare. E' molto importante trasmettere e contemporaneamente avere un evento di piazza".
Francesco Galluzzi e Giacomo Verde hanno parlato della "storica" Minimal Tv (la Tv più piccola del mondo) di Verde-Quinta parete e hanno mostrato un breve video: "Minimal TV nasce da esperienze di comunicazione artistica. E' un set-TV che viene montato in occasione di mostre, festival o feste. Scopo del progetto è far "mettere mano" alla gente ("mano-mettere") ai dispositivi video segnalando che la "TV e' di-chi-la-fa" e che tutti i messaggi video sono comunque irreali".
Caratteristico è l'uso della diretta Tv attraverso due video-box lasciati in mano agli spettatori.

Dal sito www.hackerart.org di Tommaso Tozzi ripercorriamo la storia della
Minimal Tv
LA TELEVISIONE NON ESISTE
Questo è uno degli slogan della Minimal TV. Nella Minimal TV tutto viene messo in gioco, tutto può diventare televisione, noi partiamo dallatelevisione al punto zero, dal livello minimo; è la televisione più piccola del mondo, nel senso che esiste perchè tutto ciò che accade viene trasmesso su quattro o cinque monitor posizionati in strada, nei bar o in altri punti strategici. La Minimal TV è nata all'interno di festival teatrali e sagre di paese con lo scopo primario di far fare la televisione, di far giocare a fare la televisione al pubblico, ai passanti, a tutti quelli che si trovano a passare dallo studio della Minimal TV che è sempre posizionato in un luogo accessibile. Caratteristica della Minimal TV è l'uso di tecnologie povere, un altro slogan della Minimal TV è: fatevi la televisione che volete.
Quello che poi viene detto o fatto durante le trasmissioni è relativamente importante, più importante è che le persone si rendano conto di come si può fare televisione e partecipino mettendo in campo la propria immagine e la propria esperienza. Funziona così: c'e uno studio televisivo, che di volta in volta cambia scenografia, con un unico conduttore Sasà Nothing raggiungibile anche via telefono; c'è una postazione esterna, il Video-Box, con un televisore ed una videocamera collegati allo studio, nel quale vediamo le immagini su di un monitor di controllo. Gli spettatori con la "guida" di Rorò possono dialogare con Sasà, entrare in trasmissione e lo possono fare anche fisicamente, aprendo la porta della regia. Un'altro punto esterno è il Net-Box che consiste in un computer collegato ad Internet al sito ufficiale della Minimal TV dove vengono inseriti messaggi ed immagini (volti dei partecipanti) relativi ad un argomento specifico; inoltre attraverso lo strumento della videoconferenza il pubblico può "confrontarsi" con gli altri cittadini della Rete. Tutto ciò che accade nel Net-Box viene mandato alla regia che lo inserisce poi nella programmazione delle trasmissioni. Durante il giorno registriamo dei servizi montati in macchina, servizi tra il reale ed il fantastico sulla situazione del paese o sugli argomenti relativi al festival o alla sagra che ci ospita. Alcune selezioni delle registrazioni vengono poi mandate in onda la sera (solitamente la Minimal TV inizia alle 18/19) durante le trasmissioni insieme ai "numeri" e alle gag di Sasà e Rorò che giocano a realizzare generi televisivi. Anche se si ride o ci si diverte molto, evitiamo di imitare la Televisione con le sue gag e i suoi atteggiamenti cabarettistici. Uno dei nostri obiettivi non è fare una parodia della televisione bensì fare televisione, il nostro compito è più quello di essere dei "registi", non è una simulazione della televisione ma una trasmissione che vive di vita propria. La Minimal TV rompe tutti gli schemi tipici del linguaggio televisivo, ad esempio gli spot pubblicitari (che noi definiamo rumeni) vanno contro ogni legge della pubblicità; così come i ritmi televisivi che usiamo non tengono conto dei tempi televisivi che siamo abituati a fruire. LA TELEVISIONE E' DI CHI LA FA e quindi ha la struttura di chi la gestisce.
Ad esempio anche il palinsesto, che facciamo circa mezzora prima di andare in onda, non viene mai rispettato perché la partecipazione attiva della gente sconvolge completamente la programmazione. La televisione è di chi la fa, quindi la televisione non ha un autore, quindi la televisione non esiste... LA TELEVISIONE NON ESISTE ... SONO SOLO FIGURINE

Gli slogan vengono mandati in sovraimpressione insieme ai disegni e gli interventi fatti con computer grafica in tempo reale sopra le facce di chi interviene o sulle interviste.
Inoltre durante le trasmissioni passiamo con disinvoltura da immagini di videoarte all'intervista col vigile urbano oppure al macellaio o al sindaco e poi gli spariamo un video di Bucalossi con un cervello spappolato preso a martellate. C'è una convivenza tra arte sperimentale e di ricerca e la bassa televisione.
Il risultato finale è un mix casuale ed irripetibile, perché in ogni serata si innescano procedimenti anomali tra le diverse componenti, causando un effetto imprevedibile anche a noi stessi "autori". Un aspetto di casualità si manifesta anche nella mobilità dello staff,
vale a dire, c'é una specie di "accodamento" allo staff iniziale. In pratica si possono inserire nello staff classico altre figure come ad esempio l'editorialista (che potrebbe essere il macellaio del paese),l'aiuto regista, eccetera. Personaggi anche con nuovi ruoli che caratterizzano l'aspetto mutevole della Minimal TV. La cosa importante è far toccare con mano alle persone che la televisione non esiste. Oggi comunemente diamo alla televisione un valore di realtà, di esistenza, di documentazione del reale mentre di fronte ad un obbiettivo il nostro tipo di comunicazione è alterato, molto simile ad una situazione teatrale, recitiamo.
Un'extracomunicazione dove mettiamo in scena un personaggio, un personaggio televisivo. La Minimal TV offre la possibilità di confrontarsi con l'immaterialità dell'immagine elettronica, senza stare a fare gli accademici o teoria della comunicazione. Questo è un gioco, un gioco molto serio che sviluppa consapevolezza nella visione della TV ufficiale. Siamo purtroppo abituati ad uno stile televisivo molto filoamericano perche' nessuno ci ha mai mostrato un altro stile, un altro approccio tra le "figurine" e l'obbiettivo, per cui la TV potrebbe essere benissimo totalmente diversa.
La Minimal TV è una sorta di macchina aperta che la comunità ospitante può usare a suo piacimento ed ogni volta è stata usata in modo diverso. La Minimal TV come operazione artistica? Ma se la televisione non esiste, l'arte esiste? (risate e sguardi perplessi)
Il primo esperimento di Minimal Tv fu in un appartamento nel quale da una stanza Sasà Nothing trasmetteva in un televisore situato nella stanza adiacente e tutti pensavano che si trattava di una televisione privata. Gli ospiti della serata potevano colloquiare con il presentatore attraverso il telefono di casa. Il progetto fu poi accettato e finanziato dalla Giallo Mare Minimal Teatro di Empoli.
Staff
Federico Bucalossi (camera e mixer art computer)
Vanni Cilluffo / Sasa' Nothing (conduttore)
Francesco Galluzzi / Rorò (inviato speciale e video-box)
Claudio Parrini (Internet-box manager)
Giacomo Verde (camera e televizion guru).
Esigenze Tecniche
- almeno 3 televisori con supporti da mettere in strada;
- almeno 2 videocamere;
- 1 videoregistratore;
- 1 mixer audio/video;
- una stanza per lo studio-regia facilmente raggiungibile dagli
spettatori;
- linea telefonica nello studio per farsi chiamare dagli spettatori;
- 1 computer a/v per la grafica;
- 1 PC per il collegamento Internet;
- 1 o 2 assistenti tecnici;
Home page della Minimal TV è http://www.leonet.it/art/giallomare/minimal.html
Gli intervistati
Claudio Parrini (Vinci - Fi) Membro di StranoNetwork, dopo una ricerca in ambito pittorico, il suo lavoro verte oggi sul ruolo dell'artista in relazione ai nuovi mezzi di comunicazione. E-mail: c.parrini@leonet.it
Federico Bucalossi (Empoli - FI) Membro di StranoNetwork e Yellowcake, proviene da esperienze diverse che vanno dal video alla musica alla computergrafica attualmente si occupa di nuove tecnologie e discipline della comunicazione collaborando con vari gruppi.
Giacomo Verde (Lucca) Artista ipermediale con esperienze di teatro di ricerca e videoarte. Si occupa delle possibilita' creative offerte dallo scarto tra realta' e comunicazione elettronica con particolare attenzione all'uso di tecnologia povera.
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
Per un'arte della connessione
Recensione a Marco Deseriis e Giuseppe Marano, NET.ART. L’arte della connessione, Shake Edizioni
di Tatiana Bazzichelli
Finalmente anche il mondo dell’editoria italiana apre gli occhi e dà dignità, dopo quasi un decennio di pratiche, al fenomeno della NET.ART. La casa editrice Shake , da sempre attenta alle realtà emergenti della cultura underground (e non solo) italiana e internazionale, apre la strada nel panorama editoriale - ci auguriamo – alla pubblicazione di testi che riflettono sulla cultura e sulle pratiche in rete e di rete dal punto di vista artistico.
Non si tratta quindi di una pubblicazione che reitera i tradizionali presupposti della creazione artistica applicandoli anche al web, ma di un’analisi che punta a evidenziare le possibilità connettive della rete, ripercorrendo la storia della NET.ART internazionale dal punto di vista delle potenzialità intrinseche e strutturali che il .net offre.
NET.ART, quindi, come "arte della connessione" e come possibilità di creare processi che vivono nella rete e per la rete. NET.ART non come pratica artistica semplicemente diffusa attraverso Internet, ma come network di progetti che agiscono combinando sperimentazione sui codici, azioni di guerriglia-marketing, giochi identitari, tecniche di plagio, camuffamento e pratiche performative.
Gli autori del libro, Marco Deseriis (a.k.a. Snafu) e Giuseppe Marano (a.k.a. Subjesus), fondatori di The Thing Italia, offrono sia a lettori che si avvicinano per la prima volta all’argomento, sia a un pubblico più esperto, un utile strumento per orientarsi nel mare più o meno sconfinato delle pratiche di NET.ART internazionale, dando utili dritte per poter approfondire la tematica on line. URL e riferimenti sono infatti d’obbligo, visto che la NET.ART è una pratica di utilizzo sperimentale, espressivo, "contaminante" della rete, interpretabile sicuramente meglio partecipando di persona alle pratiche e azioni, piuttosto che leggendo le descrizioni di queste su un testo scritto. Un’impresa, quindi, sicuramente difficile quella di documentare in forma "narrativa" ciò che strutturalmente non lo è, e che si esprime in forma ipertestuale e diffusa nelle maglie della rete.
Il testo, partendo dalla definizione di NET.ART, termine che si presta spesso a notevoli interpretazioni e fraintendimenti (soprattutto nell’ambito artistico), arriva progressivamente a descrivere le forme di utilizzo sperimentale del codice, il dirottamento digitale, la software art, il cybersquatting, la disobbedienza civile elettronica e le altre forme di sabotaggio in rete che vengono realizzate soprattutto dalla seconda metà degli anni novanta fino ad oggi.
Un elenco di numerose pratiche che rende giustizia a una moltitudine di progetti internazionali, il cui eco per alcuni è giunto anche in Italia negli anni passati, per altri, meno conosciuti, è sicuramente consigliabile la conoscenza e l’approfondimento.
Il libro si chiude con il capitolo "Politiche della connessione", che porta i lettori nei meandri della fitta rete di collaborazioni, link, scambi e processi collettivi che accompagnano costantemente la dimensione "virtuale" del fare arte in rete e che si concretizzano "fisicamente" nella partecipazione e ideazione di eventi, festival, dibattiti internazionali sulla net.art e net.culture e nella creazione di progetti allargati in continuo movimento (come mailing list, blog, laboratori di ricerca, server artistici).
Una nota per gli autori: per la notevole mole di progetti e net.artisti citati, sarebbe sicuramente utile una cronologia essenziale e un indice dei nomi, elementi che aiuterebbero il lettore nel comporre il proprio quadro d’insieme della NET.ART internazionale. Speriamo che questo avvenga nelle successive ristampe, che naturalmente auguro agli autori di realizzare!
Una nota per gli editori: …a quando un libro sulla NET.ART italiana?
Il sito ufficiale: http://www.shake.it/netart.html
Tatiana Bazzichelli su strano.net
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
tnm news
E' uscito "Neural 20"
di Redazione tnm

:: [Neural.it]
>
:: News e recensioni quotidiane
>
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
>
:: ABBONATI per un anno!
>
:: tre numeri + un cd di elettronica
>
:: a 19,60 euro.
>
:: http://neural.it/subscribe/
>
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
>
[Sommario Neural n.20]
>
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
>
hacktivism
>
. Geert Lovink intervista, Hackit 2002,
>
. Howard Rheingold intervista,
>
. Tommaso Tozzi intervista,
>
. news (Plug'n'pray, Wikipedia,
>
Injunction Generator, Swappingtons).
>
. reviews: (Mitnick-Art of Deception,
>
The Future of Ideas, Sarai Reader 02,
>
Netocracy, Hacker Culture,...)
>
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
>
e.music
>
. Carsten Nicolai (intervista),
>
. Micromusic.net (intervista),
>
. Otolab (intervista),
>
. news: (Dj Spooky-Erratum Errata
>
Invisible Cities, IanniX, Gameboyzz
>
Orchestra Project)
>
. reviews: (Sonic Boom, Soundtoy,
>
Microsound, Digitopia Blues)
>
. reviews cd: (Symphony for dot
>
matrix printers 2, Scanner,
>
Radiotopia, Donna Summer,
>
Forma 1.02, Sogar, Dialtones...)
>
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
>
new.media.art
>
. Critical Art Ensemble (intervista),
>
. Eduardo Kac (intervista),
>
. Digital is Not Analog festival,
>
. news (Run.me, Grey Area, 32000
>
points of light, GoogleSynth,
>
Data Diaries).
>
. reviews (Ascott-Art Technology
>
Counsciousness, Writing Machines,
>
Ars Electronica, Stelarc, Transurbanism,
>
Jodi-Install.exe, Beyond Webcams...)
Launderette Soap
Un progetto teatrale
di 'O Zoo No
Laundrette-soap E' una storia che non si può raccontare in poche pagine; bisogna viverla. E' una storia complessa e tutt'ora in atto che non si può raccontare in nulla di singolo. E' somma di comunicazioni, di mezzi di narrazione, di notizie, fatti, avvenimenti; vive del rapporto fra essi, della loro giustapposizione, della costruzione progressiva.
Laundrette-soap E' un progetto-contenitore che si mostra al pubblico in diverse forme. Sono tessere di un mosaico che lo spettatore monta autonomamente. Ogni pezzo va ad aggiungersi e a modificare il quadro unico, ma ogni pezzo preso anche singolarmente è narrazione a se stante, si basta, non soffre la mancanza del disegno totale. Ogni tessera è comprensibile, autoconclusiva, viva.
Laundrette-soap, per sei sabati consecutivi, sarà anche teatro a puntate. Sei puntate di circa 20 minuti ciascuna in sei luoghi diversi della città di Torino. Teatro in luoghi reali: in piazza, nei pressi di una fontana, in un supermercato, sulle rive del Po, e in ogni luogo dove i nostri personaggi si incontreranno, si daranno appuntamento, vivranno la loro esistenza.
Sei puntate di una storia che tracima dagli argini della rappresentazione e scorre per la realtà della città, le parole le opinioni i dubbi dei suoi abitanti, la radio, la tv, la carta stampata, internet... Una storia che va seguita e inseguita ma che ti viene anche a trovare sotto casa, al bar, mentre fai la spesa. Tutto sta ad avere occhi e orecchi e cuore e attenzione e interesse per comprenderla, nel senso di prenderla con sé. Buon viaggio.
"Alcuni viaggiatori sanno, o dicono di sapere, comunque certamente spargono la voce che Aldo, un tempo, faceva il rappresentante di una fabbrica di bulloni e che in un bar incontrò Giulio in cerca di informazioni. Altri aggiungono che Lucio E' da sempre che colleziona voci catturate col suo registratorino che lui dice essere invisibile. Diversi giurano di aver visto Giulia recitare in una fiction tv. Il fratello di Giampaolo si chiama Rudi; non so se Rudi abbrevi Rodolfo. INAMODAMENIC, tieni a mente questo nome.
Altri ancora avvertono che questa storia la si sta già narrando."
IL PROGETTO
Si tratta di realizzare, prendendo i termini in prestito dalla televisione, una sorta di sit-com o telenovela, o forse ancora più precisamente un telefilm (per intenderci sul formato) ma in forma TEATRALE. Ovvero adoperare i codici del telefilm (fondamentalmente la serialità) e trasformarli e trasporli in uno spettacolo teatrale in sei puntate. Sono sei puntate di circa 30 minuti ciascuna, sei spettacoli teatrali da rappresentare in sei diversi luoghi della città di Torino: luoghi reali, non istituzionali dello spettacolo; dunque non teatri, cinema o sale, ma piuttosto una piazza, una fontana in un parco, un supermercato, il lungo Dora, il parco del Valentino, o altri luoghi cari alla città e carichi di storia e di storie.
Ogni puntata sarà autoconclusiva, dunque lo spettatore che dovesse assistere ad una sola rappresentazione sarà messo in condizione di comprendere tutto, divertirsi, partecipare ad un evento teatrale tanto stravagante ed unico quanto intelleggibile nella sua totalità. Ovviamente il cosiddetto meccanismo dell'affezione e dell'attaccamento ai personaggi (che ritorneranno nelle puntate successive, trattandosi di un prodotto seriale) e della curiosità a continuare a seguire la vicenda, saranno ben presenti. Non si vuole penalizzare il pubblico occasionale, anche se si intende creare parallelamente un pubblico affezionato che segua lo spettacolo con assiduità e interesse crescente, e mai la parola 'segua' è' stata usata in maniera più appropriata, in quanto lo spettatore interessato dovrà letteralmente 'seguire lo spettacolo' di luogo in luogo, riscoprendo così Torino e i suoi angoli, i suoi negozi, le sue strade, i suoi punti anche sconosciuti. Spettacolo itinerante sembrerebbe la parola giusta per definire il progetto, ma E' indispensabile aggiungere ìperiodicoî. Le sei puntate non si svolgeranno tutte lo stesso giorno, ma una ogni settimana. Ogni sabato, per sei settimane, a partire dal 13 di settembre fino al 18 di ottobre; e le puntate verranno replicate nello stesso luogo durante tutta la giornata: indicativamente una puntata ogni due ore da mezzogiorno a mezzanotte, dalle 12 alle 12, per un totale di 7 repliche al giorno.
Ma sarebbe giusto anche definirlo Spettacolo Disseminato e Disseminante, perché lascia per la città dei segni, degli indizi, delle anomalie, dei presagi che gli spettatori potranno comporre autonomamente come in una spy-story metropolitana e psico-geografica, come in un immenso mosaico le cui tessere sono da cercare e per comprendere il quale non E' necessario essere a conoscenza di tutte le tessere. Ma questo verrà spiegato meglio nelle pagine successive.
Multimedialita`
Il progetto intende avvalersi di tutti i mezzi mediatici possibili: stampa, radio, televisione, Internet, chat... Questi mezzi non saranno di contorno, di appoggio o meramente riassuntivi, ovvero non serviranno solo ad informare dove e come avverrà l'evento teatrale e neppure a riassumere le puntate precedenti o a raccontare cosa E' successo. Tutti gli altri mezzi di comunicazione avranno uno scopo integrativo: mostreranno il passato dei personaggi, testimonieranno il reale passaggio nella città dei protagonisti, si potranno scoprire informazioni che durante l'evento teatrale non verranno svelate. Creeranno ìrealtà vere e paralleleî che renderanno il progetto un evento totale.
Sarà costituito un sito Internet apposito che seguirà la vicenda. Qui si potranno trovare le biografie dei personaggi, altre storie a loro correlate (ma non necessariamente facenti parte del plot del telefilm teatrale), materiale fotografico; qui si potrà scoprire il passato di ogni personaggio, si imparerà a conoscerlo meglio. Qui si vedranno anche momenti della stessa vicenda raccontata nelle puntate teatrali, ma non si tratterà di repliche, bensì di brani inediti, utili alla comprensione della storia, ma non indispensabili. Si potranno anche raccontare nuovamente le vicende già rappresentate nell'evento teatrale, ma in questo caso si cambierebbe ottica, punto di vista, e il nuovo racconto andrebbe ad aggiungersi alla storia e non a ripeterla.
I giornali, oltre ad informare sull'evento, potranno contenere ìnotizie realiî concernenti la vicenda (esempio: se un personaggio muore, sul giornale verrà pubblicato il necrologio) e seguiranno dunque l'evento in modo nuovo.
Una (o più) radio seguirà l'evento, sia a livello di informazione (nelle due accezioni appena descritte: informazione sull'evento e notizie ìrealiî interne all'evento) sia come mezzo di divulgazione dei pensieri dei personaggi o di divulgazione di vere e proprie scene del telefilm stesso. Anche queste non saranno repliche della vicenda teatrale, ma scene aggiuntive che integreranno l'intreccio con nuovo materiale.
L'importante è comprendere che l'evento teatrale non è un modo per cercare di arrivare alla televisione, alla radio, al cinema o alle prime pagine dei giornali, ma esattamente il contrario: la radio, la carta stampata, la celluloide, il mondo dell'informazione che integra l'evento e la stessa televisione, sono mezzi per portare la gente a teatro, portare la gente a seguire persone vive in carne ed ossa che inscenano una fiction in una piazza o nel supermercato sotto casa; mezzi per portare il teatro dentro la vita degli spettatori. Accendendo i fari dell'informazione di massa il teatro torna a riguardarci e lo scopriamo più vivo e coinvolgente che mai.
In concreto: cosa succederà?
Spiegata l'idea di teatro a puntate e affermato l'utilizzo di tutti i media disponibili, diventa ora possibile comprendere l'evento.
Trattandosi di teatro rappresentato in luoghi reali, creeremo una realtà concreta e tangibile dell'intera vicenda.
Tutto partirà già a giugno. I nostri protagonisti - nella loro reale vicenda che si narrerà nelle puntate settembrine - hanno aperto un sito che pubblicizza la loro videoteca. E noi a giugno apriremo il sito della loro videoteca, consultabile da chiunque. Sarà un sito semplice, con grafica vecchia, perché rispecchierà le capacità e le possibilità economiche dei nostri protagonisti. In questo sito si potranno leggere elenchi di film che la videoteca possiede - sarà un elenco di film inventati, verosimili, ma non reali (titoli che letti in sequenza potranno a loro volta raccontare delle microstorie - e, sempre nel sito, ci si potrà iscrivere ad una sorta di mailing list per accedere alla password con la quale poter entrare nelle pagine dedicate al weblog (il diario di bordo) dei nostri protagonisti.Poi c'è la vita di tutti i giorni dei nostri protagonisti, e anche questa partirà da giugno. E' già partita da tempo, ma solo da giugno sarà visibile:
1. Giulia un giorno di giugno perderà una lettera indirizzata a un suo ex-fidanzato, e noi tappezzeremo Torino con 500 copie scritte a mano di questa lettera. La lettera di Giulia - potremmo addirittura chiamarla "l'originale" - sarà realmente e fisicamente presente nella città di Torino, abbandonata in 500 posti diversi. Ovviamente lo scarto irreale è che noi ne faremo centinaia di copie, però si suppone che chiunque trovi la lettera pensi di essere in possesso di un ìpezzo unicoî; e probabilmente si porterà a casa la lettera, o ne parlerà con gli amici.
Si può anche ipotizzare che di questa ìlettera trovataî si occupi un giornalista della Stampa, giornalista che scriva un pezzo dichiarando di aver trovato questa lettera e di voler trovare il mittente perché gli sembra importante che non vada persa.
Il cortocircuito potrà avverarsi nel momento in cui due persone si troveranno di fronte ognuna in possesso dell'"originale", oppure dopo aver letto l'articolo. Oppure non accadere. Non è così importante che si scopra l'imbroglio, è fondamentale che presagi reali vengano disseminati nella vita della città.
2. Aldo sono mesi che sta leggendo un libro e regolarmente lo perde, lo perde per strada, su una panchina, su un mezzo pubblico. E noi - sostenendo la pratica del book-crossing - lasceremo in giro decine di copie di questo libro, autografate da Aldo: alcune anche con un bigliettino della moglie Mara ad uso segnalibro. Durante le puntate teatrali di settembre/ottobre, Aldo parlerà di questa sua disavventura: "Non so cosa mi stia succedendo: ogni volta che arrivo intorno a pagina 20, perdo questo libro; E' la sesta volta che lo ricompro...". Ecco che ancora una volta la fiction delle puntate teatrali si mischia con la realtà. Un personaggio finto di uno spettacolo perde un libro, e tu lo trovi. Dov'è il limite fra finzione e realtà? Da dove è uscito il libro che due mesi fa hai trovato e che ora sta nella tua biblioteca? C'è forse un buco nello "schermo" della finzione? Cortocircuiti.
3. Lucio - uno dei 5 personaggi - colleziona col suo registratorino dialoghi rubati; Lucio ha a casa centinaia di cassettine di dialoghi di torinesi. Noi non solo faremo ascoltare questi dialoghi all'interno delle sei puntate; noi non solo perderemo in giro per la città alcune di queste cassettine; noi faremo anche ascoltare parte di essi per radio: brevi brani di dialogo rubato nei quali gli ascoltatori si riconosceranno e ai quali chiederemo di immaginarsi una storia, di proseguire il dialogo, di scoprire chi sono gli interlocutori.
4. Magari nessuno se ne accorgerà, ma il biglietto aereo Londra-Torino di Giampaolo, a voler guardare bene, sarà rinvenibile su un bancomat di via Po.
5. Se Rudi scriverà su un muro "Io amo Giulia, tutte le serenate del mondo sono per lei", magari questa scritta sarà ripresa dalla rubrica della "Stampa" che si occupa di graffiti.
Presagi. La città si riempirà di piccoli e grandi segni di questa storia che si comincerà a narrare molto prima del teatro.
6. E Giulio perderà la fotocopia della sua carta d'identità.
7. E qualche fortunato troverà la foto dell'inaugurazione della videoteca.
8. E qualcun altro - o forse lo stesso - sarà in possesso di una foto che inchioda Giulia alle sue responsabilità.
Questi sono alcuni esempi della vera storia di finzione che si sta abbattendo su Torino. Tutti non li sappiamo neanche noi, ecco perché bisognerà stare attenti, tenere gli occhi aperti.
Questi sono alcuni esempi di quello che accadrà nella prima fase, ovvero da giugno 2003.
Poi c'è la seconda fase, che principalmente sarà incentrata nelle sei puntate di teatro, di mezz'ora ciascuna, che verranno replicate 7 volte al giorno per sei sabati consecutivi dal 13 settembre al 18 ottobre. Ma anche in questa fase il rapporto realtà/finzione proseguirà. I cortocircuiti fra quello che accade il sabato e quello che durante la settimana sarà rintracciabile saranno continui. La plurilettura dell'evento, l'amplificazione di significato attraverso la moltiplicazione di informazioni, sarà anche accelerata dal sito Internet.
A questo punto della storia, la maggior parte degli spettatori saprà dell'esistenza del sito di laundrettesoap.it.
Questo sito, che nella nostra finzione diciamo essere di una multinazionale che ha sponsorizzato la videoteca dei nostri giovani protagonisti, sarà in realtà una fucina di informazioni parallele, storie di contorno, segreti dei nostri personaggi.
Questo sito sarà la nostra stessa storia raccontata da cento altri punti di vista, tanto vari da raccontare in realtà altre storie. Qui si potrà trovare il contenuto della borsetta di Giulia; le registrazioni di vecchie telefonate fra Giulio e sua mamma; oppure, di quelle telefonate fra Giulio e sua mamma alle quali abbiamo assistito durante le puntate teatrali ascoltando solo la voce di Giulio in diretta, qui nel sito si potranno ascoltare le registrazioni integrali anche con la voce della madre; qui si potranno leggere i diari segreti; qui si potrà seguire la vita di Mara - moglie di Aldo - che nelle puntate compare una sola volta; qui si potranno vedere degli streaming di pochi secondi tratti dalle puntate teatrali, e anche degli streaming inediti, mai avvenuti dal vivo; ecc.ecc.
Musica
La musica sarà un elemento fondamentale delle sei puntate teatrali. In ogni puntata ci sarà musica dal vivo. Questo non avverrà semplicemente organizzando un concerto, ma i musicisti saranno parte integrante della drammaturgia, verranno integrati nella storia e giustificati dalla narrazione.
Si intende comporre delle musiche originali, e anche delle canzoni.
Dove. I luoghi
I sei luoghi dove si svolgeranno le rispettive sei puntate sono ancora in via di definizione, ma la scelta si muove su basi molto precise. Si intende legare il progetto - o meglio: la rappresentazione - alla vita della città. La novità sta nello assistere a una vicenda che si svolge esattamente in un luogo che preesiste alla vicenda e che continuerà ad esistere dopo la conclusione di essa, e allora esso (luogo) sarà carico di nuove valenze, memorie, significati. Ci sono luoghi, luci, strutture murarie, angoli, ambienti vivi, odori in una città, che il cinema e qualunque altro supporto riproduttivo non sono in grado di restituire nella propria interezza, ma dai quali vale la pena di farsi avvolgere per raccontare una storia. E così i luoghi non rimangono solo scenografie naturali e reali, ma divengono significati e vita.
Per ora i luoghi presi in esame sono Piazza Castello, la fontana delle Stagioni al Valentino, un ipermercato, un fast-food e il lungo Dora.
Perché
Il teatro, dato più volte e in momenti storici diversi per morto, non morirà, mai. Ci sarà sempre qualcuno che si metterà a raccontare ad altri una storia, che rappresenterà per gli altri una vicenda. Un uomo vivo che incanta altri uomini vivi nello stesso spazio e nello stesso tempo. Gli altri mezzi sono corollari, sono nuove tecniche per narrare e affascinare. Creare un telefilm dal vivo che per 42 giorni si sposti per sei puntate in sei luoghi diversi della città seguito e integrato da ogni forma di comunicazione, significa usare tutti i mezzi possibili per portare la gente a vedere una storia, a vedere un teatro più vivo che mai (tanto che entra e si insinua nella mia realtà di tutti i giorni attraverso la radio, la televisione, la rete telematica, i quotidiani), significa dare nuova linfa al teatro e restituirgli la dignità di forma comunicativa primaria e primigenia.
Quando
L'evento parte già a giugno, sarà l'occupazione principale di Torino d'estate.
Poi si concluderà con le sei puntate, per sei sabati consecutivi, dal 13 di settembre al 18 di ottobre. Sette repliche al giorno, ogni due ore, dalle 12 alle 12, ovvero da mezzogiorno a mezzanotte.
La storia. Breve sinossi
Inamodamenic insegna Cinemadomani letta al contrario, dall'interno di una videoteca mentre si aspetta che entri un cliente per noleggiargli il film della sua vita.
ANTEFATTO:
Nel 1998, Giulio, Giulia e Giampaolo (trentenni) e Aldo (quarantacinquenne) aprono assieme un'attività commerciale: una videoteca. La loro attività ha alti e bassi. Giampaolo si occupa poco della videoteca e infine va a Londra a studiare. In videoteca per quattro anni, tutti i giorni, sta con loro per tutto il giorno Lucio, un giovane ragazzo con un ritardo cognitivo che la madre, lavoratrice, E' contenta di sapere in compagnia.
LA NOSTRA STORIA A PUNTATE
si apre con il fallimento definitivo della videoteca appena avvenuto.
I nostri protagonisti si ritrovano con un centinaio di milioni di debito e senza lavoro.
E' la storia di giovani che provano a vivere la propria vita, che cercano lavoro, che attraverso l'amicizia e la forza del gruppo superano le difficoltà del nostro mondo di oggi. Insieme si buttano alla ricerca di un lavoro, scontrandosi con tutte le difficoltà dell'Italia del 2003: corsi di formazione, lavoro interinale, scarse possibilità, lavori assurdi, pressioni dei genitori. C'è il loro rapporto personale, c'è il rapporto con la città di Torino, c'è il rapporto con il mondo degli adulti e del lavoro. C'è il divertimento del cavarsela in una situazione tragicomica. C'è da passare assieme trenta minuti al giorno per vedere come andrà a finire.
Chi siamo
O Zoo No nasce nel 1996 come Associazione Culturale. I soci fondatori sono Benedetta Francardo, Massimo Giovara, Paola Rota e Roberto Zibetti.
Dal 1996 al 2000 produce i seguenti spettacoli:
Come le lumache sull'erba, di Alberto Milazzo con Lorenzo Fontana, Benedetta Francardo, Andrea Romero e Roberto Zibetti, regia di Alberto Milazzo
Voilà, Boheme dal libretto di Illica e Giacosa per la Boheme di Puccini con la regia di Massimo Giovara
Han Shan dall'opera di Jack Kerouac, di e con Massimo Giovara
Il mondo nuovo da A. Huxley, con Benedetta Francardo, Barbara Bonriposi, Carlo Ottolini, Enrico Messina e Cristiana Daneo, regia di Roberto Zibetti
Il caso Sofri di Luigi Di Majo, con Massimo Giovara
ME da ìIl giovane Holdenî di J.D.Salinger, con Roberto Zibetti e Alberto Losano, regia di Paola Rota e Roberto Zibetti
Laundrette Soap di Roberto Zibetti e Valentina Diana, con Benedetta Francardo, Valentina Diana, Alberto Losano, Nicola Ormezzano e Roberto Zibetti
La domenica della vita da Queneau, con lilli Valcepina, regia di Paola Rota e Andrea Violato
Stream of Consciousness di Andrea Roncaglione con Piero Ferrero, Andrea Romero, Marco Viecca, Simona Nasi, Massimo Giovara. Regia di Massimo Giovara
East di Steven Berkoff con Bolo Rossini , Benedetta Francardo, Alessandro Genovesi,Massimo Giovara, Roberto Zibetti e Paolo Serazzi . Regia di Paola Rota e Massimo Giovara
Tracce di Anne di Martin Crimp, con Benedetta Francardo, Bolo Rossini, Alessandro Genovesi, Lilli Valcepina, Elisabetta Vergani, Chiara Pauluzzi,Massimo Giovara, Paolo Serazzi. Regia di Paola Rota.
Roberto Zibetti lavora come attore professionista dal 1990. In teatro ha lavorato con Luca Ronconi (Gli ultimi giorni dell'umanità, Aminta), Massimo Castri (La disputa), Elio De Capitani( Risveglio di primavera) Giorgio Strelher (Il campiello) e con Klaus Michail Gruber ( Splendid).
In cinema ha lavorato con Bernardo Bertolucci ( Io ballo da sola), Dario Argento (Nonhosonno), Ligabue (Radiofreccia). E' uno dei soci fondatori dell'associazione 'O Zoo No
Valentina Diana, diplomatasi alla Civica Scuola d'arte drammatica ìPaolo Grassiî, lavora in teatro come attrice dal 1992 insieme a importanti registi italiani ed europei, tra i quali: Giorgio Marini, C.Remondi e R.Caporossi, Marco Baliani, Isabelle Pousseur, M.De Vita Conti, Walter Manfré, Elio De Capitani, Renato Gabrielli, Giorgio Barberio Corsetti, Francois Kahn, Alfonso Santagata, Gabriele Vacis. Nel 1994 partecipa al corso di perfezionamento ìLe lingue del teatroî indetto dalla Regione Toscana e dalla U.E., durante il quale lavora con Denise Marleau, Barbara Nativi, e soprattutto Thierry Salmon, con il quale lavorerà a Modena in ìStudio sul brindisiî.. Nel 1999 fonda insieme a Maria Grazia Comunale e Andrea Collavino il gruppo ìYurodivije Teatroî con il quale mette in scena Il marito di Akulka e successivamente ìLe due zitelleî, da T. Landolfi. Attualmente lavora ad un suo progetto di spettacolo: ìENZOî, di cui cura interamente testo allestimento e interpretazione, presso Teatranza artestudio Moncalieri, Torino.
Carlo Giuseppe Gabardini: nato nel 1974, diplomato alla Civica Scuola d'Arte Drammatica ìPaolo Grassiî nel 1997, ha lavorato come attore al teatro dell'Elfo (La dolce ala della giovinezza di Lorenzo Loris; Sogno di una notte di mezza estate e Tango americano di Elio De Capitani), al teatro Verdi di Milano (Otello di Kikko Noci Brambilla), al CRT (Fatima Blus di Luca Labarile), al Teatro Regio di Torino (I diavoli di Loudun di José Carlos Plaza), al Teatro Settimo di Torino (Fenicie di Gabriele Vacis), per la A.Gi.Di di Paolo Guerra (Romeo & Juliet di e con Paolo Rossi). In cinema ha recitato ne Il Mnemonista di Paolo Rosa. In televisione E' stato autore e attore di sketch comici all'interno della trasmissione Scatafascio di e con Paolo Rossi (Italia 1, 1998) e della trasmissione RIDO (Raidue, 2000). In radio E' stato attore nella sit-com Inglese perfetto, naturalmente con Lella Costa e Beppe Severgnini. E' autore di due monologhi teatrali che hanno debuttato rispettivamente nel gennaio e nel marzo del 2000: Acqua porca-Storia dell'ACNA di Cengio e Caio Giulio Cesare.
E' coautore degli ultimi quattro spettacoli teatrali di Paolo Rossi: Storie per un delirio organizzato 2001 (scritto con Paolo Rossi, Riccardo Piferi, Stefano Benni); Stasera si recita Moliere (scritto con Paolo Rossi); Storie per un delirio organizzato 2002 (scritto con Paolo Rossi, Riccardo Piferi, Stefano Benni); Il signor Rossi e la Costituzione (scritto con Paolo Rossi).

