L'editoriale
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and1
Le notizie
del numero 52
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and2
Alle frontiere digitali del teatro, alle frontiere teatrali delle nuove tecnologie
Antonio Pizzo, Teatro e mondo digitale. Attori, scena e pubblico, Venezia, Marsilio, 2003
di Anna Maria Monteverdi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and19
Teatro delle interfacce
Ovvero la tecnica come questione d'arte
di Frank Bauchard
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and20
Una piattaforma di lavoro su teatro e nuove tecnologie
Presentazione del progetto CRÉATION NUMÉRIQUE, LES NOUVELLES ÉCRITURES SCÉNIQUES
di Emanuele Quinz
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and21
E' nato prima il video game o la fiaba?
DG Hamelin.com, spettacolo per ragazzi di Renzo Boldrini e Giacomo Verde
di Anna Maria Monteverdi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and22
AHA: ACTIVISM-HACKING-ARTIVISM
Un progetto di arte transmediale e comunitaria
di Tatiana Bazzichelli
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and23
L'altro teatro
La memoria del teatro nei video di Nico Garrone
di Giacomo Verde
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and24
Esperienze artificiali multisensoriali
Recensione a Oliver Grau, Virtual Art. From illusion to immersion, MIT Press, 2003
di Anna Maria Monteverdi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and25
Quanto osa lo sperimentale?
Bruno di Marino, Interferenze dello sguardo. La sperimentazione audiovisiva tra analogico e digitale, Bulzoni, Roma, 2002.
di Simonetta Cargioli
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and26
Alcune considerazioni sul teatro in rete
Un intervento che "Primafila" non ha voluto pubblicare
di Maia Borrelli
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and30
E se Il grande fratello fosse nostro cugino?
Alcune provocatorie tesi teatro e nuove tecnologie
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and31
Ancora sul teatro politico
Un intervento per "Hystrio"
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and60
Per un teatro politico?
dal "Patalogo 19"
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and61
Che cosa è successo a Roma?
L'incontro tra stabili di innovazione e gruppi al Teatro Vascello
di Marco Cavalcoli
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and70
Un'antologica dei Marcido
Una nota
di Marco Isidori
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and60
Gli indescrivibili spettacoli di Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa
descritti (sul "manifesto") nel corso del tempo
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and72
Speciale tnm (ma non solo)
L'editoriale
di Redazione ateatro
ateatro continua, se non altro, a resistere, resistere, resistere.
L’archivio cresce, mese dopo mese, aumentano le visite e arrivano numerose le segnalazioni (e gli incoraggiamenti) di chi usa il sito per informazione, studio, ricerca. La locandina sta iniziando a funzionare. I forum sono tra le sezioni più visitate, anche se il dibattito langue. Forse neppure chi frequenta ateatro ha capito davvero che un sito è una realtà interattiva, che inserire informazioni, opinioni, riflessioni, è davvero facile e immediato. Tuttavia la ragione di questa «fredddezza» ci pare più profonda. E’ come se avessimo esaurito le nostre risorse di indignazione, provocazione e progettualità. E’ un segnale preoccupante, anche perché lo scenario circostante non è dei più esaltanti: le programmazioni riducono i rischi al minimo, le rassegne continuano a chiudere, le risorse a diminuire, l’ETI pare ricaduto in tutti i suoi antichi vizi.. Ma le reazioni sono minime (le mobilitazioni dello scorso anni, da Roma a Castiglioncello) paiono aver fatto la fine dei girotondi: fiammate di indignazione e visibilità che non riescono a tradursi in azione e in una politica culturale di ampio respiro.
Ciò nonostante, "ateatro" non si accontenta di resistere: continua anche a rilanciare il suo progetto.
In questo ateatro 52, il merito è soprattutto di Anna Maria Monteverdi, che ha costruito un impressionante speciale dedicato a "teatro e nuovi media". Come sapete tnm è da sempre una delle sezioni portanti di questa webzine: non potrebbe essere altrimenti, visto il media che usiamo. Quindi trovate materiali sull’argomento in (quasi) tutti i numeri di ateatro, e ci sono già stati diversi speciali tnm (in particolare in ateatro 38 e in ateatro 13, a partire dal dibattito innescato nel numero precedente. Ma ricordiamo anche in ateatro 50 e in ateatro 47 gli articoli sulle street tv e sul webcam theatre.
L'idea di fare un nuovo speciale tnm è nata dal recente moltiplicarsi di iniziative, spettacoli, pubblicazioni (e polemiche..) relativi alle performance tecnologiche. tnm ha selezionato eventi, siti, festival, libri sul mondo dell'interattività e del video, e ha chiesto ad artisti e studiosi recensioni, riflessioni e opinioni sull’intreccio tra il mondo della tecnologa e quello performativo, per cercare di capire quale possa essere la direzione più proficua e interessante per la ricerca e sperimentazione teatrale: non riteniamo che il digital theatre sia un fenomeno passeggero, ma la nuova condizione della scena contemporanea ricca di implicazioni e spunti politici ed etico-estetici.
Come si può notare, in questo speciale gli argomenti vanno oltre e al di là del teatro come ormai tradizione di tnm.
Consideriamo la prospettiva dell'Hacker art e dell'artivism divulgata da Tatiana Bazzichelli un esempio imprescindibile per capire come l'arte, il digitale e la rete possano produrre opere e azioni (oper'azioni) ricche di senso e ad alto gradiente di connettività, un'ipotesi di percorso interessante in vista anche di sperimentazioni di web theatre, così come abbiamo deciso di dare spazio a quelle attività di divulgazione della realtà virtuale che stanno sempre di più entrando di diritto nelle opere, installazioni e performance.
Non potevamo iniziare che con Antonio Pizzo, autore di Teatro e mondo digitale. Per chi frequenta il web, Pizzo è conosciuto per un saggio on line Verso l'attore artificiale che puntualizzava storicizzandole le definizioni di attore-macchina alla luce dell’evoluzione tecnica (da Craig ai Futuristi, da Kantor a Rem e Cap) e digitale (Eliza creata nel 1966, primo esempio di «vita artificiale»). In questo libro fa invece il punto delle esperienze di digital performance a livello internazionale, suddividendole in virtual reality theatre e Internet theatre.
Ancora: Virtual art di Oliver Grau, MIT Press. Le edizioni del MIT stanno rendendo accessibile ad un pubblico sempre più vasto, il fenomeno della computer art e della virtual art attraverso pubblicazioni divulgative che offrono uno sguardo storico e precedenti illustri dei vari temi riguardanti il digitale, per esempio quello dell'immersione (le prospettive antiche, le macchine ottiche). Come già emergeva dal volume Multimedia di R. Packer e Ken Jordan (recensito in ateatro 42), l'arte multimediale sta entrando nella storia dell'arte dalla porta principale, quella della tradizione.
Simonetta Cargioli recensisce il libro di Bruno di Marino Interferenze dello sguardo. E' una antica passione quella di di Marino per il cinema sperimentale e quello underground americano ovvero il pre-video. Con la lettura di opere ormai storiche di registi come Maya Deren, Stan Brakage, Jonas Mekas, Interferenze dello sguardo è un libro da collocare nella nostra biblioteca personale a fianco di Occhio mio Dio di Alfredo Leonardi e Il cinema di Andy Warhol di Adriano Aprà. Forse non tutti sanno che a di Marino si deve la più importante retrospettiva italiana dedicata alla videoarte italiana (e relativo catalogo) in cui una sezione significativa era dedicata proprio al videoteatro (Elettroshock, vent'anni di videoarte).
Ancora, Giacomo Verde ci parla dell'attività videodocumentaristica teatrale di Nico Garrone a partire dalle giornate di studio all'Accademia di Macerata per l'insegnamento di Video e teatro; Emanuele Quinz da Parigi ci informa sul progetto di convegno internazionale per l'autunno 2003 a Parigi mentre la sua associazione Anomos (che ha pubblicato l'antologia critica Digital performance) ci concede l'importante saggio di Frank Bauchard Il teatro delle interfacce (traduzione di Erica Magris realizzata appositamente per ateatro); Tatiana Bazzichelli ci parla della sua frenetica attività (e la newsletter da lei creata) sul tema Artivism Hacker art, activism: rimandiamo alla mostra Kairòs, la virtualità dell’arte e la realtà delle immagini a San Benedetto del Tronto dove il 18 maggio verrà inaugurata proprio una sezione speciale AHA.
Come spettacolo abbiamo scelto Dg Hamelin.com di Verde-Boldrini ovvero "l'hacker spiegato ai bambini" con una animazione in Flash 6 dello spettacolo.
Maia Borelli infine rilancia su ateatro il tema "teatro e virtuale" in un articolo rifiutato da "Prima fila" a quanto pare perché l'autrice non parlava di spectacle vivant.
Non è finita, per il prossimo ateatro-tnm abbiamo in preparazioni molti nuovi materiali! Ma anche su questo aspettiamo da voi indicazioni, suggerimenti e consigli. Intanto grazie agli amici che hanno risposto all'appello per lo speciale tnm dall'Italia e dalla Francia. Very very special thanks to Erica Magris e un ringraziamento sincero anche a Pericle Salvini per aver messo a disposizione la sua importante ricerca di tesi su Teatro e tecnologia attualmente inedita (ci auguriamo ancora per poco) discussa presso l'Università di Pisa ed incentrata sulle esperienze di Vr theatre e Internet theatre e relativa saggistica. La sua lettura (e la brillante bibliografia critica selezionata) ci ha suggerito non pochi spunti per questo speciale tnm.
Ma ateatro 52 non è solo tnm: torna anche uno dei tormentoni della webzine, il teatro politico, in concomitanza con il numero che la rivista "hystrio" dedica al tema; e, in occasione della personale del gruppo a Torino, c’è un ingrandimento su Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa, una delle compagnie teatrali italiane più coerenti e interessanti.
E a tutti bon spectacle (digitale & no)!
Le notizie
del numero 52
di Redazione ateatro
IL PREMIO GRINZANE CAVOUR ALLA FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO
(15-19 maggio 2003 -Torino, Lingotto Fiere)
Il Premio Grinzane Cavour proporrà, inoltre, tre eventi speciali: Lettura Scenica del testo francese del radiodramma Fièvre di Marie-Clais Blais, Concerto Diario Mali di Ludovico Einaudi e la Mise en espace della traduzione italiana della pièce Il ventriloquo di Larry Tremblay.
Venerdì 16 maggio Ore 17,30 - Stand dell'Ambasciata del Canada
Les Italies imaginaires des Québécois: incontro sull'immaginario dell'Italia in Canada e del Canada in Italia
Tavola Rotonda
Intervengono Micheline Cambron (direttrice del CETUQ e della collana FID), Carla Fratta, Giovanni Dotoli, Anna Paola Mossetto, Sébastien Ruffo, Giuliano Soria
Ore 18,30 - Sala Blu
Fièvre
Lettura scenica del testo francese del radiodramma di Marie-Claire Blais
A cura del Laboratoire de Théâtre della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Torino
Ore 21 - Sala Azzurra
Diario Mali
Concerto di Ludovico Einaudi
Domenica 18 maggio Ore 21 - Sala Blu
Il ventriloquo
Mise en espace della traduzione italiana della pièce di Larry Tremblaycon Ettore Lalli,
regia di Guido Ruffa
presentazione di Anna Paola Mossetto con la partecipazione dell'autore
Il ventriloquo di Larry Tremblay in traduzione italiana
E' appena stata pubblicata la traduzione del breve testo drammaturgico del québécois Larry Tremblay Il ventriloquo per la casa editrice L'Harmattan, collana Drammaturgie francofone/testi (www.editions-harmattan.fr). La traduzione è a cura di Anna Paola Mossetto, docente della facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Torino e che coordina anche l'ERTEF l'Equipe di ricerca sui teatri francofoni extraeuropei. L'Ertef coniuga gli interessi di un gruppo di studiose per l'analisi comparata e la diffusione in Italia delle opere drammaturgiche di lingua francese d'Africa, America, Asia e Oriente.
"Nulla di più teatrale di un ventriloquo che finge contemporaneamente il proprio silenzio e la voce altrui. Ma quando questo maestro della duplicità viene preso nella vertigine della sua stessa messa in scena, tutto può accadere. La sorpresa, la metamorfosi diventano la regola di un gioco estremo, funambolesco e quotidiano al contempo, dove i personaggi familiari si rivelano mostri divoranti e gli affetti e le cure paiono strumenti di spaventosa tortura. A farne le spese è il pupazzo-adolescente Gaby, sorella di Pinocchio e di Alice ma anche del suo stesso creatore e manipolatore, sia esso il ventriloquo oppure lo psicanalista o più genericamente l'essere umano condannato alla perenne ricerca ora di regole ora di trasgressioni per sopportare la vita.
In quest'opera di vero teatro, una festa di compleanno, una riunione di famiglia, un rapporto fraterno, una vocazione letteraria precoce, sono altrettante occasioni per far esplodere le convenzioni in mille fuochi di artificio verbale e scenico.
L'opera conferma la vocazione di Larry Tremblay per un teatro di parola evocatrice e provocatoria, ludica e feroce, capace di essere racconto e fantasmagoria, di creare atmosfere e sovvertire ruoli, drammatizzando e sdrammatizzando a piacere, con ogni tipo di registro espressivo, tanto i tic della società contemporanea quanto le nevrosi dell'uomo universale."
(Anna Paola Mossetto)
Larry Tremblay, nato a Chicoutimi, nella provincia canadese del Québec, appartiene totalmente al mondo del teatro in qualità di drammaturgo, attore, regista, professore di recitazione all'école supérieure de Théatre de l'Univeristé du QUébec a Montréal, specialista di kathakali. Come drammaturgo ha scritto più di una decina di opere -molte delle quali tradotte e rappresentate in vari paesi -fra cui: Le declin du destin; Leçon d'anatomie, Les mains blues. E' inoltre l'autore di un romanzo: Le mangeur de bicyclette, Le ventriloque. Le ventriloque è stato rappresentato nel 2001 a Montréal, a Parigi e a Bruxelles; nel 2003 ha vinto a Montréal il premio Le masque per la miglior realizzazione scenica.
Per un maggior approfondimento sul teatro contemporaneo del Québec -drammaturgia e regia-: Le théatre québécois 1975-1995 a cura di Dominique Lafon, Montréal, ed. Fides, 2001; ed inoltre Il teatro del Québec, Milano, Ubulibri, 1994 -contiene la traduzione de Le cognate di M. Tremblay, Le muse orfane di Michel Marc Bouchard, Frammenti di una lettera d'addio letti dai geologi di Normand Chaurette).
Que reste-t-il du corps virtuel : entre rhétorique et utopie, la corporéité de la cyberculture des années 1990s
avec Michel MAFFESOLI (Paris V), Philippe QUEAU (Unesco), Antonio CASILLI (Cetsah), Stéphane HUGON (Ceaq)
L'Espace Paul Ricard et le Centre de Recherche sur l'Imaginaire organisent une table ronde sur le thème
Les Rendez-Vous de l'Imaginaire de Paris
Jeudi 15 mai - 18h30, Espace Paul Ricard, Galerie Royale, 9, rue Royale, 75 008 PARIS, (M° Concorde)
"A la fin du 20ème siècle, artistes, journalistes, chercheurs et usageurs des nouvelles technologies ont donné une impulsion à l'imaginaire d'un nouvel idéal de corps. Un corps-avatar désincarné, jouissif, branché, perpétuellement améliorable, habitant un cyberespace paradisiaque, lieu de sociabilité harmonieuse.
Le bref été de la cyberculture s'est peut-être terminé avec le crack boursier du janvier 2001, et plus encore avec le brusque réveil du 11 septembre de la même année.
Mais que reste-t-il de l'utopie de la régénérescence corporelle issue des nouvelles technologies? S'agissait-il d'une mode passagère ou bien d'un nouveau paradigme de la forme humaine?"
Generazioni in metamorfosi
Festival di ricerca e di studio sulla mutazione dell’eresia, del sacro e del magico nelle generazioni del nuovo millennio
direzione artistica Alessandro Garzella
Teatro Politeama Cascina (Pi)
progetto a cura di Claudia Zeppi
PROGRAMMA
5 6 7 giugno 17.00
Sipario Toscana fondazione
Crazy Shakespeare
ideazione Fabrizio Cassanelli e Alessandro Garzella
5 6 7 giugno 18.00
Sipario Toscana fondazione
Fool Lear
di Ciro Lenti - ideazione e regia Alessandro Garzella
5 6 7 giugno 19.30
Sipario Toscana fondazione
Preghiera bastarda
ideazione e ricerca Alessandro Garzella e Letizia Pardi
5 giugno 21.30
Ferdydurke - AGON
Vendutissimi asta d’anime in tv
testo e regia di Renato Gabrielli
5 6 - 7 giugno 23.00
Compagnia Katzenmacher
Affronti
ideazione e regia Alfonso Santagata
6 giugno ore 19.30
7 giugno ore 21.30
Conservas
7 Dust non lavoreremo mai show
ideazione Simona Levi - regia Simona Levi con la collaborazione di Dominique Grandmougin
6 giugno 21.30
Xear.org
oVMMO ovidiometamorphoseon
di Giacomo Verde, Marco Sodini, Massimo Magrini, Mauro Lupone Alessandra Giuntoni
7 giugno 21.30
Compagnia Pippo Delbono
La Rabbia
ideazione e regia Pippo Delbono
7 giugno 24.00
Dinamitri Jazz Folklore
Anteprima nazionale del cd Folklore in Black
Happening ad ingresso libero
Per tutta la durata di Metamorfosi negli spazi del teatro
FOTOMOBILE
Foto, video, installazioni…
di Andrea Bastogi
Informazioni e prenotazioni agli spettacoli:
Sipario Toscana fondazione & Teatro Politeama, Via Toscoromagnola 656, Cascina 56021, Pisa - Italy
Tel. 0039.050.744400 fax 0039.050.744233
Le novità di maggio su www.dramma.it
Il dramma del mese è Tango di Francesca Zanni, il testo sui figli dei desaparecidos argentini che ha debuttato sulla scena nel 2000, è stato trasmesso dalla Rai per "Palcoscenico" nel 2002, ed è stato ripreso ad aprile con la regia dell'autrice ed interpretato da Crescenza Guarnieri e Rolando Ravello, con le musiche originali di Daniele Silvestri. Lo spettacolo ha ottenuto i Patrocini di Amnesty International, delle Abuelas de Plaza de Mayo e di Ponte della Memoria. Un progetto Teatroinascolto® prodotto da La Casa dei Racconti e la Contemporanea ‘83.
Per il sito del mese presentiamo le pagine web del Teatro OutOff di Milano, ricco di materiale multimediale sugli spettacoli della stagione e delle stagioni passate.
Da qualche settimana il forum è diventato piuttosto animato e alcune delle discussioni in corso sono piuttosto stimolanti. Vi segnalo in particolare una stanza dove si discute di Bandi e Premi ed un'altra, chiamata Il nostro concorso, dove gli utenti stanno scambiandosi pareri e idee per mettere su un nuovo concorso internauta.
Sulla base di questi due temi nati nel forum è pensato anche il nuovo sondaggio che attende il vostro contributo per mettere le basi ad una nuova, originale iniziativa nel panorama dei concorsi teatrali.
Vi schiaffo di nuovo qui la copertina del libro in cui sono raccolti i miei ultimi due testi (rispettivamente Premio Rosso di San Secondo 2001 e Secondo Premio Fondi La Pastora 2002) con la prefazione di Giuseppe Manfridi. Potete ordinare il libro on line a soli € 6,50 senza spese postali e riceverete la copia con dedica personale.
Nella sezione Drammaturgie, nuove recensioni ed articoli.
Scaricabili dalla home page i bandi di prossima scadenza (maggio) e cliccando qui troverete i bandi validi in scadenza nei prossimi mesi.
Tanti nuovi copioni nella libreria virtuale, ecco gli ultimi arrivi.
Vi segnalo inoltre la nuova rivista on line Matità sulla drammaturgia a cura di Manifatturae raggiungibile dal logo cliccabile sulla home page.
E poi non dimenticare i comunicati stampa, i link a centinaia di siti teatrali, scrivi una scena del
nuovo copione interattivo, le segnalazioni per il dizionario dei drammaturghi del 900, i cartelloni dei teatri, le scuole di scrittura teatrale.
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
Alle frontiere digitali del teatro, alle frontiere teatrali delle nuove tecnologie
Antonio Pizzo, Teatro e mondo digitale. Attori, scena e pubblico, Venezia, Marsilio, 2003
di Anna Maria Monteverdi

Antonio Pizzo è una delle più autorevoli voci della critica teatrale italiana relativa al multimediale digitale. Il suo libro appena uscito per Marsilio, fa ordine tra le esperienze internazionali rispettivamente di digital performance (che include anche il Virtual Reality Theatre) e di web theatre. Non rientrano invece nel campo d'indagine del volume le esperienze di trascrizione o documentazione del teatro in supporti digitali e/o on line con funzioni archivistiche o di memoria (ma possiamo già immaginare gli scenari di un rivoluzionario e futuribile dvd theatre, laddove la riscrittura dell'evento teatrale possa essere definitivamente liberata e dalla schiavitù di asservire alle logiche produttive e di palinsesto della televisione, e dalla necessità di restituzione integrale del "documento").
Con una necessaria premessa teorico-estetica sull'evoluzione della tecnica in linguaggio, vero punto nodale della questione, Pizzo ricorda i caratteri propri del multimediale digitale (per distinguerlo dallo "stile multimediale pre-tecnologico", spesso usato per definire l'uso di più media delle avanguardie artistiche nella pittura, nella musica, nel cinema, nel teatro dal Primo Novecento): immersione, interattività e trasformazione e cerca di verificare come tali possibilità possano estendersi o essere condivise anche dalla pratica teatrale. La nozione di environment, di performance, di event, accomunerebbe spettacolo live e digital multimedia (anzi, il teatro servirebbe proprio da modello per la rappresentazione uomo-computer, come affermavano Brenda Laurel in Computer as Theatre e Janet Murray in Hamlet on the Holodeck). Così come ogni spettacolo si dà nel qui e ora, nella sua evenemenzialità impossibile da reificare, nell'attualizzazione di un testo che non esiste se non nell'insieme di relazioni (individuali-spaziali-temporali) della scena, anche il digitale vive in un tempo percepito come presente, come generarsi di processi (un tempo fatto cioè "non più di eventi, come il tempo televisivo, ma di infinite virtualità", come ricorda Edmond Couchot), nella interazione tra macchina e agente attraverso interfacce, e nella sua "generazione senza referenzialità", poiché non traduce né rinvia ad alcuna realtà preesistente, al punto che Pizzo definisce la loro contaminazione un "delicato e sfumato attrarsi tra simili". Secondo tale approccio teorico sarà proprio la presenza del digitale in scena (e non genericamente dell'audiovisivo che appartiene all'era della "riproducibilità") ad "aumentare" (enhanced theatre è una delle definizioni del teatro digitale) il senso di presenza e di liveness del teatro. I termini della questione posti in essere da Walter Benjamin vanno così ridefiniti a partire non più dalla perdita dell'aura dell'opera in una prospettiva digitale e virtuale dell'arte, ma di un'acquisizione di datità reale, come ricordava Pierre Lévy. Perché il virtuale crea, come afferma Philippe Quéau, una nuova età del reale: "Ce n'est pas dans l'isolement ni dans le caractère étanche qu'il faut viser le fonctionnement de ces deux réels mais bien plutot dans leurs aller-retour réciproque" (P.Queau, Le frontières du virtuel et du réel, in L.Poissant (a cura di), Esthétique des arts médiatiques (vol.1), Presses de l'Université du Québec).
Del resto chi pratica e frequenta il web, le mailing list, le newsgroup, ne conosce il potere comunitario, sociale e aggregativo, e sa quanto di concretamente presente e materiale (e caldo) ci possa essere in una comunicazione telematica non più unidirezionale come quella della vecchia televisione. Le tecnologie oggi ci insegnano che ottimisticamente e ideologicamente la via della trasformazione (rivoluzione?) corre sul filo di un modem. Chi non crede oggi nelle tecnologie a teatro non crede nelle possibilità del teatro di agire sulla realtà: "Il tempo reale è il tempo politico" ricordava Paul Virilio in Dromologia.
Ricordando inoltre il debito nei confronti della Nuova Spettacolarità e in generale dello storico teatro-immagine per quanto riguarda la nozione di scrittura scenica e della messa in crisi del concetto di rappresentazione, Pizzo parla di questo teatro che nella sua evoluzione multimediale ne assorbirebbe (o amplificherebbe) il carattere di interattività (che equivale a una volontà di verifica soggettiva e diretta da parte del pubblico), di perdita dell'autoralità registica (spostandosi l'opera sempre più verso una diversificazione e personalizzazione di esperienza). Così alla luce del digitale, sottolinea Pizzo, il teatro è solo uno dei possibili luoghi dello spettacolo: la navigazione nel mare di immagini 3 D (o di un ipertesto, o della rete) ha infatti un carattere e una modalità altamente performative ed interattive.
Nonostante queste premesse teoriche che sembrerebbero aprire scenari entusiastici per un nuovo teatro, in realtà ci rendiamo conto che le esperienze di Digital Theatre finora rese pubbliche non hanno poi quel carattere così rivoluzionario che ci aspetteremmo (o comunque si tratta di esperienze alla "preistoria del genere" o ancora in corso di elaborazione). Sull'argomento Pizzo riporta alcuni esempi storici relativi alle ricerche di Mark Reaney, vero pionere del virtual theatre sin dal 1987 ed entra nel merito dell'uso dell'applicativo per Vr Walkthrough Pro usato da Reaney in un primo tempo per simulare (e dunque perfezionare) in scala reale tridimensionale la scenografia progettata, e in seguito per trasportare tali ambienti direttamente sulla scena. Storico e spesso citato esempio di scena virtuale è The adding machine (1995) di Mark Reaney e Ron Willis dell'Università del Kansas di cui Pizzo dà dettagliata ricostruzione drammaturgica (da Rice), scenica e tecnica (l'uso del Virtual Enviroment Driver che interagiva con gli attori); ancora Play (da Beckett) di Lance Gharavi (assistente di Reaney), con i personaggi diventati figure in 3 D nell'ambiente virtuale con il pubblico che indossava gli Head Mounted Display (detti anche Virtual eyes); infine Tesla Electric. Le esperienze italiane citate da Pizzo sono limitate al Tpo di Prato di Davide Venturini (in particolare lo spettacolo per ragazzi Storie Zip) e a Zonegemma (Storie mandaliche, spettacolo ancora in progress con Giacomo Verde come tecnoartista e narratore). Zonegemma con Storie mandaliche ha messo in atto sin dalla fine del 1998 una vera drammaturgia ipertestuale (ipertesti di Andrea Balzola) grazie al Mandala System e successivamente al sistema Flash, e una narrazione che tiene conto della ramificazione labirintica e dell'ipertesto e della figura del Mandala come segno grafico e come simbolo della trasformazione interiore dell'individuo. Le tecnologie digitali generate dal computer ma rigenerate sul momento dal cyber-contastorie Giacomo Verde, evidenziano questa similitudine (e unità di fondo) tra mondo tecnologico e mondo organico, disegnando i contorni di un nuovo tecno-umanesimo.
La seconda sezione del libro riguarda rispettivamente il teatro attraverso Internet e in generale le performance on line a partire anche dalle riflessioni di Monika Wunderer, che aveva pubblicato nell'importantissima antologia di Peter Schrum Theatre in the cyberspace (edizioni Peter Lang) il testo Presence in front of the fourth wall of cyberspace; di Web theatre sono citati alcuni esempi: The renaissance man di Matthew Saunders, Internet e frammenti (Maurizio Vandinelli), Connessioni remote di Giacomo Verde e Anatomia della morte di... (Marcello Cotugno). Con performance on line l'autore invece intende l'uso di tecnologie MOO o MUD (giochi di ruolo o chat gestiti da utenti collegati in una rete telnet o irc). Lo stesso autore ammette laconicamente alla fine del libro di quanto siano, allo stato attuale dell'arte, "precari e discontinui" i tentativi e i risultati di questa ricerca teatrale "affascinante per la complessità e l'articolazione dei problemi" ma in cui "è più evidente l'assenza di unità d'intenti e di proposte, dove la pratica, al di là delle difficoltà tecniche, appare inadeguata alla risoluzione di questioni di ordine estetico e filosofico, comunicativo e sociologico". Spetta allora agli osservatori attenti e creativi del mondo reale e delle tecnologie transmediali, ai frequentatori della rete, di siti web e mailing list dedicate, offrire spunti per un nuovo teatro, attivo e tecnocreativo, che attinga nuova forza eversiva e rivoluzionaria scenica e contenutistica, dalla infinita rete senza centro e dalla sua filosofia.
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
Teatro delle interfacce
Ovvero la tecnica come questione d'arte
di Frank Bauchard
Questo testo è stato pubblicato originariamente su "anomalie n.2 digital performance"; manythanks a ANomos che ci ha concesso di pubblicarlo e a Erica Magris che l'ha tradotto.
La tecnica è una questione d'arte.
Chi si interessa alle relazioni fra il teatro e le nuove tecnologie dovrebbe meditare su questa considerazione di Piscator: la tecnica è una questione di arte. Come se, una volta posta, la questione della tecnica a teatro subisse uno spostamento ed una trasformazione. In realtà essa non si mette a vibrare se non in questo allontanamento dal centro, nell'oscillazione continua tra i due poli di una riflessione più ampia. Si intensifica tanto più si snoda legandosi a concezioni estetiche, drammaturgiche e sceniche. Se la questione delle nuove tecnologie ci interessa è perché rilancia e riapre dei dibattici estetici che si estendono dalla drammaturgia alla concezione della recitazione, dalla scenografia all'architettura teatrale. L'idea dell'autonomia della tecnica è la posizione implicita e alla fine condivisa - come se si trattasse di sostituire un pregiudizio con un altro – da un lato degli artisti che riciclano idee consunte in nuovi dispositivi, dall’altro di quelli che rifiutano di mettere la loro prassi alla prova degli avvenimenti, dei mutamenti del pensiero e della sensibilità collettiva, in un'epoca che pone il teatro in pericolo e che lo costringe a dare continuamente dimostrazione del proprio potere.
Utopia e storia
La costruzione di scene generate e controllate dal computer è un fatto senza precedenti. Queste configurazioni sceniche, però, non sono delle creazioni ex-nihilo. Coscientemente o no, esse si riallacciano a delle esplorazioni o a delle preoccupazioni anteriori degli uomini di teatro. Richiamano, risvegliano, riattivano le radici sotterranee di un altro presente del teatro, a cui attribuiscono delle nuove possibilità. Non si tratta tanto di ricreare delle artificiose filiazioni, quanto di stabilire delle risonanze - non esclusive, ma a volte ignorate - fra le ricerche più contemporanee e alcune esperienze precedenti.
Kiesler
Kiesler si è in primo luogo fatto conoscere per la sua messa in scena del dramma di Kapec Rossum Universal Robot (1923), in cui trasponeva su un piano estetico i segni e i simboli della tecnica delle sua epoca. Architetto, egli si è sempre interessato al teatro in quanto luogo in cui si esercita il proprio sguardo, in cui si mettono in gioco dei punti di vista, in cui si interroga il visibile; egli soleva dire: " la scena ha le sue proprie leggi, non è data in subaffitto ai fabbricanti di libri ". E queste sue leggi dipendono innanzitutto da una scienza della visione. In tal modo, egli rompe molto presto con la "scena-quadro", che fissa lo spettacolo nella scatola ottica, per concepire delle "scene-spazi", cioè dei dispositivi scenici intorno ai quali lo spettatore può muoversi, scegliendo così i propri angoli di visione. Per questo architetto visionario,che alla fine è riuscito a costruire ben poco, il teatro era associato alla libertà tecnica. Nel suo ambito era possibile realizzare ciò che non era mai stato fatto o ciò che era ormai scomparso. Il teatro era un laboratorio di prova dove si potevano sperimentare delle visioni totali del mondo.
Robert Edmond Jones
Teorico, scenografo e regista, Jones auspicava un teatro che rendesse conto della propria epoca. Di ritorno negli Stati Uniti dopo un lungo soggiorno presso alcuni grandi uomini di teatro d'Europa, come Max Reinhardt, egli riferisce della sua esperienza in un'opera - Continental Stagecraft - decisiva per la ricezione americana del teatro europeo.
Il teatro americano del suo tempo gli appariva - sembrava - pareva out of date. Attento al cinema, alla psicanalisi, alle nuove scritture e alla loro resa del flusso di coscienza, egli pensava che il teatro dovesse interrogare le relazioni fra la vita quotidiana e la vita interiore. "pensiamo con delle immagini, come se avessimo un minuscolo schermo cinematografico nel cervello", osservava Jones, come se ogni invenzione tecnica debba produrre un modello descrittivo della realtà. Nella sua concezione, la commistione di tecniche teatrali e cinematografiche doveva collaborare alla creazione di uno spazio sintetico. Il teatro del futuro doveva combinare a two way drama con a two way stage, che permettessero di restituire in maniera simultanea la vita interiore (emozioni, pensieri) dei personaggi ed il loro comportamento sulla scena. Alla stesso modo in cui la nuova scena da lui invocata faceva appello all’invenzione di nuove scritture drammatiche, il funzionamento dello spirito umano doveva richiedeva delle nuove architetture della percezione.
Poliéri
Se il teatro è il luogo da cui si guarda, un dispositivo di visione quindi, esso dipende da una diottrica, da leggi visive, ottiche, fisiche e matematiche. Nessuno più di Poliéri ha portato così avanti le esigenze speculative della scenografia. Egli scrive: " la scenografia comporta due poli teorici, uno estetico, l'altro fisico, che contribuiscono entrambi alla messa a punto di una vera e propria scienza delle apparenze", operando un recupero dell'arte e della scienza della prospettiva del Rinascimento attraverso l'appropriazione delle tecniche del XX secolo.
Per il momento isoleremo due linee di riflessione nell'opera, enorme ed impegnativa di Poliéri: la prima, è la messa in evidenza del fatto che ogni tecnica crea e plasma il suo proprio spettacolo. Allo stesso modo in cui il cinema ha a suo tempo fatto nascere il cinerama, il cinema sferico, il cinema su schermi multipli… la tecnologia digitale dovrebbe dare luogo a nuove forme di scenografia. Egli sarà allora il primo a concepire delle vere e proprie scenografie elettroniche, in cui si combinano proiezione elettronica su grande schermo, elaborazione in tempo reale dell'immagine e trasmissione a distanza.
La seconda linea di riflessione prende come punto di partenza la sua opera Scénographie, che, sebbene si presenti come una storia della scenografia dalle origini agli anni '60, non è un libro da storico del teatro. Si tratta piuttosto del poema archeologico di un artista archivista inamorato della precisione, che mette in evidenza delle risonanze, degli scambi, delle logiche di circolazione, di trasposizione, d'integrazione fra le tecniche che concorrono alla definizione di dispositivo di visione e che dipendono da ambiti artistici distinti. Questo approccio a prima vista diacronico ci introduce ugualmente ad un sguardo sincronico sui dispositivi di visione che coesistono in un epoca data, e fra i quali esiste un rapporto al tempo stesso di contemporaneità e di permeabilità.
Eppure all'interno di questa storia il teatro resta una matrice e un laboratorio ineguagliato, per la sua capacità di integrare, sovrapporre, ibridare e interrogare l'insieme dei dispositivi di visione che attraversano una società ad un epoca data. Ma ciò presuppone che il teatro sia un dispositivo di visione a sua volta articolato con l'insieme dei dispositivi di visione, che, in un determinato momento, partecipano alla conquista del mondo attraverso la rappresentazione.
Svoboda e l’avanguardia ceca
Il percorso artistico di Svoboda, in primo luogo scenografo, benché realizzatore di qualche regia, si inscrive nel campo di idee dell'avanguardia ceca, le cui basi teoriche sono state elaborate dagli strutturalisti del circolo di Praga.
Per Jindrich Honzl, regista e teorico, il teatro è un'arte composita, che combina innumerevoli arti e tecniche. Nessun elemento che contribuisce al teatro può essere isolato dal contesto ed essere considerato il cuore del teatro stesso, che si tratti ad esempio del testo o dell'attore. Lo svolgimento dello spettacolo poggia infatti sull'azione dei suoi diversi elementi. Il teatro consiste quindi nel mettere in relazione le differenti componenti che prendono parte all'azione. Nello stesso tempo, tutte le componenti si trasformano secondo le leggi dell'arte drammatica, che dà il segno delle cose al posto delle cose stesse.
Per Svoboda, il teatro offre uno spazio psico-plastico retto da leggi teatrali, non da leggi visive. Il teatro è soprattutto il luogo dell'azione, e non un dispositivo di visione. Denis Bablet, nella sua opera su Svoboda, opporrà la "nozione dinamica di spazio di messa in scena, che nasce dalla realtà concreta dell'opera drammatica" di quest’ultimo alla concezione di Poliéri, in cui "lo sconvolgimento dello spazio, il rinnovamento delle tecniche, lo spettacolo totale, divengono il loro stesso fine".
O l'uno o l'altro?
Nello specchio della storia, vediamo vacillare ogni concezione limitata o chiusa del teatro. La rappresentazione teatrale non si articola più intorno al testo e all'attore: l'azione e la visione divengono i due poli intorno ai quali ruotano le concezioni di teatro più aperte.
Attraverso questo percorso possiamo distinguere due grandi approcci al teatro e più ampiamente alla scena: l'uno considera il teatro innanzitutto come il luogo dell'azione, l'altro soprattutto come un dispositivo di visione. Jones e l'avanguardia ceca da un lato, Kiesler e Poléri dall'altro, hanno attualizzato queste concezioni in funzione dell'evoluzione delle arti e delle tecniche della loro epoca.
Il teatro come azione
La considerazione del teatro come luogo dell'azione implica una determinata concezione della scena. Se, come afferma Honzl nel suo testo maggiore - La mobilité du signe théâtral - "una manifestazione teatrale è un insieme semico", allo stesso modo la scena non si concretizza che attraverso un insieme di segni: "non è per nulla la sua disposizione architettonica ad accordarle lo statuto di scena, ma il fatto che essa rappresenta l'azione drammatica". Quindi la scena è virtualmente dappertutto, a condizione di suggerirla attraverso dei segni. Lo stesso ragionamento è applicato all'attore. Questi non è per forza un uomo, può manifestarsi attraverso una marionetta, un oggetto o un raggio di luce. Come un attore non è un uomo, così una scena non è uno spazio architettonico.
Questa concezione, non solo emancipa il teatro da una gerarchia dei suoi elementi costitutivi, ma lo libera anche dall'influsso di una metafisica dualista fondata sulle articolazione fra la voce e il senso, il Verbo e il corpo, i contenuti e i supporti.
Il teatro può allora aprirsi a nuove intensità e nuove modalità di composizione: "l'azione - essenza stessa dell'arte drammatica - fa fondere la parola, l'attore, il costume, la scenografia e la musica, nel senso in cui li riconosciamo come conduttori di un'unica energia, che li attraversa passando dall'uno all'altro o più contemporaneamente. Noi avanzeremo nel paragone aggiungendo che questa corrente (l'azione drammatica) non passa attraverso il conduttore a resistenza più bassa (l'azione drammatica non è perpetuamente concentrata nella recitazione dell'attore), ma che spesso il fenomeno teatrale nasce per l'appunto nel momento in cui la resistenza che questo o quel mezzo teatrale oppone all'espressione viene ad essere dominata (…), allo stesso modo in cui un filamento elettrico brilla in funzione della resistenza che oppone alla corrente".
Questa riflessione, che prefigura il multimediale, è doppiamente straordinaria in quanto suggerisce che l'azione può demoltiplicare le sue modalità d'inscrizione come una corrente i suoi conduttori, e che la teatralità è tanto più forte quanto si fronteggia a dispositivi che le oppongono resistenza.
Ogni teoria teatrale forte si accompagna a una concezione dello spettatore. Il rapporto fra gli spettatori e la rappresentazione si fonda in questo caso su degli atti cognitivi. La rappresentazione diventa infatti un atto semantico, uno spessore di segni visivi e sonori, che lo spettatore ha il compito de decifrare, e che eppure non fa appello a un teatro dei significati.
"Cosa è il teatro? una specie di macchina cibernetica", affermava Roland Barthes, e cioè una macchina per produrre segni che lo spettatore deve decodificare.
Il teatro come dispositivo di visione
Supponiamo che la concezione di teatro come dispositivo di visione implichi una concezione della scena completamente diversa.
Jacques Poliéri, più di ogni altro, ha fornito a questa concezione i suoi fondamenti teorici. Egli ci introduce ad una scenografia speculativa che mette in relazione le arti - teatro, danza, pittura, scultura, architettura… - i saperi - scienze naturali e scienze umane - e le tecniche meccaniche ed elettroniche - di ripresa, di proiezione, di regolazione, di trasmissione… Nell'opera di Poliéri, non solo la scenografia ha il primato sul regista, ma il suo campo si intervento supera il quadro del teatro per inventare dei giochi di comunicazione su scala urbana, e poi intercontinentale, collegando in tempo reale spazi lontani, e inventando così un teatro elettronico su scala planetaria, liberato da ogni quadro architettonico.
In un'epoca in cui la standardizzazione dell'architettura teatrale ha fissato il rapporto scena/sala in un rapporto frontale e fisso, si ha la tendenza a rendere la scena autonoma nei confronti dello spettatore. Per Poliéri, al contrario, la scena non esiste se non attraverso il rapporto e i giochi visivi con lo spettatore. Lo spettatore di Poliéri è sempre collocato in maniera molto precisa nella spazio e iscritto in una relazione particolare con lo spazio scenico. La scenografia agisce innanzitutto sulle percezioni dello spettatore e sulle leggi visive e ottiche fra la sala e la scena. Il centro di gravità della scenografia si sposta di conseguenza dalla scena verso il rapporto sala/scena. La scenografia sarà chiamata "a definire il fenomeno fisico-chimico che unisce l'emissione e la ricezione della spettacolo, il rapporto geometrico, la distanza della sala alla scena, e poi la geometria, la notazione di questa stessa distanza".
Questo tipo di ricerca doveva dare luogo a un'impresa di "sistematizzazione dello spazio scenografico", vale a dire ad una ricerca su tutte le configurazioni visive possibili in spazi geometrici elementari (rettangolo, cubo, sfera…), poi ad a uno studio della cinetica scenica basata sull’osservazione dei rapporti spettatore/spettacolo in ambienti mobili (scena circolare mobile…), introducendo così l'idea di una scenografia del movimento. Ponendo l'architettura e la percezione al centro della sua concezione della scena, Poliéri fornisce dei fondamenti teorici alle esplorazioni sceniche più attuali.
Questo approccio scenografico incentrato sulla relazione fra la scena e la sala è particolarmente appropriato per rendere conto del trattamento scenico dell'immagine. La riflessione sull'immagine, troppo spesso limitata ad uno studio dell'eterogeneità dei registri dei livelli di presenza, deve essere ricollocata in questa economia della distanza. Infatti, moltiplicando le distanze e le scale di percezione, l'immagine "equivale ad un cambiamento permanente della posizione dello spettatore".
I due approcci che abbiamo illustrato, sono oggi i più utili a chiarire e a comprendere le metamorfosi sceniche attuali che mettono all'opera le nuove tecnologie. Possiamo, a titolo di esempio, evocare brevemente Site seeing zoom, l'ultimo spettacolo della compagnia danese Hotel Pro Forma, ed uno spettacolo meno recente de Robert Lepage, Elseneur.
Site seeing zoom
Site seeing zoom propone un'esplorazione del funzionamento della memoria nell'era di Internet. Trae ispirazione, collocandole nel quadro della contemporaneità, dalle tecniche visive della memorizzazione descritte da Frances Yates nella sua opera fondamentale sull'Arte della memoria. Al centro dello spettacolo è posto un dispositivo raffigurante un palazzo della memoria digitale, formato dall'intersezione a croce di schermi traslucidi. Un proscenio, su cui compie dell'evoluzioni un attore, è collocato lungo gli schermi, che offrono altrettante superfici d'inscrizione alle proiezioni di immagini che restituiscono i processi mentali di quattro personaggi. A ogni personaggio corrisponde una base di dati, composta da immagini fisse, da video e da oggetti in 3D. La navigazione nello spazio mentale dei personaggi costituisce la trama narrativa dello spettacolo. Il dispositivo sceno-tecnico fornisce una scena-spazio - la Raumbünhe cara a Kiesler - intorno alla quale lo spettatore può circolare. L'intersezione a croce degli schermi serve da supporto a processi plastici in incessante ricomposizione. I movimenti laterali o verticali dell'immagine, i contrasti tra la luminosità dell'immagine e delle specie di black out, gli zoom in avanti o all'indietro, che postulano differenti scale di percezione, allontanando o avvicinando gli spettatori, permettono delle riconfigurazioni simultanee dello spazio. In questo dispositivo lo spettatore si muove intorno alla scena. Ma egli è mosso, almeno in pari misura, dalle immagini, che, variandone il suo punto di vista, ne modificano la posizione. Nello spirito dei realizzatori, il dispositivo è ugualmente la concretizzazione di un'operazione di spostamento: un ready-made di Internet – colto nello stesso tempo come una rete di comunicazione non-lineare e un modello di funzionamento della memoria umana - che lo fa passare dalla seconda alla terza dimensione.
Elseneur di Robert Lepage
La recitazione dell'attore in Elsinore, uno spettacolo ispirato all' Amleto, in cui Robert Lepage interpretava i personaggi della tragedia di Shakespeare, si sviluppava in una variazione quasi continua della distanza scena-sala.
Robert Lepage sviluppava una serie di personaggi al centro di un dispositivo tecnico complesso, che creava altrettante interfacce alla sua recitazione: video-sorveglianza, telecamere a infrarossi, amplificazione e manipolazione della voce…Le proiezione del corpo dell'attore, l'amplificazione della sua voce, agivano allora come delle maschere visive e acustiche, che avvicinavano o allontanavano la sala e la scena. In seguito a questa esperienza egli osserverà che "i mezzi tecnici utilizzati rendevano il contatto con il pubblico più intimo".
La forza del percorso artistico di Lepage sta nell'avanzare nella determinazione di notevole groviglio - intrico fra le leggi drammatiche e le leggi visive, fra la fluidità dell'azione e l'architettura della percezione dell'azione stessa. L'uomo vitruviano disegnato da Leonardo da Vinci, proiettato su di un pannello mobile oscillante all'inizio della rappresentazione di Elseneur, introduceva lo spettatore in un universo in cui la tecnologia è contemporaneamente un compagno dell'attore, che contribuisce a rilanciare continuamente l'azione, ed un'architettura della percezione, che immerge e fa navigare lo spettatore nel labirinto del castello di Elseneur.
Verso un teatro delle interfacce?
Computer as theatre. Il computer come teatro. Si tratta del titolo di un curioso volume di Brenda Laurel, che tenta di dimostrare come il teatro permetta di misurare la complessità delle relazioni fra l'uomo e la macchina. L'autrice - nel corso di una riflessione che accosta Aristotele a Atari - inserisce il teatro al centro della problematica delle interfacce: "i computer sono un teatro. Le tecnologie interattive, proprio come il teatro, offrono una piattaforma di rappresentazione di realtà coerenti, i cui agenti effettuano delle azioni a tenore cognitivo, emozionale e produttivo (…). In duemila anni, si sono sviluppate e messe pratica delle teorie teatrali che hanno degli stretti rapporti di parentela con la concezione delle interfaccia uomo-macchina, o, per essere più precisi, con la creazione di realtà artificiali nelle quali si cercano di sviluppare gli aspetti cognitivi, emozionali ed estetici dell'azione". Se l'opera di Brenda Laurel è un invito ai realizzatori di videogiochi a strutturare i loro prodotti come una rappresentazione teatrale, essa provoca indirettamente la questione di sapere se le interfacce potrebbero trovarsi al cuore del teatro.
Di fatto l'interfaccia si afferma sempre più come il centro propulsivo di nuovi processi di composizione a teatro. Nelle nuove pratiche sceniche il computer si trova sempre più al centro della rappresentazione, dando corpo ad una "scena intelligente": una scena generata e controllata dal computer, che viene assunto a mediatore di tutti i parametri che concorrono allo svolgimento della rappresentazione. La nozione di scena intelligente è indissociabile da uno spostamento del lavoro del regista verso la programmazione e l'ingegneria informatica. Egli sarà sempre più chiamato a definire le procedure di un sistema, facendo interagire testo, attori, suono, immagini e gesti. Un dispositivo destinato a interfacciare molteplici realtà e media, che si ritrovano così al cuore della rappresentazione, di cui il regista controlla il ritmo e le forme.
Vediamo profilarsi due differenti approcci principali nell'utilizzazione delle interfacce sulla scena teatrale.
Nel primo tipo di interfacce, il dispositivo materiale e il software serve da mediatore fra il computer e delle unità periferiche (camere, strumenti tradizionali e virtuali…). Ci si orienta allora verso la costituzione di vere e proprie regie digitali, che combinano molteplici fonti sonori e visive: immagini video in presa diretta, elaborazione digitale dell'immagine in tempo reale, immagine prese su Internet, immagini d'archivio, voci off preregistrate, elementi musicali prodotti e trasformati in diretta…Questa regia digitale può essere controllata da dei tecnici, o più raramente dagli interpreti, il che comporta necessariamente che gli interpreti integrino ancor più nella recitazione le loro interazioni con le interfacce.
Il secondo tipo di ricerca sulle interfacce, più frequente in ambito coreografico che in ambito teatrale, è incentrato sulla creazione di oggetti o di esseri digitali interattivi a partire dalla captazione di movimenti o di emozioni degli interpreti. L'interfaccia si pone allora fra due sistemi di natura diversa, fra i quali il computer svolge delle operazioni di traduzione. Le interazioni fra il reale e il virtuale determinano allora lo svolgimento della rappresentazione e la costruzione dell'azione scenica. Esse aprono la strada ad un teatro interattivo.
Una delle ricerche più riuscite in questa direzione è quella di Jean-Lambert Wild nel suo spettacolo Orgia. Il motore dello spettacolo è costituito dal sistema Daedalus, che genera degli esseri artificiali dal comportamento aleatorio, visualizzati da organismi dei fondali marini, chiamati Posydones, suddivisi in due specie, gli Apharias e gli Hyssard. Gli attori sono muniti di sensori, che registrano - a partire dal ritmo cardiaco, dalla respirazione, dalla conduttività della pelle e dalla variazione di temperatura - i loro livelli di stress e di emozione. Attraverso i sensori, il dispositivo materiale e il software, le emozioni degli attori influiscono sul comportamento dei Posydones, che, per un'illusione ottica si muovono nello stesso spazio degli attori. Orgia rappresenta uno dei rari tentativi teatrali di utilizzazione di nuove tecnologie che prendano come punto di partenza l'interprete.
L'interfaccia apre un multiforme campo di sperimentazioni. È chiamata a fare teatro, se conduce nello stesso tempo all'affermazione di nuove economie della rappresentazione. Ripensare, in funzione di dispositivi singoli, gli elementi della teatralità, e i rapporti fra lo spettatore e la scena, è il compito che attende gli artisti che si confrontano alle nuove tecnologie.
BIBLIOGRAFIA
D. BABLET, Svoboda, Paris Cité 1978.
R. BARTHES, Essais critiques, Paris Seuil 1964.
F. BAUCHARD, Aux frontières du théâtre, in "ec/arts" n°2 2001.
F. BAUCHARD, Vers une nouvelle scène : le cas d’Elseneur, in "Du Théâtre" 1997.
C. BERET (éd), Friedrich Kiesler artiste-architecte, Paris Centre Georges Pompidou 1996.
M. CORVIN, Poliéri Une passion visionnaire, Paris Adam Biro 1999.
HONZL, La mobilité du signe théâtral, Travail Théâtral 1970.
B. LAUREL, Computer as theatre, Reading Ma. Addison Welsey 1993.
B. LAUREL (éd.), The art of Human-Computer Interface Design, Reading Ma. Addison Wesley 1994.
B. PICON-VALLIN (éd), Les écrans sur la scène, Lausanne L’Age d’Homme 1998.
J. POLIERI, Scénographie/sémiographie, Paris Denoël/Gonthier 1971.
J. POLIERI , Scénographie, Théâtre, Cinéma, Télévision, Paris Jean Michel Place 1990.
U. DELBERT, Towards a new theatre, the lectures of Robert Edmond Jone,s Limelight Editions, 1992
E. SADIN, thé@tre > fast forward, in « ec/arts » n°1 2000.
E. SADIN, Pratiques poétiques complexes&nouvelles technologies : la création d’une agence d’écritureS, in « Ec/arts » n°2 2001.
Questo testo è nato da numerose conferenze sul teatro e le nuove tecnologie, svoltesi a Présence Capitale, al Théâtre de Compiègne (congresso arte/tecnologia) e alla Chartreuse de Villeneuve-les-Avignons.
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
Una piattaforma di lavoro su teatro e nuove tecnologie
Presentazione del progetto CRÉATION NUMÉRIQUE, LES NOUVELLES ÉCRITURES SCÉNIQUES
di Emanuele Quinz
CRÉATION NUMÉRIQUE, LES NOUVELLES ÉCRITURES SCÉNIQUES è un programma di ricerca, che include una serie di incontri professionali e una manifestazione internazionale sul tema «Teatro e nuove tecnologie».
Il progetto nasce dalla collaborazione tra le due strutture parigine DEDALE e ANOMOS, da anni impegnate nella ricerca e nella diffusione della cultura digitale.
ANOMOS, dopo aver promosso diversi progetti legati alle applicazioni delle tecnologie alla danza (tra cui i convegni internazionali Danza e Nuove Tecnologie, Bolzano 1999, New Interfaces for Dance, Parigi ISEA 2000 e le pubblicazioni La scena digitale. Nuovi Media per la danza, Venezia Marsilio 2001 ; Digital Performance, Parigi anomos 2002 ; Interfaces, Parigi anomos 2003), ha consolidato il suo rapporto con il mondo professionale e accademico, stabilendo una serie di convenzioni con il Ministero della Cultura, il Dipartimento di Danza dell’Università Parigi VIII e il Centre National de la Danse, fondando MEDIADANSE LAB, un laboratorio di ricerca e sperimentazione sulle tecnologie digitali applicate alla danza.
Nella prospettiva di un ampliamento del campo di investigazione al teatro, già tentato in parte con la pubblicazione di Digital Performance, anomos si é associata a DEDALE, struttura di produzione e di diffusione, per costituire una piattaforma di riflessione e di sperimentazione sulle pratiche creative contemporanee e i nuovi media.
In particolare, il progetto CRÉATION NUMÉRIQUE, LES NOUVELLES ÉCRITURES SCÉNIQUES intende rispondere direttamente alle domande di un pubblico specializzato e non, rispetto agli apporti delle tecnologie digitali nell’ambito della creazione teatrale, della ricezione, della scenografia e soprattutto della drammaturgia.
Uno degli obiettivi principali del progetto è di creare una dinamica di scambio tra i diversi soggetti implicati: artisti, ricercatori, istituzioni, pubblico.
La prima tappa del progetto è costituita da un lavoro di ricerca storica e teorica, che ha la funzione di disegnare la mappa delle ricerche teatrali attuali e passate che utilizzano le tecnologie informatiche.
In un secondo momento, a partire da settembre 2003, saranno organizzati 5 seminari, a cui parteciperà un gruppo di ricercatori e artisti internazionali con lo scopo di esplorare e illustrare alcuni temi fondamentali:
IL TEATRO NELLA SFERA DEL DIGITALE;
LA SCENA DELLE INTERFACCE;
LA QUESTIONE DELL’ATTORE: VIRTUALITÀ, INTELLIGENZA ARTIFICIALE;
TESTO, SCRITTURA, DRAMMATURGIA;
LA QUESTIONE ISTITUZIONALE: DISTRIBUZIONE, PRODUZIONE.
I seminari saranno seguiti da altrettanti incontri pubblici, che avranno luogo al Centre Pompidou e allo Studio della Comédie Française a Parigi.
La terza tappa del progetto si costruisce intorno ad una manifestazione, che avrà luogo nel 2004, e che comprenderà un convegno internazionale e una serie di produzioni teatrali.
Si tratta di un progetto ambizioso, che cerca di rispondere a diversi obiettivi: da un lato, costituire un sistema d’informazione e fare un censimento dei centri di ricerca internazionali, delle pubblicazioni e dei progetti artistici sul tema TEATRO E NUOVE TECNOLOGIE, costituire quindi una banca dati e un corpus teorico; dall’altro creare una dinamica d’informazione, di riflessione e di scambio all’interno del settore teatrale per favorire l’applicazione delle tecnologie; sensibilizzare i luoghi di diffusione perché includano nella loro programmazione spettacoli che utilizzano le tecnologie.
Il lavoro di ricerca sarà guidato da due ricercatori, Clarisse Bardiot e Ludovic Fouquet, assistiti dalle associazioni Dédale e anomos e da un comitato di esperti, e si avvarrà di una piattaforma di lavoro e di scambio on-line, che permetterà di assemblare diverse informazioni e di fare partecipare a distanza i ricercatori associati. Una parte dei risultati delle ricerche teoriche sarà pubblicata in un volume della rivista ANOMALIE DIGITAL_ARTS.
Il progetto è finanziato dal Ministero della Cultura francese. Ancora molti dettagli restano da stabilire, e prometto di inviarvi al più presto il programma definitivo.
Allego una breve constatazione, a cura di Clarisse Bardiot e Ludovic Fouquet, coordinatori dell’equipe di ricerca, che abbiamo utilizzato come documento di lavoro per la redazione del progetto. Allego anche un profilo di DEDALE e ANOMOS, per chi non conoscesse le due strutture e le loro attività.
Per ulteriori informazioni, potete comunque contattarmi : equinz@anomos.org
o contattare l’incaricata del progetto Agathe Ottavi: agathe.ottavi@dedale.info
ANNESSI :
CONSTATAZIONE (a cura di Clarisse Bardiot e Ludovic Fouquet, coordinatori dell’equipe di ricerca)
Il teatro ha da sempre cercato di integrare le « nuove tecnologie » del suo tempo: macchine spettacolari del XVII secolo; schermi cinematografici all’inizio degli anni 20 negli spettacoli di Meyerhold o Piscator; utilizzazione dei microfoni, del video e dell’editing audiovisivo in tempo reale nelle produzioni di Lepage, Sellars e del Wooster Group – giusto per citare qualche esempio conosciuto da tutti. Oggi, la scena si é trasformata in un ambiente digitale complesso, erede di concezioni ancestrali ma anche aperto a configurazioni inedite ed impensabili fino a poco tempo fa, con le quali tutti i professionisti del teatro, dagli attori agli scenografi, ai tecnici possono comporre.
Ciò nonostante, le tecnologie digitali suscitano spesso delle reticenze e dei sospetti da parte di molti uomini di teatro, mentre la danza e la musica sono state capaci di integrarle rapidamente nelle pratiche artistiche. Senza dubbio, diverse esperienze teatrali sono state realizzate e diverse compagnie hanno messo le tecnologie al centro delle loro ricerche. Ma troppo spesso rimangono casi isolati e nascosti, confermando la regola di un teatro attaccato, radicato alle sue tradizioni.
Possiamo comunque constatare da parte degli artisti, una forte domanda d’informazione sui modi di utilizzo delle tecnologie e di collaborazione con i tecnici o il personale specializzato nelle tecnologie. In effetti, nel contesto di progetti che uniscono teatro e creazione digitale, emergono delle nuove professioni, spesso grazie all’iniziativa delle stesse compagnie, e queste nuove professioni sono spesso all’origine di nuove formazioni professionali. I processi di produzione e di diffusione subiscono una profonda mutazione: si costituiscono delle équipe pluridisciplinari, che includono mestieri lontani dal teatro (informatici, ingegneri…), lo statuto e le conoscenze richieste all’attore e al regista sono totalmente nuove, i teatri non sono spesso più adatti per questo tipo di rappresentazione, sia a livello dell’equipaggiamento tecnico che delle competenze interne…
È importante anche sottolineare la mancanza di visibilità del teatro all’interno degli eventi dedicati all’arte digitale. Per la maggior parte, si tratta di manifestazioni pluridisciplinari, in cui il teatro è spesso l’unica disciplina dimenticata. Da un anno, abbiamo potuto comunque assistere ad una serie di iniziative puntuali (come il convegno future theatre allo ZKM, nel quadro dell’esposizione Future Cinema), che rimettono il teatro al centro della scena digitale.
Il teatro in quanto spettacolo è anche confrontato al problema della trasmissione e dell’archiviazione. I progetti digitali attuali, devono anche potersi costruire a partire dalla conoscenza delle esperienze passate. Per questo, la ricerca storica e la costituzione di una banca dati diviene un’esigenza imprescindibile.
----------------
DEDALE / ANOMOS
DEDALE é una piattaforma di riflessione e di sperimentazione sulle nuove forme artistiche e i nuovi medi.
Cercando di favorire le relazioni internazionali tra gli specialisti delle nuove tecnologie, gli artisti, gli operatori culturali, le istituzioni, le società di produzione e di ricerca, DEDALE articola le sue attività su diversi assi:
- un centro d’informazione europeo sulle arti digitali;
- l’organizzazione d’azioni di formazione (incontri, workshops) destinati agli artisti e agli operatori culturali;
- la produzione, la sperimentazione e l'accompagnamento di progetti artistici;
Dédale organizza anche il festival d’arti digitali, "Emergences" (nel 2002, durante la biennale Villette Numérique). Festival internazionale consacrato alle nuove forme artistiche e ai nuovi media in Ile-de-France, riunisce e mette in sinergia i diversi attori della regione (centri culturali, università, laboratori di ricerca e società di produzione …).
ANOMOS è un’associazione culturale, nata (a Bolzano nel 1996 e a Parigi nel 1998) dalla collaborazione di un gruppo di ricercatori e di artisti delle più diverse matrici, e ha come obiettivo la ricerca sulle nuove configurazioni del sistema delle arti, in particolare quelle legate all’affacciarsi delle tecnologie digitali, considerando sia lo sviluppo dei linguaggi e dei dispositivi, sia i mutamenti estetici che ne sono alla base o ne derivano. Alla ricerca anomos affianca un’attività di sperimentazione, volta alla produzione e promozione di opere artistiche, che attraverso l’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie informatiche, cercano di definire nuove modalità di percezione e di creazione interdisciplinare.
La sede francese dell’associazione, fondata a Parigi nel 1998, affianca ad un nucleo attivo di direzione artistica un comitato internazionale d’onore che raccoglie alcuni tra i più importanti artisti e teorici dell’arte digitale e presieduto fino al 2000 dal filosofo Pierre Lévy e coordinato da Emanuele Quinz.
Il campo di ricerca di anomos.fr si estende dalle nuove interfacce digitali ai sistemi generativi, alle connessioni interdisciplinari, all’architettura virtuale alla moda e alla riflessione sulle nuove forme di spettacolarità.
La strategia di anomos.fr attribuisce una particolare attenzione alla diffusione, attraverso la serie di incontri a tema FACE AU PRESENT, di serate e performance, ma soprattutto attraverso la pubblicazione trimestrale di ANOMALIE, DIGITAL_ARTS, sottolineando lo stretto legame tra la teoria e la pratica, tra l’estetica, la creazione e lo sviluppo dei linguaggi e delle tecnologie.
Nel corso dell’anno 2001 nasce da una convenzione tra anomos e il Dipartimento di Danza dell’Università Paris 8, MEDIADANSE LAB, primo laboratorio europeo che attiva un programma di ricerca, creazione e formazione sulla danza con il tecnologie digitali. Nel 2003 nasce la sezione MODESIGN, che si occupa di ricerca e consulenza nell’ambito del design e della moda.
Anomos.fr ha realizzato e ha in corso diversi progetti di collaborazione con importanti festival e istituzioni, come il Ministère di l’Educazione Nationale, il Ministère della Culture, il Centre National della Danse, La Villette Citato della Science e di l’Industrie, in Francia ; l’Accademia dei Media di Colonia in Germania ; il MIT Media Lab di Cambridge MA, in Usa ; ISEA International Symposium of Electronic Arts,
CONTATTI
DEDALE
AGATHE OTTAVI – coordinazione del progetto TEATRO
agathe.ottavi@dedale.info
+ 33 (0)1 43 66 09 66
ANOMOS
EMANUELE QUINZ, presidente
equinz@anomos.org
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
E' nato prima il video game o la fiaba?
DG Hamelin.com, spettacolo per ragazzi di Renzo Boldrini e Giacomo Verde
di Anna Maria Monteverdi
L'attore e regista Renzo Boldrini continua le sue collaborazioni con artisti tecnologici per creare spettacoli per ragazzi che diventano subito un evento sia per il pubblico che per chi studia teatro e multimedialità. Di Storie Zip, pièce per attore e mouse (con il Teatro di Piazza d'Occasione www.tpo.it e Davide Venturini al software grafico) vincitore dello Stregagatto 1999 aveva parlato Carlo Infante in Imparare giocando Interattività fra teatro e ipermedia (Bollati Boringhieri 2000) che aveva elogiato di questa storia non ordinaria (ma per ordinateur!) di Cappuccetto rosso, il lupo e i tre porcellini, raccontata con segni tracciati in diretta con Photoshop su schermo e pancia-schermo dell'attore, la fenomenologia del digital storytelling. Tutto l'universo linguistico del multimediale e del web è al servizio della fiaba (la casetta dei porcellini è www.treporcellini.home) senza alterarne il senso, casomai trasferendo quest'ultima in un immaginario contemporaneo fatto di schermi di computer, icone e velocità (zip, appunto). Se il gruppo da lui diretto insieme con Vania Pucci, il Giallo Mare Minimal Teatro di Empoli, ha fatto propria la tecnica del teleracconto di Giacomo Verde (telecamera che riprende in macro piccoli oggetti e televisione che li trasmette in diretta) con La sirenetta e Boccascena creando (tele)videoscenografie manipolate in diretta dal narratore, Boldrini la rielabora ulteriormente insieme con il bravissimo computer artist Federico Bucalossi nel 2003 per illustrare la narrazione di Fuori onda, tratto da La calza della befana di Emma Perodi, scrittrice toscana di fine Ottocento autrice di novelle per bambini (vedi Fiabe elettroniche, ed.Titivillus).
DgHamelin.com è l'ultimissima creazione del duo Verde-Boldrini che parte dalla fiaba del pifferaio magico raccontata da un solo attore in scena, il quale, in diretta e con un mouse, gestisce i tempi sia della parola che della visione, fatto questo di grande valenza teatrale poiché per la prima volta (se si esclude Storie Mandaliche di Zonegemma ancora in allestimento) in uno spettacolo di digital performance nulla è esterno all'attore che diventa macchina che concerta e dirige registicamente se stessa, di sera in sera secondo modalità sempre diverse.
Lo spettacolo ha avuto una lunga e necessaria gestazione per permettere a Giacomo Verde e Renzo Boldrini di elaborare non tanto una scenografia affascinante e stupefacente, ma definire la corretta dimensione cultural-politica della tecnologia usata, il cui ruolo nello spettacolo è, in primis, quello di elaboratore centrale di metafore: la storia non è collocata in un fantastico scenario senza tempo, ma nel qui e ora del mondo del virtuale.
Nella nuova città digitale di Hamelin i grandi sono resi ciechi dal guadagno, incantati e annegati nel vortice del denaro, i bimbi "svegli" abili col computer sanno però trovare un bug nell'accesso ai portali informatici del perfido architetto che l'ha costruita e li salveranno. Si tratta di riportare i grandi alla ragione, e costruire insieme un nuovo mondo dove regni l'allegra confusione dei giochi e non il suono delle monete. Il narratore -si scoprirà alla fine- è uno di quelli che è stato salvato dai bimbi e per questo ha la missione di raccontare a tutti la storia, per non farla dimenticare, per farla tenere bene in mente, insomma per salvarla in un file!
La trama parte dall'antica città di Hamelin di cui il raccontastorie va ad illustrarne qualità e felicità, e i "ma" che inevitabilmente precedono la storia: i topi penetrano nella città, il pifferaio è disposto a eliminarli conducendoli al suono del magico piffero verso il fiume dove annegheranno; il sindaco non salda il conto e il pifferaio si vendica incantando questa volta i bimbi portandoli verso la montagna, dentro ad una grotta da dove non torneranno più.
La città antica è restituita in scena in maniera davvero originale: la sua immagine sullo schermo scorre, anzi, si srotola come un papiro antico; il raccontastorie ha un mouse-radio che, in modalità drag, gli permette di far "avanzare" o "indietreggiare" nella porzione verticale o orizzontale il quadro che illustra in bianco e nero una città medioevale con gli abitanti in piazza, saltimbanchi e autorità civile e ecclesiastica, isolandone di tanto in tanto i personaggi (grazie al mouse up). Intorno, a mo' di cornice enormi toponi... Lo schermo diventerà in seguito, il desktop del computer centrale della digi-città o del Pc dei bimbi svegli. Così la storia va avanti riquadro per riquadro (o "videata per videata") e "step by step" con il clic del mouse.
La tela disegnata dei narratori di tutte le tradizioni popolari (ma anche i grandi cicli di affreschi) diventa in questo caso, schermo che assorbe la materia luce di cui sono fatte le immagini assolvendo però quella medesima funzione di un "visibile parlare" immediato e iconico. Il racconto teatral-tecnologico è come una pittura antica: così come nel Duecento si usavano schemi di rappresentazioni, raffigurazioni emblematiche e immagini simboliche, lo spettacolo usa come riferimento linguistico, l'universo world wide web, il linguaggio html e il gergo (e talvolta lo slang) del "medialismo": icone (buste da lettera e-mail) button, barre, webcam, cookie, pop up, perché "C'e modem e modem, ma bando alle chat".
Nella nuova città digitale di Hamelin costruita dal Dg architetto dove ai bimbi è proibito l'accesso, tutto funziona attraverso dati, flusso ininterrotto di dati, i grattacieli sono come altissimi bar code. Gli scambi, le transazioni, tutto avviene attraverso codici computerizzati, l'immagine della futuribile città di Hamelin sembra quella descritta da William Gibson in Burning chrome (La notte che bruciammo Chrome) o il cyberspazio in Neuromancer ("Una rappresentazione grafica di dati ottenuti dalle memorie di ogni computer nel sistema umano"). Richiamo evidentemente non incidentale poiché il movimento della science fiction americana degli anni Ottanta che immaginava un mondo dominato da una tecnologia come compiuta seconda natura dell'uomo, in uno scenario di degrado sociale in cui la padronanza del computer era l'unico strumento di lotta e di sopravvivenza per le classi inferiori, è stato di fatto un fenomeno che ha decisamente scavalcato i limiti del genere per imporsi come marchio comportamentale di un movimento mondiale autonomo di idee e di pratiche sociali reali legate alla rete (non è un caso che il sito Isole nella rete, lo storico network indipendente che ha riunito i primi media attivisti, si sia ispirato nel nome al romanzo omonimo di Bruce Sterling, scrittore e principale teorico del cyberpunk).
In questo universo digitale dalla perfetta funzionalità e razionalità tecnico-produttiva simbolo dei poteri ma anche dei pericoli di una tecnocrazia incontrollata, i personaggi sono come appaiono dal desktop del loro computer, gli hacker-bimbi sono i buoni che salveranno la città dalle ire delle Dg architetto, il quale poiché la storia si ripete, non essendo stato pagato per i servizi resi alla città rinchiuderà stavolta gli adulti nella grotta-cassaforte la cui apertura è ovviamente legata a un codice d'accesso, a una key word. L'architetto folle che ha costruito queste cattedrali digitali dove l'unica legge è quella dell'arricchimento, viene stanato dai topi digitali e dai bimbi (ribaltando così la storia originaria!!!) i quali, alla ricerca del conforto familiare e del contatto reale coi genitori, attraverso prove, tranelli, labirinti e rischi degni della più classica delle fiabe, ma anche del più classico video game, arriveranno a conquistare il tesoro umano contenuto dentro la cassaforte. Di grande intensità sia l'atmosfera visiva che quella sonora: tutte le belle animazioni fatte in Flash MX sono opera di Lucia Paolini e Francesco Menconi, studenti dell'Accademia di belle Arti di Carrara, con un "cammeo" di Claudio Molinari, un "maestro" dell'animazione 3D. Menconi ha creato in animazione il paesaggio urbano fatto di stringhe di informazioni che scorrono sotto una "musica liquida" generata al computer dal bravissimo sound designer Mauro Lupone: quel suono è il rumore dei soldi invisibili, il passaggio dei bit neuronici, delle autostrade informatiche.
Boldrini passa con grande disinvoltura, abilità e simpatia da narratore ad architetto a sindaco a bimbo sveglio grazie alle diverse maschere digitali volute da Verde, che in questo caso si chiamano delay, webcam, cercando sempre dialogo autentico e sonore risposte dal pubblico, mostrando come si possano ri-creare storie vecchie come il mondo persino con un p.c., ma anche come con la stessa facilità si possa ribaltare quel mondo che ha senz'altro, da qualche parte nello schermo di protezione, un invisibile bug. Per far pratica, lo spettacolo invita tutti i piccoli e grandi spettatori a giocare insieme e "interagire" attraverso la rete, perché the game is not over, lo spettacolo continua su altri schermi, quelli del computer di casa su www.dghamelin.org.
Questo spettacolo è davvero una bella occasione per affermare, attraverso la metafora del gioco, il tema dell'attivismo tecnologico che tutti noi, non più bambini, abbiamo colto: la distruzione di una società disumana e relativi valori, questo la fiaba moderna insegna, non passa attraverso la distruzione della tecnologia ma al contrario da un cosciente riappropriarsi collettivo del sapere (e di un immaginario) tecnico-scientifico per la costruzione comunitaria di un nuovo modello di città.
Anzi di civitas.
Per vedere il video clicca qui (Windows Media Player, 237 KB).
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
AHA: ACTIVISM-HACKING-ARTIVISM
Un progetto di arte transmediale e comunitaria
di Tatiana Bazzichelli
http://www.strano.net/bazzichelli
La sfida maggiore dell’attuale società "interconnessa" sembra essere la completa fusione del sistema dei media e delle tecnologie digitali con la realtà politica, economica e sociale. Ciò che appare oggi in un medium, per esempio una cosiddetta opera di ".net art", potrebbe domani svilupparsi in una pratica televisiva, in un seminario collettivo, in una mostra d’arte, ecc.
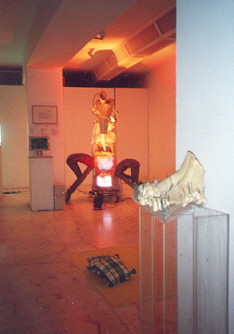
Appare sempre più riduttivo cercare di definire un’opera d’arte partendo dal suo "supporto", come un tempo si era soliti fare per la scultura, la pittura, la video-arte stessa.
L’analisi andrebbe spostata dal mezzo al messaggio, dalle definizioni e dai "nomi" alle pratiche.
La .net art di cui tanto si parla, e che ancora – per fortuna - risulta difficile definire in maniera univoca, per sua intrinseca caratteristica va aldilà dell’appartenenza a un mezzo "fisico" e si esprime attraverso pratiche che non vivono unicamente nella Rete.

Se si pensa alle pratiche che la cosiddetta "net art" innesca, appare chiaro il suo carattere transmediale. Queste, vanno a toccare trasversalmente diversi media e diversi settori della nostra esistenza (la società, l’economia, la politica, il sistema mass-mediatico, la nostra vita quotidiana).
Basta pensare alle opere degli artisti più "in voga" attualmente a livello internazionale, come Etoy, Rtmark, 01.org, Critical Art Ensemble, per rendersene conto.

Al concetto di transmedialità ben si affianca quello di fare comunità.
E’ possibile utilizzare la Rete, integrandola con gli altri media, per produrre azioni e re-azioni, per dare vita a comunità che non esistano unicamente nel mondo dei bit, ma che siano strettamente collegate a dinamiche di vita "reale", sociale, politica.
Ne sono un esempio le opere portate avanti, sin dagli anni ’80, da artisti e attivisti italiani come Tommaso Tozzi, Giacomo Verde, Massimo Contrasto, il collettivo Strano Network e che oggi si esprimono negli Hackmeeting, nella battaglia per il free software e i cyber-rights.
La necessità di creare network, di dare vita a reti di relazioni sociali a partire da pratiche in rete, ma che in Rete non si esauriscono, è oggi decisamente facilitata dallo sviluppo capillare della tecnologia (purtroppo diffusa a questi livelli unicamente nel mondo occidentale), dalla crescente facilità di accesso ai diversi media, dal progressivo affermarsi della banda larga.
In questo senso, un’opera di .net art dovrebbe essere realmente capace di "fare network" (.net), di creare comunità, a partire dalla messa in critica dei meccanismi della società dell’informazione globale.
Non quindi un’arte che crei duplicati di opere già esistenti, ma un’arte che punti a interferire con i meccanismi di produzione della cultura e dell’informazione, agendo a livello allargato non in un unico medium (la Rete), ma diventando essa stessa medium (rete) fra diverse collettività e diversi medium.
Il progetto AHA: Activism-Hacking-Artivism, nasce da queste riflessioni, con l’obiettivo di essere un’opera realmente transmediale e comunitaria.
AHA come mostra-evento collettiva
L’esperienza AHA: Activism-Hacking-Artivism, making art doing multimedia, nasce nel febbraio 2002 presso il Museo Laboratorio d’Arte Contemporanea di Roma, attraverso una mostra-evento sul media attivismo. Per info: http://www.luxflux.net/museolab/mostre/aha.htm
I concetti principali di AHA, sono Activism = attivismo politico, Hacking = attivismo tecnologico, Artivism = attivismo artistico. La mostra AHA ha evidenziato un percorso collettivo, frutto di un movimento che dai primi anni ottanta si batte per un uso indipendente e autogestito dei media (video, computer, radio e testi scritti) e che oggi più che mai, sta dimostrando di essere una valida alternativa all’informazione ufficiale.
AHA è nata come riflessione dopo le manifestazioni di luglio 2001 contro il vertice del G8 di Genova: territorio non unicamente di duri scontri, repressione e violenza, come la maggioranza dei media ha evidenziato, ma anche importante esperienza per chi costruisce informazione dal basso, attraverso telecamere amatoriali, siti internet di movimento, circuiti di radio indipendenti.
Ma AHA è anche riflessione sulla sperimentazione artistica che fa uso del digitale, che, nelle sue più vitali manifestazioni, incarna necessariamente l’attitudine all’uso critico e autogestito dei media. Non più opere ma processi, non più originalità ma riproducibilità, non più rappresentazione di un unico genio ma azione collettiva, esempio di una progettualità creativa che, inserita in un museo, ne apre le porte e le mura.
All’interno della mostra AHA sono stati presentati, in maniera integrata, video, progetti al computer, estratti di trasmissioni radio e testi scritti a opera di diversi collettivi.
Per citarne alcuni: il collettivo Isole Nella Rete, Indymedia Italia, Radio GAP, Strano Network, Tactical Media Crew, Candida TV, Netstrike.it, AvANa.net, Autistici/Inventati, copyDOWN, Dyne.org, gli artisti e attivisti Giacomo Verde, Tommaso Tozzi, i GMM (Giovanotti Mondani Meccanici), Massimo Contrasto, Federico Bucalossi, Claudio Parrini, Ferry Byte, Arclele, Mariano Equizzi (in coproduzione con Luca Liggio e la INTERACT), la compagnia teatrale Neguvon e le storiche riviste Decoder e Neural.
AHA v.2: proiezioni video
Dopo l’esperienza della mostra, il progetto AHA prende il nome di AHA v.2 e continua a vivere attraverso diverse proiezioni video (nell’estate del 2002 sono stati proiettati i video presenti nella mostra in varie città – Empoli, alla Festa dell’Unità; Bologna, all’Hackmeeting; Firenze, al Parterre 2002).
A Bologna, nell’ambito dell’Hackmeeting 2002 al Centro sociale TPO, AHA si "manifesta" con la proiezione dei video sull'hacking, ripercorrendo il percorso dell'uso consapevole e critico delle tecnologie attraverso contributi video sulla storia della telematica amatoriale (BBs), sugli hackmeeting e progetti free. L’hackmeeitng è una tre giorni di seminari, giochi, dibattiti, scambi di idee e apprendimento collettivo. E’ un’occasione di condivisione di saperi e autoformazione gratuita, attraverso corsi e seminari autogestiti e la possibilità di reperire informazioni mettendo in rete i propri computer con quelli degli altri partecipanti (http://www.hackmeeting.org
Durante l’hackmeeting, grazie alla proposta del collettivo New Global Vision, i video di AHA diventano scaricabili dal web, utilizzando programmi di file-sharing (i video possono essere scaricati al: http://www.ngvision.org/mediabase/category/6). New Global Vision è un progetto che si propone di creare una rete di canali video on line indipendenti e a costo minimo. Si basa infatti sull’uso di tecnologie e software di pubblico dominio che permettono di scaricare e di pubblicare video liberamente (http://www.ngvision.org).
Sempre durante l’estate, AHA v.2 rivive nel Parterre di Firenze dal 6 al 13 luglio, nell’ambito dell’iniziativa DIGITAL ZONES – Porte digitali, a cura del collettivo Strano network. In questo caso, AHA v.2 si esprime attraverso video sul media attivismo che sono proiettati in una particolare porta "fluttuante", una porta in cui scorre dell’acqua (maggiori info su http://www.strano.net/news/2002/dz01.htm).
Nel marzo 2003, le proiezioni di AHA, sono effettuate nell’Università di Scienze della Comunicazione, in occasione dell’evento continuato "Ex-Cathedra, Movimenti culturali notturni", che per la prima volta in Italia, apre una Facoltà di notte per iniziative culturali (info su: http://www.comunicazione.uniroma1.it/sdcmediazine/sera3.asp). Sono proiettati i video sull’Activism, Hacking e Artivism, e nella seconda giornata di proiezioni, intervengono anche i ragazzi di Candida TV per presentare le loro produzioni (http://candida.thing.net).
Nasce la Mailing List AHA sull’attivismo artistico
Il 30 dicembre 2002, AHA è diventata aha@ecn.org, una mailing-list sull’attivismo artistico, nata nel sito di Isole nella Rete (http://www.ecn.org).
L’idea che ha dato origine alla mailing list è stata quella di rendere il progetto AHA realmente collettivo, con la proposta di far nascere una comunità italiana on line che si occupasse di attivismo artistico e di net art, analogamente alle realtà straniere come le mailing list nettime, rhizome, ecc.

La mailing list AHA è infatti una conferenza elettronica non moderata ad accesso pubblico sull’attivismo artistico, intendendo per "attivismo artistico" ogni forma di espressione creativa non vincolata dalle logiche di profitto, no-copyright, orientata a stimolare la reale sperimentazione sui linguaggi espressivi al di fuori di ogni censura e appartenenza gerarchica, per una libera riflessione sull’uso delle nuove tecnologie.
aha@ecn.org vuole essere un territorio di incontro e di dialogo aperto, aldilà di ogni forma di auto-celebrazione e sterile perpetuarsi di nomi e di appartenenze, caratteristiche che oggi connotano largamente il cosiddetto "sistema dell’arte". Vuole essere uno spazio di confronto e di scambio di conoscenze, una piattaforma comune in cui segnalare, proporre e far crescere collettivamente progetti sulla sperimentazione e l’uso espressivo delle nuove tecnologie.
Per maggiori info: https://www.ecn.org/wws/info/aha
Per consultare l’archivio: https://www.ecn.org/wws/arc/aha

In sintesi, il progetto AHA si propone di testimoniare come gli eventi/mostre d’arte possano andare di pari passo con la vita reale, adattandosi allo scorrere del tempo in modo camaleontico: per un’arte in movimento che vada oltre se stessa ed esprima le pratiche di soggetti in divenire, processi aperti s/materializzati.
Per questo, AHA nasce e si ricrea come una TAZ, manifestandosi attraverso i media e intersecando diverse comunità.
Info su: http://www.strano.net/bazzichelli/aha.htm
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
L'altro teatro
La memoria del teatro nei video di Nico Garrone
di Giacomo Verde
Ho avuto la fortuna di organizzare, assieme a Silvana Vassallo, all'Accademia di Belle arti di Macerata per la cattedra di Video e Teatro una serie di incontri sulla documentazione video teatrale. Uno di questi incontri è stato con Nico Garrone. La cosa che è saltata agli occhi è quanto sia importante avere una attenzione autorale, creativa, per poter realizzare un documento che sia capace di fare memoria di un evento così effimero come uno spettacolo teatrale. Ma anche quanto sia importante riuscire a "conservare" tracce delle esperienze fatte. Infatti molto belli sono stati i frammenti tratti dal documentario per la televisione L'altro teatro in cui Nico Garrone racconta l’esperienza delle "cantine romane". In questo lavoro sono particolarmente interessanti due elementi: il fatto di riuscire a raccontare quel pezzo di storia teatrale disponendo di pochissime immagini dell'epoca; e la dimostrazione che negli anni Ottanta era ancora possibile far passare in televisione "materiali creativi" e non-allineati. Nico fa parlare i protagonisti dell'epoca (attori, registi, critici) mettendoli in condizioni "performativo-domestiche": un tavolino sul marciapiede dell'ex teatro; mentre ci si fa il bagno; rilassati su un sofà; mentre viene predetto il futuro con le carte... In questo modo sembra trasparire l'atteggiamento generale, il vissuto, il pensiero che stava dietro all'agire teatrale di quegli artisti. E devo confessare che pur conoscendo la storia di quegli anni è sempre molto utile e bello rivedere l'immagine-pensiero che animava le visioni e le creazioni di quei "cantinari", spogliata di una certa retorica che a volte avvolge gli scritti critici o i racconti a cena. Meno male che Nico ha avuto l'intuizione e la capacità di farne memoria-video con sapiente passione.
Una passione che lo fa continuare a realizzare altre video memorie come quella per La villeggiatura che il Teatro Settimo realizzò in una villa veneta. In questo caso il racconto video mixa le prove dello spettacolo, alcuni brani fatti apposta per la video camera e le riprese dello spettacolo seguendo l'andamento drammaturgico della commedia. Così come sulla scena, ad un certo punto, arriva il temporale a segnare la fine delle vacanze; la vera pioggia, che ha messo in crisi le repliche estive dello spettacolo, fa da sottofondo estetico ed emotivo alle prove dell'allestimento. E anche in questo caso abbiamo la fortuna di vedere un poco conosciuto (per la grande maggioranza del pubblico) Marco Paolini "pre-Vajont" cimentarsi con Goldoni. Anche in questo caso Nico riesce a restituire il clima di quello spettacolo senza dover mostrare tutto: si sa che in video il teatro ci sta comunque stretto, e solo dei frammenti scelti e trattati con attenzione possono riuscire a rendere il senso generale di opera teatrale quasi come il frammento di ologramma contiene sempre la sua totalità.
Infine ci tengo a segnalare un terzo video: quello su L'isola di Alcina con Ermanna Montanari del Teatro delle Albe. In questo caso Nico riesce ad "animare" una scena visivamente statica ma ricca di sonorità vocali inserendo delle proprie visioni e sovrapponendo il testo alle immagini dello spettacolo: ricreando così una sorta di "visione-mentale" simile a quella che un qualsiasi spettatore può fare durante l'esperienza teatrale, cercando in questo modo di rendere in video non tanto la scena ma l'intensa esperienza che uno spettatore può provare assistendo allo spettacolo. E soltanto attraverso una consapevolezza creativa delle differenze, e delle potenzialità, che esistono tra il video e il teatro è possibile realizzare dei video così splendidamente "corretti e irrespettosi" della scena. Dei video che consapevoli della impossibilità di rendere la "realtà" di una spettacolo teatrale si preoccupano di fare memoria "dell'immateriale" e del "fuori scena" necessario alla realizzazione di qualsiasi opera teatrale.
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
Esperienze artificiali multisensoriali
Recensione a Oliver Grau, Virtual Art. From illusion to immersion, MIT Press, 2003
di Anna Maria Monteverdi

L'evoluzione dei media di immersione, le tecnologie per convogliare esperienze artificiali multisensoriali ha, secondo Oliver Grau, una lunga storia rintracciabile nella pittura, nel cinema, nel teatro e che affonda le sue radici per esempio nella costruzione spaziale degli affreschi della Villa dei Misteri di Pompei, negli scorci prospettici rinascimentali e barocchi in cui l'osservatore era illusionisticamente incluso nello spazio dell'immagine producendo la sensazione di una partecipazione corporea.
Si passa poi dal panorama (viene descritto il quadro di Anton von Werner del 1883 The Battle of Sedan), al Cinerama (che tentava di espandere il campo visivo dei film, sfruttando le zone periferiche dell'occhio umano, capace di vedere 155 gradi verticalmente e 185 orizzontalmente), dal Sensorama al Cinema espanso e quello in 3 D, infine alla sensazione di immersione prodotta dai visori stereofonici Head Mounted (HMD) progettati da Ivan Sutherland nel 1966 e prodotti nel 1968 con finaziamenti del Ministero della difesa statunitense, o dal più recente Cave.
Dopo uno sguardo all'antichità si passa al Novecento, alle avanguardie storiche: le Ninfee (1909-1926) di Claude Monet che formavano una fascia ininterrotta lungo le pareti dell'Orangerie a Parigi a cercare uno sguardo circolare dello spettatore; le tecnologie avevano già tentato di realizzare la sensazione del rilievo dall'osservazione di oggetti con lo stereoscopio inventato nel 1843 da David Brewster e successivamente perfezionato, apparecchio che utilizzava la capacità fisiologica di distinguere la profondità di campo. Scenografie e teatri a pianta centrale, poi, furono progettati a inizio secolo mentre il Cinerama presentato all'Esposizione mondiale di Parigi proponeva 10 film da 70mm proiettati contemporaneamente per formare una immagine a 360°. Dobbiamo dire che la storia di queste tecnologie "pre VR" e il loro potere di illusione "binoculare" era stato piacevolmente raccontato (e tradotto in italiano per Baskerville) da Howard Rheingold nell'ormai celebre La realtà virtuale. I mondi artificiali generati dal computer e il loro potere di trasformare la società (in particolare nel capitolo Il teatro dell'esperienza).
Il libro di Grau cerca di offrire un "panorama" (appunto...) di esperienze visive e procedimenti artistici che possano dare dignità a un procedimento che, dalle simulazioni militari, è ormai alla base delle più recenti esperienze di performance e computer art, anche se l'autore tiene a precisare che non vuole dare una legittimazione ma solo relativizzare storicamente i due concetti di illusione e immersione alla base della virtual art. Questa impostazione permette anche ai più scettici di abbandonare i luoghi comuni sulla disumanizzazione di un'arte allineata all'inevitabile progresso tecnologico e di avvicinarsi alle tecnologie del virtuale, poiché il loro utilizzo non svela nient'altro che un'innata, inesauribile e utopistica volontà dell'uomo di uscire dai limiti imposti dalla "cornice".
Negli utlimi capitoli di Virtual art Grau entra nel merito degli esempi di applicazioni artistiche delle tecnologie VR, immersivi e interattivi, come quello storico e pluricitato ideato da Charlotte Davis, Osmose, viaggio in 3 D nel simulacro della natura (1995. Immagini di Osmose e testo di Grau dal sito http://www.immersence.com/bibliography/OGrau-VirtualArt-N.html; l'installazione è stata inaugurata a Montréal al Museo d'arte contemporanea che ne ha realizzato anche un video di documentazione); ed ancora, Maurice Benayoun (www.benayoun.com), Jeffrey Shaw, Knowbotic Research, Christa Sommer, Monika Fleischmann (tra le opere: Home of the Brave e Murmuring Fields. Di Fleischmann e Strauss vedi in rete il saggio Images of the body in the house of illusion che lo studioso Corino ha reso consultabile su: http://server.forcom.unito.it:8000/baudhaus/ricerca/corino7appendice.html).
Da citare anche l'installazione Memory Theatre VR di Agnes Hegedues (1997) ispirata al Teatro della Memoria di Giulio Camillo (1550). Nel settimo capitolo l'autore si avventura nel territorio della storia della telepresence art e della telematic art, i cui pioneri sono stati secondo Grau l'australiano Simon Penny e il californiano Ken Goldberg; tra le opere di Goldberg Telegarden, realizzata per Ars Electronica di Linz nel 1996 in cui un giardino in miniatura veniva innaffiato da un braccio robotico controllato attraverso una webcam, da navigatori della rete che potevano, quindi, a distanza e soltanto con un tasto del computer diventare giardinieri virtuali. Grau si spinge fino a documentare la cosiddetta trangenic art, termine coniato dal brasiliano Eduardo Kac nel 1999 per definire un'arte legata alle biotecnologie e alle manipolazioni genetiche; Kac ha realizzato GFP K-9, che altro non è che un cane sul quale sono state trasferite proteine verdi fluorescenti da una medusa del Pacifico.
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
Quanto osa lo sperimentale?
Bruno di Marino, Interferenze dello sguardo. La sperimentazione audiovisiva tra analogico e digitale, Bulzoni, Roma, 2002.
di Simonetta Cargioli
Da anni Bruno di Marino, titolare dell'insegnamento di Teoria e tecniche di elaborazione dell'immagine presso l'Università di Salerno, porta avanti una ricerca sul cinema underground, sperimentale e d'animazione. Su questi momenti della sperimentazione cinematografica ha scritto diversi libri e ha organizzato retrospettive e rassegne nel nostro paese e all'estero. Quest'ultimo saggio raccoglie testi di analisi e riflessione sulle forme dell'audiovisione, "interferenze" tra analogico e digitale e, attraverso questo, più in generale sulle relazioni tra tecnica e estetica. L'attenzione si focalizza, come precisato nelle prime pagine dell'introduzione, sulle forme sperimentali del cinema, lasciando da parte il trattamento delle forme sperimentali sviluppate da più di trent'anni con il medium video - parecchie pubblicazioni sono uscite in Italia sull'argomento negli ultimi dieci anni - e accennando alle mutazioni in corso legate all'uso artistico dei nuovi media informatici.
Lo sguardo è quello di uno storico del cinema che scava nel passato: l’analisi comincia dalla sperimentazione con le avanguardie storiche e risale il filo del tempo sino all'attuale computer animation, attraversando ovviamente i fecondi anni Sessanta e Settanta; è lo sguardo di un critico del cinema d'autore, attento alla tecnica, che sa leggere le impronte di un linguaggio personale, di uno stile che si snoda in un confronto e dialogo con le macchine e con le tecniche; ed è lo sguardo di un appassionato di cinema e di immagine in movimento, curioso delle sue evoluzioni, del suo divenire dall'"invenzione" del cinema, con le prime proiezioni dei Lumière e le esperienze di Meliès, sino ai giorni nostri.
In Interferenze dello sguardo trovano una sintesi i campi di ricerca privilegiati dall'autore: nei vari capitoli vengono proposte letture e interpretazioni storico-critiche di opere realizzate con tecniche diverse e in epoche diverse, spesso lontane. In questo modo vengono messe in luce continuità poco conosciute e talvolta ignorate del tutto. Nello stesso momento vengono datate con precisione certe forme della sperimentazione, contribuendo a disattivare l'impressione di novità che possiamo provare davanti a certe immagini realizzate con tecnologie odierne. Emerge quindi in primo piano una storia argomentata della sperimentazione cinematografica. Ma, cosa si intende con il termine "sperimentazione", di cui spesso si percepisce l'abuso nelle conversazioni o nei testi a proposito dell'arte? E non è una domanda di poca importanza se pensiamo che per Dominique Noguez, studioso di cinema appunto "sperimentale", autore tra l'altro nel 1979 del famoso Eloge du cinéma expérimental, la nozione è una trappola, un terreno scivoloso: precisa infatti che in arte si possono sperimentare delle tecniche, dei modi di lavorare, dei procedimenti, ma questo non vuol dire che si stiano sperimentando nuove forme linguistiche. Questa precisazione ci pare importante oggi, assillati come siamo dalle mode sperimentali che dobbiamo - e il libro di di Marino è uno strumento utile al riguardo - imparare a leggere e a analizzare grazie anche alla luce del passato. L'autore elenca i tratti della sperimentazione cinematografica che il lettore potrà estendere, con appositi accorgimenti e/o variazioni, a altri linguaggi dell'arte:
1. assenza di sceneggiatura e messa in scena;
2. totale autonomia produttiva dell'autore;
3. attenzione focalizzata sull'immagine in sé;
4. uso di supporti e dispositivi non necessariamente professionali;
5. uso creativo del montaggio;
6. connessioni con altri linguaggi e estetiche: pittura, musica, poesia, danza…;
7. Forme alternative di produzione e di distribuzione.
Il cinema sperimentale così definito comprende diverse possibilità di essere dell'immagine - dal documentario all'elaborazione e trasformazione - e diversi atteggiamenti del pubblico, che è comunque quasi sempre e in modi diversi chiamato a reagire per rompere la relazione richiesta dal cinema convenzionale impostata sull'illusione e sulla mimesi. Lo sperimentalismo nell'arte ricerca sempre nuove regole del gioco e contribuisce quindi all'estensione delle possibilità sensoriali e linguistiche, oltre le tecniche, i generi, i supporti. Precisa l'autore:
«Accanto ad una storia del film sperimentale o d'"avanguardia" (nella sua accezione più storicizzata) […] possiamo intendere tout court lo sperimentalismo non come macrogenere, bensì insieme di particolari tecniche di rielaborazione e modificazione dell'immagine, che si configurano sotto forma di stilemi utilizzati anche nell'ambito della fiction.» (pagina 21)
L'analisi delle forme dello sperimentalismo dalle avanguardie storiche a oggi fa emergere le differenze e gli scarti nella percezione, nella visione, nella produzione delle immagini marcati dalle mutazioni tecnologiche; non ha più senso parlare di analogico e digitale, tutto si modifica, si mescola, immagini e supporti si smaterializzano, con il conseguente rapporto diverso tra immagine e realtà. Ciò che vediamo su schermi e monitor è cioè il frutto di costanti interferenze tra modi di essere dell'immagine, tra supporti, tra cinema e video, tra cinema e arti visive. Questo esige dal pubblico speciale che è lo studioso, è chiaro, modi adeguati di mettersi in relazione con le opere, con i linguaggi, per praticare l'arte della critica e dell'interpretazione. Il libro di di Marino fornisce utili e preziosi contributi e spunti di riflessione necessari. E copre nei vari capitoli un vasto terreno di ricerca e produzione dell'immagine in movimento:
1. La musica delle forme. Breve storia del cinema astratto;
2. Azzeramento e moltiplicazione dell'immagine. Film, struttura, dispositivo;
3. Ricreare il tempo. Teorie, tecniche e autori dell'animazione sperimentale;
4. La materia della memoria. Film amatoriale, diario, found footage, détournement;
5. Body hard. Cinema sperimentale, video, performance, pornografia;
6. Le forme della musica. L'estetica del videoclip.
Di Marino tasta il polso anche alle non facili connessioni tra sperimentazione artistica e industria (cinema commerciale, televisione, pubblicità) e si sofferma su alcune problematiche legate alle committenze. Si sente invece la mancanza di una scheda bibliografica e di una nota sulla reperibilità dei lavori a cui si fa riferimento. E peccato che le illustrazioni siano in bianco e nero.
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
Alcune considerazioni sul teatro in rete
Un intervento che "Primafila" non ha voluto pubblicare
di Maia Borrelli
Vorrei fare una provocazione paragonando il web al grande palcoscenico dove va in scena oggi lo spettacolo del mondo, in tutta la sua sconsolante miseria e invadente abbondanza. Se questo può essere accettato, almeno al livello di una metafora, cerchiamo di capire cosa stia succedendo in rete utilizzando l’arte della rappresentazione per eccellenza, il teatro.
Primo punto di contatto tra il mondo dei teatri e il mondo della rappresentazione digitale contemporanea è il concetto di virtualità. Non dobbiamo pensare alla virtualità solo come VR, realtà virtuale, ovvero invenzione di ambienti artificiali per i videogiochi e per usi militari, ma come ad un concetto che ha radici antiche e profonde. Virtuale vuole dire fare come se fosse, e in questo gioco l’attore e il suo regista sono da sempre maestri. Il primo luogo del virtuale è stato infatti lo spazio della narrazione e del teatro, che è spazio sia fisico che mentale. Io penso che lo spettacolo teatrale sia un grande momento di scambio tra individui, mediato dalla narrazione, visiva. parlata e agita, e che questa virtualità condivisa, che sta alla base del teatro, dia luogo ad un’esperienza umana che può essere molto significativa. Il gioco che si svolge tra l’attore e lo spettatore in teatro è sempre stato in definitiva un gioco di continuo rimando tra reale e virtuale, dato che il luogo ultimo dello spettacolo è da qualche parte nella testa dei suoi spettatori. Infatti, anche se la rappresentazione teatrale si svolge in uno spazio e un tempo ben definiti, l’esperienza che se ne ricava è senza dubbio virtuale: interna, immateriale e individuale, e coinvolge tutti i sensi. Si tratta di capire se oggi si possa usare la rete per significative ed efficaci esperienze sociali, come è per uno spettacolo teatrale.
Ora voler lasciare ai programmatori di mondi virtuali il controllo totale sulle forme e i modi della odierna ed invadente realtà virtuale, senza indagare sulle possibilità che la nostra immaginazione ha di spremere dalla rete altri momenti di scambio tra individui, altri luoghi dell’esperienza umana e altri corti circuiti creativi, vuol dire per me rinunciare ad adattare al mondo contemporaneo la forza dirompente della millenaria sapienza teatrale. Se dal pensiero teatrale si possono derivare elementi utili all’analisi dell’esperienza umana mediata dal computer, allora l’occupazione di spazi digitali da parte di queste nuove comunità teatrali, la creazione di strani eventi teatrali sul web, di cui si sta cominciando a parlare, non può che essere proficua e portatrice di nuovi sensi per il teatro contemporaneo.
Proviamo a vedere se la combinazione di interattività, partecipazione psichica e nuova intimità relazionale, che è caratteristica di alcune esperienze vissuta nel cyberspazio, può fornire la base per lo sviluppo di una nuova cultura artistico-teatrale.
La diffusione e il moltiplicarsi degli scambi sociali e delle esperienze umane vissute grazie al computer sembrano dimostrare che lo spazio tecnologico può "funzionare" come rappresentazione della realtà odierna, favorendo in parte la socialità e le relazioni affettive e psichiche tra le persone giovani. Dato che il nostro agire percettivo è sempre partecipativo, nel senso che siamo noi a scegliere che importanza dare a quello che percepiamo, si tratta di stabilire se l’esperienza vissuta in uno spazio tecnologico funzioni - o meno - come rappresentazione plausibile, non di una generica realtà, ma piuttosto della nostra percezione della realtà. E questo ognuno lo può stabilire autonomamente, scegliendo o meno di sperimentare questo tipo di esperienze e ricavandone o meno la propria soddisfazione personale. Si può arrivare alla strana contraddizione di poter comunicare più facilmente, e a volte con maggiore profondità, in assenza di corpi e di contatto fisico piuttosto che in presenza. Sembra paradossale, ma è un dato di fatto della realtà contemporanea. Internet, con i suoi forum, le sue chat, i suoi incontri tra sconosciuti, sembra permettere un’esperienza di rappresentazione che è individuale e collettiva insieme e che sta lasciando un segno nella vita di molte persone. Per quanto immateriale, l’esperienza vissuta grazie alla rete è da catalogare come reale perché è vissuta veramente e con intensità dalla comunità dei partecipanti.
Aldilà del teatro, sulla rete si incontrano da un po’ di tempo forme performative e di creatività appartenenti ad ambiti disciplinari differenti: arti visive, video, danza e quant’altro, identificate sotto l’etichetta della cosiddetta Netart. Queste diverse ricerche si intrecciano in modo transdisciplinare con il mondo del teatro, attraverso progetti che ruotano intorno alla necessità di ridefinire il corpo dell’attore e di considerare le sue protesi tecnologiche come estensioni del suo sistema sensoriale all’interno di ambienti digitali. Per chi sperimenta in rete, lo spazio digitale può effettivamente essere uno dei luoghi dell’esperienza umana e la partecipazione interattiva dello spettatore, resa possibile dalla connessione, può apportare modifiche alle modalità della narrazione teatrale o, a volte, allo svolgimento stesso dello spettacolo.
In conclusione: guardare a Internet come se fosse uno spettacolo permette di applicare il punto di vista del teatro ad un medium che è stato impropriamente assimilato alla televisione, mentre è un mezzo di comunicazione del tutto differente. Trovare un altro punto di vista per osservare il fenomeno Internet e le sue implicazioni sociali può dare la possibilità di sperimentarne un uso produttivo-creativo molto diverso da quello riproduttivo-manipolatorio a cui sembrava destinato.
Il teatro può essere uno del luoghi di critica sociale, per esercitare la nostra estraneità dall’uso dei nuovi media come strumento di propagazione di un pensiero dominante in cui stentiamo a riconoscerci. Ancora di più oggi, con la difficile situazione politica internazionale in cui ci troviamo, il teatro può essere, come ha scritto giustamente Fabrizio Cruciani "lo spazio a parte in cui si esaltano quei valori di interrelazione faticosamente e drammaticamente riconquistati alla negazione quotidiana".
I siti
Sulla scena internazionale sono significative le esperienze del progetto Arts in Multimedia, curato dalla Brooklin Academy of Music di New York, le attività dello ZKM , centro per arte e media diretto da Peter Weibel in Germania, i laboratori di ricerca scientifica del MIT di Boston, oltre ai tentativi più o meno riusciti di gruppi che si autodefiniscono teatrali come George Coats Performance Group, Electronic Disturbance Theatre, DeskTop Theatre, Surveillance Camera Players, Plaintext Players, Fakeshop, Gertrude Stein Repertory Theatre, Franklin Furnace, o di singoli performer come Stelarc o il nostrano Giacomo Verde con ZoneGemma. L’esperienza più istituzionale è forse quella realizzata nel 2001 da un gruppo di artisti e di tecnici di New York che porta lo strano titolo di The Technophobe and the Madman, primo musical via Internet,.
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
E se Il grande fratello fosse nostro cugino?
Alcune provocatorie tesi teatro e nuove tecnologie
di Oliviero Ponte di Pino
Se ci occupiamo di teatro e nuovi media, non possiamo escludere dal nostro orizzonte Il grande fratello: la trasmissione (giunta in Italia alla terza edizione, ottenendo un successo impressionante) da un lato può essere guardata e osservata con uno sguardo "teatrale", dall’altro pare mettere in pratica alcune delle utopie delle avanguardie storiche novecentesche. Dunque si impone un confronto non superficiale tra questa esperienza e quelle che vengono attualmente condotte sul versante del teatro web.
Quelli che seguono sono solo alcuni spunti di riflessione, volutamente semplificisti e provocatori. Ma li ritengo utili, perché possono aiutarci a fare prima confusione (e poi, chissà, chiarezza) nel groviglio pratico-teorico che ruota intorno al nodo teatro e nuovi media.
Una precisazione, per evitare equivoci nella lettura. Appartengo a una generazione che ha letto Orwell e per me la profezia del Grande Fratello è sempre stata e resta uno dei peggiori incubi - e ora pare sempre meno fantascientifica. Allo stesso modo Il grande fratello per molti aspetti mi ripugna, mi irrita, mi annoia, e dunque l’ho frequentato solo saltuariamente. Ma mi ripugna un po’ troppo. Dunque voglio capire meglio i motivi di questo disagio.
Il grande fratello, il format televisivo creato dalla società olandese Aran Endemol ed esportato con successo in molti paesi, compresa l’Italia, rappresenta uno dei fenomeni più innovativi della televisione generalista. Gli studiosi hanno parlato di "reality show" ("un programma basato su situazioni reali che coinvolgono persone comuni, presentate in un contesto narrativo", Aldo Grasso, Storia delle televisione italiana, Garzanti, Milano, 2000, p. 832) e di "tv interattiva", considerate le possibilità di intervento del pubblico. Hanno anche sottolineato che Il grande fratello non è solo una trasmissione televisiva, ma "coinvolge in maniera parossistica tv, pay-tv, radio, stampa, satelliti, internet, webcam, cellulari" (Aldo Grasso, cit., p. 700), ma anche una trasmissione parodistica (Mai dire grande fratello), una rivista, eccetera. Insomma è un meccanismo che consente un marketing di notevole ampiezza, che è il frutto di una diversa integrazione tra i media, di quella che Tatiana Bazzichelli definisce "transmedialità" (e questo è uno degli aspetti teoricamente più interessanti dell’intera operazione).
Per quanto riguarda gli elementi teatrali, vale la pena di individuare (con uno sguardo volutamente ingenuo) quelli presenti nel format (e quelli che non ci sono). Anche se già qui emerge un problema: seguire Il grande fratello sul web oppure seguirlo il giovedì sera su Italia 1 sono due esperienze diverse, perché si svolgono in contesti mediatici differenti. Nelle considerazioni che seguono, questa distinzione resta in secondo piano; il presupposto implicito è che il medium di riferimento, per così dire, sia Internet.
In primo luogo (presupponendo che chi legge conosca già i meccanismi fondamentali del programma) vengono identificati con assoluta precisione un tempo e uno spazio in cui ha luogo la performance: un numero di settimane predeterminato e la "Casa". E’ l’identificazione di uno spazio e tempo diversi da quelli della vita quotidiana e della normalità: per gli inquilini della Casa la discontinuità dalla vita quotidiana è drammatica, e si riflette nella percezione e nell’attenzione del pubblico.
Quante esperienze artistiche di frontiera degli ultimi decenni sono partite da condizioni analoghe di autoconfinamento e di esibizione di sé? Basti pensare a Beuys, Stelarc, Abramovic. Certo, sono state condotte con maggiore consapevolezza e radicalità - ma partono in ogni caso dall’idea di rendere in qualche misura il proprio corpo "ostaggio" dell’evento, e garanzia della sua verità. Forse i protagonisti del Grande fratello, non hanno piena coscienza di questo fatto - ma l’hanno sicuramente i suoi creatori, come l’avevano e l’hanno molti dei militanti che in questi decenni hanno prestato il loro corpo a manifestazione di carattere politico o sindacale, arrivando a volte all’autodistruzione.
Dal punto di vista del teatro, questo tempo e questo spazio rappresentano il "qui e ora" dell’evento: la diretta televisiva o web crea e produce l’evento in diretta. Non sono le condizioni di una normale trasmissione televisiva (che ha il suo tempo e il suo spazio), perché questo limite così esplicitato assume una connotazione rituale, quasi sacrale.
Vengono poi identificati gli attori-performer, scelti attraverso un attento processo di selezione e consacrati dall’ingresso nello spazio scenico. E’ interessante notare come queste "persone" diventino per presto "personaggi". I diretti interessanti sono ovviamente consapevoli di essere i protagonisti di una rappresentazione (e sanno che vengono visti in tutta Italia); inoltre possono (anzi, devono, se vogliono avere successo) seguire una strategia di dissimulazione: per evitare di essere eliminati devono indossare una serie di maschere, per esempio si comportano diversamente con i loro coinquilini o nel confessionale dove parlano con il GF. Le conversazioni con il GF, tra l’altro, sono veri e propri "a parte" ("convenzione per cui l’attore non parla più rivolgendosi all’interlocutore, ma tra sé: in pratica rivolgendosi al pubblico per fargli conoscere il suo intimo pensiero", Enciclopedia dello spettacolo, Garzanti, Milano, 1977, s.v.).
Dal punto di vista del pubblico, gli internati della Casa diventano via via più riconoscibili: con il passare del tempo, se ne colgono sempre più nitidamente carattere, psicologia, emozioni, motivazioni... Molti di essi diventano vere e proprie maschere, caratteri da Commedia dell’Arte (in questo aiutati dal talento della Gialappa’s); in questo, soprattutto nell’ultima edizione, ha influito la scelta di "regionalizzare" e caratterizzare maggiormente i concorrenti: quelli delle edizioni precedenti apparivano interscambiabili e «carini», tutti figli dell’«Italia da bere» berlusconiana; quelli dell’edizione 2003, rivendicando la loro "etnicità", hanno fatto evocare ad alcuni commentatori addirittura Pasolini per la loro vera o presunta "originarietà". Ovviamente dal punto di vista teatrale i personaggi del Grande fratello ricadono in una particolare categoria: quella di "attori che siano essi stessi personaggi (si pensi a Chaplin o a Totò, a Woody Allen o a tanti protagonisti dello spettacolo leggero); l’identificazione può arrivare al punto da impedire in pratica all’attore l’interpretazione di personaggi diversi dal proprio" (Enciclopedia dello spettacolo, s.v.). Ma questo al rassicurante teatrino televisivo va benissimo: creato il personaggio, l’icona, lo si può sfruttare fino a sazietà (del pubblico).
Creando un personaggio, gli inquilini della Casa impongono al pubblico un modello: tanto nel modo di essere tanto nella consapevolezza di sé (soprattutto attraverso i monologhi al Confessionale). Diffondono anche dei moduli di comportamento: l’ostentata sincerità sulle proprie vicende e sentimenti, l’accettazione del fatto che siamo sempre controllati, ma anche una sostanziale ipocrisia: nel panopticon della Casa non possano esserci segreti, ma la strategia vincente prevede un margine di dissimulazione confronti sia degli altri inquilini, che si vogliono eliminare e metaforicamente "uccidere", mentre una convivenza sostanzialmente pacifica è in qualche modo imposta e accettata dalle regole della Casa.
Dati un qui e ora (e una compresenza del pubblico - seppure non fisica, ma attraverso la diretta) e una serie di attori-personaggi, l’altro elemento teatrale fondamentale è la drammaturgia. Quella del Grande fratello ha diversi livelli. Il primo, diciamo così, è quello del plot ("l’ossatura, la sinossi del dramma [con] i nomi degli attori... le entrate e le uscite dei personaggi, gli attrezzi necessari allo spettacolo", Enciclopedia dello spettacolo, cit.). Il plot del Grande fratello ricorda certi gialli di Agatha Christie. C’è un gruppo di persone confinato in uno spazio chiuso (una villa di campagna, l’Orient Express, la nave in crociera sul Nilo); a una a una vengono progressivamente eliminate da un serial killer. Nei gialli di Agatha Christie bisogna scoprire l’assassino. Qui l’assassino è il pubblico. Il mistero riguarda le vittime: chi NON verrà ucciso da questo implacabile serial killer, che colpisce regolarmente ogni settimana? In questo aspetto di imprevedibilità (e nel versante agonistico della lotta tra gli inquilini) Il grande fratello è più simile a un evento sportivo, anche se la struttura portante resta quella teatrale.
Un secondo livello drammaturgico riguarda una serie di eventi ripetitivi: abbiamo già citato gli ingressi nel Confessionale, ma a questa categoria appartengono anche le "nomination" con cui i reclusi scelgono periodicamente i compagni che vorrebbero espellere, e poi ovviamente l’eliminazione-esecuzione del concorrente che gli spettatori scelgono tra i più "nominati". Infine ci sono le sorprese, i piccoli soggetti, i minicopioni inseriti per ravvivare la vita monotona di quel carcere mediatico: le prove da superare, le "sorprese", eccetera. Si crea così una griglia assai complessa, se si considera che è accompagnata da una ampia serie di regole che determinano quello che si può fare e soprattutto non fare nella casa: niente giornali, libri, radio, musica e neppure, paradossalmente, televisione. Nessuno scambio di notizie con parenti e amici, salvo eventuali "visite" via video nel corso della trasmissione tv. Eccetera eccetera.
La Casa è dunque uno spazio totalmente fittizio, un luogo altro, una sorta di utopia, o di agghiacciante contro-utopia. In questo contesto ipercontrollato, alla fine, le reazioni dei personaggi e i loro dialoghi hanno un grado di libertà (di improvvisazione, se vogliamo) piuttosto predeterminato e limitato. Diciamo che Il grande fratello ha un copione con un plot e una serie di soggetti; dopo di che dà spazio a una serie di azioni, di performance da parte degli inquilini della casa. Ma i gradi di libertà sono maggiori di quelli di un tradizionale spettacolo teatrale, ma restano assai limitati.
Considerate queste affinità, sarebbe possibile leggere puntata dopo puntata Il grande fratello come un evento teatrale, con gli strumenti di analisi messi a punto con questo obiettivo. Vale la pena di notare che gli autori del format dimostrano una notevole padronanza delle grammatiche dei media e delle possibilità di trasferire alcuni elementi da un medium all’altro. Ma non è tutto. Un secondo aspetto, forse ancora più interessante, riguarda la maniera in cui questi elementi teatrali vengono fatti interagire con i nuovi media, mettendo di fatto in pratica alcune delle visioni delle avanguardie novecentesche.
Nella tradizione della avanguardie ci sono alcune utopie ricorrenti, che possono essere coniugate in diverse maniere. Per esempio l’annullamento della distanza tra teatro e vita, tra realtà e rappresentazione. Il grande fratello trasforma - nelle condizioni che abbiamo esaminato - la vita in teatro, gli spettatori in attori. Non sono gli attori presi dalla strada del neorealismo: i reclusi del GF erano davanti al piccolo schermo, e sono passati semplicemente al suo interno. I "quindici minuti di celebrità" che Andy Warhol aveva promesso a tutti noi diventano la regola. Pare il trionfo di una democrazia creativa dove chiunque ha qualcosa da dire e il diritto di dirlo (a otto milioni di persone!).
Se questo aspetto riguarda il versante arte-vita, l’altro versante riguarda le possibilità di espansione e ridefinizione del rapporto del pubblico con tra l’evento attraverso le nuove tecnologie. La direzione è ovviamente quella di un maggiore coinvolgimento dello spettatore nel determinare il corso dell’evento teatrale, intervenendo sul qui e ora.
Nel Grande fratello è il pubblico a determinare lo svolgimento dello spettacolo, in una forma di coinvolgimento formalmente (ancora una volta) "democratica": attraverso il voto telefonico sceglie settimana dopo settimana l’indiziato (il nominato) da eliminare. In qualche misura, il pubblico diventa attore e personaggio. Se Il grande fratello fosse un vero giallo, l’assassino non sarebbe probabilmente il protagonista, ma in ogni caso il personaggio principale, quello che con il suo delitto mette in modo l’azione drammaturgica. Anche nel Grande fratello il pubblico, pur non essendo il protagonista, è il personaggio principale: è quello che riconduce alla normalità e alla libertà i reclusi della casa (anche se si tratta di una libertà assai strettamente vigilata: i reduci della trasmissione, almeno nei primi mesi, paiono vivere all’interno del piccolo schermo, dove girovagano da una trasmissione all’altra come anime in pena). Ma è importante notare che il pubblico in qualche modo decide dello sviluppo del plot ("le entrate e le uscite dei personaggi", con tutto quello che ne consegue): e sono anche qui numerosi gli esperimenti che in passato hanno seguito questa strada, con risultati spesso meno convincenti.
Il coinvolgimento del pubblico trova sul web un’altra declinazione: attraverso le diverse webcam disseminate nello spazio scenico, il visitatore può determinare il proprio punto di vista e (se si vuole) la propria trama, la propria sequenza: che so, seguendo unicamente un personaggio attraverso i vari sottospazi che occupa, oppure seguendo unicamente quello che accade in una determinata stanza. In questo senso, la televisione resta più vicina al cinema, che impone il punto di vista; il web rimanda invece a uno sguardo teatrale, dove lo spettatore può scegliere dove focalizzare l’attenzione.
Prese singolarmente, queste pratiche erano già presenti in molte esperienze (di televisione, di web, di teatro-web). In questa occasione, hanno trovato una applicazione sinergica e soprattutto hanno coinvolto attivamente un pubblico di massa. Per certi aspetti, è un’opera di alfabetizzazzione che ha portato esperienze elitarie a una fruizione molto più ampia.
Dal punto di vista estetico, è chiaro che per un critico teatrale Il grande fratello è un fallimento. La scenografia è squallida, la casa è di rara bruttezza, ricorda l’asettico anonimato delle carceri socialdemocratiche del Nord-Europa. I personaggi sono, a dir poco, banali. Lo loro esperienze - quelle che vivono nella Casa, ma anche il loro passato - rappresentano volutamente la normalità corrente. Alla fine, non hanno niente da dirci, solo che esistono - ma non ne sono sicuri neppure loro, e infatti sono finiti in quegli arresti domiciliari per esibizionisti. (Chi ha davvero qualcosa da dire e da fare, chi ha preso qualche impegno nei confronti della vita e degli altri, difficilmente può permettersi tre mesi di isolamento totale dal mondo). In genere nella Casa non succede quasi nulla, e quel poco non è interessante. Il meccanismo della suspence è tra i più consunti.
Tuttavia questo intreccio di noia e banalità, al di là del clamoroso successo che ne ha fatto un vero fenomeno di costume, pone un’ampia serie di questioni. Da un certo punto di vista, è inevitabile e normale che tecnologie e tecniche d’avanguardia trovino più vaste applicazioni. Il nodo è: che cosa accade durante questo processo?. E’ evidente che Il grande fratello, pur utilizzando tecnologie che hanno uno straordinario potenziale estetico e liberatorio (anche rispetto al mezzo televisivo), ne fa un uso limitato, limitante e regressivo. Sulle ragioni di questo risultato, si possono fare diverse ipotesi.
1. E’ una trasmissione gestita da mega-colossi dell’informazione, sotto stretto controllo politico. Dunque che pretendiamo? Viene però da chiedersi se sarebbe possibile di fare un Grande fratello «indipendente», che funzioni senza essere regressivo, se è possibile usare le stesse tecniche e tecnologie per costruire consapevolezza e reale senso di comunità.
2. A irrigidire il processo comunicativo del Grande fratello è la sottostante struttura teatrale, l’idea che ci siano un plot e un gruppo chiuso di personaggi, insomma una griglia rigidamente prestabilita che nella sua natura resta tendenzialmente autoritaria, perché crea nell’immaginario strutture rigide. Se si accetta questa opzione e la si radicalizza, qualunque forma diamo alla comunicazione rischia di essere considerata un limite insopportabile. Anche una chat, in apparenza un medium con pochissimi vincoli, ha in realtà una struttura molto rigida.
3. E’ quel plot che non funziona. O meglio, il plot funziona sin troppo bene, nel senso che sembra riflettere il nostro attuale rapporto con gli altri e con il mondo. Esiste un potere superiore che ci controlla, ci condiziona e determina le nostre vite. C’è un’entità, anch’essa invisibile e astratta, che decreta il nostro successo e insuccesso (il mercato, il pubblico). Noi siamo soli (non ci sono parenti e amici, nella Casa) e dobbiamo sopravvivere a ogni costo, con tutti i mezzi, seppure all’interno delle regole stabilite dal GF; e sopravvivere vuol dire eliminare l’altro, toglierlo di mezzo. Vale la pena di ricordare che un programma analogo, Saranno famosi, ambientato nel mondo degli aspiranti showman e showgirl, ha una struttura analoga, e presuppone un’idea di spettacolo decisamente mattatoriale, basato sullo scontro e non sulla collaborazione, sulla concorrenza più spietata e non sulla pratica intorno a un progetto comune. Quella del GF è la logica che in questa epoca di downsizing e «razionalizzazione» pare dominare i luoghi di lavoro, e in genere molti rapporti sociali. E’ la logica del potere e della forza. Oltretutto si fonda sul sadismo inconsapevole del pubblico, che fa una scelta più «contro» che «pro». Ma è possibile costruire un plot che porti invece all’emancipazione di tutti, invece che alla soddisfazione del narcisismo di qualcuno? E che sia appassionante e coinvolgente per il grande pubblico, senza cadere nella banalità didascalica?
4. Queste nuove tecnologie, al di là degli usi che ne vengono fatti da piccole élite, ottengono in ogni caso un effetto devastante. Il male può essere nella tecnologia in sé, oppure nel fatto che le nuove tecnologie, dalla radio alla tv alla rete, permettono di fare un uso massificato di un evento comunicativo o estetico. Nei due casi la sostanza non cambia. Meglio dunque restare ancorati alle forme più tradizionali, magari alla più tradizionale di tutte: il teatro vissuto come incontro reale tra un attore e uno spettatore, senza alcuna mediazione.
5. Un’arte davvero democratica (qualunque giudizio diamo della democrazia come forma di organizzazione politica) non può esistere. L’eccellenza artistica è un dono di pochi: pochissimi grandi e autentici artisti, solo un’élite li può apprezzare. Le aperture democratiche creano ambiguità e confusione, e producono inevitabilmente opere di bassa qualità. Forse esisteranno capolavori di web theatre, ma saranno per pochi. Il grande fratello e operazioni analoghe sono un’altra cosa, non è e non saranno mai arte perché lavorano sulla banalità quotidiana e su una umanità massificata, dall’una e dall’altra parte dello schermo.
Quelle appena descritte sono posizioni volutamente rozze e caricaturali. Ma hanno lo scopo di suggerire una riflessione sulla valenza politica (e non solo estetica) delle nuove tecnologie.
In questi anni si sono innestati anche «processi virtuosi», se così vogliamo dire. L’esempio più clamoroso è quello della documentazione video realizzato a Genova durante il G8 nel luglio del 2001: un processo di autorappresentazione collettiva e di controinformazione militante di ampio respiro, e che potrà avere significative ricadute sulla pratica comunicativa. Non a caso la controcassetta realizzata dal «Foglio» in occasione della contromanifestazione romana pro-Israele non ha avuto alcun impatto significativo.
Un’altra novità degna di attenzione è l’emergere delle nuove street-tv: un fenomeno che per certi aspetti ricorda l’esplosione delle radio private negli anni Settanta (e in certi casi ha gli stessi protagonisti ma, speriamo, non avrà la stessa parabola di integrazione e appiattimento).
Anche nelle varie forme di ibridazione tra teatro e nuovi media, il rapporto tra l’aspetto tecnico, quello estetico e quello politico è cruciale, sia sul versante della progettualità creativa sia da quello della fruizione e dell’analisi. Gli esperimenti pionieristici condotti finora in questo settore hanno affrontato il nodo in diverse maniere, senza ancora riuscire (a mio avviso) a costruire un format che abbia la stessa coerenza e l’efficacia (sebbene discutibile) del Grande fratello.
Ancora sul teatro politico
Un intervento per "Hystrio"
di Oliviero Ponte di Pino
Il n. 2 (2003) di "Hystrio" ha un ricco dossier sul Teatro politico, con interventi di Renato Palazzi, Pier Giorgio Nosari, Giampaolo Spinato, Pino Pelloni, Alessandra Faiella, Alessandro Trigona Occhipinti, Anna Ceravolo, Nando Dalla Chiesa, Martina True e Simona Maggiorelli.
Il dossier è aperto da questo intervento di Oliviero Ponte di Pino, che riprende e aggiorna alcuni spunti del saggio Per un teatro politico?, pubblicato nel 1996 sul Patalogo 19 e disponibile in rete.

Uno dei bozzetti realizzati da Daniela Dal Cin per la copertina di "Hystrio".
Il teatro è un’arte politica. Ma il teatro è una cosa diversa dalla politica.
Tra queste due verità - note dai tempi degli antichi greci, che non avevano edificato il loro teatro né sull’Acropoli né nella Boulè - si muovono la pratica e la riflessione sul teatro politico.
In Italia, abbiamo visto con qualche ritardo, alla fine degli anni Cinquanta - grazie a Giorgio Strehler e al Piccolo Teatro - la prima esplosione del teatro di Bertolt Brecht, destinata a perpetuarsi in una voga durata oltre un ventennio e punteggiata dai grandi allestimenti del Piccolo Teatro: dall’Opera da tre soldi nel 1956 allo scandalo del Galileo nel 1963, dalle polemiche sull’allestimento "kolossal" di Santa Giovanna del Macelli nel 1970 all’Anima buona di Sezuan nel . Quella di Brecht resta senz’altro la più complessa riflessione sul rapporto tra teatro e politica, tanto da aver generato una intera ideologia - quella del teatro epico - e una teoria estetica - quella dello straniamento. Nella visione brechtiana, le contraddizioni e i conflitti che attraversano e dividono la polis e i suoi singoli cittadini si riverberano all’interno del segno teatrale, generando nuovi significati.
In quegli stessi anni Cinquanta un’altra allieva - come Brecht - del primo teorico del teatro politico, Erwin Piscator, creava un nuovo gruppo teatrale, che assimilava nella logica del teatro politico la lezione di Antonin Artaud. Per Judith Malina e il suo Living Theatre la politica non passava soltanto attraverso quello che veniva detto dall’attore o dal suo gesto, ma ne attraversava il corpo.
Non c’è dubbio che queste due prospettive abbiano accompagnato i sommovimenti degli anni Sessanta e Settanta. Da un lato un teatro che parte dal corpo, e dunque dall’individuo, nella sua singolarità e fisicità, nelle sue profondità per generare strumenti di autoanalisi e di liberazione personale - con il rischio, alla lunga, di ridursi a tecnica della felicità o per esplorare le terre del mito e degli archetipi. Dall’altro un approccio più tradizionale, dove il teatro è un mezzo per conoscere (o al peggio propagandare) una verità sul mondo - con la prospettiva di un teatro subordinato alla politica, che lascia in secondo piano gli aspetti più propriamente estetici. Almeno finché Heiner Müller non ha iniziato ad applicare - con inedita radicalità - il metodo brechtiano alla realtà del socialismo reale e alla stessa logica drammaturgica e politica brechtiana (in particolare ai "drammi didattici"), giungendo fino al punto di rottura.
Con gli anni Ottanta, dopo il tramonto dei movimenti politici che avevano caratterizzato la fase precedente, anche il teatro politico sembrava archiviato tra gli arnesi del passato. Il comunismo sovietico, al quale Brecht si era legato, era ormai prossimo al tracollo. Il Living Theatre, disperso e indebolito dopo le scissioni e gli arresti brasiliani ma sempre fedele ai suoi ideali anarchici, pareva destinato a una nobile marginalità, così come il Bread & Puppet di Peter Schumann - un’altra grande esperienza di teatro politico cresciuta con i movimenti pacifisti degli anni Sessanta. Più in generale, era la stessa dimensione politica ad apparire marginale, nell’età del riflusso e del narcisismo: un’epoca in cui le forme d’identità ereditate dal passato (ideologica, di classe e censo, geografica) diventano sempre più fragili, e anche i ruoli sessuali cercano nuove definizioni. Non è un caso che la tradizionale prospettiva politica sia stata rilanciata e al contempo messa in crisi anche e soprattutto dai movimenti gay e femminista (che non a caso negli anni Settanta trovarono subito espressione sulle scene, negli Stati Uniti come in Europa).
Dopo una sorta di eclissi, tuttavia, negli ultimi anni anche Italia il teatro politico sembra aver trovato nuove necessità, motivazioni ed energie, in varie forme e per molteplici ragioni.
Una prima linea di resistenza, forse la più facile, l’hanno tracciata i comici, che spesso riescono ad anticipare e interpretare gli umori profondi del pubblico. L’indomito Dario Fo continua a produrre la sua satira militante, fino ai recenti lavori sul caso Marino e su Berlusconi-Ubu. Sulla sua scia si sono mossi in tanti, prima nei cabaret e nei teatri, e alla fine in televisione: Paolo Rossi ha messo alla berlina Tangentopoli con la sua gag sul pianeta Craxon e l’irresistibile canzonetta ad Hammamet; ma in molti hanno fatto a gara nel fondare partiti politici che prefiguravano e facevano concorrenza a Forza Italia: ci hanno provato Beppe Grillo (30 giugno 1994: "Domani fondo un nuovo partito, il partito del ‘Come va? Bene, grazie’. E alle prossime elezioni mi candido. Scommettiamo che batto tutti?"), Claudio Bisio (8 gennaio 1995: "Quando eravamo a Viterbo, sui muri della città c’erano manifesti del mio spettacolo Tersa Repubblica, dove mi si vede in una immagine bella patinata, vestito di tutto punto, sorriso a trentadue denti, lo sguardo rassicurante. Un po’ in stile seconda Repubblica, insomma. Quando il sindaco, credo democristiano, li ha visti si è allarmato: ‘Bisio? Chi è ’sto Bisio? Sarà mica il candidato di Forza Italia?’, pare abbia chiesto ai suoi collaboratori. ‘Che fa? Comincia già ora la campagna elettorale? E’ sleale!’"), Paolo Hendel, Roberto Benigni (21 febbraio 1995: "Io vorrei tanto metter su un partito con lei, Biagi. Ora va di moda gli alberi, si prende per simbolo un bel pero. Slogan: fate una pera, e come va a finire va a finire"); i fratelli Guzzanti con le loro imitazioni hanno messo alla berlina un’intera classe politica. Nell’ultima campagna elettorale, i veri leader della sinistra sono stati Daniele Luttazzi e Roberto Benigni: il primo invitando nel suo Satyricon il giornalista Marco Travaglio, il secondo dicendo la sua su Silvio Berlusconi nel Fatto di Enzo Biagi - decretando la fine della carriera Rai del decano del giornalismo italiano. Così è tornato alla ribalta un antico terreno di scontro tra il teatro e la politica: un vecchio arnese come la censura torna d’attualità - a dimostrazione che forse la satira non ha ancora perso tutta la sua efficacia. Nell’estate del 2002 a Siracusa basta un manifesto con Berlusconi e Fini messo in scena per ridare forza alla tragedia greca, e su Luca Ronconi si scatena il putiferio.
In questo vuoto di comunicazione e riflessione politica, comici, cantautori (Jovanotti e Bono dal Papa per parlare del debito del Terzo Mondo) e registi cinematografici (Nanni Moretti che diventa il profeta dei girotondi) rappresentano provvisori punti di riferimento - anche se alla lunga non possono fornire questa supplenza a tempo indefinito, a meno di non diventare buffoni di corte.
Nel frattempo, però, il teatro aveva già ricominciato ad affrontare in una prospettiva diversa le problematiche politiche e civili che sembrava aver abbandonato, in nome dell’autonomia dell’estetico.
Non è un caso che una prima linea di ricerca sia partita dal lavoro sulla marginalità e sul tema della diversità - e in definitiva dalla riflessione sull’identità. Prima ancora che un’arte esplicitamente politica, è un teatro che esce dai suoi luoghi deputati per lavorare nel sociale - o meglio, nelle aree della marginalità sociale: per esempio, il lavoro nel carcere (vedi il lavoro di Armando Punzo a Volterra), con i portatori di handicap (vedi le esperienze dei francesi Oiseau Mouche e della compagnia di Pippo Delbono), con gli immigrati (vedi il percorso delle Albe-Ravenna Teatro). Il teatro offre in primo luogo una serie di strumenti e di tecniche che possono portare a una maggiore consapevolezza e all’espressione di sé; al tempo stesso, porta sulla scena - e dunque in uno spazio di visibilità pubblica per la città - fasce fino a quel momento escluse dal comune. La marginalità (e il conflitto sociale esplicito o latente che essa implica) trovano visibilità e occasioni di riflessione, portano a una crescita della consapevolezza dell’altro che potrà eventualmente portare a una evoluzione dell’atteggiamento politico. Al teatro, queste esperienze portano un rinnovato senso della propria necessità (e forse a una rifondazione del suo statuto), e una diversa qualità di energia e di presenza. Questi "teatri delle diversità" ricordano, soprattutto, che a teatro il nuovo non nasce solo e tanto dal centro, dalle grandi istituzioni, ma dalle periferie - e dall’incontro, dallo scambio.
Un secondo filone di lavoro, anch’esso cresciuto quasi in clandestinità e poi assurto a grande fortuna, fino a diventare un modulo estetico, riguarda l’incrocio tra teatro civile e teatro di narrazione, al quale hanno fatto riferimento Marco Paolini e Laura Curino (con il supporto registico-drammaturgico di Gabriele Vacis), Marco Baliani, Ascanio Celestini. Nei loro spettacoli raccontano gli eventi e i personaggi che hanno coinvolto la collettività, dal Vajont al caso Moro, da Adriano Olivetti a Ilaria Alpi, da via Rasella alla vita di fabbrica a Ilaria Alpi... Per questi autori-attori si tratta in primo luogo di ritrovare un rapporto con una memoria collettiva cancellata dalla frantumazione del corpo sociale, dall’abulia delle istituzioni scolastiche e dalla programmatica smemoratezza dei mass media (oltre che dalle miopi distorsioni dei vari revisionismi). Ma non è solo di un problema di contenuti: è necessario costruire nuove modalità di comunicazione e una legittimità e autorevolezza che rendano credibile questa figura insieme nuova e antica.

Uno dei bozzetti realizzati da Daniela Dal Cin per la copertina di "Hystrio": questo, realizzato per primo, è rimasto inedito.
L’irruzione sulla scena politica e mediatica di nuovi movimenti - prima quelli per i diritti umani e civili (per esempio quelli contro la pena di morte e contro la tortura) e poi naturalmente i no-global - ha immediatamente trovato una eco sulle scene. Il teatro resta un mezzo di comunicazione economico, flessibile, versatile, efficace. Crea uno spazio di riflessione pubblico, una occasione di scambio di esperienze immediatamente fruibile. Può invadere lo spazio urbano, con forme che vanno dalla parata all’agit prop, dall’installazione alla performance. Non è dunque un caso che dopo i fatti di Genova del luglio 2001 a finire in carcere sia stato un intero gruppo teatrale, la PublixTheaterKarawane austriaca.
A spingere verso una diversa e più acuta sensibilità politica del teatro sono stati anche i conflitti che continuano a insanguinare il pianeta - e quelli prossimi venturi. La tragedia della ex-Jugoslavia - un evento terribilmente vicino e "impensabile" - ha ispirato a Mario Martone un film dal titolo emblematico, Teatro di guerra, che non a caso ruota intorno alla messinscena di una tragedia di Eschilo, I sette contro Tebe, e intorno alla nostra impotenza di fronte a quell’orrore. Dopo i fatti di Genova e gli attentati dell’11 settembre, quella che poteva apparire un’efficace metafora si sta rivelando un nodo cruciale. La svolta verso l’impegno politico di Harold Pinter - per certi aspetti sorprendente - in atto da alcuni anni pare un sintomo premonitore. Il grido rabbioso e disperato di Sarah Kane - che era partita proprio reagendo alla guerra nella ex-Jugoslavia con Blasted - diventa un’esperienza condivisa, nella sua capacità di coniugare disagio personale e disperazione politica. in Germania René Pollesch si scaglia contro la globalizzazione con una fluviale trilogia. Anche in Italia drammaturghi come Fausto Paravidino si sporcano le mani con l’attualità politica. Tornano in scena - non solo e tanto come classici della drammaturgia contemporanea, ma per bisogni legati all’attualità - i testi di Brecht e La morte accidentale di un anarchico di Fo.
Sono solo alcuni segni, in uno scenario ricchissimo di fermenti e curiosità, che utilizza strumenti vecchi e nuovi in mix spesso inediti. Ma nel frattempo le istituzioni culturali sembrano sempre più chiuse su se stesse, il teatro pubblico diminuisce i margini di rischio, gli spazi si restringono. Il teatro di guerra diventa anche il tentativo di incidere sulla politica del teatro. Il teatro politico si muove per sua natura nell’area dello scontro e del dissenso. Nella tradizione occidentale, il palcoscenico è il luogo dove le divisioni che attraversano il corpo sociale e il dissenso possono venire alla luce e diventare oggetto di esperienza, consapevolezza e riflessione collettiva. Oggi i conflitti vengono cancellati, rimossi, occultati. Oppure vengono irrigiditi in contrapposizioni frontali da leggere solo come rapporti di forza (parlando però sempre di guerra del bene contro il male, in un teatrino davvero misero...). La funzione del teatro politico è quella di riportare il conflitto al centro della scena, perché possa trovare uno sbocco e un’espressione politica. Senza pensare che il teatro è politica, ma senza dimenticare di essere anche politica.
Per un teatro politico?
dal "Patalogo 19"
di Oliviero Ponte di Pino
Pubblicato originariamente sul "Patalogo 19", 1996.
"Le arti che non realizzano alcuna ‘opera’ hanno grande
affinità con la politica. Gli artisti che le praticano - danzatori, attori,
musicisti e simili - hanno bisogno di un pubblico al quale mostrare il loro
virtuosismo, come gli uomini che agiscono hanno bisogno di altri alla cui
presenza comparire: gli uni e gli altri, per ‘lavorare’, hanno bisogno di uno
spazio a struttura pubblica, e in entrambi i casi la loro ‘esecuzione’ dipende
dalla presenza altrui. Tale spazio destinato alle apparizioni degli uomini non
è affatto un attributo fisso e scontato di qualsiasi comunità. La polis
greca fu appunto quella ‘forma di governo’ che forniva agli uomini uno spazio
per apparire, nel quale agire, una sorta di teatro dove la libertà poteva fare
la propria comparsa".
Hannah Arendt, Tra passato e
futuro
"L’arte e la politica non funzionano come due ingranaggi
sincronizzati; un’idea non può essere trasposta semplicemente in un’immagine,
a meno di ottenere un quadro storto o un’esplosione dell’idea. Io sarei
piuttosto per l’esplosione".
Heiner Müller,
1983
"Per la politica ‘passare’ da Costanzo
è importantissimo, se Costanzo
passasse alla
politica subirebbe
una diminutio".
Enrico Mentana, 1996
La questione del teatro politico, oltretutto, pareva risolta già in precedenza. Il problema, si argomentava, non è quello dei contenuti. Come diceva Godard, non si tratta di fare film politici (o spettacoli politici o libri politici), ma di farli "politicamente": il punto è l’elaborazione dei materiali, la forma, poiché la qualità politica di uno spettacolo non dipende tanto dai contenuti, o dalle etichette che esibisce, quanto dall’uso del linguaggio e dal rapporto di comunicazione con il pubblico. Bisogna inoltre tener conto del paradosso del "politically correct", con il suo paternalismo apparentemente bonario. In teoria, il "politically correct" avrebbe dovuto sancire il trionfo delle preoccupazioni "politiche" in qualsiasi discorso pubblico. Tuttavia, nascondendo i conflitti dietro la griglia degli eufemismi, degli interdetti e dei divieti linguistici, innesca un meccanismo di autocensura che rischia di cancellare la realtà dello scontro politico. Di conseguenza, fermo restando che di qualsiasi testo e spettacolo si può dare una lettura politica, un teatro esplicitamente "politico" pareva confinato ad un’età adolescenziale dell’evoluzione estetica, quando ancora era possibile confondere l’arte con la propaganda, subordinare l’estetica all’ideologia.
Eppure, malgrado tutto questo, e contro ogni logica e previsione, di recente in Italia sono state numerose le iniziative che focalizzano esplicitamente l’attenzione e le emozioni dello spettatore su tematiche politiche e civili. Ancora più significativo, il fatto che questa tendenza sia avvertibile soprattutto tra i più giovani, sia nelle scelte di molti gruppi di recente formazione, sia nei tentativi di scrittura drammaturgica presentati ai vari premi.
Questo ritorno all’impegno ha assunto forme diverse, esplicite ed impensabili solo qualche anno fa: passando dal recupero del dimenticato Brecht agli spettacoli pro-Sarajevo, dal monologo sulla pena di morte al lavoro con carcerati o portatori di handicap o malati di Aids, dalla riflessione critica in forma di spettacolo su alcune pagine di storia recente (dalle guerre mondiali alla Resistenza, dall’Olocausto al Vajont, fino alla cupa stagione del terrorismo, rivisitata magari con la collaborazione dei protagonisti) ai laboratori nei centri sociali, dalle compagnie multietniche alle ballate per le vittime della mafia, senza dimenticare la satira dei "comici di sinistra".
In ogni caso se oggi si pratica un teatro politico, non ha un unico modello, non segue un solo schema. Risponde presumibilmente a necessità variegate, tanto da parte di chi lo fa quanto da parte del suo pubblico. L’unico elemento comune è probabilmente l’esigenza di usare il teatro per trasmettere un messaggio che è (anche) politico. Ovvero di compiere un gesto politico che assume una forma teatrale.
Questo revival tradisce forse la nostalgia per un’efficacia che il teatro (e la politica) sembra aver perduto, e che solo alcuni "profeti", considerati con sufficienza dai più, come se fossero solo sopravvivenze del passato, come Dario Fo, o Judith Malina e il suo Living Theatre, hanno disperatamente cercato di tenere viva. O forse è l’indizio di un’esigenza più profonda, e segna ancora una volta la necessità del teatro di misurarsi con la propria storia, e ritrovare continuamente le proprie origini. Andando però alla ricerca di un impegno politico e civile che rifiuta l’ideologia, per muoversi in una zona che è insieme "prima" e "oltre" la politica, così come viene tradizionalmente intesa.
Brecht
Parlare di teatro politico significa inevitabilmente rievocare l’autore-simbolo del genere, il vecchio e tanto bistrattato B.B. A utilizzarlo direttamente come arma para-elettorale ci aveva provato un paio di stagioni fa il Teatro di Genova, con una messinscena della Resistibile ascesa di Arturo Ui: il protagonista Eros Pagni alludeva, senza ombra di dubbio, al nemico numero uno del momento, il Cavalier Silvio Berlusconi. Nelle parole del regista Marco Sciaccaluga, la prima delle "emozioni" che l’ha spinto a mettere in scena il testo è stato proprio "l’enorme, quasi imbarazzante, rimbalzare di situazioni, battute, temi e trame che rimandano, non solo metaforicamente, all’attuale grande travaglio della società italiana: la consonanza tra i poteri finanziario, mafioso e politico nel loro perverso potere di dominio sul mondo". Perché "in Arturo Ui sono sommati il grande capomafia, il politico che ha fatto del cinismo finanziario la sua arma più importante, quello che ha accettato di scendere a patti con la malavita e da questa poi è stato ricattato. C’è anche il grande comunicatore moderno, che sa bene cosa sia la propaganda. Arturo Ui è la maschera che li contiene tutti. Guai però a indicarne con precisione una sola faccia" (dal programma di sala dello spettacolo).
E’ fuor di dubbio che nel testo brechtiano non manchino possibili agganci all’Italia della Seconda Repubblica. Ma, aldilà della buona volontà degli artefici dello spettacolo (e aldilà delle forzature nel parallelismo Weimar 1933-Italia 1993), nell’era delle comunicazioni di massa il teatro appare un veicolo di propaganda poco efficace: troppo elitario, troppo "colto" e intellettualistico per poter competere con la forza d’urto della televisione o con la facile presa di un buon numero di cabaret.
Quello di Genova non è stato però l’unico, né il più ambizioso, tentativo italiano di recupero di Brecht. All’autore è tornato anche Giorgio Strehler, che gli ha dedicato con un apposito Festival l'intera stagione del suo teatro. Una scelta consapevolmente polemica nell’era di Formentini sindaco di Milano e Berlusconi presidente del consiglio, con un programma che voleva forse ritrovare - all’interno del ciclo di riprese dei suoi gloriosi spettacoli che conduce da anni - l’originaria forza dirompente, l’ormai mitica epoca dell’Opera da tre soldi e del Galileo, con le relative polemiche. E magari recuperare la centralità del teatro all’interno del dibattito culturale.
Ma nelle intenzioni programmatiche a interessare non è tanto il Brecht "ideologico", percepito forse come datato e usurato. Nel presentare il remake della sua Anima buona di Sezuan, clou della stagione brechtiana del Piccolo, Strehler ne mette infatti in secondo piano la portata direttamente politica, privilegiando in primo luogo la poesia: "L’attualità di Brecht sta nella ricchezza dei suoi contenuti e nella grandezza poetica. In questo testo si discute di cose eterne, della lotta fra il bene e il male: la nostra condanna è di dover essere cattivi per poter fare il bene" (dal programma di sala dell'Anima buona di Sezuan).In secondo luogo, Strehler sottolinea la dimensione etica: "La risposta di Brecht, che ci arriva in modo poetico, più che politica è etica. Non c’è solo il bianco o solo il nero, essere buoni o essere cattivi. Brecht ci dice che per difenderci è inutile chiedere consiglio agli dei, a chi ci governa, che dobbiamo alzarci noi, abitanti di questo piccolo universo che non fa che girare su se stesso. Quel grido di aiuto che Shen Te rivolgerà nel finale agli spettatori, stavolta, sarà più vero e meno teatrale. Sarà una chiamata di responsabilità a noi tutti" (Giorgio Strehler, da un’intervista di Anna Bandettini, "la Repubblica", 25 marzo 1996).
Malgrado le intenzioni, il ritorno a Brecht del Piccolo Teatro non è riuscito ad andare oltre il successo di stima. Anche perché l’evento che avrebbe dovuto chiudere questo percorso e misurare l’attualità del drammaturgo in un cortocircuito con la realtà degli anni Novanta, l’annunciatissima Madre Coraggio di Sarajevo (un’opera con cui "esorcizzare la tragica capacità dell’uomo di distruggersi") non è andato in scena nei tempi previsti. Lo spettacolo - che avrebbe dovuto finalmente inaugurare l’Incompiuta Nuova Sede - resta anch’esso un’Incompiuta: infatti nel nuovo teatro mancano le poltroncine, e Madre Coraggio può essere vista solo in forma di lettura, in una sera d’estate, in via d’Amelio a Palermo e - a Milano - al Teatro Lirico.
Per quanto ambizioso, l’isolato (per l’Italia) esperimento strehleriano non può ovviamente dirimere l’annoso dibattito su Brecht. E’ davvero superato perché i suoi schemi ideologici, il suo marxismo più o meno ortodosso (un tema su cui si è discusso per decenni con ferocia), sono stati smentiti dalla storia? Oppure ha già raggiunto la "sublime inefficacia dei classici"? O forse è ancora "efficace", ma le grandi istituzioni teatrali non possono più, per la loro stessa natura, farsi veicolo di un’autentica provocazione? Magari aveva ragione Eric Bentley quando, parlando dell’influenza di Brecht sul pubblico, spiegava: "Dante, è presumibile, ha cambiato molte meno persone di Tommaso d’Aquino: se qualcuno può convertirti al cristianesimo, è più probabile che sia un sacerdote o un filosofo piuttosto che un poeta. Se pensi che a convertirti sia stato un poeta, forse ti stai ingannando: probabilmente il poeta è arrivato dopo che la reale persuasione - se ce ne fosse stato bisogno - era già stata fatta. Dunque, se qualcuno può diventare marxista, è più probabile che venga convinto da Marx stesso, e non dai poeti marxisti. Se mi chiedete se Brecht abbia avuto una qualche influenza sul mondo, dal punto di vista politico, risponderei: molto poca, e non sempre nella direzione che auspicava. L’influenza delle parole, dopo tutto, è spesso, in qualsiasi contesto, abbastanza diversa dalle intenzioni" (Re-interpreting Brecht, p. 193).
Sarà dunque proprio la sua inefficacia di propagandista a salvarlo dall’oblio? "Brecht riteneva che fossero gli errori a conferire immortalità alle opere d’arte. Finché contengono errori, finché non sono perfette - diceva - sono utilizzabili, sfruttabili" (Heiner Müller, Tutti gli errori, p. 30).
Certo, in Germania, dove solo in questa stagione si sono visti decine di allestimenti brechtiani (a cominciare dall’attualissimo Arturo Ui, ultima regia di Heiner Müller, protagonista lo straordinario Martin Wuttke), la situazione si pone in termini diversi. E se in Italia il ritorno a Brecht non ha ancora trovato la sua chiave, è probabilmente solo questione di tempo.
Proprio Müller, del resto, ha affrontato nella maniera più diretta l’eredità brechtiana sia dal punto di vista ideologico che da quello estetico. O meglio, ha affrontato l’ideologia brechtiana (così come quella della Ddr) inserendola in una dimensione tanto esistenziale quanto fisica, addirittura corporea. Fino a portare l’idea stessa di teatro politico a conclusioni paradossali. Il suo obiettivo non è certo quello di delineare una società diversa, più equa e più giusta, o di suggerire linee di condotta, quanto quello di destabilizzare la realtà, di renderla insopportabile.
"Mi trovo sempre leggermente in imbarazzo quando devo parlare della mia posizione ideologica. Conosco solo un modo per rapportarmi alla realtà: da artista. Per il resto vivo una condizione piuttosto infelice. Per me la funzione dell’arte è di rendere impossibile la realtà: la realtà in cui vivo, quella che conosco. (...) La prima esigenza è il bisogno molto elementare di distruggere illusioni; sì, ci provo gusto a distruggere illusioni: forse perché le mie sono andate in frantumi molto presto e ora voglio provare l’effetto che fa sugli altri. Mi stupisco sempre quando sento il pubblico, la gente che ha letto o visto qualcosa di mio, dire che li deprimo. Rimango sempre a bocca aperta. Mi capita spessissimo di sentir dire: ‘A scrivere cose del genere, dovresti impiccarti’... Non li capirò mai. Come fa a deprimermi l’oggetto di una mia descrizione? Niente che io sia riuscito a descrivere è in grado di deprimermi. Mi sembra che a conversazioni del genere manchi sempre il riconoscimento di quanto sia politico il lavoro dell’artista, anche a prescindere dalle prese di posizione ideologiche. Descrivendo qualcosa produco o distruggo ideologia, e così facendo produco forse consapevolezza. La descrizione di un avvenimento è attività politica di per sé" ("Oltre il fascismo: riscoprire la biografia", 1977, in Tutti gli errori, p. 43).
Sarajevo
Allestire come progettava Strehler una Madre Coraggio a Sarajevo significa mettere il teatro a confronto con una delle più terribili tragedie di questi anni. Ma ambientare un classico nella città bosniaca non è l’unica possibilità di misurarsi con la tragedia iugoslava, e in generale con la guerra e i massacri del mondo contemporaneo. Ci sono naturalmente quelli che a Sarajevo, durante l’assedio, hanno continuato a far vivere i palcoscenici, in condizioni proibitive, perché avvertivano la necessità del teatro; per lo stesso motivo, c’è chi (come Susan Sontag) è arrivato laggiù dal "mondo senza guerra" proprio per lavorare su quei palcoscenici disastrati(cfr. il Patalogo 17, "La resistenza intellettuale a Sarajevo"). E sono i numerosi testi (anche di autori italiani) ispirati a quelle vicende. Ma in reazione alla catastrofe balcanica si sono sviluppate anche altre esperienze, forse meno prevedibili e convenzionali.
Ai confini estremi del teatro si muove per esempio Salvino Raco, che nei mille e più giorni dell’assedio ha organizzato in varie città europee, con gruppi di attori e amici, una serie di performance di elementare spettacolarità (semplici oratori, supportati da una colonna sonora di esplosioni, spari e crolli) dedicate alla città bosniaca e ai suoi abitanti. Ispirati alla necessità di "rompere il silenzio", sono eventi al confine tra lo spettacolo e il rito, la manifestazione politica e la pedagogia, l’agit prop e la performance, che lasciano lo spettatore sospeso tra la commozione e il disagio. Spiega lo stesso Raco:
"I miei collaboratori sono attori, vecchi amici, che sentivano il bisogno di lavorare sul tema della guerra. Ci interessa la figura dell’attore sociale, quello che dice, che fa, che interviene sui temi sociali, politici. I testi - che sono più che altro delle didascalie - nascono da testimonianze reali, da lettere che ho raccolto dai profughi presso il comitato milanese per la Bosnia a Milano".All’estremo opposto, nell’immediatezza assoluta del comico, si pone invece la curiosa esperienza di Clown senza frontiere, l’organizzazione non governativa fondata da Tortell Poltrona nel 1993. Nel febbraio di quell’anno il clown catalano si era esibito nel campo profughi di Veli Joze, in Istria: da quell’esperienza è nata Pallassos Sense Fronteres (Clowns Without Borders), di cui fanno parte clown, giocolieri, acrobati, burattinai e musicisti di tutto il mondo, accomunati dall’obiettivo di alleviare il disagio di chi vive nei campi, soprattutto bambini e ragazzi. Con i loro spettacoli, vogliono "migliorare la situazione psichica e, ove possibile, sanitaria, alimentare e pedagogica, dei rifugiati". Obiettivo principale di Pallassos Sense Fronteres è dunque l’invio di clown e artisti nei campi, "per contribuire a migliorare le condizioni di vita soprattutto facendo ridere la gente". Il presupposto è che le tragiche esperienze e le disastrose condizioni dei profughi finiscano per cancellare anche una fondamentale capacità umana: quella di ridere. Gli adulti devono ritrovare il coraggio di ridere. I bambini devono a volte addirittura "imparare a ridere". Per loro, Poltrona e i suoi amici organizzano spettacoli, incontri e corsi, oltre alla distribuzione di materiale didattico.
Il lavoro nasce in qualche modo da una richiesta dei profughi bosniaci?
"Non proprio, anche se chiaramente volevano che qualcosa si dicesse. Probabilmente non nei termini in cui l’abbiamo fatto noi. Per esempio, alcuni profughi non se la sentivano di provare ancora una volta le sensazioni dell’assedio e sono scappati via".
Non senti il rischio di spettacolarizzare un tema tragico come quello della guerra?
"Non so se ho risolto il problema, spero di sì, a partire dalla scelta di un luogo come la casa diroccata di via Maggi, a Milano, e dal fatto di usare gli attori come semplici portavoce. Non credo si possa parlare di spettacolarizzazione. Infatti non lo chiamo ‘spettacolo’, ma ‘evento con drammaturgia animica’, che cerca di toccare gli aspetti più intimi dell’esistenza".
Non sarebbe più utile l’azione politica diretta - che so, una manifestazione di piazza?
"Ce ne sono già abbastanza. Molti spettatori mi hanno detto che non vogliono più manifestazioni o chiacchiere, ma una sensibilizzazione attraverso forme artistiche. Poi, secondo me, le posizioni politiche sono sempre troppo rigide. Su questo tema a Parigi ho avuto uno scontro con una personalità influente, che mi ha detto che non mi avrebbe sostenuto, perché il problema iugoslavo è solo politico e tutto il resto non gli interessa".
Il processo di sensibilizzazione non può passare attraverso i mass media?
"Non credo che servano a risvegliare le coscienze sopite".
In questi eventi, per gli spettatori ma credo anche per gli attori, è molto forte una dimensione rituale, e quasi religiosa, come se si trattasse di una cerimonia laica, della celebrazione di una memoria e di una sofferenza che nasce, anche se in maniera frammentaria, dalle rovine: le rovine di una città bombardata, di un palazzo diroccato, ma anche le rovine della storia.
"C’è una dimensione religiosa. Non era nelle mie intenzioni, ma è accaduto. Forse perché le 55 vittime che vengono commemorate hanno voluto questo. Ma questo è un modo per eludere la domanda. Probabilmente la comunione tra attori e spettatori ha fatto sì che così accadesse. In teatro, la comunione delle cose che accadono a attori e pubblico può portare a questo. E contribuisce anche la scansione dell’evento in quattro momenti: attesa-riflessione, denuncia, evocazione e commemorazione".
In tre anni di attività Pallassos Sense Fronteres ha organizzato una cinquantina di spedizioni non solo nei campi dell’ex-Iugoslavia ma anche nell’ex-Sahara Spagnolo, tra i palestinesi di Gaza, tra i meniñ os de rua brasiliani, in Guatemala e a Cuba (purtroppo nel "secolo dei profughi" c’è solo l’imbarazzo della scelta).
Gli attori viaggiano a loro spese verso queste destinazioni pericolose, e cercano di portare un attimo di gioia spensierata (e corroborante) alle vittime dei bombardamenti, dei cecchini, delle violenze, degli stupri... Quando arrivano all’improvviso, in qualche desolato campo profughi, vengono accolti con un attimo di esitazione e diffidenza. Ma ben presto si raccoglie una folla che ride e sorride, con tanti bambini in prima fila. Per loro il teatro è un’esperienza forte, forse necessaria. Dunque Poltrona e i suoi amici organizzano spettacoli, incontri e corsi, per insegnare a ridere e sognare di nuovo a chi ha dimenticato il segreto. E gli attori? Anche per loro, l’incontro ha qualcosa di straordinario. Come spiega un "Clown senza frontiere", l’americano Moshe Cohen, "recitare per spettatori che non hanno riso da così tanto tempo, è una sensazione indescrivibile".
Il Gran Teatro del Mondo
Di fronte all’enormità delle tragedie della storia contemporanea, di fronte
all’infinito dolore che provocano e alla loro altrettanto grande insensatezza,
Raco e Tortona rappresentano due tappe di un percorso dove lo spettacolo pare
solo una tappa. Su un versante, corre una riflessione personale che tende ad
assumere venature religiose o metafisiche. Dall’altro, lo sbocco è l’azione
pratica del singolo a favore del singolo, nell’immediatezza del bisogno, volta
al ristabilimento della normalità (dove la normalità sono anche il teatro e la
risata). Entrambe le strade finiscono alla lunga per eludere il problema
dell’impegno politico, in uno scenario dove l’azione da parte dei "cittadini
del mondo" appare velleitaria. Come se i nostri strumenti di interpretazione
della realtà fossero diventati inutili, lasciando al singolo un senso di
sconsolata, infinita impotenza, al quale è possibile reagire solo con
l’attivismo volontaristico o con la contemplazione introspettiva.
"L’uomo moderno poco sa delle leggi che governano la sua vita. Come individuo sociale reagisce per lo più sentimentalmente; ma questa reazione sentimentale è confusa, indeterminata, apparente. Le fonti dei suoi sentimenti e delle sue passioni, così come quelle delle sue cognizioni, sono ostruite e come intorbidate. L’uomo odierno, vivendo in un mondo in rapida trasformazione e trasformandosi rapidamente egli stesso, non ha di questo mondo la benché minima idea in base alla quale gli sia possibile agire con prospettive di successo; le sue concezioni della convivenza umana sono distorte, inesatte, contraddittorie, potremmo dire impraticabili; cioè, con una simile visione del mondo - del mondo umano - davanti agli occhi, l’uomo questo mondo non può dominarlo" (Bertolt Brecht, Scritti teatrali, vol. I, Einaudi, Torino, 1975).
Proprio intorno a questa sensazione è costruito La febbre, il
monologo (presentato in Italia un paio d’anni fa da Giuseppe Cederna) in cui
l’americano Wallace Shawn affronta di petto uno dei due problemi fondamentali
del nostro tempo, il rapporto Nord-Sud (l’altro, strettamente collegato, è
quello ambientale). Shawn non lo fa in termini generali, o generici, o
attraverso un qualche filtro ideologico, ma mettendo a confronto la coscienza
e la "falsa coscienza" di un individuo del "Primo Mondo". Un privilegiato,
dunque, ma in ogni caso non un paternalista, né un neo-colonialista, né
tantomeno un razzista; al contrario: chi parla nella Febbre è un
progressista ben intenzionato, tendenzialmente liberal e politicamente
corretto, tanto "assetato di giustizia" da confondere le memorie di
un’infanzia felice con la possibilità di realizzare l’utopia. In termini più
banali, è chiunque si interroghi sulle ingiustizie di questo mondo e avverta
la necessità di cancellarle.
A prima vista, un testo di questo genere può apparire "fuori tempo", dopo che i grandi schemi ideologici di redenzione, quelli che promettevano il riscatto ai poveri attraverso il mercato, il progresso tecnologico o il comunismo, si sono rivelati inefficaci: non sono riusciti a diminuire il divario tra gli eletti e i dannati, tra i ricchi e i poveri, tra i pochi e i molti. E le azioni individuali, più o meno eroiche, più o meno coscienti, se aiutano ad acquietare il disagio, appaiono sproporzionate alla dimensione dell’ingiustizia. Ma è proprio qui, nel vuoto e nell’inefficacia di queste due posizioni, nella semplicità (o nell’ingenuità) di chi rifiuta la rimozione e decide di misurarsi con queste banalità fondamentali del vivere contemporaneo, che esplode la forza del testo di Shawn, la sua provocazione morale.
Come tutti noi, il sensibile e colto protagonista della Febbre è massimamente colpevole e massimamente innocente. Malgrado le sue buone intenzioni, per colpa delle sue buone intenzioni, anche la violenza di cui non è diretto responsabile o testimone finisce per inquinarlo.
In questa ambigua condizione, Shawn (o meglio il suo alter ego) inizia una confessione visionaria e politica. La sua voce, ora tragica ora patetica, si muove su un fronte che è insieme pubblico e privato, individuale e collettivo, intimo e planetario. Perduto tra incubo e realtà in una città del Sud del Mondo, circondato da violenze esplicite e implicite, assalito dai suoi ricordi di privilegiato, sempre tentato di tracciare il bilancio di una comoda esistenza, orgoglioso e vergognoso della propria cultura, del proprio buon gusto, cerca di sollevare il velo dell’indifferenza morale e del cinismo, degli alibi offerti dai grandi schemi ideologici (l’illusione che sarà il motore della storia ad appianare le differenze, a renderci finalmente uguali). Oltrepassa quello stadio dell’anestesia che è la buona volontà progressista, ne smaschera le ambiguità e le illusioni. La svuota, anche se non può superarla. Cerca di assumersi le proprie responsabilità e lascia affiorare l’angoscia per una realtà insostenibile, eticamente, psichicamente e fisicamente. Cerca di capire: cita Marx ("il feticismo della merce"), rilegge magari Fanon e Camillo Torres, riflette, senza nominarli, su Cuba e Nicaragua. Non trova soluzione, ma suggerisce una diversa consapevolezza.
Provare a costruire una diversa consapevolezza: forse il teatro non può andare molto aldilà di questo (e dunque, alla lunga, ridursi dalla dimensione politica a quella psicologica). Forse il teatro e la politica (almeno così come l’abbiamo intesa fino a oggi) non sono più in grado di affrontare problemi che hanno scala planetaria, che superano di molti ordini di grandezza le possibilità d’intervento individuale. E allora quelle affrontate da Shawn sono tematiche troppo generiche perché possano dar vita a un autentico conflitto drammatico: naturalmente siamo tutti contro gli stupri di massa e la pulizia etnica, tutti noi - a cominciare dalle star del cinema e della televisione, con i loro sensi di colpa e l’attenzione all’immagine - siamo contro l’Aids, la sclerosi multipla e le altre malattie alla moda, tutti noi detestiamo le violenze contro i bambini e lo sterminio di foche, balene e rinoceronti, nessuno di noi desidera che le moltitudini del Terzo Mondo muoiano di fame nelle bidonvilles, nessuna organizzazione lotta perché il pianeta si trasformi in una pattumiera.
Ma allora, se lo scenario globale è troppo grande, può essere possibile ritrovare l’efficacia politica del teatro restringendo l’obiettivo e focalizzando problematiche più specifiche e controverse? Forse tornare all’orizzonte della polis, dove il teatro occidentale ha le sue origini, e dove è nata e si è definita anche la politica, può offrire una soluzione.
Teatro civile
Vajont di Marco Paolini e Mi uccideranno in maggio di Luciano Nattino sono due esempi di teatro "militante" che affrontano temi di indiscutibile impegno civile. Paolini attraverso la tragedia di Longarone racconta la distruzione di una civiltà contadina, lo scempio ambientale e l’arroganza dei potentati economico-politici nazionali. Nattino si cala nei panni di Paul Rougeau, condannato alla pena capitale in Texas, che ha raccontato attraverso le sue lettere la vita e l’insopportabile attesa dell’esecuzione nel braccio della morte. Questi monologhi necessitano di un supporto tecnico minimo (una lavagna per Paolini, lo scheletro di una cella e un sistema video a circuito chiuso per Nattino) e quindi si prestano ad essere presentati nelle situazioni più varie ed a costi contenuti; inoltre "il dramma didascalico assume un suo rilievo di caso particolare sostanzialmente perché, attraverso la peculiare povertà della messa in scena, semplifica e raccomanda lo scambio tra il pubblico e gli attori e tra gli attori e il pubblico" (Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa, p. 132).
Realizzati da attori professionisti (che quindi non si limitano ad utilizzare tecniche acquisite altrove, ma le usano per ampliare ed approfondire la loro gamma espressiva), questi lavori vengono presentati in genere fuori dai teatri e dai normali circuiti distributivi, in collegamento con realtà in vario modo "militanti": le repliche vengono richieste da organizzazioni che operano nella società civile (ambientaliste ed ecologiste per Paolini, in particolare là dove sono in corso battaglie in difesa del territorio e del paesaggio; vicine invece ad Amnesty International per il lavoro contro la pena di morte di Nattino). Nascono da un’esigenza "forte" dei loro autori-interpreti, per certi aspetti più etica che direttamente politica, e si riallacciano forse all’epoca della loro formazione artistica e civile, le lotte degli anni Settanta.
"Questo lavoro teatrale nasce dal bisogno di fare qualcosa per fermare la barbarie della pena di morte nel mondo. Perché è così difficile essere contro. Perché ci sono mani pronte, anche da noi. E’ vero che c’è Amnesty e c’è un comitato ‘Paul Rougeau’ per la tutela a distanza dei diritti dei detenuti nei bracci della morte. Ma non basta. Cosa possiamo fare di più, tutti?" (Luciano Nattino, dal programma di sala).E’ probabile che spettacoli di questo genere finiscano spesso per coinvolgere e "commuovere" un pubblico già sensibilizzato e conquistato alla causa (e potrebbero rischiare alla lunga di assumere una valenza consolatoria). Ma non vogliono essere occasioni di semplice denuncia. Ambiscono ad essere prima di tutto momenti di conoscenza e comunicazione, una funzione che evidentemente gli altri media non riescono a svolgere in maniera altrettanto efficace: o perché evitano certi temi, oppure perché si limitano a fornire un’informazione superficiale, raffreddata da giornalisti ed esperti, filtrata dal supporto tecnico, senza poter restituire la sostanza della reale esperienza umana. Nel contempo, confrontandosi con una realtà forse troppo grande per poter essere ridotta in uno spettacolo, esperienze di questo tipo tendono a sfuggire alla gabbia dello specifico teatrale."Il racconto si è arricchito di testimonianze raccolte nel lungo elenco di luoghi che mi hanno ospitato: aule, municipi, biblioteche, centri sociali, chiese, case, piazze ed alla fine anche teatri. Ma era lungo perché non è mai stato pensato come uno spettacolo teatrale. E’ lungo per forza! ...perché alla fine ci sono quelli che si fermano perché vogliono sapere il seguito... spesso restano tutti e si parla del processo, di oggi, di cose che ci toccano da vicino, e si fa presto a tirar tardi. In quei momenti mi sento spesso ‘esposto’, investito dal ruolo dell’intellettuale, e non mi sento per niente a mio agio. Nessun artista di mia conoscenza vorrebbe oggi essere investito di un tale onore, nessun artista studia da intellettuale oggi, c’è penuria. Io in questi momenti resto lì perché mi vergogno di non aver saputo e poi di aver saputo e di aver dimenticato questa Strage di Stato che come uomo non posso ancora tollerare in silenzio. (...) Un paese che dimentica se stesso è un paese triste; spero con tutta l’anima che ascoltare questa storia serva a non dimenticare che è anche la nostra; che questo popolo ci appartiene e non vuole essere dimenticato. Che il teatro serva anche a questo, normalmente, non una tantum. Che questo mestiere antico e bellissimo che faccio non sia del tutto inutile agli umani" (Marco Paolini, dal programma di sala).
Tendono a slittare da un lato verso una forma saggistica, riconducendo l’attore a un ruolo di didatta: "Spesso ci siamo detti che questo era un lavoro da giornalisti, da giudici, non da attori, ma perché su queste cose non fanno un’altra bella inchiesta?", si sfoga Marco Paolini nel programma di sala. Oppure aspirano ad un iperrealismo documentaristico, nel quale a parlare dovrebbero essere unicamente "i fatti" - mentre lo spettacolo non può essere che un pallido (e in definitiva falso) surrogato dell’esperienza e della sofferenza reali.
La storia
A raccontare come Vajont un frammento degli ultimi decenni di storia (ma alla stessa pagina di storia è dedicato anche il testo di Maurizio Donadoni Memoria di classe) sono molti altri spettacoli ed esperienze di queste stagioni. (Anzi, spesso è l’intera esperienza del secolo che vorrebbe essere condensata in uno spettacolo, in forma più o meno metaforica: dal Novecento e Mille realizzato una decina d’anni fa da Leo De Berardinis si è approdati, nelle ultime stagioni, al Novecento di Alessandro Baricco, al Signor Novecento di Vincenzo Cerami e Nicola Piovani per Lello Arena, al Millenovecentonovantadieci secondo Corrado Guzzanti alla Ballata di fine millennio che Moni Ovadia ha presentato all’interno del Brecht Festival del Piccolo...)
E’ come se ci fosse un vuoto di memoria, un salto nella trasmissione di esperienze tra le successive generazioni, un vuoto che la scuola e i mezzi d’informazione non possono (o non vogliono) colmare. Per chi è cresciuto nella dimensione (vera o fittizia) della "fine della storia", per chi non li ha vissuti in prima persona o ne è stato testimone, le due guerre mondiali, i campi di concentramento e l’Olocausto, la Resistenza, ma anche gli anni del terrorismo, sono stati oggetto per lo più di retorica e di rimozione, al massimo di strumentale polemica ideologica.
Il teatro allora può offrire l’occasione per una riflessione storica, che al tempo stesso permetta di accostarsi - indipendentemente da ogni filtro ideologico - all’esperienza dei padri e dei nonni. In questa chiave è forse da interpretare (aldilà del fascino da maledetto attribuito al personaggio e alle più facili mitologizzazioni) l’interesse per l’opera di Pier Paolo Pasolini, il cui nome viene evocato con costante frequenza: come se venisse ritenuto l’ultimo Maestro in grado di confrontarsi con i movimenti più profondi, a livello antropologico, della società italiana.
Entr’acte: Dalla politica-spettacolo allo spettacolo della politica
Alcuni di quei movimenti "viscerali" li hanno invece colti alcuni dei nostri comici, che hanno fatto della battuta politica (e della battuta sul politico) un’arma di sicuro successo. E in questi tempi convulsi, chi prima e chi poi, hanno praticamente tutti deciso di darsi alla politica: se Berlusconi, che aveva iniziato la carriera suonando il pianoforte sulle navi da crociera, era riuscito in poche settimane a creare un partito che vale il 20% dei voti degli italiani e diventare primo ministro, un vero professionista dello spettacolo avrebbe dovuto fare di meglio, con facilità. Ecco dunque scendere in campo, tra gli altri, Beppe Grillo (30 giugno 1994: "Domani fondo un nuovo partito, il partito del ‘Come va? Bene, grazie’. E alle prossime elezioni mi candido. Scommettiamo che batto tutti?"), Claudio Bisio (8 gennaio 1995: "Quando eravamo a Viterbo, sui muri della città c’erano manifesti del mio spettacolo Tersa Repubblica, dove mi si vede in una immagine bella patinata, vestito di tutto punto, sorriso a trentadue denti, lo sguardo rassicurante. Un po’ in stile seconda Repubblica, insomma. Quando il sindaco, credo democristiano, li ha visti si è allarmato: ‘Bisio? Chi è ’sto Bisio? Sarà mica il candidato di Forza Italia?’, pare abbia chiesto ai suoi collaboratori. ‘Che fa? Comincia già ora la campagna elettorale? E’ sleale!’ "), Roberto Benigni (21 febbraio 1995: "Io vorrei tanto metter su un partito con lei, Biagi. Ora va di moda gli alberi, si prende per simbolo un bel pero. Slogan: fate una pera, e come va a finire va a finire"), eccetera.
E’ difficile dire quanti voti abbia portato all’Ulivo (o portato via al Polo delle Libertà) la forza d’urto della satira di sinistra. Però è certo che nei mesi della campagna elettorale il satirico si è trovato impigliato in una forbice: chiaramente, quanto più il suo avversario è potente e individuabile (e dunque "caricaturabile"), tanto più la sua satira avrà successo presso il pubblico. Dunque la condizione del suo successo artistico e di pubblico è il successo politico dei suoi avversari. Viceversa, il risultato del suo successo politico è la sua estinzione.
Così, dopo la vittoria delle sinistre nelle ultime elezioni, alla precisa domanda degli intervistatori preoccupati del declino del genere, i comici davano come Benigni la risposta di prammatica: "Certo la destra viene meglio perché è naturalmente più dotata per suscitare le risate. E’ come i carabinieri. Perché si fanno tante barzellette sui carabinieri e nessuna sui poliziotti? Mistero. Comunque mi sforzerò anche di sfottere la sinistra. Veltroni-D’Alema: Kennedy contro Molotov. Magari regge" (E l’alluce fu). Il tono è il rimpianto di chi sa benissimo che i tempi eroici ma spassosi di Bettino e i Quaranta Ladroni, di Andreotti gobbo e diabolico, del Miliardario Ridens e della sua gang, sono tramontati per sempre.
Già prima della vittoria delle sinistre alle ultime elezioni, del resto, i più avvertiti avevano già annunciato l’abbandono della satira politica (anche perché avvertivano, probabilmente, la stanchezza del pubblico di fronte all’argomento). Tuttavia la possibilità che il comico, al di là degli stretti confini della satira, possa ancora trasmettere un messaggio politico, non è affatto esclusa. Almeno nella prospettiva di Beppe Grillo, che ha portato in tournée il suo scatenato show teatrale tra gli applausi di folle calcistiche nelle piazze di tutta Italia, prima di un finale di grande effetto pubblicitario: il suo show è stato censurato dalla Rai nel gennaio del ’96 (la logica dice che se esiste la censura, esiste anche un messaggio politico da censurare).
"Posso farmi un complimento? Il problema non sono certo le battute, ma gli argomenti che tratto. Il mio spettacolo fa paura perché è un pezzettino di televisione diversa. E’ di questo che hanno paura: in una televisione fatta tutta di lotterie, quiz e intrattenimento, di giochi e di medium non possono accettare il precedente di un uso intelligente dei media. I guizzi creano più danno che benefici. Di fronte a uno spettacolo come il mio, io agirei esattamente come loro. Perché poi la gente dice: ‘Ma come? C’è una cosa così e non me l’ha detto nessuno?’. Mi immagino la gente che dice: ‘Ma come? C’è un paese dove la gente vive facendosi l'energia da sola? Se la comprano, se la vendono, uno va in vacanza, torna e dal suo apparecchio un computer gli prende l'energia e gliela pagano? E io sono qui a battagliare con l’Enel?’ ".La perdita della storia
E’ meglio che il tuo show non vada in onda perché turberebbe il pubblico della televisione?
"La paura di queste persone è che un pezzettino di televisione diversa creerebbe un po’ di turbe nell’ascoltatore medio, perché sono concetti serissimi, però mediati da un comico. E quindi hanno un effetto dirompente".
Quindi secondo te questi contenuti hanno più effetto se vengono veicolati da un comico che da un esperto.
"Le cose che dico le prendo dagli esperti, sono cose che tanta gente ha detto prima di me, su di essere non ho nessun diritto. Ma il loro potere dirompente è la mediazione mia: perché attraverso di me arrivano alle persone normali. Mentre l’esperto rimane lì, si compiace, ha sempre paura di essere giudicato da un altro esperto".
Il ruolo della satira è dunque quello di dare voce a istanze che altrimenti non raggiungono il grande pubblico?
"Non so che cosa significhi satira. Io faccio della politica, attraverso la mia personalità, che è paradossale. Mi esprimo in toni grotteschi, sudo, mi trasformo anche fisicamente. Quando ho finito di lavorare, sembro più un cantante rock".
Nei tuoi ultimi lavori, il rapporto che hai con il pubblico è più vicino al concerto rock che allo spettacolo teatrale o di cabaret...
"Oggi vedo che la vera politica la fanno Brian Eno, Bono degli U2, Sting, un pittore. La fanno tutti tranne i politici, che non hanno capito che non stanno facendo più politica. Stanno facendo delle piccole rubriche della settimana enigmistica, ‘Strano ma vero’, ‘Forse non tutti sanno che...’, ‘Il tenero Giacomo vi rimanda all'ultima pagina’. I politici sono tutti soggetti enigmistici, da cruciverba. La politica si è spostata. Chi fa politica con qualche risultato, ci riesce perché è insospettabile. Chi viene a vedere il mio spettacolo non pensa di venire a vedere un comizio".
Pensa di assistere allo spettacolo...
"...ma sente un comizio. E’ questa la mia macchiavellica".
Lo svuotamento della storia non riflette però soltanto il difficile rapporto degli italiani con il loro passato prossimo, ma più in generale la perdita del senso della storia nella società postmoderna. La ricostruzione della storia attraverso il teatro (spesso basata su diari, racconti e testimonianze della "gente comune") promette un’alternativa, per quanto debole e fragile, a questa polverizzazione, spersonalizzazione e de-umanizzazione della storia operata dai mass media. Offre la possibilità di costruire un linguaggio e di raccontare delle storie. Del resto la rivisitazione della storia (tanto in chiave di critica quanto in chiave di ricerca d’identità) è da sempre una delle funzioni del teatro come luogo d’incontro e di autorappresentazione di una collettività. Ma è sintomatico (ed è probabilmente inevitabile, in uno "Stato senza nazione" come il nostro) che la scena ufficiale, e in particolare il teatro pubblico, abbiano preferito evitare di misurarsi su questo terreno, trascurando una delle proprie vocazioni (implicita nel termine "nazional-popolare" che ha segnato l’epoca della nascita degli stabili italiani), e dimostrandosi incapaci di offrirsi come luogo di riflessione sulla situazione e la storia nazionale (salvo eccezioni, come quest’anno il Pasticciaccio di Gadda-Ronconi). E’ altrettanto sintomatico che l’interesse per la materia sia stato appannaggio di esperienze in qualche misura marginali, episodiche, e sia avvertita in particolare dai più giovani.
Leonka
Quella di definire e rappresentare un’identità collettiva non è certo l’unica funzione di quel "teatro civile" di cui "l’Unità", presentando la stagione teatrale, avvertiva il bisogno (Teatro civile ...in paese incivile, 9 ottobre 1995). Una "scena civile" non deve solo costruire e riflettere l’identità della polis e la sua storia: deve anche essere in grado di riflettere e rappresentare i conflitti che la attraversano e la dividono. Uno dei rari segni di ostentato dissenso antropologico, culturale e politico nell’Italia di questi anni è venuto dai Centri Sociali, dove - in una fase di relativa "permeabilità" con la realtà esterna - sono state realizzate diverse esperienze teatrali (e più in generale culturali e artistiche), sia di ospitalità sia laboratoriali, fino ad approdare alla realizzazione di veri e propri spettacoli. Emblematico è il lavoro condotto all’interno di uno dei centri più noti, il milanese Leoncavallo, attraverso due spettacoli "corali": Randagi, realizzato alla fine del ’94, e Viaggiatori, andato in scena nella primavera del ’96 (cui va aggiunta la messinscena della Visita della vecchia signora di Dü rrenmatt realizzata sempre nel ’96 da Roberto Corona).
A volte il flusso dell’esperienza - che in un centro sociale come il Leoncavallo scorre più tumultuosa e turbolenta che altrove - si blocca per un istante. L’esistenza nella sua immediatezza, come manifestazione di energia vitale e reazione agli stimoli esterni, si trova sovrapposta alla propria immagine. E questa sovrapposizione apre l’abisso, che può essere terribile, che esiste tra sé e la propria immagine. In questo movimento di presa di coscienza, energie e pulsioni vengono incanalate e formalizzate per dare una struttura alla propria percezione di sé, e alla percezione che ne hanno gli altri. Seguendo il percorso che va dall’esercizio, con i suoi meccanismi consapevolmente ripetitivi, ad una auto-rappresentazione via via più articolata e complessa, la pratica teatrale è uno dei metodi - forse uno dei principali - di questa ricerca: perché il teatro impone di passare da una messinscena dell’io (attraverso abbigliamento, atteggiamento, linguaggio eccetera) a una rappresentazione del sé e dei conflitti che lo coinvolgono. Proprio nella freschezza quasi laboratoriale, prima che per valutazioni puramente estetiche, sta l’interesse del lavoro condotto al Leoncavallo da Gigi Gherzi (per Randagi in collaborazione registica con Roberto Corona, e nei due casi con il supporto per la drammaturgia con Claudio Tomati).
Randagi ha la forma di una favola corale tipo La collina dei conigli, in cui si fronteggiano due realtà: quella degli abitanti di una città che si vuole felice a tutti i costi, popolata da una borghesia efficientista e consumista; e quella dei randagi del titolo, beffardamente refrattari a questa utopia senz’anima. In questo apologo politico non ci sono veri e propri personaggi (a parte la maschera del Borgomastro): piuttosto due cori che utilizzano forme della danza, della commedia dell’arte, del fumetto, per rappresentare il conflitto che divide la città in un agit-prop ironico e pieno di passione. Alla fine i "cattivi" bruceranno e distruggeranno il branco dei randagi - che però rinasceranno come dalle loro stesse ceneri, a ricordare che è impossibile cancellare il conflitto, che la parte oscura (nell’uomo, nella società) non potrà essere eliminata. Con voluta ingenuità, Randagi radicalizza il conflitto tra "normali" e "dropouts", ed esibisce una contrapposizione frontale che non può (e non vuole) trovare una sintesi. Non mette in scena solo la dialettica tra un centro e una periferia, ma (se è consentita la metafora psicanalitica) lo scontro tra un super-io distruttivo e un inconscio tendenzialmente autodistruttivo.
Viaggiatori è la fase successiva di questo laboratorio-incontro che utilizza le tecniche del teatro per ricercare, esprimere e poi comunicare in forma di spettacolo un’idea di sé e della propria esperienza di una "tribù" di frequentatori dei centri. Questa volta il tema è quello della festa: cioè il tempo e lo spazio "liberati" da vincoli sociali troppo stretti ("L’unica libertà è nel tempo dato! L’unica libertà è nello spazio dato! Fuori c’è solo SPAZIO per il TEMPO della malattia, della follia, del suicidio!"). E’ uno spazio in cui ciascuno arriva con una propria identità di emozioni ed esperienze: ciascuno dei trenta attori accoglie un gruppetto di spettatori mostrandogli "le cinque cose a cui tengo di più". Ma questa identità non è solo una ricchezza: limita le possibilità di fondersi nel caos originario, e spesso porta con sé immaturità e infantilismi. E però la liberazione nel caos non arriva spontaneamente: è necessario addirittura un truce maestro di cerimonie, assistito da tre "streghe" in stile cubiste da discoteca, in grado di innescare il processo, di guidarlo e di mantenerlo in moto.
Tra lo psicodramma e Mad Max, tra l’happening e l’animazione, Viaggiatori (sottotitolo Esercizi di vertigine) è un percorso di scoperta, un viaggio iniziatico in cui le guide - i veri personaggi - hanno connotazioni sinistre e mostruose. Il gruppo degli attori, incitati dal regista-domatore ed eccitati dalle sue streghe, si trasforma ed evolve sotto gli occhi dei testimoni-spettatori. La danza guida il corpo verso la liberazione: verso la fusione comunitaria, l’emancipazione dai tabù, il piacere della trasgressione. Ma insieme, ambiguamente, questa liberazione può coincidere, almeno in apparenza, con il divertimento coatto e industriale della discoteca; l’emancipazione dalle pastoie regressive dell’individualità ricorda il processo di disumanizzazione dei lager; la perdita d’identità può scatenare processi di esclusione e di aggressività... Insomma, dai felici e ingenui anni Sessanta dei figli dei Fiori a questi anni Novanta, anche se le tecniche e il linguaggio restano gli stessi, anche se si spera di catturare le stesse vibrazioni, la creazione di uno spazio e di un tempo "liberati" si è fatta molto più difficile e a tratti angosciosa. Le tecniche "scoperte" (o riscoperte) allora sono un indispensabile strumento di conoscenza, di allargamento della coscienza e di scoperta di sé. E tuttavia possono diventare anch’esse mistificazione e inganno, e si rivelano tali non appena la zona liberata in cui vengono praticate queste tecniche si illude di aver tagliato i ponti con il resto del mondo. Proprio nel tenere costantemente presente l’ambiguità dell’esperienza della "liberazione", aldilà di facili utopie consolatorie, Viaggiatori trova il suo senso: nel tentativo di dare l’ordine di un racconto a un’esperienza in cui le estasi e le angosce, il caos della comunità e la cristallizzazione della solitudine, si ritrovano inestricabilmente allacciate.
Quello compiuto al Leoncavallo - aldilà dei risultati artistici - può rappresentare un uso paradigmatico del teatro, sia per quanto riguarda la definizione di sé sia per quanto riguarda la definizione di uno spazio "altro". Ma pone anche un’altra questione fondamentale, che riguarda il rapporto tra il teatro e la città. Che cosa accadrebbe se la città non fosse altro che un amalgama di individui indifferenziati e intercambiabili? Se la collettività non avesse uno spazio pubblico in cui rappresentarsi (e da questo punto di vista "teatro" come luogo di autorappresentazione collettiva può essere ed è anche un’assemblea, una piazza, o la televisione)? Chiaramente smetterebbe di essere una polis, nel senso in cui l’abbiamo definita finora.
Ma che cosa accadrebbe se, in questa collettività, un gruppo più o meno marginale decidesse di dare una rappresentazione di sé in forma teatrale? Il semplice fatto che un gruppo si illuda che esista una polis a cui parlare, di fatto la fa esistere. Nel momento stesso in cui ne postula l’esistenza, la realizza.
Nel caso degli spettacoli del Leoncavallo, per esempio, non è la polis, l’insieme della città, che si rispecchia e si rimette in discussione. Anzi: è solo una parte della città, un suo segmento in qualche misura marginalizzato (o autoemarginato) che cerca attraverso il teatro una rappresentazione di sé, una identità, per poi proporla all’insieme della polis. Quel "noi", contrapposto al "voi" di chi non condivide la stessa esperienza, nel momento stesso in cui si offre in quel luogo di comunicazione e di scambio di esperienze che è lo spazio teatrale, rimanda immediatamente a un altro "noi" che li comprende entrambi.
E’ questo meccanismo a fare la forza politica ed estetica di ogni gruppo teatrale in grado di costruire una propria autonoma cultura teatrale. E’ questo meccanismo che rende reciprocamente necessari il teatro e la città: l’uno senza l’altra non esistono. Ed è questo meccanismo che rende necessari, per il teatro le esperienze di quei gruppi che possiamo raccogliere - malgrado le caratteristiche specifiche e irriducibili di ciascuno - sotto l’etichetta di "diversi" o di "marginali" (o magari di "stranieri", di "barbari"), per scelta oppure per sesso, origine o caratteristiche psicofisiche: carcerati, handicappati, immigrati, anziani, malati, eccetera. Senza dimenticare negli anni scorsi le esperienze del teatro omosessuale e di quello femminista, costruite proprio sulla diversità e che hanno avuto, fin dall’inizio, espliciti obiettivi politici.
I diversi
E’ una sensazione che gli spettatori di Ravenna Teatro, della Compagnia della Fortezza o dello Oiseau-Mouche conoscono bene: quegli attori (rispettivamente immigrati africani, detenuti del supercarcere di Volterra, handicappati) hanno una presenza particolare, emanano un’energia che è difficile ritrovare in una "normale" compagnia teatrale. La loro "diversità" è talmente evidente nei loro gesti e nell’intensità della loro presenza da caricare la scena di una fascinazione irresistibile, insieme inquietante e poetica.
In questo senso, Antonio Viganò, regista di Excusez-le ou Il vestito più bello, parlando degli attori della Compagnie de L’Oiseau-Mouche dice: "Ho rubato momenti di verità assoluta a degli attori, non a delle persone". Come precisa una breve auto-presentazione del gruppo: "Si tratta di una compagnia teatrale unica in Europa; i suoi componenti, attori professionisti, sono ragazzi e ragazze con handicap mentale. La compagnia è nata nel 1981 e si è stabilita a Roubaix, in Francia, lavora con differenti registi e coreografi e fino ad oggi ha prodotto più di tredici spettacoli che sono stati portati in tournée in tutta Europa e negli Stati Uniti. Gli attori ricevono una formazione seria e completa (danza, arti plastiche, voce, musica e video) che poi utilizzano negli spettacoli. Al teatro portano la profondità del loro mistero, il loro silenzio a volte, una presenza teatrale intensa, dei gesti insoliti e una stranezza propriamente poetica. Per gli Oiseau Mouche il teatro non è questione di terapia, ma una scelta radicale di teatro professionale in cui la qualità dell’agire, dell’essere in scena, viene al primo posto senza scuse o concessioni. Gli attori della compagnia, nel loro handicap e nella loro volontà di superarlo, sono una testimonianza di lotta contro tutte le sofferenze e soprattutto contro le esclusioni. Sono diversi, ma solo loro sono in grado di modificare il nostro sguardo. Liberano la nostra visione perché più di altri ci invitano a viaggiare oltre le apparenze".
E’ proprio l’aspetto specificamente teatrale (più dell’interesse sociologico o terapeutico, più del progetto d’integrazione di questi "diversi") ad affascinare registi e pubblico. Ancora Antonio Viganò:
"Intorno all’handicap, oggi, ruota un grande business, alimentato da un intervento pubblico enorme. Disabili e malati mentali fanno anche sci, ma sempre in regime di separazione: li caricano su un pulmino e via, verso un’attività che può essere anche la più costosa, ma non deve turbare lo sguardo sul mondo - e i valori che lo innervano, anzitutto la produttività - di chi si dice normale. Una cosa simile accade in ambito teatrale, dove si parla di malattia e disagio, ma quasi sempre l’io-narrante (e dunque lo sguardo che regge la rappresentazione) è una persona normo-dotata. Noi abbiamo cercato di ribaltare questa impostazione. L’io-narrante de Il vestito più bello sono i ragazzi che vanno in scena; con le loro esperienze e il loro approccio alla vita. La diversità è rivendicata e valorizzata. Aiutata a raccontarsi. Noi evitiamo di impostare il rapporto con loro come se si trattasse di una terapia: ciò che facciamo è arte e lavoro. Più la si nasconde, d’altronde, più la diversità si rende visibile: sulla scena, un disabile o un malato mentale non può che essere e raccontare se stesso".Un atteggiamento analogo caratterizza il lavoro di Armando Punzo con i detenuti del carcere di Volterra: "E’ come se fossi diventato un archeologo: scrostando dallo strato più vecchio quelli più recenti, facevo emergere quello che mi sembrava più autentico. Mi sono lasciato catturare dalla loro emotività compressa. Ho voluto valorizzare tutto il potenziale espressivo di questi uomini. Ho usato quel materiale, quella gestualità ribelle - conosciuta quando ero bambino - per creare e ricreare una realtà fittizia, l’immagine di un popolo che era nella mia fantasia, frutto di un mio bisogno. Un popolo semplice, vitale e combattivo, non ammansito, non ammaestrato, lontano dall’ipocrisia e dalla falsità" (La scena rinchiusa, p. 28).
Ma il processo, che si svolge per la maggior parte in realtà chiuse e segregate, interessa in primo luogo la percezione di sé di chi ne è il protagonista: "Viene in mente che, probabilmente, l’asprezza di un’esistenza passata in cella, ma poi sconvolta dall’opportunità che sa offrire il teatro quando riesce a farti scoprire diverso da quello che ti sei sempre creduto, ha finito per far nascere persone nuove. C’è il dubbio che possano esser nati nuovi talenti. Ma la certezza che il lavoro del teatro, fatto così, abbia insinuato tra quei ‘peccatori’ un’immagine di se stessi inedita, quella sì che c’è" (Armando Punzo, da un’intervista di Carlo Ciavoni, "la Repubblica", 24 luglio 1996).
I "diversi", per riprendere la prospettiva di Hans Mayer, sono coloro per i quali "non brilla la luce dell’imperativo categorico, poiché il loro agire non può diventare la massima di una legislazione universale. Ma proprio per questo l’illuminismo deve provare la sua verità davanti a loro" (I diversi, p. 7). Non è inutile precisare che alla categoria dei "diversi" appartengono secondo Mayer tanto i grandi eroi tragici, "prototipi della diversità esistenziale in quanto perlopiù soggiacciono alla maledizione divina", quanto i "personaggi drammatici che hanno potuto sopravvivere come unica alternativa ai nomi mitici della tragedia greca: Faust e Amleto, Shylock e Eulenspiegel, don Giovanni e don Chisciotte, Giovanna d’Arco e le femmine distruttive".
Il diverso vive in una maniera particolare e personale questa "maledizione divina". E vive anche un rapporto con il proprio corpo e con il mondo, un’energia e un senso del tempo irrimediabilmente diverso da quelli degli "uguali". Questa diversità è in qualche modo riconducibile alla diversità dell’attore sulla scena, alla sua radicale alterità: la prima maschera, la maschera originaria, è probabilmente quella della morte. Perché Dioniso, il dio del teatro, è anche il dio dell’alterità, dell’uscire dal sé.
L’Altro
Con i "diversi" (gli immigrati, i carcerati, gli handicappati, ma anche i giovani del Leoncavallo, eccetera) quello che entra in scena con tutta la sua forza è l’altro. O, per usare le maiuscole care a Lévinas, "Autrui", "Altri": "La manifestazione di Altri all’inizio si fa avanti allo stesso modo in cui si fa avanti qualsiasi significato. Altri è presente in un sistema culturale e ne viene illuminato come un testo dal suo contesto. La manifestazione del sistema garantisce questa presenza e questo presente, che si rischiarano reciprocamente alla luce del mondo. La comprensione di Altri è in tal modo un’ermeneutica e un’esegesi" (Emmanuel Lévinas, La traccia dell’altro, pp. 33-34).
Il gesto registico e lo sguardo dello spettatore si inscrivono dunque in una "esegesi dell’Altro", che ha una lunga storia: "La filosofia occidentale coincide con quel disoccultamento dell’Altro, in cui, manifestandosi come essere, l’Altro perde la sua alterità. Dalla sua infanzia, la filosofia è colpita da orrore per l’Altro che rimane Altro, è colpita da un’insuperabile allergia" (op. cit., p. 27). Non solo la storia della filosofia occidentale, ma anche più in generale quella della sua cultura e del suo teatro sembrano aver ottemperato a questo imperativo: evitare che l’Altro rimanga tale, assimilarlo alla propria razionalità, al proprio discorso.
Questa "assimilazione" genera tuttavia un altro dei paradossi di cui è intessuta questa riflessione sul teatro politico. Affermare la propria soggettività in quanto "diversi", renderla riconoscibile e comunicabile, significa sottoporsi a questo processo. Nella speranza naturalmente di essere accettati, come eguali tra eguali. Ma con il rischio di perdere la propria identità, la propria "anima", per annullarle in un intreccio di tolleranze reciproche, in un implacabile processo di omologazione. Si apre così una incessante dialettica tra la richiesta di accettazione (per annullare le discriminazioni e le ingiustizie) e l’autoemarginazione (per salvaguardare la propria identità, magari postulando una diversità assoluta, irriducibile, in grado di resistere a tutte le assimilazioni).
Del resto, una cosa è la "diversità", l’alterità in astratto, e un’altra sono le diversità concrete che si incontrano nella vita e nella pratica quotidiane. In astratto, la "diversità" e il suo "orrore" rischiano di produrre solo mostri: uno spettacolo da baraccone che dà un brivido, ma riduce l’Altro a cosa, a "monstrum" da esibire allo stupore e al sollazzo della gggente. Fermo restando che il mostruoso può avere un suo valore estetico.
Concretamente, invece, le diversità esprimono una loro visione del mondo, una loro storia, una loro cultura, un loro rapporto con la realtà. Dunque la prospettiva si può ribaltare. L’Io può diventare Altro e viceversa, come sa bene Marco Martinelli: "E’ un paradosso: se la Romagna è Africa, incontrare la cultura africana ha significato per noi approfondire la nostra tradizione. Abbiamo trovato il fulèr perché abbiamo incontrato i griot: e viceversa, lavorare in scena con attori italiani è stato un modo per Mor, Mandiaye e Has di andare a scoprire le loro tradizioni più antiche, come la cultura animista che sta sotto l’Islam, e che l’Islam tende a cancellare. Mi diceva Mandiaye che tante cose importanti della ‘sua’ Africa, le ha scoperte perché un giorno ha messo piede a Ravenna, perché ha incontrato noi, perché ha cominciato a fare quella strana cosa che è il teatro, un po’ arte un po’ scienza, un po’ gioco un po’ messa in causa di ciò che si è" (intervento al convegno "Theatre in a multicultural context", Stoccolma, 9-11 febbraio 1996).
Il Piccolo Teatro del Mondo
Il passo successivo consiste dunque nel costruire un rapporto paritario, non paternalistico, tra un Io e un Altro: un rapporto di reciprocità, di scambio tra un Io e un Tu. "Ricordo il momento preciso in cui tutti l’abbiamo ‘vista’, quest’idea: in treno, tornando da Mulheim, primavera 1992, avevamo recitato Siamo asini o pedanti? al Theater an der Rhur. Rocco Militano ci stava raccontando del progetto suo e di alcuni suoi amici di costruirsi una casa in Sudamerica. Chiacchierando con lui è venuta l’illuminazione: perché non costruire una casa, ma non solo una casa, una casa del teatro in Africa, dove Mor, Mandiaye, El Hadiy, possano ritornare e praticare lì quell’arte scenica che hanno cominciato a praticare in Italia, con le Albe? (...) L’idea di costruire un teatro in Senegal, dove gli Arlecchini neri possano improvvisare con la loro lingua, davanti al loro pubblico, ci lavora giorno dopo giorno, ponendoci tante domande. Sarà un teatro al chiuso o all’aperto? C’è bisogno davvero di quattro muri o è meglio una struttura itinerante? E le Albe nere, che lo dirigeranno, in che relazione dovranno restare con Ravenna Teatro? Continueremo a fare spettacoli e progetti insieme, ma quanti mesi qua, quanti in Senegal? E certo, dovrà essere una casa del teatro aperta alle case del teatro in Italia e in Europa, un luogo di fertile scambio tra il teatro occidentale e la teatralità africana, ma come dovrà relazionarsi con la realtà senegalese? E in che relazione con le Istituzioni di là? Con i gruppi di musica e danza che già esistono, con gli intellettuali, con le scuole? Il luogo dove operare è già stato individuato: Guedawaye, leggi Ghegiavai, un piccolo comune alla periferia di Dakar, sull’oceano. Le Albe nere lo hanno scelto perché è un mondo particolare: formato dagli immigrati che hanno abbandonato i villaggi d’origine per trovare lavoro e sopravvivenza a Dakar, a Guedawaye convivono le quattordici etnie senegalesi, e rispettive lingue e tradizioni, dai musulmano wolof agli animisti diola. Un laboratorio vivente per la società multiculturale: se dobbiamo imparare a convivere, bianchi e neri, mi dice Mandiaye, è bene che impariamo a farlo prima tra noi senegalesi, per questo il teatro può essere utile" (Marco Martinelli, "Hystrio", aprile-giugno 1995).
Senza dimenticare che in molti paesi del Terzo Mondo, dall’Asia all’America Latina, e naturalmente nel mondo arabo, il teatro resta un potente mezzo di liberazione e di emancipazione: "Per circa venticinque anni - e con maggior sistematicità a partire dall’inizio degli anni Ottanta - nei paesi in via di sviluppo è nato un nuovo tipo di teatro politico, di orientamento pragmatico. Alcuni osservatori lo definiscono ‘teatro del popolo’, altri preferiscono ‘teatro popolare per il cambiamento sociale’. Sfortunatamente entrambi i termini evocano precedenti e sfortunati tentativi occidentali di fare un teatro politico per i diseredati. Dunque preferisco chiamare questo nuovo tipo di teatro per il mondo in via di sviluppo ‘teatro della liberazione’. Le associazioni con la teologia della liberazione e il teatro degli oppressi sono intenzionali, poiché l’attività e i metodi del teatro della liberazione sono ispirati da attività che hanno un orientamento analogo nel campo della religione e della pedagogia nei paesi in via di sviluppo. Dunque c’è una differenza fondamentale con gran parte delle esperienze di teatro politico occidentali: il teatro della liberazione è centrato sul processo e non si focalizza sulla rappresentazione come unico scopo del teatro" (Eugéne van Erven, The Playful Revolution, p. 1).
Ma senza neppure dimenticare, in quest’utopia di scambio interculturale, che "la comunicazione avviene solo tra due esseri messi in gioco - lacerati, sospesi, chini entrambi sul loro nulla" (Georges Bataille, Su Nietzsche, p. 51).
Nota
Nel corso di questa riflessione ho utilizzato innanzitutto gli Scritti teatrali di Brecht e gli scritti di Heiner Müller (in particolare Tutti gli errori, Ubulibri, Milano, 1994); poi, sulla storia e la crisi del teatro politico, Walter Benjamin ("Che cos’è il teatro epico?", in L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino, 1974), Erwin Piscator (Il teatro politico, Einaudi, Torino, 1976), Massimo Castri (Per un teatro politico, Einaudi, Torino, 1973), Re-interpreting Brecht: his influence on contemporary drama and film (a cura di Pia Kleber e Colin Visser, Cambridge University Press, Cambridge, 1990).
Per quanto riguarda il pensiero "impolitico" (inteso non come spoliticizzazione, né ispirato da un atteggiamento apolitico, ma vissuto come "un eccesso, un’intensificazione, una radicalizzazione del politico"), mi è stato prezioso il volume Oltre la politica, a cura di Roberto Esposito (con scritti di Adorno, Arendt, Barth, Bataille, Blanchot, Broch, Canetti, Patocka, Weil), Bruno Mondadori, Milano, 1996. Sul tema "oltre il politico", non è inutile citare le Albe di una decina d’anni fa: "Le Albe producono teatro politttttttico. Perché politttttttico? Perché con sette t? Vediamo sette possibili risposte. (...) 5. E’ sapere che non possiamo cambiare il mondo (leggi Rivoluzione) ma qualcosa, in qualche angolo, qualcosa di noi, di qualcunaltro, dispersi su un piccolo pianeta che ruota attorno a un sole di periferia in una galassia tra le tante, arrestare una lacrima, curare qualche ferita, sopravvivere, essere odiosi a qualcuno, saper dire di no, piantare il melo anche se domani scoppiano le bombe, perdersi in un quadro di Schiele, aver cura agli amici, scrivere certe lettere anziché altre (leggi Rivoluzione)" (intervento a Narni, 1987, poi in Ravenna africana, a cura di Marco Martinelli, Edizioni Essegi, Ravenna, 1988).
Nella mia ricerca delle possibilità di un teatro "impolitico", ho utilizzato tra l’altro Hannah Arendt (Vita Activa, Bompiani, Milano, 1964; "Bertolt Brecht: il poeta e il politico", in Il futuro alle spalle, Il Mulino, Bologna, 1981; Tra passato e futuro, Garzanti, Milano, 1991), Simone Weil (Quaderni I-III, Adelphi, Milano, 1982-1986), Emmanuel Lévinas (La traccia dell’altro, Pironti, Napoli, 1979; Umanesimo dell’altro uomo, il melangolo, Genova, 1985; e, sul numero 273-274 della rivista "aut aut" la sezione L’"Altro" di Lévinas con interventi di Vattimo, Rovatti, Polidori, Berto, Boella, Greblo). Ma anche Hans Mayer (I diversi, Milano, Garzanti, Milano, 1992), Leslie Fiedler (Freaks, Garzanti, Milano, 1981), Karl Rosenkranz (Estetica del Brutto, Olivares, Milano, 1994).
Per quanto riguarda la "anti-polis" postmoderna e la crisi della rappresentazione e della rappresentanza, un possibile punto di riferimento è Paul Virilio (Lo schermo e l’oblio, Anabasi, Milano, 1994, e Cybermonde, la politique du pire, entretien avec Philippe Petit, Les éditions Textuel, 1996).
Le citazioni della parte finale le ho rubate a La scena rinchiusa. Quattro anni di attività teatrale dentro il Carcere di Volterra (a cura di Maria Teresa Giannoni, TraccEdizioni, Piombino, 1994), Eugène van Erven (The Playful Revolution. Theatre and Liberation in Asia, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 1992) e Georges Bataille (Su Nietzsche, Rizzoli, Milano, 1970).
E mi sono risultate illuminanti alcune conversazioni, a volte brevissime, con registi e attori (non solo quelli citati): colgo l’occasione per ringraziarli tutti.
Le interviste con Salvino Raco e Beppe Grillo, qui parzialmente riportate, sono state pubblicate sul "manifesto". Il testo di Wallace Shawn La febbre è edito in Italia da e/o, Roma, 1992; il nuovo testo di Shawn, The Designated Mourner, ha debuttato a Londra, al Royal National Theatre, lo scorso aprile (sul testo e sull’autore, vedi anche The Dangling Man di John Lair, "The New Yorker", 15 aprile 1996). La battuta di Benigni è ripresa da E l’alluce fu, a cura di Marco Giusti, Einaudi, Torino, 1996. Le lettere di Paul Rougeau che hanno ispirato lo spettacolo di Luciano Nattino sono raccolte in Mi uccideranno in maggio, Sensibili alle foglie, Roma 1994.
Che cosa è successo a Roma?
L'incontro tra stabili di innovazione e gruppi al Teatro Vascello
di Marco Cavalcoli
Cosa è successo a Roma il 4 aprile? Secondo me qualcosa di buono. Innanzitutto registriamo le presenze dei Teatri Stabili di Innovazione: c'erano il Teatro Vascello di Roma, il Laboratorio di Pontedera, Ravenna Teatro, Akroama di Cagliari, il Nuovo Teatro Nuovo di Napoli. Assenti ma fortemente desideranti il CSS di Udine e Galleria Toledo di Napoli. Spero e confido in un prossimo coinvolgimento del Teatro Litta di Milano, che mostra di prendere la faccenda con attenzione.
Sono rimasto piacevolmente sorpreso dal clima quasi barricadero di partecipazione politica. Non è del tutto vero che ci si scopra improvvisamente fratelli quando la realtà picchia duro su tutti, può anche scattare la guerra fra disgraziati, e che si risponda con la condivisione dell'impegno è un primo fatto degno di nota.
Non riassumo l'intero pomeriggio di discussione, cerco di evidenziare alcune conclusioni:
1) Partiamo dal presupposto che i vecchi Centri di Ricerca non se la passano, in media, troppo bene. Il cosiddetto Nuovo Teatro gode di considerazione e di denari immensamente inferiori a quelli di cui gode il Teatro di Prosa musealmente inteso, ben affiancato oggi dalla Commedia Musicale (nel senso del Varietà), entrambi del resto surclassati dalle risorse elargite agli Enti Lirici. Ci muoviamo insomma in casa dei cugini poveri.
Un primo dubbio da fugare per i partecipanti di Castiglioncello e Roma è che gli Stabili di Innovazione possano risolvere i problemi di tutti aprendo genericamente le porte ai bisognosi.
2) Un direttore artistico disonesto ci mette circa mezzo secondo ad utilizzare la scomoda verità pratica di cui sopra per innalzare un bel muro di scuse a giustificazione della propria inattività.
Che cosa si può invece fare? Da una parte il Ministero ha eliminato l'obbligo di ospitalità per gli Stabili, che più che Stabili cominciano così a diventare Chiusi a Riccio per statuto, dall'altra non ha ben chiarito che cosa distingue un'attività stabile di innovazione da un'attività stabile punto e basta.
Tutti concordano nel ritenere che i vecchi centri di Ricerca sono preziosi nella misura in cui si pongono come punto di riferimento per un Ecosistema culturale, imbarcandosi in progetti ministerialmente a perdere, essendo essi stessi artisti "di ricerca" dell'organizzazione, tenendo gli occhi aperti sui movimenti dei propri territori.
L'ETI ha tra le sue finalità principali quella di favorire la nascita e la crescita di nuovi soggetti, nuovi linguaggi, nuove poetiche, senz'altro più di quanto non gli venga richiesto di coprire di attenzioni Ida Di Benedetto.
I Centri di Ricerca si impegnano quindi ad andare insieme all'ETI per richiedere un investimento straordinario triennale, da aggiungere a quanto già ricevono per le ospitalità, da dedicare alla creazione di progetti tesi a vivificare le energie teatrali del proprio territorio, tramite ospitalità, coproduzioni, collaborazioni, commissioni o accoglienza di progetti specifici etc.
3) All'estero quando si pensa al Teatro Italiano si guarda sostanzialmente a noi. Soprattutto in quei Paesi europei che non vivono una distinzione così netta tra Teatro di Tradizione e Teatro di Ricerca, peculiarità essenzialmente italiana, il Nuovo Teatro non viene percepito come l'avanguardia della tradizione teatrale italiana, ma semplicemente e senza enfasi come Il Teatro Italiano. Oltre a Ronconi, che sarà pure bello Stabile e arrivato, ma non è certo la Prosa tradizionalmente intesa, Castellucci Barberio Corsetti Martinelli Martone Teatrino Clandestino Kismet Briciole Fanny & Alexander Motus Masque Kinkaleri e scusate tutti quelli che tralascio sono nomi comuni sui giornali e nelle stagioni europee (e magari giapponesi australiane e nord-sudamericane), per occhi esterni non rappresentano un singolo settore della Scena italiana, la rappresentano e la evocano in quanto tale.
Eppure in Italia continuiamo ad essere trattati come delle realtà giovaniliste che non hanno ancora smesso di giocare alle cantine (quel giovane regista di Barberio Corsetti, con quasi trent'anni di carriera alle spalle...).
Andremo dagli operatori esteri che ci conoscono bene per chiedere una presa di posizione sul nostro teatro in relazione alle condizioni in cui dobbiamo lavorare in questo Paese. Può essere una sorta di manifesto composito del teatro europeo a sostegno del teatro italiano che amano e che vogliono continuare a vedere esistere con tutta la dignità che merita. Stiamo parlando ovviamente dei massimi Festival e Teatri Europei, e di personalità della cultura note all'opinione pubblica.
4) Le compagnie si stanno coalizzando regione per regione, specialmente in Lombardia, in Toscana (soprattutto la danza, che continua a ruggire contro le distinzioni di genere artistico), in Emilia Romagna, nel Lazio. Molti vanno insieme agli incontri in Regione, o elaborano insieme proposte di leggi e regolamenti. Intensificare questo lavoro è necessario per essere forti e propositivi nei rapporti coi Centri e con le Istituzioni nei propri territori, e a livello nazionale, se ci si tiene in rete.
E' anche necessario per muoversi nei confronti dei Centri che per diversi motivi sono ripiegati su loro stessi. Chissà cosa ne penserebbero di un intervento speciale ETI, ogni tanto ai sordi spuntano le orecchie, essere pronti e organizzati ha la sua importanza anche nei deserti (direi soprattutto lì).
5) Luca Dini propone un rapido aggiornamento a maggio a Firenze durante Fabbrica Europa. Una richiesta da parte di molti: che non ci si gonfi tra le mani una convention, manteniamo un clima molto operativo.
Quindi a presto,
Marco Cavalcoli
Altre info, proposte, pareri, nel forum Nuovo Teatro Vecchie Istituzioni.
E dite anche la vostra, soprattutto su quello che accade a livello regionale. (n.d.r.)
Un'antologica dei Marcido
Una nota
di Marco Isidori
Tre sono gli spettacoli che i Marcido proporranno in occasione di questa Antologica al Teatro Juvarra di Torino.
Canzonetta, da I Persiani di Eschilo, è la rappresentazione che restituisce nel modo più conciso e fedele, il senso del lavoro della compagnia, sul tema della tragedia attica.
Si tratta dell'incarnazione, palpitante in un vero e proprio rituale selvaggio, di quello che venne definito all'epoca (1990), e non da noi, come l'esibizione scenicamente architettata di un sacrificio umano.
Accettiamo consapevolmente, riportandola, l'enfasi elementare d'un tale linguaggio, perché siamo convinti, che questa riesca a centrare una verità sullo spettacolo, rendendogli in qualche misura esatta testimonianza.
Dobbiamo considerare che i Marcido vivono artisticamente sulla fertile confusione tra l'"ossequio" alle leggi della canonica teatrale, e quel surplus energetico/performantico che ciascun attore può e deve portare alla nostra personale necessità di una strutturazione semantica sempre "zeppa" dell'azione spettacolare. Nel caso di Canzonetta, Maria Luisa Abate è trasformata dall'in-venzione del sensazionale costume sciamanico ("costume" è termine comunque riduttivo per l'oggetto qui in causa) di Daniela Dal Cin, in una figurazione assolutamente "altra", una figurazione mostruo-sa alla quale abbiamo voluto dare il nome di Grande Ballerina.
In quanto "attrice", Maria Luisa Abate fornisce una prova della quale, per il superbo controllo della tecnica recitativa, accoppiato allo scatenamento/invasamento, paragonabile senz’altro a quello di una Pizia in furore divinante, si può certo, dire che sia una prova condotta fino ai limiti della sua perizia e della sua "pazienza" d'attrice.
Del secondo spettacolo presentato Le Serve, una danza di guerra, non possiamo riferire, senza che ci colga, puntuale, la commozione che s'affaccia quando dobbiamo ricordare i termini della prima, "compiuta" rappresentazione marcidoriana; correva l'anno 1987; oggi, 2003, quell'assalto all'arma bianca (nel senso d'una adesione quasi erotica per comunanza sentimentale) al dettato poetico di Jean Genet, è ancora uno spettacolo vivo; esprime ancora, e con immutata forza, già tutte le coordinate drammaturgiche del teatro della Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa, e proprio questa sua "classicità" ce lo fa ciclicamente riproporre (oltre, naturalmente, al disegno di fedeltà al nostro proposito di mantenere in repertorio quanti più spettacoli sia materialmente possibile).
Apre l'antologica: Happy Days in Marcido's Field, la rappresen-tazione "più giovane" (1997) qui proposta.
L'incontro/scontro con Samuel Beckett è stato decisivo per i Marcido. Innanzitutto per la facilità diabolica con la quale è possibile scivolare con Beckett, sul piano della retorica, che non può restituire in nessun modo la complessità poetica del mondo del drammaturgo irlandese (il beckettismo è fortemente radicato ed ha già le sue birignose tradizioni nel teatro europeo), e questo scoglio ci è parso d'averlo superato, e poi, secondariamente, Happy Days in Marcido's Field è stato per noi un momento di particolare importanza artistica perché ha segnato la nascita di quel soggetto "corale" che ci è piaciuto definire come "Attore Generale" e che è diventato, una colonna portante del teatro dei Marcido.
COMUNICATO STAMPA
Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa comunica che dal 6 al 18 maggio 2003, al Teatro Juvarra di Torino, sarà presentata
UN'ANTOLOGICA DEI MARCIDO
all'interno della quale si potranno "rivedere" tre storici spettacoli della compagnia, diretti da Marco Isidori:
§ "Happy Days in Marcido's Field" (Debutto anno 1997)
da martedì 6 a sabato 10
§ "Le Serve, una danza di guerra" (Riedizione anno 2000)
da lunedì 12 a mercoledì 14
§ "Canzonetta" (Debutto anno 1990)
da venerdì 16 a domenica 18 maggio
Le rappresentazioni inizieranno alle ore 20,45.
Gli interpreti principali sono: Maria Luisa Abate, Alessandro Curti, Paolo Oricco e Marco Isidori.
Scene e costumi sono di Daniela Dal Cin.
Per informazioni e prenotazioni:
Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa tel. 011/436.87.30 - 819.35.22
Teatro Juvarra tel. 011/54.06.75
MARCIDO MARCIDORJS E FAMOSA MIMOSA
VIA F. APORTI N° 27 · 10131 TORINO
TEL./FAX: 011/819.35.22
E-MAIL: info@marcidomarcidorjs.org
http://www.marcidomarcidorjs.org
Gli indescrivibili spettacoli di Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa
descritti (sul "manifesto") nel corso del tempo
di Oliviero Ponte di Pino
Una giostra: l’Agamennone (1988)
Palcoscenico ed Inno (1991)
Musica per una Fedra moderna (1992)
Spettacolo (1993)
Il cielo in una stanza (1994)
Happy Days in Marcido’s Field (1997)
Una canzone d'amore (Prometeo) (1998)
A tutto tondo (Suzie Wong) (2000)
Una giostra: l’Agamennone (1988)
Creato sei anni fa, Una giostra: l’Agamennone di Marcido Marcidorjs mantiene intatta la sua forza comunicativa: e già questa è una prima dimostrazione dell’efficacia del linguaggio del gruppo torinese, e della solidità di un’idea di teatro precisa e tagliente.
Teatro come macchina, in primo luogo: una macchina che tende ad assimilare nell’indimenticabile scena di Daniela Dal Cin attori e spettatori. Dopo un breve prologo da avanspettacolo, il pubblico entra infatti in una arena-placenta, sistemandosi sul lato esterno dell’ovale, su una panca sopraelevata, e osserva l’azione che si svolge sia nella trincea lì sotto e al centro della pista, sia aldisopra di questa ragnatela di legno, ferro e corda. È una macchina celibe in cui la scena trova una forma rigida e ineluttabile, che è insieme la sua quintessenza e la sua definitiva prigione: ma ad alleggerire questa sensazione, come s’è già notato, interviene spesso un esibizionismo consapevolmente guittesco, che cita una spettacolarità "bassa".
Poi, un’idea di teatro come sconfinamento dell’umano. I corpi, nelle composizioni e nei groppi tra coreografia e scultura, nelle esibizioni e nelle acrobazie circensi, sono già al confine tra l’uomo e la macchina, tra il corpo e la materia. I costumi, sempre firmati da Daniela Dal Cin, rimandano a un intreccio dell’umano con il minerale, il vegetale, l’animale: le scaglie di rame del manto di Clittennestra-rettile, le lance di legno che si dipartono da Agamennone-istrice, l’abito interamente ricamato di anelli d’ottone e la raggera d’alluminio al cui centro campeggia Cassandra-ragno. Allo stesso modo, la vocalità violentemente antipsicologica e antinaturalistica fa esplodere tutta la materialità del suono, la sua concretezza musicale.
Con questa ritualità stridente, rocciosa, enfatica, Marcido Marcidorjs aspira a una "opera d’arte totale" ossessiva e claustrofobica, in cui l’elemento umano resta angosciosamente sospeso tra la dannazione e la redenzione, tra l’annullamento nella materia e la sublimazione nello spirituale. Forse in questa ambiguità irrisolta risiedono insieme il fascino dell’operazione e il suo limite: perché se questo dissidio e sovrapposizione è il tema di fondo dello spettacolo, il testo di Eschilo rischia di rimanere più che altro un deposito di suggestioni, lo spunto per concretizzare, attraverso il testo e i suoi personaggi, fantasmi che hanno una diversa origine e destino.
Tuttavia, se l’Agamennone si riduce quasi a pretesto per una giostra archetipica, l’esperienza dello spettatore rimane "forte". I segni continuano a graffiare e la tensione (grazie anche alla generosità fisica degli interpreti) resta sempre alta: una poesia acuminata, a tratti quasi sgradevole, martella beffardamente, sofisticata e barbarica.
Palscoscenico ed Inno (1991)
Musica per una Fedra moderna (1992)
Il boccascena è interamente occupato da un gigantesco televisore. All’alzarsi del sipario-monoscopio con l’insegna del gruppo – "Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa" – si svela un’immagine di forte impatto, costruita con maniacale artigianalità: i punti luminosi del tubo catodico sono stati sostituiti da centinaia di bottoni colorati, che come in un quadro di Seurat compongono un’immagine. Dal fluttuare di punti, curve, sinuosità, emerge una figura femminile, quasi crocifissa sullo schermo – un rimando alla Sirenetta che ispira lo spettacolo, pura immagine alla ricerca di un’anima, sospesa tra il fantastico mondo sottomarino e la realtà.
I precendenti lavori del gruppo torinese guidato da Marco Isidori consistevano nella costruzione di macchine teatrali complesse e crudeli, chiuse su se stesse, a malapena concesse allo sguardo d’un pubblico voyeur: di quelle sculture in movimento, gli attori erano insieme gli operai e il prodotto, il sacerdote e la vittima sacrificale. Questa volta, la scultura scenica (firmata come i costumi dalla bravissima Daniela Dal Cin) si offre fin dall’inizio con tutta la sua forza di provocazione. Palcoscenico ed Inno, costruito "intorno alla" Sirenetta di Andersen, si gioca interamente nello spazio lasciato libero quando quella visione indietreggia, oltre lo schermo immaginario. Quello spazio di confine, quasi a riscattare la forzata immobilità del fantasma televisivo della Narratrice (Lauretta Dal Cin) con l’agilità scimmiesca d’un acrobata, viene occupato da due personaggi da circo onirico (Maria Luisa Abate e Ferdinando D’Agata) e dalla "protagonista titolare", una Sirenetta con le regolamentari squame (Costanza D’Agata).
L’interpretazione è resa impossibile, per affidarsi unicamente alla nuda forza dell’archetipo (in passato Genet e Eschilo, ora la favola crudele di Andersen), con il suo tasso di violenza e di dolore. La Parola e la Scena si scontrano frontalmente, secondo una concezione decisamente agonistica del teatro: con il risultato che la soluzione scenica, anche se di forte impatto, di volta in volta diverge, divaga, si scontra con il testo. O gli imprime una forzatura, come nel caso della folgorante apparizione dell’Uomo Palla (Marco Isidori) che attraversa il proscenio, rubato a un fumetto di Little Nemo o a qualche Paese delle Meraviglie.
In Musica per una Fedra moderna il corredo scenografico è ridotto al minimo, pur rimanendo estremamente costrittivo per i quattro attori, praticamente imbozzolati al centro di altrettante cornici metalliche da una sistema di fasce. Se non fosse per il candore degli abiti, quei volti dipinti di rosso (partendo forse da una suggestione del testo – "il muso dei cani è tutto rosso di sangue") e quelle strutture patibolari potrebbero rimandare a un rituale sadico e impotente – che non riesce a trovare la liberazione: né in un impossibile orgasmo, né in un delitto solo narrato. Più che alla truculenta vicenda mitologica rievocata da Seneca, nella sua Fedra il regista Marco Isidori è evidentemente interessato alla sperimentazione sull’aspetto sonoro-vocale. Nei precedenti lavori del gruppo, la declamazione tendeva ad essere volutamente enfatica, melodrammatica, sostenuta da un’oratoria ora tronfiamente ridondante ora marcatamente grottesca, come deformata da un ricercato eccesso di pathos. In questo caso, il processo è condotto all’estremo: la frantumazione delle frasi, il dispersivo esibizionismo delle passioni, la sottolineatura isterica di ritmi e accenti, la sovrapposizione di tonalità e rumori trasformano il testo in una sorta di partitura futurista. Non a caso lo stesso regista, in veste di direttore d’orchestra, è in proscenio a governare questo magma vocale, accovacciato in una posizione quasi fetale. Sotto la spinta centrifuga di questo miraggio musicale, il testo finisce per svuotarsi di senso ed espressività, per ridursi a pura vocalità, per irrigidirsi in moduli un po’ datati e seguiti con eccessivo rigore. Più che avvicinarsi alle sfumature di una trascrizione musicale, lo spettacolo scivola verso la retorica dell’eccesso o – nei casi migliori – approda a un virtuosismo alla lunga monotono. Manichini immobili e dissennati, gli attori si riducono a macchine celibi, portavoci di un delirio autistico e gridato, di un’angoscia a tratti quasi compiaciuta, che neppure la retorica grandguignolesca di Seneca riesce a oggettivare.
Ma anche in questa Fedra, come sempre nel lavori di Marcido Marcidorjs, si avverte un’idea forte e eccentrica di teatro – anche se non sempre si realizza. Da un lato, si manifesta l’aspirazione a una struttura implacabile e perfetta, una ricerca di simmetrie senza ambiguità, la coerenza inderogabile a un principio, che si riflette in una staticità ora solenne ora ossessiva. A equilibrarla – o meglio, a squilibrarla – c’è una attenzione generosa ma altrettanto ossessiva per il particolare: l’ingenua e faticosa utopia che ogni istante, ogni immagine possa e debba trasformarsi in una rivelazione. Proprio attraverso il particolare – sempre ipercompresso dal rigore della struttura, dall’implacabilità della macchina – fanno breccia il caos, un irresistibile bisogno eversivo, il gorgo delle ossessioni. La sensazione di violenza trasmessa dagli spettacoli del gruppo torinese sembra nascere dall’impossibilità: l’impossibilità di abbandonarsi al flusso del caso e delle pulsioni, e l’impossibilità di costringere questo caos in uno schema. Non è un caso, forse, che i momenti più emozionanti degli spettacoli della Marcido siano proprio quelli in cui la cristallizzazione intellettualistica s’incrina, ed emergono incontrollabili l’errore, la dissonanza, il lapsus, l’invenzione fantastica.
Spettacolo (1993)
Battezzare il proprio spettacolo, per l’appunto, Spettacolo, tradisce certo una semplificazione e un eccesso di confidenza; ma per un gruppo come Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa, impegnato da anni nella messa a punto di una propria idea di teatro, può anche essere una dichiarazione di raggiunta maturità. Dopo lavori che erano innanzitutto macchine teatrali che spesso intrappolavano in un unico marchingegno pubblico e attori, l’etichetta di Spettacolo può anche indicare un consapevole recupero della dimensione frontale per l’interfaccia tra palco e platea.
In pratica, lo Spettacolo dei Marcido è un allestimento della Fedra di Seneca, che utilizza le diverse tecniche teatrali messe a punto in questi anni dal regista Marco Isidori, dalla scenografa Daniela Dal Cin e dai loro collaboratori. In primo luogo, un rifiuto assoluto della psicologia e dell’interpretazione, nella vocalità e gestualità degli attori e nelle geometrie sceniche. Fin dal monologo iniziale di Ippolito, trasformato in coro e svuotato di senso da frantumazioni, echi, riverberi, inciampi, balbuzie: pura materia sonora che esplode, si avvita su se stessa e si ricompone secondo ritmi musicali, a metà tra le antipoesie futuriste e l’analisi fonetica alla Jacobson.
Da questo coro di ambigui fantasisti da varietà, identici e unisex, cappello a cilindro e scarpe con i tacchi, in abiti chiari con vistosi fiocchi ai polsi e alle caviglie, si staccheranno via via la Nutrice (Maria Luisa Abate), Ippolito (Ferdinando D’Agata) e Teseo (Corrado Parodi). Estranea e diversa, fin dal suo primo apparire, è soltanto Fedra. In lei la ritualità sacrale della tragedia si ribalta in un esibizionismo vagamente sadomaso, con la belva-protagonista ingabbiata in costumi scultorei, issata su alte pedane, esposta seminuda a mezz’aria con l’unico sostegno di un palo, intrappolata da costumi e da macchinari che la trasformano in un’icona in bilico tra ieraticità e feticismo. La sua declamazione è sempre enfatica, ricca di sottolineature ed eccessi, a volte strozzata, singhiozzante e gutturale, a volte melodrammaticamente intensa, ripiena e arrotondata.
"È finita l’epoca dei mostri" si lascia sfuggire la Nutrice. Ma Fedra rimane l’ultimo mostro che può infrangere le leggi dell’umanità, ancora in grado di farsi travolgere dalla sua animalità e già pronta come un mostro cyberpunk alla contaminazione con la macchina: dunque creatura intrinsecamente teatrale, attraente e repellente, irrimediabilmente diversa, ultimo residuo e insieme anticipazione di una spettacolarità inquietante e scandalosa.
Spettacolo evita ogni compromissione con il presente, scegliendo di concentrarsi su se stesso, sulle dinamiche interne della materia sonora, sul montaggio delle figurazioni. L’obiettivo finale del percorso della Marcido potrebbe essere una sorta di "opera vocale", basata sulla pura musicalità e su un montaggio d’attrazioni sontuoso e perturbante. Rifiutando l’introspezione, Marcido codifica una minuziosa retorica dell’espressione e dell’ostentazione, in un’estetica di imbizzarrito rigore, che proietta l’evento teatrale verso il pubblico, ma dopo averne preventivamente polverizzato il senso, castrando ogni tentativo d’identificazione e proiezione dello spettatore, per lunsingarne piuttosto una curiosità fredda e perversa. Montaggio d’attrazioni e d’alterità, Spettacolo costruisce intorno alla Fedra di Seneca un guscio dalle forme affascinanti come una conchiglia. Fino a occultare quasi del tutto emozioni e sentimenti dietro una corazza di spigolosa astrazione, spesso sconcertante, imprigionando questo rosario di eccessi nei ceppi della geometria.
Il cielo in una stanza (1994)
Per quasi un’ora ho cavalcato una tigre, così come la leggenda vuole sia accaduto a Gengis Khan. Non nella steppa, ma in un appartamento, all’ammezzato del numero 68 di una via non troppo lontana dalla stazione di Porta Susa, a Torino. Unico spettatore – e "unico" vuol dire certo privilegiato, ma forse anche "ultimo" della specie – di uno spettacolo estremo, che nella sua radicalità sana e ingenua si interroga sull’efficacia della comunicazione teatrale.
In quest’occasione, la compagnia torinese Marcido Marcidorjs ha chiamato lo Spettatore fuori dalla sua tana per attirarlo nella propria, separandolo dalla massa del pubblico, per irretirlo in un meccanismo di comunicazione intenso, aggressivo e seduttivo, a metà tra l’attrazione da luna park e un masochismo appena evocato. Ma con un’inconfondibile sensazione di vero e insieme con un vago retrogusto d’osceno, come accade quando una forma di comunicazione codificata affonda una qualche intimità.
Manifesto del "Teatro Ulteriore" teorizzato e praticato da Marcido Marcdorjs e Famosa Mimosa, Il cielo in una stanza è uno "spettacolo d’appartamento", come se ne sono già visti, per un unico spettatore a replica ("dieci contro uno", annuncia l’ironico sottotitolo). Varcata la soglia e accolto l’invito di Sabino, "il portiere più cretino del mondo", di salire in groppa alla tigre Ma (animata da due attori-portatori), la prima sensazione è di superare un’altra soglia: quella che separa l’attore dallo spettatore. I due ruoli finiscono quasi per coincidere, realizzando in forma individuale, da laboratorio, una delle utopie dell’avanguardia. Quello del Cielo in una stanza si propone allora come teatro "riflessivo", nel molteplice significato del termine: non a caso una delle immagini più forti, per lo spettatore-attore, è la propria, intravista in uno specchio, a cavallo della tigre Ma, il destriero e l’amico immaginario dell’"invasore universale" Gengis Khan.
Il linguaggio di Marco Isidori (oltre che regista e interprete, anche autore del testo Gengis Kahn, di cui questo Cielo in una stanza è una sorta di prova) risulta fiammeggiante, enigmatico, a tratti oscuro. Percorso da brividi apocalittici ("l’attuale generazione è l’ultima, siamo gli ultimi segni scomposti della smania vitale; siamo sterili definitivamente"). Ispirato dal rifiuto e da un’ansia del rinnovamento. Edificato su una ribelle nostalgia della carne. Nell’epoca dell’elettronica e della smaterializzazione, Il cielo in una stanza sembra infatti invocare (come il Jarry del Supermaschio) un ritorno all’energia biologica, alla fatica animale del corpo, di cui la tigre Ma rappresenta la materializzazione. Si intuisce un rifiuto della macchina eccessivo e volutamente grottesco (e magari provocatorio, in una Torino che la Fiat ha ormai svuotato delle sue fabbriche e dei suoi operai per spostare la produzione in fabbriche robotizzate, de-umanizzate).
Teatro di corpi, dunque: corpi come materia, come elemento scenografico, come massa in cui l’identità può dissolversi (le cinque identiche, interscambiabili figure che fungono da motore e da coro). Eppure paradossalmente anche teatro come macchina che assale, manipola e trasforma lo spettatore.
Allora, al di là della cornice anticonvenzionale e più dei garbugli di metafore, delle perorazioni fiammeggianti e delle enigmatiche teorizzazioni a favore di un recupero della parola e della comunicazione, nel Cielo in una stanza a colpire, incuriosire, spiazzare sono piuttosto le invenzioni visuali (scene e costumi sono firmati al solito da Daniela Dal Cin): l’acconciatura con "palloncini sapienti" del custode Sabino, il quintetto di chorus girls con i loro costumi tra il pop e lo scimmiesco, le occhiaie del consigliere Boltraffini che emergono dal retro della bestia, la violenza e lo sfregio che traspaiono dal travestimento al femminile (tunichetta rosa, collier, piedi scalzi), i ventagli giganti decorati in turchino e arancione con intrecci di coppie da kamasutra.
E soprattutto la tigre Ma, colorata e naif, all’apparenza giocherellona eppure potenzialmente devastante. Nel suo nome, il "Ma" – l’avversativa, il dubbio, l’opposizione, il distinguo, la dilazione – sembra una chiave per aprire le porte della pratica artistica. Nell’occasione questo Ma sostiene letteralmente lo spettatore, con fatica fisica, muscolare, piroettandolo qua e là nell’appartamento, risucchiandolo in una realtà virtuale, allucinata e onirica, incastonata nel ritmo quotidiano della città.
Happy Days in Marcido’s Field (1997)
Una ventina d’anni fa, lavorando su Giorni felici di Samuel Beckett con Gabriella Bartolomei, Pier’Alli aveva realizzato uno spettacolo di assoluto fascino intellettuale, tutto costruito sull’intreccio degli sguardi. Affrontando lo stesso testo in chiave di "teatro d’appartamento" (e con il titolo Happy Days in Marcido’s Field) la regia Marco Isidori punta invece sull’impatto del corpo e della pelle, in una messinscena che coniuga raffinato rigore e forza di provocazione.
La prima immagine è volutamente aggressiva. È un fitto sipario di corpi nudi e appesi al soffitto quello che separa il pubblico dalla struttura di legno piramidale che occupa l’intera stanza-palcoscenico. Bloccata, quasi infilizata sulla cima di queste travi appare una donna, la pelle arrossata e annerita dal fuoco, come scorticata e sanguinolenta, in un sacrificio erotico alla Bataille. Sotto un’enorme ma ingrigita parrucca anni Sessanta, inguainata in un bustino decorato di rose, questa Winnie sferza con il suo stravolto monologo il monte di nudità che nel frattempo si sono avvinghiate allo scheletro ligneo, come in un affresco dell’Inferno; e sferza gli spettatori, nei loro abiti "civili". Come se per avere il "teatro" e catturare lo spettatore (e non solo il suo sguardo) fosse necessario prima questo denudamento, e poi andare ancora oltre, fino alla carne viva.
La Winnie di Maria Luisa Abate costruisce la sua recitazione a partire da un demoniaco surplus di energia, quasi a compensare la sua immobilità. A tratti questa forza eversiva, trascinante, può raddoppiarsi nell’ironia (magari grazie ai commenti stranianti del coro) oppure esplodere in una ribellione tanto violenta quanto inefficace, nelle varie sfaccettature dell’orgoglio e della disperazione.
Nel frattempo la stratificazione dei corpi (i generosissimi allievi della Marcido) ha dato forma a una ritualità sadomasochistica e guardona, dove s’intricano sessualità, violenza e potere, azione e passività, dominio e sottomissione. La scultura scenica di Daniela Dal Cin, intrappolando Winnie, la riduce a oggetto. E tuttavia è lei, truce e sarcastica, a esercitare, con l’energia dell’incessante monologo, un implacabile dominio sul marito Willie – quello che la regia ha trasformato in coro, in terra e suolo. È lei a vittimizzare questo amante impossibile, che la sommerge e la divora, per tutto l’arco dello spettacolo. È lei a sedurlo con un’attrazione erotica che non sarà mai soddisfatta, e che si raddoppia sul pubblico, il vero destinatario di questa messinscena del desiderio frustrato, irrigidito nel suo ruolo di voyeur così come la delirante Winnie in quello di seduttrice.
La macchina del teatro, compressa fino a esplodere in questo spazio domestico, mette a nudo i rapporti tra l’attore, il coro e gli spettatori, materializza le catene che formalizzano il desiderio e rendono possibile la comunicazione, in un rito che vieta ogni un reale contatto. Quasi alla fine di questo cerimoniale osceno, esaurita la sua parabola, la solitaria eroina beckettiana che sta per sprofondare nell’abisso e nel silenzio rifiuta la sua catena: si libera per un istante dall’immobilità, quasi a vanificare questa codificazione dei rapporti, come pronta a balzare sul pubblico. Ma più di questa immagine, uscendo da quelle strette stanze l’ultima sensazione è l’odore caldo dei corpi, labile traccia di una prossimità prima quasi oscena e infine intima, forse di una comunità.
Una canzone d’amore (1998)
(…)
Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa costruiscono macchine teatrali che aspirano a una totale, implacabile coerenza. La scena stessa del nuovo spettacolo del gruppo torinese, Una canzone d’amore (ovvero il Prometeo eschileo riscritto, diretto e incarnato da Marco Isidori, replicato nel teatrino di Longiano), è già un mondo. Forse è il mondo. Di più, è un mondo in cui sono incastrati altri mondi: Prometeo, colui che si è ribellato alle imposizioni degli dei e ha liberato per gli uomini le forze della natura – il fuoco – è incatenato al centro di una gigantesca sfera di ferro, quasi a parodia del celeberrimo uomo vitruviano disegnato da Leonardo, dell’essere inchiodato alla propria individualità. Intorno a questa gabbia-prigione, in forma di cornice, un’arco sempre di ferro indica un ulteriore orizzonte, quello del boccascena. Lo spettacolo, nella fusione di architettura, teatro, musica, danza, aspira all’opera d’arte totale, o totalizzante. I versi martellati e ridotti a cantilena, i gesti ricondotti all’uniformità della coreografia, le scene e i costumi, i lacci che costringono gli attori e li apparentano alla materia inanimata, tutto sembra aspirare a una perfezione granitica, che non tollera scarti e imperfezioni (anche se l’unità del coro non è ancora del tutto a punto). Ma poi qualcosa sfugge sempre. È l’irruzione mitica e quasi carnevalesce di Io, l’eterna fuggiasca cui dà voce Maria Luisa Abate. È simbolicamente lo stesso Prometeo che alla fine di questa tragedia cantata si libera dai suoi vincoli.
A tutto tondo (2000)
Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa (ovvero Marco Isidori, drammaturgo e regista, e Daniela Dal Cin, creatrice di complesse e affascinanti macchine sceniche) inseguono da anni, con una coerenza che sfiora l’autolesionismo, la loro visione teatrale. Questa volta a ospitare la nuova tappa del percorso dei Marcido è il Teatrino San Domenico, ovvero un appartamento in cima a uno stupendo palazzo della Torino vecchia, cui si accede per appuntamento e tra premurose cure. Vi si replica A tutto tondo, ovvero Nuova certificazione del mondo di Suzie Wong, un testo (di Isidori) volutamente oscuro, oltre il limite dell’insensatezza, costruito intorno a un metodico smantellamento del significato attraverso la disarticolazione sintattica e l’addensamento di metafore oscure: "codesta Seratina solo una Festa è dell’empietà autorale Sua: flusso sturato, deficiente al massimo, del tutto incontinente e cieco veramente è questo tale male". È quasi un’ansia di rendere impossibile ogni interpretazione, in un delirante parossismo verbale e metaforico. Martellante parodia dell’ineffabile caro alla lirica, questo rap barocco s’avvita come uno sfogo provocato dal gas esilarante. La forma è quella di un "teatro canzonetta" che – addensando banalità e discontinuità logiche, finte vertigini e sfuggenti ironie – obbliga lo spettatore a un faticoso esercizio di decifrazione destinato all’insuccesso e alla frustrazione, per spingerlo a de-pensare per trovare diversi livelli di percezione.
È chiusa in una gabbia, questa vertigine di parole: come in un fumetto d’avventura, in cima alle sbarre ci sono le repellenti teste mozze di chi si è avvicinato al mistero e non ha superato la prova. All’inizio dello spettacolo, la grata cala verso il pubblico, a segnalare una zona di pericolo. In primo piano, c’è la sagoma di un mansueto gorilla che verrà smembrato per consentire l’apparizione della protagonista della serata: la sensuale e terribile Suzie Wong (l’energetica e controllatissima Maria Luisa Abate, con i suoi potenti virtuosismi vocali). È una memoria vagamente anni Cinquanta, che funge da puro pretesto per l’invenzione di un feticcio di soubrette: Daniela Dal Cin l’ha trasformata in una farfalla con zoccoli da equino, ibrido inquietante di una seduzione grottesca e narcisista.
Rinchiuso e compresso con Suzie in questa gabbia-bomboniera rosa e vezzosa, a riversare questo flusso verbale sul pubblico, c’è anche il coro di sei "cinesini", ovvero la corte che ruota intorno al corpo seducente e terribile (ma con qualche pizzico d’esasperata auto-parodia) di Suzie: calzamaglia nera unisex e pesante trucco nero, i cinesini hanno funzione di prologo, commento e contrappunto vocale e gestuale, ma non costituiscono mai un antagonista.
Ma questa declamazione che tende al canto, per quanto ricca di micro-dinamiche interne, resta dal punto di vista drammaturgico sostanzialmente statica, ossessivamente ripiegata su se stessa. Così l’azione poggia per intero sulle invenzioni scenografiche: l’improvviso sollevarsi del pavimento, l’aprirsi delle botole, il tripudio masochistico di corde e fettucce con cui Suzie viene alla fine imbozzolata – mentre la spossata attrice-feticcio continua a esibire l’oscena spaccatura del linguaggio, il baratro che inghiotte il senso, una ferita sempre uguale a se stessa.
