L'editoriale di ateatro 101
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and1
Il codice Grotowski
Appunti sulla bibliografia grotowskiana
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and10
Nuovi media, nuovo teatro?
Le definizioni, la mutazione, gli schermi
di Anna Maria Monteverdi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and12
I switch on
Play di Beckett in Virtual Reality
di Lance Gharavi (traduzione di Anna Maria Monteverdi)
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and13
Il teatro di marionette catalano
Una intervista con Carles Canellas
di Anna Maria Monteverdi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and14
Le recensioni di ateatro: Ur-Hamlet, drammaturgia e regia di Eugenio Barba
L'utopia teatrale multiculturale dell'Odin Teatret
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and16
A cosa servono tutti questi organizzatori?
L'intervento per il convegno Management culturale e formazione
di Mimma Gallina
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and20
Santarcangelo 2006 tra continuità e innovazione
Catherine Diverrès, Forced Entertainment, MK, Roberto Castello, Rodrigo García
di Giorgia Sinicorni
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and31
Le recensioni di ateatro: The Secret Room di Renato Cuocolo con Roberta Bosetti
Invito a cena con segreto
di Andrea Balzola
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and50
Le recensioni di ateatro: Faccia di fuoco di Marius Von Mayenburg
Regia di Oskaras Koršunovas
di Stefania Bevilacqua
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and63
Il nuovo cda del Piccolo Teatro da Rosa a Risè
Gli enti locali lavorano alle nomine
di redazioni ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and81
Hystrio 3 - 2006
Il sommario e i vincitori del Premio
di Hystrio
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and82
Cascina: bando per residenze di nuovo teatro
La Città del Teatro lancia Contact
di Città del Teatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and83
Altofragile: un percorso formativo con i Motus
Per la realizzazione di un lungometraggio
di Motus
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and84
Premio "Dante Cappelletti" per le arti sceniche
Il bando
di Tuttoteatro.com
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and85
La mente da sola: un mosaico di lettere per giovani attori
Il saggio finale del Scuola di perfezionamento per attori del Centro Teatrale Santacristina diretto da Luca Ronconi e Roberta Carlotto
di Centro Teatrale Santa Cristina
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and86
I Premi della Critica teatrale 2006
La consegna al Teatro Argentina il 21 settembre
di ANCT
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and87
Tre stabili per una compagnia
La Fondazione del Teatro Stabile di Torino, il Teatro di Roma e la Fondazione Teatro Due di Parma uniscono le forze
di Ufficio Stampa TeatroStabile Torino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and88
I vincitori dei Premi Olimpici al Quirinale
Giorgio Napolitano riceve il teatro italiano
di Ufficio Stampa ETI
19/09/2006
La carica del 101 (e Il codice Grotowski)
L'editoriale di ateatro 101
di Redazione ateatro
Beh, ce l’abbiamo fatta, 101 è online!
Ed è bello grasso. E pieno di parole (oltre che di immagini...). Ma con le parole non è così facile. Per esempio, cominciamo dallo strepitoso elenco compilato - per il suo nuovo exploit teorico & critico - da Anna Maria Monteverdi vagabondando tra libri e siti:
Virtual (Reality) Theatre (o VT o VTheatre o VR performance), Digital Puppet Theatre, Virtual Puppetry, Interactive Theatre, Augmented Reality Theatre, Artificial Theatre, Enhanced Theatre, Expanded Performance, Cyborg Performance, Cyber Performance, Mobile Performance, Digital Performance, Computer Theatre, Mixed Reality Stage, Real Time Performance, Instant Digital Theatre, Live Online Performance, Net Drama, E-Theatre, Internet Theatre, Net Theatre, Chat Performance, Id Theatre, Webcam teatro, Hacker teatro, Web Streaming Performance, Web-based Drama, Digital Story Telling, Telematic Performance, Performance in Remote Connection, Networked Theatre, (Computer) Mediated Theatre, Intermediated Performance, Hyperdrama, Interactive Generative Stage, Multimedia Interactive Performance, Intelligent Stage, Activation Space, Multidisciplinary Media Performance, Trans-media Performance, Electronic Theatre, Live Cinema, Interfaced Theatre, Image-based Theatre, Synesthetic Theatre, Crossmedial Performance, Fractal Theatre, Machinic Performance, Recombinant Theatre, Chromakee Performance, Mocap Performance...
Insomma, se pensiamo al rapporto del teatro con le nuove tecnologie, ci si perde in un autentico labirinto: ma la prode amm ha trovato la bussola, o il filo d’Arianna, per trovare una via d’uscita.
Poi, le parole di Jerzy Grotowski, Che cosa ha voluto dire veramente - non a noi, né ai nostri figli, forse ai nostri nipoti - il padre del nuovo teatro? Un plotone di filologi ha trovato in “Gurutowski” la sfida finale, con risultati sorprendenti - e a volte divergenti e confliggenti... Se volete provarci anche voi, a capire Grotowski, Oliviero Ponte di Pino prova a delimitare il terreno (e come suo solito fa ancora più confusione...).
Ma non è tutto: in questo 101, si parla anche di Beckett virtuale e marionette catalane, di un Amleto voodoo e dell’utilità degli organizzatori, eccetera eccetera... Insomma, alla carica!!!
Nel frattempo siamo già al lavoro su 102. Abbiamo in cantiere uno “speciale Milano” (perché in città sta cambiando tutto perché nulla cambi), e pensiamo a un incontro pubblico a fine ottobre sulla situazione cittadina (insomma, se avete qualcosa da dire sulla situazione cittadina, parlate ora o tacete per sempre).
E poi, udite udite, stiamo per lanciare le Buone Pratiche 3, a Napoli, all’inizio di novembre. Dao che ce la facciamo! Ma abbiamo bisogno di idee, di sostegno, di affetto.
ps se però il geniale e impenetrabile Grotowski lo volete semplice semplice,
c'è sempre (dal forum) il vergognoso
G. a rime baciate
fu grotowski il gran polacco
che il teatro ha messo in scacco
stanislavskij e poi artaud,
terzo rivoluzionò
con il training ed il corpo
mandò in scena senza un orpo
od orpello ma sol quello
che s'incarna nel duello
tra l'attore e 'l spettatore
che s'affrontano col cuore
barba eugenio l'ha scoperto
ma d'allievi questo è certo
ne ha trovati dei milioni
di cui certi son coglioni
materialista mistico
lo definisce 'sto distico
dell'estasi le tecniche
e del canto le ritmiche
non avevan più segreti
con gran rabbia poi dei preti
cardinale lo stroncò
e il buon schechner lo spiegò
era povero il suo look
che piaceva tanto a brook
ma il successo non bastava
perché verità cercava
con la gnosi ed il vudù
ha raccolto una tribù
che esplorava riti arcani
dal sipario ben lontani
lui è stato un gran maestro
che però vantava l'estro
di confondere le tracce
per vedere poi le faccie
di chi crede di sapere
che il teatro è da vedere
infin l'accolse pontedera
della scena la frontiera
ora chi se l'è incontrato
assai spesso ha dedicato
un librino od un libretto
per spiegare ch'è perfetto
chi tanto il teatro l'ama
che poi, deh!, se n'allontana
Il codice Grotowski
Appunti sulla bibliografia grotowskiana
di Oliviero Ponte di Pino
“I collegamenti possono essere invisibili, ma ci sono sempre, sepolti appena sotto la superficie.”
Dan Brown, Il codice da Vinci
La bibliografia grotowskiana in Italia, dopo una lunga quiete e qualche anticipazione negli anni scorsi, ha finalmente iniziato ad ampliarsi, con diversi testi di e su Grotowski di notevole interesse.
Jerzy Grotowski, Holiday [Święto] e Teatro delle Fonti preceduti da Sulla genesi di “Apocalypsis”, a cura di Carla Pollastrelli, La casa Usher, Firenze, 2006.
Essere un uomo totale. Autori polacchi su Grotowski. L’ultimo decennio, a cura di Janusz Degler e Grzegorz Ziółkowski, edizione italiana a cura di Marina Fabbri e Renata Molinari, Titivillus, Corazzano, 2005 (da ora in poi UT).
Il Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski 1959-1969, testi e materiali di Jerzy Grotowski, Ludwik Flaszen, Eugenio Barba a cura di Ludwik Flaszen e Carla Pollastrelli, con la collaborazione di Renata Molinari, Fondazione Pontedera Teatro-Comune di Pontedera, 2001.
Antonio Attisani, Un teatro apocrifo. Il potenziale dell’arte teatrale nel Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, Medusa, Milano, 2006 (da ora in poi TA).
Renata M. Molinari, Diario dal Teatro delle Fonti. Polonia 1980, La casa Usher, Firenze, 2006.
Annamaria Cascetta, Apocalypis cum figuris, in La prova del Nove. Scritture per la scena e temi epocali nel secondo Novecento, a cura di Annamaria Cascetta e Laura Peja, Vita e Pensiero, Milano, 2005; sullo spettacolo la Cascetta ritorna anche con La passione e la “quête”. “Christus patiens” e “Christus resurgens”, in Drammaturgie della “quête”. Convegno di studi in ricordo di Umberto Artioli (1939-2004). Padova, 24-25 maggio 2005, a cura di Elena Randi e Cristina Grazioli, Esedra editrice, Padova, 2006.
A questi titoli va aggiunta la riedizione di un testo imprescindibile (e di struggente bellezza), pubblicato originariamente nel 1998:
Eugenio Barba, La terra di cenere e diamanti. Il mio apprendistato in Polonia seguito da 26 lettere di Jerzy Grotowski a Eugenio Barba. Nuova edizione arricchita da materiali inediti, Ubulibri, Milano, 2004.
Senza dimenticare, tra gli altri:
Zbignew Osiński, Grotowski e la gnosi, con una nota di Franco Ruffini, in “Teatro e Storia”, 25, Anno XVIII, 2004, 293-326;
Intorno a Grotowski, numero speciale di “Culture Teatrali”, Studi, interventi e scritture sullo spettacolo, a cura di Marco De Marinis, n. 9, autunno 2003;
Gabriele Vacis, Awareness. Dieci giorni con Jerzy Grotowski, Holden Maps/Scuola Holden, Rizzoli, Milano, 2002.
Federico Tiezzi, Workcenter di Jerzy Grotowski a Pontedera: Action, maggio 1998, in il Patalogo 21, Ubulibri, Milano, 1998, pp. 243-246.
A questi titoli vanno aggiunti i testi prodotti direttamente dal Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards:
Thomas Richards, Al lavoro con Grotowski sulle azioni fisiche, con una prefazione di Jerzy Grotowski e il saggio “Dalla compagnia teatrale a L’arte come veicolo”, Ubulibri, Milano 1993.
Finalmente - si diceva - questa bibliografia si arricchisce, perché il regista polacco è stato uno dei grandi protagonisti del teatro moderno, artefice di quella che egli stesso ha definito “Seconda Rivoluzione Teatrale del Novecento”. Nella laudatio per la laurea honoris causa conferitagli nel 1991 dall’Università di Wrocław Janusz Degler ha schematizzato i suoi principali meriti.
1) La formulazione dell’idea del “teatro povero”, originata dalla protesta contro la forma banalizzata del teatro dei grandi allestimenti e il suo stile ricco ed esteriore [...]
2) La scoperta di nuove metodologie di lavoro con l’attore che consentivano non solo il raggiungimento della perfezione nella tecnica attoriale, ma anche, e soprattutto, di svelare la personalità dell’attore [...]
3) La creazione di una propria filosofia teatrale e la conquista, da parte del teatro, di tutti quei diritti che le altre arti (soprattutto la letteratura) avevano ottenuto già da tempo [...]
4) L’aver dato inizio a ricerche parateatrali e l’aver realizzato numerosi programmi ed esperimenti che hanno avuto un significato fondamentale per la formulazione del concetto di “cultura attiva” [...] Riconosceva al teatro funzioni non tanto estetiche, quando conoscitive ed etiche [...]
5) L’ampliamento e, nel contempo, l’approfondimento della comprensione del fenomeno teatro attraverso la ricerca dei suoi legami con il rituale, risalendo alle sue radici culturali [...]
6) Infine, non ci si può esimere dal ricordare che [...] è autore di alcune decine di dissertazioni e articoli nonché del testo programmatico Per un teatro povero, spesso chiamato “la Bibbia del nuovo teatro”.
(Laudatio, in UT, pp. 91-98)
Eugenio Barba focalizza e arricchisce l’elenco:
La riscoperta e la pratica del training, le innovazioni dello spazio scenico, la relazione attore-spettatore, la ristrutturazione drammaturgica del testo, il senso e il valore del teatro.
(La terra di cenere e diamanti, cit., p. 32)
Vale la pena di sottolineare, con Barba, una delle rivoluzioni grotowskiane meno appariscenti:
L’intervento del regista sul testo drammatico non è nuovo nella storia del teatro del nostro secolo [...] Grotowski, però, ha affrontato i classici con la caparbia convinzione che essi contengano un archetipo, una situazione fondamentale della condizione umana. Per renderne consapevole lo spettatore, Grotowski costruiva equivalenti scenici che derivavano in maniera coerente dal testo, ma che ne alteravano la lettera con un estremismo mai visto nella storia del teatro e che a quel tempo era considerato sacrilego. Tale procedimento generava un nuovo avatar del testo, che acquistava, così, la stessa funzione del mito che i tragici greci ad Atene interpretavano con libertà assoluta come una matrice di varianti.
(ivi, p. 39)
Insomma, ce n’è abbastanza per meritarsi un posto di primo piano nella storia del teatro e in generale della cultura, e per diventare il punto di riferimento di generazioni di teatranti. Così, se si tiene conto della sua influenza su artisti come Barba, Brook e Vasil’ev, si capisce come ogni iniziativa volta a divulgare e discutere il pensiero e la pratica di Grotowski debba essere accolta con favore e attenzione.
Finalmente, anche perché nella sua ricchezza e complessità (e nelle sue pieghe oscure) quel percorso continua a presentare spunti di riflessione e nodi irrisolti. Per certi aspetti, Grotowski sembra addirittura diventato oggetto di sorta di una disputa dottrinale, alla ricerca delle radici filosofiche, teologiche, cosmologiche (consapevoli o inconsapevoli) delle sue pratiche: un Grotowski cattolico si contrappone così a un Grotowski gnostico, un Grotowski induista s’intreccia con un Grotowski panteista... E, oltre il sincretismo, rispunta inevitabile, ancora una volta, la caccia a un Grotowski segreto, a un sapere esoterico da decodificare e smascherare.
Dunque ben vengano approfondimenti e discussioni, tenendo presente l’atteggiamento di Antonio Attisani all’inizio del suo studio:
per chi non ha lavorato con lui, Grotowski è un “testo”.
(TA, p. 7)

Jerzy Grotowski.
Neppure io (se mi è concessa una divagazione personale) ho mai “lavorato con Grotowski”. Insomma, per me è sempre stato un testo. L’ho sentito parlare in diverse occasioni, e ho avvertito come molti il suo carisma di Maestro. Dopo aver assistito a una delle ultime repliche di Apocalypsis cum figuris, ho partecipato, nel lontano 1979, a un’iniziativa parateatrale: tuttavia sono rimasto estraneo alle dinamiche innestate in quell’occasione, che anzi avevano suscitato in me una reazione di rigetto. L’avevo raccontato, all’epoca (vedi Un week end con Grotowski, in il Patalogo due, Ubulibri, Milano, 1980, pp. 74-75). Tuttavia - me ne rendo conto oggi con chiarezza - era fin troppo facile scrivere perché non si era grotowskiani.
In quei tempi, era invece molto più difficile scrivere (e forse impossibile pubblicare) perché si era grotowskiani. Per pubblicare il suo Diario dal Teatro delle Fonti Renata Molinari ha atteso per un quarto di secolo. Allo stesso modo la straordinaria rievocazione del suo apprendistato polacco nei primi anni Sessanta da parte di Barba - un incontro fondamentale nella storia del teatro e un racconto pieno di fascino e di spunti illuminanti - è stata pubblicata per la prima volta solo nel 1998.
Però il dialogo tra Grotowski e i teatranti non si è mai interrotto. Chi, a differenza del regista polacco, ha continuato ha frequentare il teatro come artista o come spettatore ha dovuto tener conto delle sue provocazioni e trasgressioni. Lo ha detto molto bene Ludwig Flaszen quando - in occasione della morte - ha sottolineato l’importanza del percorso di Grotowski:
Ognuno vi troverà qualcosa. E lo faranno anche, andando contro le aspirazioni massimaliste di Grotowski di sperimentare l’Essenza, quelli tra noi che non hanno avuto la possibilità di percorrere quella strada in modo naturale, colpevoli, ma senza complessi, di accettare la vita come un sogno e di praticare onestamente il mestiere del teatro, la cui bellezza consiste proprio nell’essere una specie di sogno nel sogno.
(Se ne è andato, in UT, p. 129)
La questione dei testi
Nel trattare “Grotowski come testo” sorge subito un problema, che la stessa Renata Molinari, da sempre partecipe esegeta del verbo grotowskiano, sottolinea nella “nota editoriale” all’importante raccolta di saggi Essere un uomo totale:
Esiste una questione dei testi grotowskiani: traduzione rivista dall’autore, non rivista, autorizzata, versione definitiva, definitiva è quella inglese, italiana... Parole chiave, definizioni, programmi di lavoro, titoli che cercano progressivamente la loro formulazione, il loro nome, infine.
(UT, p. 38)
La questione caratterizza l’intera produzione testuale grotowskiana, a partire dalla “Bibbia del nuovo teatro”:
risulta, praticamente, che esso [Per un teatro povero] non ha un originale: alcuni capitoli vennero scritti in polacco, altri nacquero dalle lezioni tenute da Grotowski a Bruxelles in francese ma che, stenografate dagli studenti belgi in fiammingo, vennero tradotte da questo in inglese. Il miscuglio linguistico è mostrato anche dal titolo franco-inglese Le Performer et le teacher of Performer, redatto da Georges Banu, autorizzato da Grotowski.
(Zbignew Majchrowski, Chi era Jerzy Grotowski?, in UT, p. 291)
Fin dagli inizi l’attenzione dell’autore alle traduzioni è stata maniacale. Nel 1967 si era ventilata la possibilità di pubblicare alcuni testi di Grotowski in inglese. Eugenio Barba (che è tra l’altro un autentico poliglotta) ricorda che
Grotowski cominciò a rielaborare i suoi testi già tradotti, facendo aggiunte e tagli. [...] La maggior perdita di tempo era determinata dalla revisione finale di ogni testo. Grotowski controllava minuziosamente ogni singola parola: benché a quel tempo non parlasse inglese, si ostinava a voler mantenere certe costruzioni di frasi alla francese (lingua nella quale ora riusciva a leggere e ad esprimersi) anche se in inglese acquistavano altri significati o diventavano semplicemente senza senso. Judy [la moglie di Barba, inglese, n.d.r.], che era incinta, era irritata ed esausta, ma altrettanto ostinata nel difendere la sintassi e il buon senso della sua lingua. Io cercavo di mediare. Conoscevo la spregiudicatezza linguistica di Grotowski e la sua maniacale puntigliosità nelle traduzioni, ma ero anche consapevole di come una prosa inglese sgradevole e forzata potesse sminuire il valore del libro. Questa, che a dirla sembra una pacifica ovvietà, nella pratica era una lotta. Potevamo perdere una sera intera per decidere come tradurre una frase.
(La terra di cenere e diamanti, cit., p. 93)
Malgrado gli sforzi pedagogici di Barba - che ama ricordare un sorprendente giovane Grotowski con “senso dell’humour e una spiccata propensione alla boutade e ai giochi di parola” (La terra di cenere e diamanti, cit., p. 25) - questo atteggiamento non è cambiato nel corso degli anni. Così molti testi esistono in versioni diverse nelle varie lingue da lui frequentate - se non davvero conosciute - con soluzioni spesso inventive.
Non è solo la scelta del plurilinguismo da parte di chi, tenendo conferenze e lezioni in vari paesi, si confronta con diversi ambiti linguistici. Di chi, oltretutto cerca nelle diverse lingue la tonalità più adatta a restituire la pienezza di un significato che altri termini, in altre lingue, sembrano cogliere con minor precisione. Bisogna anche ricordare che “pochissime di queste cose sono state scritte da Grotowski” (TA, p. 19): i suoi testi sono spesso trascrizioni di conferenze, lezioni e interventi orali. A volte si pone addirittura un problema di diritti (materiali e morali), nel caso di interviste o di trascrizioni di interventi pubblici, conferenze o seminari (vedi UT, p. 143).
Inutile sottolineare quanto l’oralità fosse per Grotowski un elemento vitale. Su questo hanno giustamente insistito tra gli altri Stanislaw Rosiek e Richard Schechner:
Molti maestri, da Buddha e Socrate a Gesù e i maestri sufi, hanno vissuto nella tradizione orale, anche se più tardi i loro insegnamenti vennero trascritti.
(Richard Schechner, Exoduction, citato in UT, p. 269)
Un ulteriore ordine di problemi è determinato dalla situazione in cui Grotowski si è trovato a operare nel corso della sua carriera. All’inizio, in Polonia, il Teatr Laboratorium dovette muoversi con grande astuzia per sopravvivere agli attacchi e alle censure del regime comunista e all’ostilità della Chiesa cattolica. Una delle più celebri “maschere verbali” utilizzate da Grotowski, quella di “rituale laico”, al di là del suo effettivo significato, sembra fatta apposta per rassicurare entrambi.
Questa cautela difensiva (che all’inizio poteva mimetizzarsi con lo humour e l’amore per i giochi di parole, ma che via via con il peggiorare della situazione assunse tonalità sempre più drammatiche) era un habitus mentale ben radicato. Quando, già in esilio, incontrò il fratello Kazimierz in California, decise addirittura di non rilasciare più interviste, per non rischiare di danneggiarlo (vedi UT, pp. 81-82).
La lingua che Grotowski utilizzò nei suoi testi in parte aveva un carattere esoterico, attento ai tratti fondamentali della sua filosofia, in parte, invece, era cifrata perché teneva conto delle prevedibili perplessità del mecenate statale. I risultati di questa prudenza non furono sempre felici: a volte non si capiva che cosa avesse omesso per irrilevanza e cosa, invece, per esigenze di cospirazione.
(Małgorzata Dziewulska, Il ladro di fuoco, in UT, p. 151)
Quando la stessa Dziewulska parla di “progressivo occultamento dell’oggetto di ricerca del Laboratorio”, utilizza il termine utajnień, “con cui in Polonia si indicava l’occultamento di prove o documenti sotto il regime comunista” (UT, p. 150, nota 2).
In seguito, quando si trattò di ottenere l’appoggio di mecenati e istituzioni universitarie americane, frasi e termini dovevano essere perfettamente calibrati. In Italia (dove è stato sostenuto prima soprattutto dal Crt, diretto da un intellettuale cattolico “ortodosso”; e poi a Pontedera, nella “rossa” Toscana) non ci sono stati problemi del genere, anche se va registrato un curioso incidente, come testimonia in una lettera dello stesso Grotowski a Eugenio Barba, datata 7 settembre 1965. Il direttore della Biennale veneziana Vladimiro Dorigo aveva invitato il Teatr Laboratorium e
aveva ottenuto il consenso e persino l’appoggio della parte polacca. E poi, incomprensibilmente, ha cominciato a far marcia indietro, da un giorno all’altro. [...] Quando infine ci siamo messi d’accordo [...] ha cominciato ad allarmare i polacchi manifestando timori che il carattere antireligioso del nostro spettacolo potesse ferire la sensibilità degli italiani. Quando persino questo punto è stato chiarito, ci ha inviato un telegramma dicendo che il viaggio era caro, mentre avevamo stabilito i costi in precedenza. Non ci capisco niente.
(Jerzy Grotowski, in Eugenio Barba, La terra di cenere e diamanti, cit., pp. 146-147)
Un ulteriore livello di difficoltà nasce dall’ambizione stessa del progetto grotowskiano, che si è spinto in territori inesplorati. Trovare nuove parole per nuove esperienze, senza creare equivoci e fraintendimenti, è impresa sempre ardua - anche perché si scontra con categorie interpretative già consolidate e in apparenza pronte all’uso.
Come ha sottolineato Zbignew Osiński, “Grotowski tracciava il cammino”, e ciò comportava il fatto che spesso si servisse di un linguaggio esplicativo creato soltanto in una prospettiva temporale, mentre la lingua delle descrizioni fatte da altri si basava su formule forse sperimentate ma ormai del tutto inadeguate.
(Grzegor Ziółkowski, Introduzione, in UT, pp. 24-25)
Sintomatica la presentazione, da parte dello stesso ideatore, del Teatro delle Fonti a Varsavia nel 1978, a giudicare dal racconto di un testimone:
Davvero non poteva ancora dir loro che cosa fosse il “Teatro delle Fonti”; e non poteva, per ora, perché non esiste per questo ancora una lingua adatta, e una lingua adatta ancora non esiste perché una lingua così, per tutto ciò che è nuovo nelle sue ricerche, lui la trova soltanto quando è già al “dopo”, e non quando di trova “durante”, che è dove si trovava proprio adesso.
(Józef Kelera, Grotowski wielokrotnie, 1999, cit. in UT, p. 201)
Ma non è tutto. Si è già accennato a un aspetto esoterico.
L’esasperante elusività del linguaggio di Grotowski è, nel modo, più evidente, una questione di linguaggio [...] è tra quegli artisti che, deliberatamente o meno, si servono di un linguaggio ufficiale per nascondere piuttosto che rivelare le proprie idee. Mentre la sua predilezione per maschere verbali come “cultura attiva” e “dramma oggettivo” è fin troppo evidente, il suo linguaggio in qualità di personaggio pubblico da un lato e di artista dall’altro sono due cose piuttosto diverse, spesso estranee una all’altra. Grotowski dice soltanto ciò che ritiene debba essere detto in quel dato momento - non solamente per assicurare finanziamenti al suo lavoro, ma cosa più importante, per proteggere un processo creativo ben lontano dal suo completamento e dalla sua articolazione.
(Halina Filipowicz, Dov’è “Gurutowski”?, in UT, pp. 142-143)
La complessità degli scritti di Grotowski - e la sua libertà nell’uso del materiale testuale - si spinge fino all’occultamento (o al mascheramento) delle fonti, con criptocitazioni e libere rielaborazioni di opere altrui. Esemplare, in questo senso, l’inventiva riscrittura dei sermoni di Meister Eckhart che conclude uno dei suoi testi più celebri, Il performer, vivisezionata prima da Ferdinando Taviani (Commento a “Il Performer”, in “Teatro e Storia” 5, III, 2, ottobre 1988) e poi da Antonio Attisani (TA, pp. 66-71).
Riassumendo la “questione dei testi”, qualunque interpretazione degli scritti grotowskiani (e di Grotowski come testo) deve superare numerosi filtri e distorsioni: una autorialità intermittente, l’importanza dell’oralità, l’esistenza di versioni differenti (e in varie lingue), l’insieme di reticenze, opportunismi e astuzie per fronteggiare potenti e mecenati, la costante ricerca di una lingua in grado di descrivere un’esperienza in fieri, una probabile dimensione esoterica con tutte le elusività che ne conseguono, l’occultamento e il mascheramento delle fonti.
Senza dubbio Grotowski provò [...] a creare una nuova lingua in grado di descrivere le zone della realtà che lo interessavano e le possibilità d’azione ivi nascoste. Uno dei problemi più complessi nel cogliere il senso di quello che ha fatto [...] è la valutazione di quanto sia una nuova lingua o di quanto invece sia proprio un codice.
(Małgorzata Dziewulska, Il ladro di fuoco, in UT, p. 151)
Non c’è solo la cura con cui Grotowski maneggiava le parole: c’è anche il valore che attribuiva al silenzio. Chi ha partecipato a esperienze parateatrali sa che il silenzio era una delle condizioni richieste, a volte dallo stesso Grotowski:
Da domani non parlerete: non c’è bisogno di raccontarsi le cose, non c’è bisogno di chiamarsi a voce alta, se avete bisogno di qualche cosa, a tavola, per esempio, nei momenti comuni, potete chiederlo: ma non è neppure necessario, lo si può prendere e basta. Non siamo qui per essere gentili gli uni con gli altri. Certo non vogliamo essere brutali, ma non siamo qui per fare un’esperienza di gruppo, per stare in gruppo, stare bene in gruppo. E’ un’esperienza di solitudine; ognuno da solo si confronta con le diverse tecniche.
Neanche i conduttori parleranno molto. Si procederà come nella forma della tradizione, per imitazione.
(Diario, cit., p. 48)
Ulteriore complicazione,
ci sono le parole, i racconti di quanti l’hanno incontrato o hanno incontrato le sue opere: racconti che fanno testo, prima ancora di costruire una cronologia e poi una storia.
(Renata Molinari, Diario del Teatro delle Fonti, p. 11)
Oltretutto Grotowski - anche se il fulcro delle sue ricerche, lungo un percorso articolato e ricco di svolte, è stato sempre preciso e determinato nei suoi obiettivi - non ha mai pensato di costruire un metodo o un sistema:
non ha dato al suo insegnamento una forma durevole. Questo o perché non sapeva farlo, o perché non voleva farlo [...] ha affermato categoricamente: un sistema è un letto procustiano.
(Leszek Kolankiewicz, Grotowski alla ricerca dell’essenza, in UT, p. 284)
In definitiva per lui la parola (e soprattutto la parola scritta) è stata costante terreno di guerra e guerriglia:
Grotowski ha sempre lottato con e contro il linguaggio e la parola. Non voleva trasformare una pratica in una dottrina di scrittura.
(TA, p. 34)
O, se si preferisce una chiave più allusiva e sapienziale:
Dice un vecchio saggio cinese che chi sa, non parla: parla colui che non sa: Grotowski non parlava, al massimo si esprimeva con sorridenti allusioni.
(Ludwig Flaszen, Se ne è andato, in UT, p. 129)
Le due tradizioni
A rendere ancora più delicata la decodificazione di questa “parola in guerra” è un altro fatto, un ulteriore intreccio difficilmente districabile quando si tratti di fissare o di analizzare una terminologia.
Grotowski sembra potersi inserire benissimo in due diverse tradizioni. Da un lato si può vedere in lui l’anello successivo della catena dei riformatori teatrali formata da Stanislavskij, Craig, Mejerhol’d, Vachtangov e Brecht; dall’altro però lo si può agganciare alla linea dei mistici e degli gnostici, segnata dalle seguenti figure: san Giovanni della Croce, Meister Eckhart, Adam Mickiewicz, Carl Gustav Jung.
(Grzegor Ziółkowski, Introduzione, in UT, p. 34)
Si potrebbero aggiungere facilmente altri nomi: sul primo versante senz’altro Artaud, sul secondo Gurdjieff e Buber (con i chassidim). La genealogia teatrale potrebbe precisarsi e triplicarsi, come suggerisce Eugenio Barba:
E’ possibile tracciare una linea che colleghi il teatro di Grotowski alle rivolte e ricerche teatrali della prima metà del ’900, lungo il versante slavo: Stanislavskij-Vachtangov-Mejerchol’d-Ejzenštein-Grotowski. Oppure una linea meno usuale, attenta al lavoro dell’attore e del regista dentro e contro il testo: Mejerchol’d-Brecht-Grotowski. O ancora, una linea che porta fuori dall’orizzonte dello spettacolo come fine unico del lavoro teatrale: Stanislavskij-Suleržickij-Copeau-Osterwa-Grotowski.
(La terra di cenere e diamanti, cit., p. 11)
La sostanza però non cambia. Grotowski ha intrecciato due tradizioni diverse, senza evidenti punti di contatto. Di più: ha abbandonato la prima (il teatro); e non ha mai esibito la seconda (la linea mistico-gnostica), o per lo meno non l’ha mai esplicitata o tematizzata in maniera così puntuale, tanto è vero che se ne è iniziato a discutere solo in tempi relativamente recenti (Zbignew Osiński, Grotowski e la gnosi, cit.; ma la sua riflessione sul tema è iniziata nel 1988).
La nostra ignoranza è, allora, un’altra delle forme di cifratura del messaggio di Grotowski.
(Małgorzata Dziewulska, Il ladro di fuoco, in UT, p. 153)
La compresenza di queste due tradizioni ha radici molto antiche. Si intrecciano già nei primi anni del Teatr Laboratorium, come ricorda Eugenio Barba:
Esiste un doppiofondo nell’agire teatrale di Grotowski. Da un lato lo spettacolo è un rituale “laico” che coinvolge, avviluppandoli in un’osmosi spaziale, attori e spettatori, facendoli meditare sulle ferite della condizione umana. [...] Dall’altro lato vi è una tensione segreta, che va oltre il valore artistico e sociale dello spettacolo, verso una religiosità (non una religione) che per Grotowski, da quando lo conosco, si lega soprattutto all’induismo. E’ questa tensione che, attraverso un’estetica e una tecnica, lo ha spinto verso la trasgressione: una parola chiave nella terminologia di Grotowski negli anni di Opole. La rappresentazione è un atto di trasgressione, permette di abbattere le nostre barriere, trascendere i nostri limiti, riempire il nostro vuoto, realizzare noi stessi, entrare nel territorio del sacrum.
(La terra di cenere e diamanti, cit., pp. 40-41)
Questo “doppiofondo”, precisa Barba, trovava un’immediata applicazione nel lavoro con gli attori:
Grotowski e io parlavamo tra noi di due tipi di tecniche e le avevamo definite “tecnica 1” e “tecnica 2”. La “tecnica 1” si riferiva alle possibilità vocali e fisiche e ai diversi metodi di psico-tecnica tramandatici da Stanislavskij in poi. A questa “tecnica 1”, che poteva essere complessa e raffinata, si poteva conseguire [sic] attraverso il rzemiosło, l’artigianato teatrale.
La “tecnica 2” tendeva a liberare l’energia “spirituale” in ognuno di noi. Era un cammino pratico che indirizzava il sé sul sé, dove si integravano tutte le forze psichiche individuali, e superando la soggettività, permetteva di accedere alle regioni conosciute dagli sciamani, dagli yogi, dai mistici. Credevamo profondamente che l’attore potesse accedere a questa “tecnica 2”. Ne supponevamo il cammino, ricercavamo i passi concreti da compiere per inoltrarci nella notte oscura dell’energia interiore.
(La terra di cenere e diamanti, cit., p. 53)
Grotowski regista
Per capire le implicazioni di questo “doppio binario” sull’attività teatrale di Grotowski, va sottolineato il suo atteggiamento insieme materialista (il training partiva dalla realtà fisica, dal corpo degli attori, dal suono) e sperimentale, per tentativi, errori, approfondimenti (il “Laboratorium”). L’atteggiamento pragmatico venne ribadito con forza anche nel Performer:
L’uomo di conoscenza dispone del doing, del fare e non di idee e teorie.
(op. cit., p. 17)
Sul piano del linguaggio Grotowski
ebbe sempre l’accortezza di parlare più delle tecniche che dell’essenza.
(Małgorzata Dziewulska, Il ladro di fuoco, in UT, p. 157)
Di qui molte equivoci e critiche, per una prassi e una “non-teoria” che risultavano incomprensibili a chi ragionava in base a schemi prefabbricati:
Agli alchimisti veniva rimproverato da un lato che, da chimici, si lasciassero andare al mondo delle fantastiche immaginazioni ermetiche, dall’altro che, da gnostici, restassero impantanati insensatamente nel rozzo mondo della materia.
(Leszek Kolankiewicz, Grotowski alla ricerca dell’essenza, in UT, p. 251)
Nelle attività successive al Laboratorium si può cogliere una tensione pedagogica (e magari una certa tendenza al proselitismo), ma anche la necessità di mettere alla prova certe tecniche del corpo su altri soggetti. In generale, la sperimentazione grotowskiana
plasmava il corpo, la corporeità, ma con effetti sul piano della vita interiore, perché forse è così che va inteso l’“atto totale”.
(Zbignew Majchrowski, Chi era Jerzy Grotowski?, UT, p. 287)
In questo modo
il teatro cessa di essere una rappresentazione, e diventa uno strumento di lavoro su se stessi, un modo per lo sviluppo spirituale, cioè un veicolo.
(Tadeusz Burzyński, Grotowski - Nove anni dopo, UT, p. 105)
Fino addirittura a risvegliare
un vero e proprio sentimento di santità addormentato.
(Grzegorz Niziołek, Sorgente pura - sorgenti avvelenate, UT, p. 123)
Si può leggere il rapporto con il teatro (e il suo abbandono) da un altro punto di vista. Di norma il regista è (o meglio era) il garante del senso del testo, nei confronti sia dell’attore sia dello spettatore. Al tempo stesso, proprio in base a questa investitura, questa figura diventa il vertice dell’organizzazione del lavoro teatrale, da cui dipendono gli attori e i vari collaboratori. Ma non era certo questa la prospettiva in cui si muoveva il regista polacco, a cominciare dal suo rapporto con l’attore, il quale non poteva essere un semplice strumento su cui esercitare il proprio potere per plasmarlo e uniformarlo a un testo (a un senso) a lui estraneo.
Se si suppone che durante le prove l’attore dovrebbe costruire la sua parte in qualche modo al di fuori di sé - se egli ne è semplicemente il materiale - l’uomo non è libero. Ma chiedetegli di scoprirsi, di rivelarsi con il coraggio di attraversare le barriere, di essere sincero al di là delle parole e al di sopra della misura ammissibile, allora la sua libertà troverà espressione; non si tratta della libertà di fare qualsiasi cosa, a caso, ma della libertà di essere come si è. L’“ordine” rimane, tuttavia, come il letto della corrente: cosa è quello che abbiamo trovato e cosa non si deve abbandonare per continuare fare? E: come non difendersi dal fare, il che sembra un’impossibilità? E’ molto difficile definirlo precisamente. Comincia a esistere solo se il “regista” esiste verso l’“attore”, se smette di essere “regista” e smette di esistere;e d’altra parte, laddove l’“attore” non si nasconde davanti a lui e al suo partner e così non pensa a se stesso, alla sua paura. E non è più l’attore.
(Jerzy Grotowski, Holiday, pp. 74-75)
E’ anche un problema di potere e democrazia, di visibilità e protezione del lavoro, di successo e autorevolezza. Con una sorta di mossa del cavallo, Grotowski ha smesso di essere regista e ha ridefinito il proprio ruolo.
I chassidim, san Francesco, i folli zen si assomigliano tra loro. E’ come se si ricominciasse sempre dall’inizio, sono persone che si trovano allo stesso tempo nel cuore stesso della società e ai suoi margini.
(Jerzy Grotowski, cit. in Grotowski alla ricerca dell’essenza, in UT, p. 260)
Il suo è stato anche un modo per mantenere l’autorevolezza rinunciando al potere:
Val la pena di aggiungere che nella sociologia della religione molti dei cosiddetti culti di possessione, in particolare nell’Africa islamizzata e cristianizzata, in cui essi rappresentano la sopravvivenza dei culti tradizionali tribali, vengono descritti come culti periferici [...] nel duplice senso del termine: collocati nella vita sociale in periferia rispetto alla religione dominante, e praticati ormai soltanto negli strati sociali che ricoprono un ruolo periferico, marginale.
(ivi, p. 261)
E’ stata una scelta insieme umile e ambiziosa, che ha qualche precedente nella storia della cultura polacca:
Ci si è congedati dalle persone comuni e si è partiti per quella regione dove si incontreranno solo gli eletti. Nella zona della asetticità laboratoriale. Ecco perché proprio il teatro, con la sua umiltà e la sua compassione per la mutilazione umana, non era più necessario. L’uscita dal teatro, tutto il motivo polacco dell’uscita dal teatro, è enormemente originale e ispirato, ma è anche superbo.
(Małgorzata Dziewulska, Il ladro di fuoco, in UT, p. 163)
Non è tutto. L’attività teatrale è stata anche un’ulteriore maschera. Se si vuol trovare una conferma nella tradizione gnostica, non si può non citare un celebre passo del Vangelo di Filippo:
La verità non è venuta nuda in questo mondo, ma in simboli e immagini. Non la si può afferrare in altro modo [...] Bisogna veramente rinascere per mezzo dell’immagine.
(Vangelo di Filippo, 67, 10)
La verità non passa direttamente attraverso la parola, non la si può ingabbiare in un testo.

Il principe costante.
Tuttavia neppure questa maschera fu sufficiente a legare definitivamente Grotowski al teatro:
Uno dei motivi per cui Grotowski ha smesso di fare teatro è stato il fatto che la rappresentazione teatrale non riusciva più a soddisfare la sua necessità di trasgressione. Le sue attività successive continuano a rifarsi alla tecnica d’attore, ma soprattutto consentono di trovare altri sbocchi per la sua tensione verso il sacrum, e di tenere viva la provocazione e la trasgressione nei suoi propri confronti. E anche dei nostri, che lo osserviamo dal campo del teatro e cerchiamo di comprendere se il suo agire ha ancora senso per noi.
(Eugenio Barba, La terra di cenere e diamanti, p. 41)
Grotowski cattolico
Il rapporto con il sacrum va trattato con particolare cautela, perché tocca un altro nervo sensibile, anzi sensibilissimo: il rapporto con la religione, e in particolare con il cattolicesimo e la Chiesa cattolica.
“Gurutowski”, come l’avevano ribattezzato i giornali francesi negli anni Settanta, quando le sue iniziative parateatrali avevano un seguito di massa,
fu sempre sospettato di praticare una qualche cripto-religione.
(Grzegorz Niziołek, Sorgente pura - sorgenti avvelenate, in UT, p. 124)
Tanto è vero che
dietro il Teatro Laboratorio è stato visto a volte un convento, un ordine, una setta.
(Zbignew Majchrowski, Chi era Jerzy Grotowski?, in UT, p. 287)
Proprio “l’ampiezza dell’adesione” ai programma parateatrali negli anni Settanta, agli albori dell’era New Age
aveva suscitato anche reazioni radicalmente critiche: dall’intervento del cardinale Wysyńsky nel 1976 (rivolto principalmente contro gli elementi “blasfemi” in Apocalypsis cum figuris, in realtà teso a contrastare il richiamo di una “concorrenza” pericolosa soprattutto tra i movimenti giovanili) alle polemiche sulla stampa. Si imputava al parateatro di convogliare le energie dei partecipanti in un orizzonte metastorico, di distoglierli dall’impegno nella lotta politica in un periodo cruciale per la Polonia.
(Carla Pollastrelli, in Jerzy Grotowski, Holiday, p. 16)
Per la precisione, in quella feroce polemica
il cardinale Stefan Wyzsyńzki, parlando nella sua omelia alla Skałka sull’alcolismo del polacchi, criticò Apocalypsis cum figuris accusandolo di essere un orrore, una vera porcheria che rendeva peggiori gli spettatori. In questo modo Grotowski, che fino ad allora era stato sotto la pressione del potere, si trovò in più sotto il tiro della Chiesa.
(Leszek Kolankiewicz, Grotowski alla ricerca dell’essenza, in UT, p. 211)
Il cardinale non era solo, nella sua crociata:
Jacek Wozniakowski in “Tygodnik Powszechny” manifestò il suo sostanziale disaccordo, persino la sua collera per gli episodi blasfemi di Apocalypsis: la bestemmia, scrisse, non può essere un cammino di ricerca del sacro.
(Małgorzata Dziewulska, Il ladro di fuoco, in UT, p. 154)
Nel 1982 la scelta di abbandonare la Polonia da parte di Grotowski fu certamente determinata dalle difficoltà conseguenti allo “stato di guerra” proclamato nel dicembre dell’anno precedente per contrastare Solidarność. Ma sono diversi gli studiosi che mettono in relazione la scelta dell’esilio anche con la concomitante accresciuta influenza della Chiesa cattolica nel paese, con l’elezione a papa di un altro uomo di teatro polacco (nonché delfino del cardinale Wysyńsky), Karol Wojtyła. Lo stesso Grotowski, nella penultima lezione al Collège de France, ha ricordato che “gli stenogrammi delle riunioni tra la Chiesa e lo Stato dimostrano che i due poteri fossero d’accordo su una cosa soltanto: chiudere il Teatr Laboratorium” (TA, p. 12, nota 121).
Qualcuno si è spinto fino a chiedersi:
Forse le paure di Grotowski davanti alla critica della religione ufficiale erano il terrore dell’eretico?
(Małgorzata Dziewulska, Il ladro di fuoco, in UT, p. 165)
Può essere curioso allora confrontarsi con la lettura che dello spettacolo incriminato dà ora
Annamaria Cascetta, citando estesamente il passo in cui lo spettacolo viene messo in relazione al cattolicesimo (o meglio alla Chiesa cattolica) e lo schema ideologico in cui viene inserita questa interpretazione.
L’humus in cui lo spettacolo matura [...] è la difficile situazione della Polonia, della sua recente storia stretta fra due tirannidi, del suo popolo fiero, offeso dal cinismo di una politica che non ha mai rispettato la sua identità, la sua indipendenza e il suo diritto, del suo suolo violato dai campi di sterminio, piegato a strumento della “soluzione finale”, della sua Chiesa, con la sua forza, la sua fede antica e ardente, il suo radicamento nella realtà nazionale, l’energia dei suoi pastori (il primate cardinale Wyszyński, l’arcivescovo di Cracovia Karol Wojtyła), la saldezza, la sofferenza e i sacrifici, fino al martirio, del suo clero, la sua resistenza a una volontà di decapitarla prima (durante il nazismo) e poi di farla tacere (durante il comunismo). La Chiesa polacca, punto di riferimento e autentica custode dell’identità polacca, prima durante l’occupazione tedesca e poi durante la “sovranità limitata” della democrazia popolare, non può non essere per l’artista e intellettuale del Teatro Laboratorio un punto cruciale di riflessione e di ispirazione nella sua dialettica fra il richiamo spirituale del cristianesimo evangelico, originario, e il quotidiano impegno di una struttura temporale chiamata a fare i conti con un potere ostile, con una diplomazia centrale vaticana il cui orizzonte la travalica, con scelte tendenzialmente diverse dalle sue.
(Annamaria Cascetta, Apocalypis cum figuris, cit., p. 171)

La locandina di Apocalypsis cum figuris.
Nella ricostruzione dello spettacolo, nota Attisani, Annamaria Cascetta
non prende in considerazione il testo dello stesso Grotowski (Sulla genesi di Apocalypsis) né l’eco gnostica che informa diversi passaggi dell’azione, né infine le reazioni ostili del cardinale Wysyńsky e di buona parte della Chiesa polacca.
(TA, nota 97 a p. 129)
In effetti dalla sinossi di Apocalypsis emergono inevitabilmente deviazioni ereticali:
Il dubbio banchetto di Apocalypsis presentava il principio della vicendevole provocazione del bene e del male: nella materia malata di inerzia e di noia di cui è fatto il mondo, un frammento della vita spirituale scatena la perfidia, il bisogno di negazione.
(Małgorzata Dziewulska, Il ladro di fuoco, in UT, p 161)
In generale, secondo la studiosa polacca emerge un
atteggiamento più vicino al Vangelo apocrifo di san Tommaso che ai Vangeli canonici. Lo Scuro è certamente il Cristo degli eretici. Ma di quali eretici?
(ivi, p. 162)
Per non parlare
di un Cristo il quale non risorge come avviene nel senso comune e invece subisce la morte corporale dopo avere conquistato, attraverso l’accettazione del martirio, il premio della “vera vita”, ovvero una resurrezione nell’accezione gnostica.
(TA, p. 95)
In una nota al passo sui rapporti tra Chiesa polacca e Teatr Laboratorium, quasi per ammortizzare queste deviazioni ereticali, nella Prova del Nove si precisa che in Apocalypsis
la radicalizzazione del contrasto fra Simon Pietro, capo della Chiesa temporale, e il Simpleton [...] è, sul piano del contesto storico, da problematizzare. Certo, il punto di vista ottocentesco e riferito alla polemica cattolicesimo-chiesa ortodossa, slavofilia e Occidente, sostenuto da Dostoevskij, influisce molto sulla situazione rappresentata da Grotowski e sembra non recepire il grande processo di democratizzazione, di riavvicinamento a una spiritualità originaria, di difesa dei deboli, di ricollocazione di Cristo al centro del proprio messaggio della Chiesa conciliare e postconciliare.
(Pare difficile pensare che Grotowski potesse decidere di riavvicinarsi alla Chiesa cattolica per la sua “democratizzazione” e per “la difesa dei deboli”: peraltro ne avrebbe avuto più di un’occasione nei decenni successivi, e non risulta che l’abbia fatto.)
L’ampia analisi di Apocalypsis cum figuris acquista ulteriore peso, con le sue notazioni critiche e le sue omissioni, anche perché è inserita in un tentativo di sistematizzazione assai ambizioso, come quello impostato dalla Prova del Nove. Il volume parte dal presupposto (indiscutibile) che l’attività teatrale degli ultimi anni sia stata caratterizzata dall’uso di “scritture di origine non propriamente drammatica, ma narrative, saggistiche, trattatistiche, giornalistiche, poetiche, documentarie, giudiziarie o sacre” (La prova del Nove, cit., p. 12), aprendo insomma un’altra “questione dei testi” (che però non è del tutto scollegata dalla prima).
Con tali presupposti, La prova del Nove analizza una serie di spettacoli (o meglio, di capisaldi della storia del teatro contemporaneo) che per l’appunto hanno fondato questa tradizione del nuovo. Sono opere molto diverse tra loro, da The Brig del Living Theatre (una scelta giustificabile per aprire la riflessione, anche se forse Paradise Now avrebbe potuto arricchire il quadro: ma in casi come questo discutere inclusioni ed esclusioni è troppo facile) a Mistero buffo di Dario Fo, dall’Orlando furioso di Ronconi alla Classe morta di Kantor, passando per Brook e l’Odin, Mnouchkine e Dodin, Wilson e Cesar Brie, con interessanti approfondimenti su “teatro e shoah” e “teatro e scienza”. Allo stesso modo, anche gli studiosi coinvolti hanno formazioni, interessi e visioni diverse.
Tuttavia questa panoramica è preceduta e unificata (dopo l’iniziale nota metodologica di Annamaria Cascetta) da un denso saggio di Fulvio De Giorgi, che offre una precisa chiave di lettura all’intera operazione (e che può dunque aiutare a capire la centralità di Apocalypsis cum figuris all’interno del volume e la bizzarra nota sullo scisma d’Occidente).
Il contesto: le scene del Novecento. I mega-trend della storia culturale (questo il titolo del saggio di De Giorgi) è in effetti un teatrino (nei titoli dei paragrafi si parla di “scena storico-istituzionale” e “scena socio-comunicazionale”) con tre protagonisti, o meglio due antagonisti e un protagonista. I primi sono la laicizzazione e la secolarizzazione.
Con laicizzazione De Giorgi intende “i processi che sempre più tendono a separare le sfere dell’agire umano dalla sfera religiosa, vista come pre-moderna e dunque privata [...] la laicizzazione ha tematizzato la questione dell’origine e del fondamento”; si configura come “disincantamento del mondo” e porta a una “inflazione testuale [che] determina e impone forme crescenti di interpolazioni di testi, di citazionismi combinatori, di contaminazioni culturali e di bricolage intellettuali”. Procede come “circolo critico”, ovvero ermeneutico, in cui è centrale la “tecnica della retorica”.
La secolarizzazione comprende invece “i processi che hanno sacralizzato realtà profane (in particolare il potere politico), sviluppando forme di religiosità secolare immanente [...] la secolarizzazione tematizza il problema della fine”; “la rivelazione, come irruzione arazionale, si secolarizza in profetismi profani. Si ha un neopaganesimo oracolare-misterico che sacralizza realtà temporali, naturali, umane [...] si configura come momenti e processi di ‘ri-incantamento profano’: come eroizzazione e come secolarità guerriera-militante [...] L’Ombra di Dioniso, per dirla con Maffesoli, si allunga nel tempo delle tribù, come entusiasmo orgiastico, istintualità, disordine, dissolutezza. La socialità si integra attraverso la transe mistica estatica: ri-incantamento onirico-sciamanico degli allucinogeni, delle droghe, delle sostanze psicoattive, dell’alcol, della frenesia musicale”; nella sua essenza la secolarizzazione è una spinta rivoluzionaria e nichilista.
Nell’intreccio di queste due tendenze “si realizza la fusione di logica e retorica: si ha una comunicazione retorica [...] interna a un orizzonte comunitario, senza possibilità di trascendimenti universalistici e perciò senza verità ma solo con opinioni comunitarie raggiunte con strategia di persuasione. In questa comunicazione retorica, peraltro, appare ricorrente una retorica (negativa) della tecnica, una critica radicale alla tecnica, intesa come espressione stessa del male della modernità” (pp. 19-25).
Il protagonista, l’eroe che si oppone all’avvento dei due gemelli laicizzazione e secolarizzazione, è ovviamente il cristianesimo che - malgrado “un certo adattamento” - “permane”.
In ambito teatrale, che impatto può avere questa lotta epocale tra mega-trends? Si combatte “una domanda e una competizione sul senso, come disorientamento dato da sovrabbondanza di messaggi di senso e come necessità di investire di senso il proprio vissuto presente”.
Se il “senso” viene assunto come ciò-che-ha-senso o ciò che riceve senso nel patto tra l’uomo e Dio, si ha una prima scena (laicizzatrice) di significati, ma senza senso [...] è una scena che rappresenta lo sguardo dell’altro sull’alterità, l’ermeneutica dell’ermeneutica, una meta-teatralità: “essa ha per oggetto l’interpretazione dell’interpretazione che altri danno alla categoria dell’altro” [la citazione è tratta da Marc Augé, Nonluoghi, p. 27, n.d.r.].
Se il “senso” viene invece assunto come sentimento-sensibile-del-sé si ha allora una seconda scena (secolarizzatrice) di senso, senza significati che esprime un’introversione o, meglio, un’inversione (oscillante tra avversione, perversione, eversione), quasi come una rappresentazione onirica: una sorta di subteatralità o di parateatralità liquida.
(pp. 31-32)
A un livello superficiale, attraverso queste drastiche semplificazioni, il percorso grotowskiano può essere inscritto in questa chiave, sul versante della secolarizzazione con qualche incertezza tra laicizzazione e ri-sacralizzazione. Naturalmente a livelli eccelsi di disciplina e rigore, cultura e consapevolezza, tanto da poter essere addirittura inserito - almeno in parte, con qualche cautela - all’interno della “permanenza cattolica”.
Forse proprio in questa chiave - nel recupero di figure ereticali a lungo osteggiate e finalmente addomesticate e ricondotte nel solco della dottrina - si può capire il vero e proprio colpo di scena finale della biografia grotowskiana. Abbandonate da tempo al loro destino le folle di giovani adepti dell’era dell’Acquario che tanto avevano preoccupato il primate polacco, Grotowski,
considerato un bestemmiatore, ricevette il Premio vaticano “Fra’ Beato Angelico”, istituito per iniziativa di Giovanni Paolo II.
(Ludwig Flaszen, Se ne è andato, in UT, p. 131)
Ricorda il fratello Kazimierz che quando gli venne annunciato il riconoscimento, pochi giorni prima della morte, Grotowski sorrise (vedi UT, p. 85).
Grotowski gnostico
Ora che sono passati decenni, le insinuazioni sul Teatr Laboratorium come setta e sulla religione grtowskiana hanno perso ogni senso. In compenso si parla con insistenza sempre maggiore di un “Grotowski gnostico”. Districare il nodo non è facile, anche perché è molto difficile definire che cosa siano esattamente lo gnosticismo o la gnosi.
Allo stato attuale non è possibile dimostrare quando Grotowski abbia scoperto la letteratura gnostica vera e propria.
(AT, p. 91)
Il punto di partenza potrebbe essere la distinzione tra l’uno e l’altra, che lo stesso Grotowski precisò all’Università di Roma nel 1981, dimostrando il proprio interesse per questi temi (vedi UT, p. 236 e relativa nota).
E’ inoltre possibile individuare quattro diverse accezioni o modalità di rapporto con questa tradizione, che non si escludono a vicenda.
In primo luogo, possiamo identificare il generico richiamo a una tradizione costretta al settarismo dalle persecuzioni della Chiesa, lungo un filo che passa dai templari all’alchimia, dalla mistica alla teosofia. In maniera più facilmente ricostruibile, lo si può cogliere attraverso l’utilizzo (e la citazione) di testi considerati in qualche modo gnostici, dai Vangeli apocrifi fino a Gurdjieff e Jung, e a quella che possiamo definire “la tradizione occulta” (vedi David S. Katz, The Occult Tradition. From Renaissance to the Present Day, Jonathan Cape, Londra, 2005): non è difficile trovarne, in molti autori del Novecento e particolarmente in Grotowski, visti i suoi interessi.
Un altro filone - che emerge con vivida chiarezza in Essere un uomo totale - è radicato nella storia della cultura polacca, e in particolare a Mickiewicz e ai suoi Avi.
Gli Avi aprono ad ogni generazione, in Polonia, una porta sulla realtà in cui la fede nella dimensione soprannaturale della giustizia confina con il sospetto che Dio sia cattivo e crudele.
La Seconda Guerra Mondiale fu uno dei momenti in cui doveva scoppiare di nuovo quel “complesso manicheo del Cattivo Arconte del Mondo”; il pensiero di Grotowski è uno degli evidenti consolidamenti di quel motivo mickwiecziano nel periodo postbellico.
Se allora ci chiediamo da dove sia venuto, nel nostro mondo privo di controversie religiose, uno come lui, la risposta deve indicare Mickiewicz. L’eredità del vate non è neanche libera da certe conseguenze dell’influenza gnostica, ovvero dell’idea ardita di prendere sulle proprie spalle il problema della salvezza, idea che certo non è in accordo con la dottrina di Roma.
(Małgorzata Dziewulska, Il ladro di fuoco, in UT, pp. 158-159)
La stessa studiosa polacca apre immediatamente a un’altra accezione:
Sebbene formato nello spirito dell’umanesimo scientifico della metà del Ventesimo secolo, Grotowski appartiene ai pensatori che hanno già percorso la via d’uscita dalla gabbia del Nuovo Illuminismo; nel suo caso questo significava la lotta dello scientista del Novecento con sé stesso, una interessante lite con sé, portata avanti per la necessità di uscire fuori dalle categorie dell’epoca e ristabilire una prospettiva spirituale che oltrepassasse i limiti della razionalità e, quindi, anche i limiti della vita terrena. Nella riflessione di Grotowski è apparsa con forza la sfera dei problemi che vanno oltre l’empiria verificabile e che i tempi evitano di sollevare; egli appartiene a quella categoria di persone che hanno infranto l’accordo razionalista secondo il quale ci si poteva occupare solo di quello che è osservabile, trovando nel teatro un eccellente strumento per questo esperimento, poiché, secondo Peter Brook, esso si occupa in generale della rappresentazione delle cose invisibili.
(ivi, p. 159)
Su questa falsariga Antonio Attisani, sulla scia di Osiński (Grotowski gnostico, cit.), fa di Grotowski un anticipatore di una nuova tendenza che sarebbe attualmente in atto.
Negli ultimi anni la situazione generale è cambiata e, benché minoritario, esiste un movimento d’opinione su scala mondiale che testimonia una possibile alternativa al bipolarismo tra religiosità tradizionale e materialismo - dominante anche perché, di là dell’apparente contrapposizione, si è creata tra loro un’intima alleanza, quasi una fusione - e si sta cominciando a delineare una diversa possibilità. Di conseguenza il sospetto di una metafisica o di una fede religiosa di Grotowski può finalmente lasciare il passo alla vera posta in gioco, ovvero, come dice ancora H. Filipowicz, alla “debole speranza che la vita individuale non sia priva di significato nel vasto universo che ci circonda”, speranza che era alla base della sua fenomenologia di ricerca e ne è al tempo stesso una conseguenza. La stessa cosa vale per l’insistente riferimento da parte del regista al tema della tradizione o delle tradizioni. [...] Secondo queste coordinate si può affermare che Grotowski è stato il fondatore di una nuova tradizione e non un ennesimo creatore di sincretismi: la tradizione da lui inaugurata e sviluppata dal Workcenter è originale sia perché sa attingere da varie tradizioni “locali” alcuni motivi di lavoro concernenti il corpo-mente, e lo sa fare quando la trasmissione di queste tradizioni ha subito la drammatica interruzione del Moderno, sia perché ha un carattere inedito, basata com’è sulla scienza performativa, su un’inedita concezione dell’arte attorica che soprattutto con lui ritrova uno statuto “rituale”.
(TA, pp. 24-25)
Questa visione “debole” dello gnosticismo come generica alternativa al dualismo tra religiosità tradizionale e razionalismo materialista rappresenta sicuramente un altro drastico tentativo di semplificazione. Tuttavia corrisponde ad alcune sintesi del lavoro grotowskiano, per esempio a quella di suo fratello Kazimierz (che, vale la pena di ricordarlo, è uno scienziato, un fisico):
Il suo Teatro fu in larga misura luogo di esperimenti e di ricerca di ciò che esiste di soprannaturale nelle percezioni umane.
(Kazimierz Grotowski, Ritratto di famiglia, in UT, p. 84)
In questa chiave è possibile rileggere il legame con Stanislavskij, un rapporto di filiazione sempre rivendicato, proprio partendo dal lavoro sull’attore - o meglio con l’attore.
Stanislavskij per certi versi era uno spiritista. Nella sua visione del teatro, la creazione del personaggio scenico consisteva de facto nel processo della sua evocazione. Il personaggio viene dal dominio dello spirito che si estende tutt’intorno e, come spirito, deve prendere corpo per mezzo dell’attore.
(Mateusz Kanabrodzki, Il bambino e l’albero. Un addio a Jerzy Grotowski, in UT, p. 135)
Così, a pieno titolo, Grotowski
appartiene a quella categoria di persone che hanno infranto l’accordo razionalista secondo il quale ci si poteva occupare solo di quello che è osservabile, trovando nel teatro un eccellente strumento per questo esperimento perché, secondo Peter Brook, esso si occupa in generale della rappresentazione delle cose invisibili.
(Małgorzata Dziewulska, Il ladro di fuoco, in UT, p. 159)
Questa chiave può aiutare a cogliere il senso del Diario dal Teatro delle Fonti di Renata Molinari, scritto pochi mesi dopo la conclusione di uno stage parateatrale nell’estate del 1980, in Polonia. Ritorna ancora il problema del testo, in un’accezione leggermente diversa, quella della possibilità di racconto e dell’analisi:
Mi tornavano in mente le parole di Grotowski, un anno dopo il Teatro delle Fonti, quando gli chiedevo come proseguire qui da me, in Italia e senza di lui, quella esperienza. Il tema del nostro colloquio era diventato, su mia pressante richiesta: la tecnica individuale nel riflesso sociale. Ma Grotowski mi parlò anche della possibilità di trasferire su un altro piano il percorso di lavoro: per esempio quello della scrittura.
(Diario, pp. 19-20)
Il Diario è il racconto di un’esperienza certamente intensa, ricca di senso e in grado di creare memoria, e tuttavia le parole sembrano inadeguate per trasmettere quella che è e resta un cammino personale, intimo, solitario - anche se fatto in gruppo e con l’ausilio di una guida. Il ritorno alla natura, in un bosco bagnato da una pioggia incessante, l’incontro con l’“origine delle tecniche”, l’“apertura percettiva” (ma nel codice elaborato da Grotowski e Barba negli anni Sessanta, “percezione” significava “esperienza interiore”) hanno un impatto forte, profondo. Tuttavia Renata Molinari non sceglie mai la scorciatoia dell’estasi, non si rifugia nella mistica. Anche quando il percorso iniziatico raggiunge il culmine. Prima ancora che l’esperienza possa diventare pensiero o linguaggio.
Non ricordo azioni, ora, solo visioni.
Nella visione hai una diversa percezione di corpo-spazio-tempo.
Tutta l’esperienza era visione, annunciazione, principio, percorso, incontro.
Visione di luoghi, e nei luoghi, la traccia.
(Diario, p. 92)
E’ una diversa consapevolezza, per certi aspetti una rivoluzione (tutta personale) che contempla il rischio, la paura, la dolcezza, “la nostalgia per un tempo in cui eri così distratto da crederti felice”. Non è possibile rinchiudere tutto questo in una ricetta, in uno schema, in una griglia di frasi e parole, e neppure in un racconto - se non un racconto come questo, una fragile traccia, un’allusione a quello che non si può dire.
Non accade nulla, ora non solo non posso descrivere, ma non posso neppure raccontare. E’ come scoccare una freccia e colpire il bersaglio. Una cosa molto banale; una passeggiata: niente. Sedersi al sole, guardare il cielo. Con quella profondità di respiro che dà il sospendersi a niente.
(ivi, p. 89)
Non è un’alterazione della coscienza (“Niente alcool o droghe”, suggeriva un’altra delle regole grotowskiane), ma un allargamento della consapevolezza. Epifanie. Nessuna rivelazione. Nessun Verbo da trasmettere. Nessuna offerta di salvezza a prezzo scontato. Anche per questo in quegli anni era molto più facile dire perché non si poteva essere grotowskiani.
Infine si può affrontare lo gnosticismo nella sua accezione più esplicitamente filosofica (o meglio cosmologica), per quanto sia possibile condensare i temi gnostici in un sistema. Possiamo dire che lo gnosticismo ha proposto una soluzione alternativa al problema del male e alle ambiguità della risposta cristiana alla questione, attraverso una visione della creazione come opera di un Demiurgo malvagio, contrapposto a una divinità occulta buona (e con qualche tratto femminile), la quale ha disperso alcune scintille nella creazione, che è compito dei saggi rintracciare: il motivo fu caro anche ai chassidim, che lo ripresero dalla tradizione cabalistica.
Dio muore, l’universo precipita nell’indifferenza al senso e al valore, vaga nell’effimero e nel transeunte, instaura la stagione dell’“idiozia”: e tuttavia l’irreversibilità di questa condizione “va assunta pienamente”, senza malesseri, senza nostalgie,
scriveva Umberto Artioli, riassumendo (filtrata dal pensiero di Mario Perniola) la “filosofia” - o l’atteggiamento - gnostica in chiave contemporanea (vedi Drammaturgie della “quête”, cit., p. IX).
Di fronte alle atrocità della storia novecentesca, al caos e alle incertezze che hanno creato, l’atteggiamento gnostico ha assunto un’attrattiva notevole. Grotowski è cresciuto nella Polonia martoriata dalle armate naziste e sovietiche, non sorprende dunque di ritrovare in lui echi di questo radicale pessimismo:
Penso che il mondo in cui sono nato e vivo sia invivibile, come se fossimo in esilio, come se fossimo nati in questo mondo, non per questo mondo - ma non so se di un altro - e come se poi succedesse che in questo mondo si possano trovare molte cose.
(Jerzy Grotowski, 20 marzo 1981, citato in UT, p. 220)
Il tono e la terminologia sono senz’altro compatibili con una visione gnostica, proprio nell’accezione “filosofica” cui si accennava. (Inutile richiamare le suggestioni che possono suscitare testi come La vita è sogno o Il principe costante.) Anche se, come sempre, il mix grotowskiano porta a esiti non scontati:
Il legame tra l’estremo pessimismo e la carica rivoluzionaria ha un carattere paradossale: l’atteggiamento rivoluzionario, come spesso lo intendiamo, è contrario a un pessimismo sostanziale, in quanto racchiude l’idea che il mondo si possa cambiare. L’altra rivoluzione che Grotowski cerca arriva molto in profondità, ma al tempo stesso, ritenendo la natura del mondo corrotta per sempre, non intende cambiare nulla; vuole fare un colpo di stato solamente nella sfera dell’esistenza singola. [...] l’uomo, in quanto essere sociale, non può essere modificabile; la prospettiva sociale non lo interessa e va esclusa, dunque, dal ragionamento.
(Małgorzata Dziewulska, Il ladro di fuoco, in UT, p. 153)
Tra gli studiosi che più si sono impegnati nell’inseguire le tracce della “tradizione occulta” nei maestri del teatro contemporaneo c’è stato per l’appunto Umberto Artioli, lo studioso scomparso improvvisamente nell’estate del 2004, al quale è stato dedicato un convegno di studi, i cui atti sono stati raccolti in un volume, Drammaturgie della “quête”, a cura di Elena Randi e Cristina Grazioli. Nel saggio che conclude il volume, La passione e la “quête”. “Christus patiens” e “Christus resurgens”, a firma di Annamaria Cascetta, ha un ruolo centrale proprio Grotowski (che peraltro non era stato al centro degli studi di Artioli). “Il problema di fondo”, così come lo imposta Annamaria Cascetta, riguarda tanto il percorso di uno studioso come Artioli quanto quello di un uomo di teatro come Grotowski. Il tema della quête, centrale nella riflessione di Artioli, tocca la compatibilità della prospettiva cristiana con altre linee di ricerca (e di interpretazione della realtà e del trascendente).
La quête nell’orizzonte della spiritualità cristiana e la quête nell’orizzonte teatrale sono due mondi incompatibili o comunque separati?
(Annamaria Cascetta, La passione e la “quête”. “Christus patiens” e “Christus resurgens”, in Drammaturgie della quête, cit., p. 230)
In alcuni casi sì e in altri no, verrebbe da rispondere: dipende da quello che si trova lungo il cammino, anche se non è ovviamente possibile determinarlo in anticipo.
Jan Bloński, nel suo saggio Segni, teatro, santità (del 1976), inseriva invece le ricerche parateatrali in una generica “grande famiglia delle mitologie panteistiche” (UT, p. 161).
Commenta Małgorzata Dziewulska:
Il testo di Bloński era dolente, dato che confermava che tra Grotowski e la maggioranza cattolica c’era una barriera invalicabile. Perché forse era così.
Bloński tocca una controversia che risale a circa duemila anni fa [...] non ha visto quel qualcos’altro, che secondo me fu decisivo. Non l’accettazione o la liberazione da Cristo, ma la domanda se il mondo sia opera di un Dio buono, o forse del Principe delle Tenebre. Come sappiamo, la seconda visione non doveva affatto respingere l’idea della redenzione del Figlio di Dio.
(Il ladro di fuoco, in UT, p. 163)
Gli fa eco Leszek Kolankiewicz, che dopo aver partecipato ad Action ha scritto:
ritengo che il misticismo di Grotowski abbia conservato fino in fondo un carattere cristiano. Con ciò non voglio dire tuttavia che questo sia stato il solo modello. Grotowski infatti ha ristabilito i legami spezzati tra cristianesimo e gnosi come dottrina della salvezza. Ha cercato conoscenze e capacità rigoristiche, che si prestassero a essere rinchiuse in un rituale. In questo approccio tecnico ha ricordato moltissimo un alchimista.
(Grotowski alla ricerca dell’essenza, in UT, p. 279)
C’è invece chi propende per una visione sincretista, come Attisani, che prospetta addirittura una “sensibilità biosofica”:
Si è detto che Grotowski è partecipe di un movimento che ancora deve essere realmente riconosciuto ma che traccia un’alternativa possibile alle due ideologie dominanti del XX secolo, teismo e materialismo, responsabili dei maggiori carnai della storia umana. Questa alternativa non ha un proprio linguaggio, non si esprime in termini organizzativi e non sempre è stata incarnata con coerenza dai suo protagonisti; spesso si è definita solo in contrappunto ad alcuni movimenti che invece hanno avuto un ampio seguito. Detto questo, è innegabile che la neotradizione grotowskiana si manifesti in un solco nel quale stanno anche la teosofia di Madame Blavatsky e l’antroposofia di Rudolf Steiner, le “danze sacre” di Gurdjieff, il Tertium Organon di Ouspensky, la nouvelle Gnose e la structure absolue di Abellio, riferimenti intrecciati con le sue personali esperienze in India, Medio Oriente, Messico, Haiti, ecc. Con altrettanta chiarezza, però, si deve dire che Grotowski non è mai stato un adepto di alcuna associazione o setta e che a fronte di rari maestri che lo hanno beneficiato di una trasmissione diretta di saperi egli è stato più spesso un “ladro”, vale a dire un abilissimo osservatore, e ha tratto da quel materiale quel che gli serviva per le sue ricerche.
(AT, p. 253)
Diversa la conclusione di Eugenio Barba, quando rievoca il suo incontro con Grotowski a Pontedera nel 1992:
Secondo me lui aveva avuto un unico interesse: l’India o meglio l’induismo. Grotowski confermò la mia opinione e mi raccontò di dovere la propria “vocazione” per l’India a sua madre Emilia che era “induista”. E mi parlò ancora dell’importanza del libro di Paul Brunton A Search in Secret India che sua madre gli aveva fatto leggere a 8 o 9 anni. [...] Erano soprattutto i capitoli che descrivevano la vita di Ramana Maharishi che l’avevano marcato. Nel dicembre 1976, Grotowski aveva fatto il suo quarto e ultimo viaggio in India con la madre e insieme visitarono Arunachala, la montagna dove si era ritirato Maharishi.
(La terra di cenere e diamanti, cit., pp. 52-53)
Fu proprio ad Arunachala che, su sua richiesta, vennero sparse le sue ceneri.
Il lavoro del Workcenter
Qualche ulteriore aiuto per sbrogliare la matassa può venire dal lavoro del Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards. Antonio Attisani ha seguito in questi anni con grande attenzione le attività “spettacolari” del Workcenter, con l’occhio attento del critico - anche se quelli di Action e affini non sono propriamente spettatori che pagano il biglietto ma vengono coinvolti solo su invito.
Al di là dell’intensità dell’esperienza del “testimone Attisani”, quello che gli interessa è la riflessione sulla centralità dell’attore e della sua responsabilità etico-artistica (AT, p. 249).
Ma il fulcro del libro è un altro, ovvero la “scoperta” e l’approfondimento dello gnosticismo grotowskiano, che come abbiamo visto è al centro delle preoccupazioni di molti sudiosi polaccgi.
Il presupposto (condivisibile) da cui parte l’argomentazione di Attisani è la sostanziale continuità tra l’attività di Grotowski e quella del Workcenter. La conseguenza è che la scelta di Thomas Richards e Mario Biagini di lavorare su testi in qualche modo legati al filone gnostico (da alcuni passi dei Vangeli apocrifi all’Inno della Perla) risponde a una precisa volontà e riflette le credenze profonde di Grotowski. Di qui una ricostruzione del percorso di Grotowski e del Workcenter centrata soprattutto su temi e problematiche gnostici.
Lo stesso Grotowski aveva parlato del proprio interesse per lo gnostocismo in un ciclo di lezioni all’università di Roma, all’inizio degli anni Ottanta. Inoltre
aveva reso noto il suo riferimento alla gnosi nel marzo 1981 a Danzica, nel quadro di un seminario universitario: il suo intervento venne trascritto e pubblicato nel 1986, dunque quattro anni dopo la pubblicazione delle dispense romane.
(TA, p. 118, n. 14)
Come già accennato, la conoscenza dei testi gnostici (a cominciare dal Vangeli apocrifi scoperti alla fine degli anni Cinquanta) risale con ogni probabilità a un periodo precedente. Ma di questo si continuerà a discutere a lungo. Nel frattempo gli spunti sono già interessanti:
la gnosi opera sul complesso corpo-percezione invece che su quello scrittura-pensiero.
(AT, p. 115)
L’atteggiamento ha precise conseguenze quando il gruppo si accosta ai testi. Quando il Workcenter inizia a lavorare sull’Inno alla perla, su indicazione di Grotowski, Thomas Richards dice di considerare il testo, come spiega Attisani,
una “lettera proveniente dal passato, forse dallo stesso Grotowski”, rivolta a lui e a tutti i compagni; una lettera che “contiene qualcosa che, lo sentiamo, ci riguarda profondamente ma che non comprendiamo”. Da ciò una chiara indicazione operativa: a differenza del teatro in cui la messinscena trasmette allo spettatore la visione di un testo, qui l’impegno collettivo coordinato da Richards tende ad accertare cosa il testo significa, e a cogliere i suoi diversi livelli di struttura, ma soprattutto a farlo risuonare dentro ciascuno degli attuanti, per vedere cosa produce lì. E’ questo il modo di comprenderlo.
(AT, p. 173)
Ancora una volta, tuttavia, individuate le fonti, è importante sottolineare la laicità del “metodo Grotowski”:
Ciò che conta in una situazione come la presente è evidentemente il quadro, il protocollo etico e teorico generale entro il quale tutto si svolge. L’asse è la particolare laicità che connotava Grotowski e nella quale Richards sembra riconoscersi appieno: nessun credo aprioristico, soltanto il fare e i suoi risultati, da non considerare mai come protocolli generali ma eventualmente come principi che necessitano di un decisivo adattamento a ogni persona e circostanza.
(AT, p. 191)
E mentre si vanno a scavare tradizioni e dispute vecchie di duemila anni, sarebbe forse utile inserire la battaglia di Grotowski con il linguaggio nell’ambito del pensiero novecentesco, e più precisamente nella dialettica tra parola e silenzio. Vengono alla mente, per esempio, le parole di Elie Wiesel, quando - ricordando la “scuola del silenzio” chassidica - spiega che per lui si tratta di “scrivere non con le parole ma contro le parole, non contro il silenzio ma con il silenzio”.
Vicolo Grotowski
Perché è difficile scrivere di Grotowski. Quando credi di aver raggiunto un punto fermo, un appoggio, ti accorgi che ti sta sfuggendo, che forse non era quello il punto. O meglio, capisci che non era solo quello il problema.
Scrivere di Grotowski è come guardarsi in uno specchio oscuro: probabilmente non diciamo quasi nulla di lui o di quello che ha fatto, seguiamo semplicemente il contorno della nostra ombra.
Forse un’esperienza come la sua, un ostinato cammino verso l’origine e la trascendenza, richiede una scrittura che procede con il corpo, nel corpo. Suggerisce un pensiero che procede per interpretazioni e paradossi, distorcendo e trasformando i propri fondamenti man mano che procede. Dovrebbe sospingere verso una scrittura trasgressiva, che non conosce codici ma solo trappole (paradossi) che si aprono sul nulla - o sull’indicibile. Una scrittura che legge e usa il “testo Grotowski” con la stessa libertà e lo stesso rigore con cui lui leggeva e usava i testi altrui. Con la sua stessa intransigenza e necessità di chiarezza.
Non aveva accumulato beni, non si era affezionato ad oggetti; ma si era preoccupato soltanto di dissipare, nel vero senso della parola, tutto ciò che possedeva di corporeo e di materiale, affinché nulla potesse velare i messaggi che aveva lasciato scritti nella sua biografia terrena.
(Zbignew Majchrowski, Chi era Jerzy Grotowski?, in UT, p. 294)
La municipalità di Wrocław ha deciso di intitolare un vicolo della città vecchia a Jerzy Grotowski. In quella stradina non c’è alcun numero civico, non esiste alcun indirizzo. In Inne Zauleg Jerzego Grotowskiego non potrà mai arrivare nessuna lettera, anche se continueremo a scriverne.
Lucca, Santa Maria Maggiore, Milano, agosto 2006.
Questo testo è dedicato a Renata Molinari.
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
Nuovi media, nuovo teatro?
Le definizioni, la mutazione, gli schermi
di Anna Maria Monteverdi
(Introduzione al saggio monografico di Anna Maria Monteverdi per "Il castello di Elsinore", di prossima pubblicazione)
Definizioni
Virtual (Reality) Theatre (o VT o VTheatre o VR performance), Digital Puppet Theatre, Virtual Puppetry, Interactive Theatre, Augmented Reality Theatre, Artificial Theatre, Enhanced Theatre, Expanded Performance, Cyborg Performance, Cyber Performance, Mobile Performance, Digital Performance, Computer Theatre, Mixed Reality Stage, Real Time Performance, Instant Digital Theatre, Live Online Performance, Net Drama, E-Theatre, Internet Theatre, Net Theatre, Chat Performance, Id Theatre, Webcam teatro, Hacker teatro, Web Streaming Performance, Web-based Drama, Digital Story Telling, Telematic Performance, Performance in Remote Connection, Networked Theatre, (Computer) Mediated Theatre, Intermediated Performance, Hyperdrama, Interactive Generative Stage, Multimedia Interactive Performance, Intelligent Stage, Activation Space, Multidisciplinary Media Performance, Trans-media Performance, Electronic Theatre, Live Cinema, Interfaced Theatre, Image-based Theatre, Synesthetic Theatre, Crossmedial Performance, Fractal Theatre, Machinic Performance, Recombinant Theatre, Chromakee Performance, Mocap Performance...
Queste definizioni possono dare un'idea, oltre che della corsa ai neologismi nell'ambito dei nuovi media, del variegato panorama di proposte - almeno terminologiche - con cui il multimedia digitale off line e on line è sbarcato sulla scena.
Forse dovremmo aggiungere anche la riformulazione della "drammaturgia" che diventa iperdramma ovvero "una nuova scrittura ipertestuale che utilizza le nuove tecnologie audiovisive, digitali e interattive"(1); o, secondo Marcel.lí Antunez Roca, sistematurgia, cioè
"una drammaturgia che ha bisogno dell’informatica, basata sul principio della gestione della complessità del computer. La sistematurgia è un processo interattivo che indaga attraverso nuovi prototipi, un arco di mediazione che include l’interfaccia, il calcolo e i nuovi mezzi di rappresentazione; sta al servizio di una narrazione, di un racconto, di un organismo teatrale ma lo fa in maniera interattiva usando uno strumento ipermediale."(2)
Originali anche le definizioni dei nuovi tecno-interpreti, reali o virtuali: mediattore, cybernarratore, synthetic actor, digital story teller, hyperactor (3), networked news teller (4).
Flavia Sparacino parla di "mediattori" per definire "gli agenti software digitali dotati di intelligenza percettiva e di abilità espressive e comunicative simili a quelle di un performer" (5); Lance Gharavi parla invece di "agente aggiunto" (e conia il termine di VED, Virtual Environment Driver) per definire colui che nelle sperimentazioni dell’Institute for Exploration of Virtual Reality (i.e.V.R., fondato con Mark Reaney e Ronald Willis) manipola in real time l'ambiente di realtà virtuale e guida a vista sul palco, la navigazione del pubblico attraverso i mondi virtuali (6).

André Werner, The Jew of Malta.
I cambi d'abito o di personaggio sono anch'essi virtuali (7). I costumi prendono infatti forme insolite: protesi esoscheletriche, servo-meccanismi pneumatici, potenziometri, appendici elettromagnetiche o sensori di posizionamento. Osserva il digital stage designer Paolo Atzori:
"Computer indossabili contengono protesi percettive, microcamere, microfoni, sensori ecc, la sua posizione, i suoi movimenti e persino certe funzioni vitali vengono costantemente registrate, con reti di sensori e sistemi di motion tracking e video capture, in-put che vengono campionati, elaborati ed eventualmente trasferiti come informazioni per altri sistemi, come, per esempio, reti neurali con programmi per il riconoscimento gestuale." (8)
In Italia resistono ancora il termini generici come "teatro tecnologico" o "scena digitale", ma le definizioni inglesi e angloamericane sottolineano più propriamente alcuni caratteri chiave, in uno scambio (che qualcuno ha definito "dialogo tra simili") fattivo tra teatro e digitale: l'ibridazione, la sinestesia, la multidisciplinarietà, l'ipertestualità, l'interazione-reattività tra soggetto-ambiente-pubblico, la nuova percezione aumentata dai sistemi informatici immersivi, la dislocazione spazio-temporale dell'evento, la connessione tra reale e virtuale, oltre alla specificità delle tecnologie e dei sistemi (ambienti interattivi, realtà artificiale, sistemi di captazione del movimento) e delle modalità di comunicazione e "trasmissione" usati (via modem, via streaming audio/video o via mobile). Ma soprattutto focalizzano il carattere "attimale", istantaneo del digitale: il "qui e ora" della comunicazione teatrale diventa nella sua versione tecnologica il real time on site, on line, on air oltre che on stage, naturalmente.
In questo elenco c'è un elemento innegabile: l'impossibilità a classificare in una sola definizione onnicomprensiva una pratica, una tipologia d'arte in costante evoluzione e che a causa (o in virtù) della sempre maggiore sua tendenza alla transdisciplinarietà(9), sembra sfuggire a ogni tentativo di categorizzazione. Le opere d'arte digitali (media arts), come è stato rilevato da più parti (10), si rivelano infatti in una forma mutante e combinatoria: "ibridi, eterocliti, stratificati, multi-supporto" (11). Sollecitano esperienze plurisensoriali attraverso interfacce che richiedono una partecipazione fisica, intellettiva ed emotiva integrale, anche a distanza (12).
Il teatro interlacciato con il digitale va a delineare un vero e proprio "ecosistema" (13) fatto di simbiosi-innesti-migrazioni tra linguaggi e codici. Insomma, si inaugurano "un nuovo tipo di spettacolo, di percezione e di partecipazione" (B. Picon-Vallin) e un nuovo spazio di rappresentazione, inteso come "ambiente non più luogo neutro contenitore di eventi, ma spazio sensibile, estensibile, modellante e modulabile" (14).
Spesso però una modalità non ne esclude un'altra: progetti concepiti per sofisticati sistemi di realtà virtuale in scena possono prevedere contestualmente anche modalità più tradizionali; o reincarnarsi in forma di installazioni o di operazioni intermediali; o approdare in rete e collocarsi così potenzialmente dappertutto, in un "crossing" tecnologico che sviluppa modaliltà di attraversamento e di integrazione sempre più complesse e interminabili. Le cross-ibridazioni (15) o le commutazioni (Couchot) tra sistemi, scritture, dispositivi di visione e di ascolto, complice il comune codice digitale, sono infatti potenzialmente infinite. Come ricorda Andrea Balzola,
"Il testo, o meglio l'ipertesto drammaturgico, il progetto scenico, la partitura sonora-musicale, l'installazione, il video, il software, lo spettacolo, non appartengono più a generi diversi ma divengono fasi di un processo aperto, tassello di un mosaico spaziale e temporale mutante, flessibile e comunicativamente forte". (16)
Quello che ci interessa verificare è se i nuovi media stanno effettivamente cambiando anche il teatro, quali sono le nuove forme espressive di scrittura scenica, ovvero - per prendere spunto dall’interrogativo di Manovich: "Come possono le nostre nuove capacità – archiviare masse di dati, classificarli, indicizzarli, collegarli, ricercarli automaticamente e recuperarli istantaneamente – realizzare nuove tipologie di narrazione?" (17)
Nel cyber teatro il racconto diventa una tecnonarrazione (Giacomo Verde). I materiali vengono traslocati da un linguaggio a un altro (Peter Sellars, Motus, Xlab). E’ un teatro digitale che espande il concetto di presenza alle nuove possibilità di performance globale telematica e di teleazione a distanza (Electronic Disturbance Theater; Fake), che crea un dialogo interattivo e interdipendente tra attore, spettatore e immagine attraverso dispositivi multivisione e protesi esoscheletriche (Fortebraccio Teatro, Marcel.lí Antunez, Reaney-Gharavi). Sostituisce l’attore con una presenza virtuale ma non dimentica la tradizione e l’artigianalità delle macchine antiche (Lepage e Kentridge). Innesca virus nel corpo sociale in una prospettiva politica e interventista del teatro (Critical Art Ensemble). Infine, auspica una prossimità e un’interazione con lo spazio scenico inglobando il pubblico in un environment immersivo (Dumb Type; Granular Synthesis), sollecitando memorie e percezioni multisensoriali collettive (Studio Azzurro; Giardini Pensili) e percorsi narrativi non lineari, labirintici e rizomatici (Zonegemma, TPO), trasformando l’opera in un’esperienza relazionale e socializzante vissuta all’interno di un sistema aperto (l’hacker theatre di Giacomo Verde e Jaromil).
In questa prospettiva il palcoscenico è solo uno dei possibili teatri dell’azione performativa, che può estendersi (spazialmente e temporalmente) in più ambienti interconnessi: le piattaforme multitasking dove diverse applicazioni possono operare contemporaneamente, le community web, le mailing list e i diversi network telematici (wireless, telefonia, instant messagging), in una strategia di territorializzazione multipla che non ha precedenti.
MUTAZIONE, VARIABILITA’ E TEMPO REALE
Per Lev Manovich la variabilità (conseguenza della rappresentazione digitale e della organizzazione modulare delle informazioni) è il principio base, la "condizione essenziale" dei nuovi media all’epoca della convergenza digitale (18). Questa caratteristica "mutabile e liquida" (Manovich) applicata alla materia teatrale ha dato vita a un serie di esperienze artistiche e addirittura a nuovi format - il live cinema (19) - che giocano sulla possibilità di intervenire grazie al digital processing (il trattamento digitale delle "immagini che rispondono" secondo Edmond Couchot) sul corpus delle immagini e dei suoni in real time, dando vita a "composizioni sceniche" in costante divenire.
La metamorfosi, l'intercambiabilità e l'interattività, insieme all’immediatezza, sono dunque la caratteristica dei nuovi media, esattamente come il teatro, caratterizzato, secondo la distinzione di Kowzan (20) da:
1) compresenza fisica reale di emittente/destinatario;
2) simultaneità di produzione e comunicazione.
Béatrice Picon-Vallin sottolinea la "trasformabilità tecnologica" della nuova éra, in cui il nuovo teatro sottomettendovisi, ritrova l’antica radice:
"Sottomettere il palcoscenico a questo principio di trasformabilità e non più soltanto a quello della riproducibilità, è una nuova prova che implica senza dubbio il rafforzamento della natura stessa dello spettacolo, effimero e che cambia ogni sera."
Biosensori, sistemi di motion capture e motion tracking, convertitori di segnali MIDI: assistiamo alle più svariate tecnomutazioni digitali dell'attore, e contestualmente anche a quelle della scena, che indossa gli attributi altrettanto proteiformi e metamorfici della maschera elettronica: vere performing machines sono gli automatics ideati dalla Fura dels Baus che negli spettacoli interagiscono con gli attori sul palcoscenico e con il pubblico (21). Robot musicali sono quelli creati dal software e robot designer catalano Sergi Jordá per Afasia di Marcel.lí Antunez Roca: un quartetto di robot costituito da chitarra elettrica, violino, batteria e cornamusa suonano grazie agli impulsi generati dai sensori indossati da Marcel.lí Antunez, che consentono anche animazioni interattive sullo schermo. In scena compare una nuova macchina, umanizzata ed "emancipata", che "non racconta più sé stessa ma che racconta" (Studio Azzurro); le sue inattese interruzioni permettono di "far rigenerare su un palcoscenico, quella vibrazione aperta all'imprevisto, alla casualità, ai tempi di reazione" (Studio Azzurro).
Performance con la macchina o addirittura della macchina "processore di media", ovvero l’altra metà del palcoscenico, sono quelle dei gruppi Troika e Palindrome. Questi ultimi usano il software Eyecon ed elettrodi applicati al corpo (a uso di elettrocardiogrammi e elettroencefalogrammi) per controllare suono, luci e immagini: "Il performer deve "interpretare" il sistema interattivo così che i media siano veramente parte della performance live".
Le performance si differenziano anche per il tipo di software, oggetto mediale (22) o "grafo" utilizzato. Per la gestione live dell’archivio di immagini Roberto Castello e Giacomo Verde hanno usato il programma Arkaos (normalmente in uso per concerti di vjing); Renzo Boldrini gestiva in sintonia con la propria narrazione le animazioni in Flash per Dg Hamelin; Davide Venturini creava in Photoshop i disegni per Storie zip, mentre il mixaggio live delle immagini e il lumakey creato in diretta in Elsinore e in The Seven Streams of the River Ota di Robert Lepage creava le suggestioni coloristiche in sincrono con la rappresentazione; per Animalie e Qual è la parola Roberto Paci Dalò ha utilizzato il software Image/ine di Steim creato da Tom Demeyer.

Catherine Henegan, The Shooting Gallery, networked performance 2006.
L'aspetto di regia audio si impone sempre di più sulla mera creazione di una "colonna sonora". Voci e musiche di sintesi, landscape sonori, morphing audio in real time in relazione con le potenzialità e le simbologie della narrazione acquistano una rilevanza sempre maggiore. Come afferma Mauro Lupone sound design di Xlab:
"Considerando che il suono investe lo spazio e si svolge nel tempo, articolare processi di elaborazione della voce significherà anche agire sulla memoria e su processi di percezione e di ascolto. Non solo quindi modificazioni timbriche-morfologiche, ma anche azioni in cui si esplora il sistema in relazione ai concetti di spazio e di tempo: illusioni sonore o dissociazioni visive-sonore, tendenze entropiche e accelerazioni/rallentamenti psicopercettivi connessi all'informazione, memorie e sedimentazioni che riemergono, esplorazioni nelle zone di limen del suono, moltiplicazione delle sorgenti e dei movimenti spaziali ad esse associati".(23)
Per la cybernarrazione Storie mandaliche con ipertesto drammaturgico di Andrea Balzola, Lupone ha creato grazie al sistema di spazializzazione audio IMEASY una gestione direzionale quadrifonica live della complessa spettromorfologia che sottostava alle sonorizzazioni delle storie (24); nell’Ospite la compagnia Motus ha utilizzato un sistema simile di spazializzazione per la gestione in tempo reale, della traiettoria di 24 fonti audio (25).
SCHERMI: teatro o cinema (e TV)?
E' un dato di fatto che la scena digitale monitorizzata e cablata assomigli sempre più a un set televisivo o cinematografico, dato che da tempo ne ha ormai incorporato persino i codici, oltre che le definizioni (26). Se già negli anni Settanta Wilson si appropriava del linguaggio cinematografico (ripetizioni, ralenti, flashback, fermi immagine) bidimensionalizzando la scena, nel 1998 in Monster of Grace usava pionieristicamente come sfondo un film stereoscopico in animazione 3D. Alla fine degli anni Ottanta Robert Lepage portava in teatro con Le Polygraphe un vero e proprio "spettacolo cinematografico": simulazioni di riprese, punti di vista insoliti come fossero inquadrature di una macchina da presa, applicazione del montaggio alternato alla drammaturgia, uso frequente del flashback e del flashforward. In The Merchant of Venice Peter Sellars introduceva intensi primi piani televisivi trasmessi in diretta nei monitor, che andavano a scavare l’interiorità del personaggio, mentre il BAG ricreava un set cinematografico con la messa in mostra teatrale degli effetti cinematografici (le macchine da truquage, come le definiva Méliès).
In Twin Rooms Motus lavora sulla diretta televisiva: l'incubo mediatico descritto da De Lillo in Rumore bianco si innerva nel tessuto organico dei protagonisti: perseguitati da un invisibile occhio satellite che li raddoppia tra specchi e pareti lucide e trasparenti: nella proliferazione di corpi che contrasta con la loro solitudine, incarnano l'incubo psicotico della videosorveglianza.
Nella scena organizzata spazialmente come una composizione a intarsio, il miglior esempio di integrazione di dispositivi multischermo con la scena è senz'altro rappresentato da The Seven Streams of the River Ota (1994) di Robert Lepage, primo lavoro nato in collaborazione con Ex Machina, l'equipe multidisciplinare da lui fondata a Québec City. La scena è strutturata come la facciata di una tradizionale casa giapponese, bassa e lunga, con sette schermi-pannelli trasparenti fatti di spandex su cui vengono proiettate (e retroproiettate) immagini video e ombre: l'effetto di "incrostazione" tra l'immagine video e corpo dell'attore e tra la figura e lo sfondo monocromo luminescente (quasi un chromakey) genera un surreale dialogo tra corpi e luce, e rende quasi alla lettera il senso più profondo dello spettacolo: il legame indissolubile tra Oriente e Occidente e l'impossibilità di cancellare dalla memoria collettiva l'Hiroshima della bomba atomica. La scena attraversata dalla luce del video diventa così una lastra "fotosensibile", una scrittura di luce, metafora di un percorso di memoria, di illuminazione e di conoscenza.
La scena contemporanea ha sviluppato insolite modalità di proiezione su superfici diverse. Se Svoboda nel 1958 all'Expo di Bruxelles inaugurava la multiproiezione (il polyécran), oggi si ricerca l'effetto evanescente dell'immagine: proiezione su doppio strato di tulle con l’attore reale incastonato in mezzo o su materiali che mantengono una "memoria di forma", e perfino su elementi naturali e gassosi come l’aria e l’acqua vaporizzata. Fabio Iacquone con il suo Digital Versatile Theatre sta sperimentando proiezioni su gas e fumo, ricreando il mito delle apparizioni fantasmatiche. L’artista visiva Paola Lo Sciuto prova a ottenere l'effetto di "miraggio nel deserto" con un sistema scenotecnico da lei brevettato.
La sfida più attuale è quella di restituire, grazie ai nuovi materiali di matrice polimerica e plastiche fotosensibili, volumetricità e tridimensionalità interattiva all’immagine, progettando nuove architetture immateriali e liquide, pieghevoli e arrotondabili, occultando in trasparenza la superficie piatta degli schermi di proiezione e la relativa cornice di separazione. Non ci si immerge più, non c’è più nemmeno bisogno di display a cristalli liquidi, occhiali con lenti binoculari o sistemi multimonitor per ampliare il campo visivo: ora sono gli oggetti a "fuoriuscire" dal loro mondo e ad affacciarsi direttamente nel nostro.
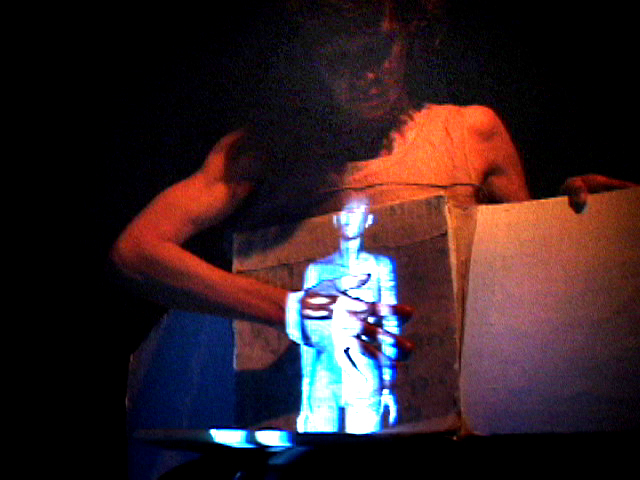
Kathleen Ruiz, AVA project, trans-media performance.
Nuovi sviluppi riguardano le avveniristiche tecnologie per i display che avvicinano sempre di più il teatro all'immaginario fantascientifico di Matrix e di Minority Report. Secondo le ottimistiche previsioni commerciali della Liquavista, neonata società della Philips specializzata nelle tecnologie applicate ai display, gli schermi LCD lasceranno presto il posto alla tecnologia O-led (Organic Light Emitter Diode, nata però già nel 1985) che si basa su strati di polimerici organici flessibili e elettroluminescenti interposti tra due elettrodi per proiezioni tridimensionali dall’effetto simil-olografico, che creano l’illusione di immagini sospese nel vuoto. Un'altra alternativa è l'Electrowetting Display, nato nel 2003: lo schermo è composto da particelle microscopiche sospese in un mezzo denso che dà simultaneamente la diffrazione, la riflessione e la trasmissione di tutte le lunghezze d'onda della luce.

L’uso del transcreen in uno spettacolo Kabuki.
L'elemento strabiliante di questa tecnologia è che la scena dietro lo schermo è chiaramente visibile nell'area nella quale non ci sono immagini proiettate. L’applicazione è per ora limitata al campo dell’intrattenimento (discoteche o concerti e parchi divertimento) o della moda (show room). Il gruppo rock Gorillaz, che ha legato la propria immagine in videoclip ai fumetti, ha letteralmente "mandato in scena" a suonare agli Mtv Awards alcuni dei loro personaggi a cartoni animati in computer graphics, con tanto di asta di microfono, basso e batteria, proiettati su un invisibile e impercettibile schermo (27), con effetto di immagine simil-olografica come potrebbe averla immaginata Dennis Gabor: l’evento è stato universalmente riconosciuto come punto di svolta della virtualizzazione dei supporti.
Ricorda Lev Manovich che se tutte le azioni avverranno in un prossimo futuro nello spazio del virtuale e della simulazione, lo schermo (ultima appendice della cornice, intesa come spazio fisico separato che impedisce il movimento di chi osserva) scomparirà del tutto a vantaggio di un effetto compositivo che ricerca, "scorrevolezza e continuità" (28):
"L’apparato della realtà virtuale si ridurrà a chip impiantato nella retina e connesso via etere alla rete. Da quel momento porteremo con noi la prigione non per confondere allegramente le rappresentazioni e le percezioni (come nel cinema) ma per essere sempre in contatto, sempre connessi, sempre collegati. La retina e lo schermo finiranno per fondersi".
Ma per ora in teatro gli schermi, più che eliminati, si sono invece ingranditi. A caratterizzare la scena degli ultimi anni il fenomeno del gigantismo.

Abbas Kiarostami, Ta’ziyé.
Enormi schermi delimitano la circonferenza dello spazio della rappresentazione in Ta’ziyé di Kiarostami, un’elaborazione teatrale che recupera un antico rito iraniano. Ugualmente enormi sono i fondali elettronici in alta definizione dell’Ospite di Motus, quello di Voyage e il ciclorama semicircolare di (Or), due spettacoli di Dumb Type; di Aladeen, di Gorky, le alte pareti avvolgenti come un gasometro di Granular Synthesis.

Marianne Weems, Aladeen.
Del resto le gigantesche proiezioni ormai fanno parte del paesaggio metropolitano e costituiscono l’armamentario basico della pubblicità, raggiungendo formati terraquei (il maxischermo pubblicitario da 24 metri inserito in un dirigibile formato da centinaia di led luminosi che lo rende visibile a 4 chilometri di distanza). Anche lo show design li ha impiegati, anche se in modi sempre più creativi: vedi le straordinarie invenzioni videosceniche e luministiche di Mark Fisher per i concerti rock dei Pink Floyd e degli U2, quelli di Robert Lepage per il Secret World Tour e il Growing Up Tour di Peter Gabriel e quelli a led con software generativo degli United Visual Artist per i Massive Attack.
(continua)
NOTE
"Il passaggio dalla macronarrazione lineare alla micronarrazione non sequenziale fa seguito a due innovazioni portate dall’evoluzione interattiva dei media. La prima è lo zapping, cioè l’uso televisivo del telecomando che frammenta la fruizione di un programma e consente una visione parallela di più programmi. La seconda innovazione, ancora più radicale, è quella aperta dai nuovi media digitali, on line come il web e off line come cdrom e dvd, dove lettura-visione-ascolto non sono più lineari ma sviluppano una navigazione non sequenziale e ipertestuale. Allora la scrittura drammaturgica o si frantuma caoticamente come nella narrazione destrutturata, oppure elabora delle unità testuali minimali e nomadi, ma compiute, che possono agganciarsi e sganciarsi nell’ipertesto spettacolare" (A. Balzola, Verso una drammaturgia multimediale, in A. Balzola-A. Monteverdi, Le arti multimediali digitali, Milano, Garzanti, 2005).
2 Intervista di Anna Maria Monteverdi a Marcel.lí Antunez Roca in www.ateatro.it .
3 E' Claudio Pinhanez a dare una definizion dell'hyperactor: "Un iperattore espande il corpo in modo da far accendere le luci, attivare suoni o immagini su uno schermo nel palcoscenico; controllare la risultante sembianza laddove la sua immagine o la sua voce sia mediata attraverso il computer; espandere le sue capacità sensorie ricevendo informazioni attraverso cuffie o occhiali-video o controllare strumenti fisici come videocamere, parti del set, robot o altri macchinari teatrali" (C. Pinhanez, Computer Theatre in www.cybertsge.org; cit da Pericle Salvini, Tesi su Teatro e tecnologia, Università di Pisa).
4 "Il Networked News Teller è un attore di strada che porta con sé un computer indossabile con un occhio privato. Il computer esegue un programma che aggiorna le notizie costantemente sull'occhio privato dell'attore. Costruisce poi una pagina web che riporta la stessa notizia secondo i diversi punti di vista dei differenti news provider. Dopo aver scelto la notizia da discutere attraverso il suo occhio privato, il News teller interroga i passanti chiedendo la loro opinione. Il performer può recitare la notizia per strada basandosi sull'interazione con il pubblico e con le notizie che appaiono sul portatile... Questa ricerca tecnoartistica è direttamente ispirata al lavoro teatrale dell'attrice Anna Deavere Smith chiamato Twilight" (F. Sparacino, La realtà aumentata nella danza e nel teatro, in A. Menicacci-E. Quinz, La scena digitale. Nuovi media per la danza, Venezia, Marsilio, 2001).
5 F. Sparacino, La realtà aumentata nella danza e nel teatro, cit., p. 101: "Definiamo mediattori immagini video, suoni, discorso, oggetti testuali in grado di rispondere al movimento e al gesto in modo credibile, estetico, espressivo e divertente. I mediattori sono agenti software la cui personalità influisce non soltanto sul loro stato interno (sentimenti) ma anche sulla percezione del comportamento dell'interprete (intenzioni) e sulle aspettative riguardo a interazioni future con attori umani".
6 Un resoconto dettagliato di Play di L. Gharavi, spettacolo in realtà virtuale dell'i.e.V.R,. è on line su www.ateatro.it n.101,
7 Ci riferiamo all'interessante progetto di teatro d'opera The Jew of Malta, libero riadattamento da Christopher Marlowe con musica originale di André Werner e uso di sistemi di motion tracking commissionato dalla Biennale di Monaco. Protagonista centrale è Machiavelli: le coreografie e la scenografia sono basate sull'idea che tutto ruota intorno a lui. Così la topografia dei luoghi e gli ambienti virtuali sono generati real time dall'attore che interpreta Machiavelli grazie a un sistema di rilevamento ottico del movimento. Pochi attori interpretano tutti i personaggi dell'opera e i rapidi cambi di costume (anche questi virtuali) sono possibili grazie a proiezioni di trame e stoffe sui loro stessi corpi. tracciati real time da videocamere a raggi infrarossi.
8 P. Atzori, Activation space, p. 347 in A. Menicacci-E. Quinz, cit.
9 Accogliamo il concetto di trasndisciplinarietà riferito alle arti digitali come l’ha espresso da Sally Jane Norman nel Rapport d'étude à la Délégation aux Arts Plastiques Ministère de la Culture (1997) dal titolo appunto «Transdisciplinarité et Genèse des Nouvelles Formes Artistiques »: «La transdisciplinarité est une notion polysémique par excellence ( . ...) Avant tout, nous avons voulu que la transdisciplinarité serve de point de départ à un dialogue sur le rôle et la place de l'art, dans une société profondément transformée par les technologies de l'information et de la communication».
10 Cfr. Claudia Giannetti, Aesthetic paradigms of media art inserito nella rivista digitale Media art dello ZKM www.medienkunstnetz.de; e inoltre E. Couchot-N. Hillaire, L'art numerique, Paris, Flammarion, 2003.
11 E. Quinz, cit.
12 Sul tema delle interfacce vedi il numero monografico Interfaces, "Anomalie_digital arts" n. 3, Paris, 2003; e inoltre L. Poissant (a cura di), Interfaces et sensorialité, Presses de l'Université du Québec, 2003.
13 Sull'ecosistema tecno-teatrale vedi l'introduzione di Anna Maria Monteverdi al suo Il meglio di ateatro-Teatro e nuovi media. "Con la parola ecologia - come è ormai dato acquisito grazie agli studi sulla fenomenologia di Merleau-Ponty, sull’epistemologia genetica di Piaget, sull’ecologia della mente di Bateson e sull'ecologia sociale e della cultura di Ingold - non si intende unicamente l'ambiente naturale circostante ma la relazione complessa tra gli elementi che compongono una certa "nicchia ecologica" (dunque animali, esseri umani ed oggetti tecnologici compresi) e la loro interazione sociale e ambientale. L'approccio metodologico "ecologico" si presta a nostro avviso a un'analisi integrata e non "riduzionista" degli elementi chiavi del tecnoteatro: ibridazione, connettività, scambio, simbiosi, interazione, rizomaticità. Dobbiamo inoltre a Bonnie Marranca il riferimento sistematico al teatro come "ecologia": nel suo libro Ecology of Theater la studiosa americana fondatrice del "Performance Art Journal" offre una singolare interpretazione teatrale "ecocritica" dei giganti del teatro sperimentale degli anni Settanta-Ottanta: Wilson, Monk, Shepard, Breuer, Mabou Mines alla luce dell’idea di una "drammaturgia come ecologia". Come è noto, inoltre, numerosi sono gli studi sul rapporto tra sistemi digitali, realtà virtuale e pensiero ecologico: l’ambiente virtuale come ecosistema digitale auto-organizzato, l’evoluzionismo tecnologico (Longo, Sini), la "connettività del sapere" e l'ecologia cognitiva di Pierre Lévy in base alla quale "non c’è più soggetto o sostanza pensante, né materiale, né spirituale... in una rete in cui dei neuroni, dei moduli cognitivi, degli umani, delle istituzioni di insegnamento, delle lingue, dei sistemi di scrittura, dei libri e dei calcolatori si interconnettono, trasformano e traducono delle rappresentazioni" (Lévy, 1992).
14 A. Balzola, cit.
15 Prendo in prestito questo termine assai chiarificatore da Derrick de Kerchove ("Perform Arts", estate 2006).
16 A. Balzola, cit.
17 L. Manovich, Il linguaggio dei nuovi media, p. 294
18 Un nuovo oggetto mediale non è qualcosa che rimane identico a se stesso all’infinto, ma è qualcosa che può essere declinato in versioni molto diverse tra loro: L. Manovich, Il linguaggio dei nuovi media, p. 57 e seg.
19 Il vjng, trans-genere per eccellenza, è una performance video live che il digitale sta evolvendo in forme sempre più elaborate. E' stato "nobilitato" anche nel nome, diventando live cinema: il prestigioso festival di arte elettronica "Transmediale" di Berlino edizione 2005 lo ha elevato al rango di altre storicamente forme di espressione tecnologica, ben più radicate, dedicandogli una sezione curata da Hans Beekmans (che ne è anche diventato il "teorico"). Molto diffuso in ambiti artistici oltre che nell'area dell'intrattenimento musicale, il vj come il dj – che fa cut'n'mix e scratching di tracce musicali preesistenti tramite campionatori- usa o mixer analogici o programmi digitali di gestione, rimixaggio e rielaborazione di data base visivi. Lev Manovich definisce il dj nella generalizzata evoluzione digitale, una nuova "figura culturale", quella che meglio esemplificherebbe la tendenza all'integrazione propria dei media: "L'ascesa di questa figura di dj si può collegare direttamente all'ascesa della cultura del computer. Il dj ne esemplifica al meglio la nuova logica basata sulla selezione e sulla combinazione di elementi preesistenti. Il dj esemplifica anche tutto il potenziale di questa logica nella creazione di nuove forme artistiche. Infine, l'esempio del dj dimostra anche che la selezione non è un fine in sé e di per sé. L'essenza dell'arte del dj sta nella capacità di mixare gli elementi selezionati in modo ricco e sofisticato. La prassi della musica elettronica dal vivo dimostra che la vera arte risiede nel "mix". Operano in questo settore Ogino Knaus, Sarako, Otolab, Metamkine, Alessandro Amaducci mentre software e hacker artist come Jaromil hanno creato programmi liberi open source come FreeJ proprio per applicare una vasta gamma di effetti e mixaggi a immagini fisse e in movimento in tempo reale. La caratteristica di alcuni di questi programmi è la loro libera distribuzione sulla rete, ad esempio FlxER.net, che favorisce attraverso piattaforme di file sharing on line, uno scambio continuo di banche dati che sono a disposizione di chiunque sia iscritto alla lista e sia disposto a condividere il proprio patrimonio di immagini e loop.
20 Marco De Marinis, Semiotica del teatro, Milano, Bompiani, 1982.
21 Rimandiamo al sito della Fura www.lafura.com; e inoltre a F. A. Miglietti, Identità mutanti, Costa e Nolan, Genova, 1997; M. Oneto, Tecnomutazioni. Postfuturismi del terzo millennio, Genova, Annexia edizioni, 2002, pp. 90-93.
22 Riprendo il concetto di "oggetto mediale" da Manovich: "Il nuovo oggetto mediale può essere un’immagine digitale fissa, un film a composizione digitale, un ambiente virtuale in 3D, un gioco da computer, un DVD che incorpora degli ipermedia, un sito web contenente ipermedia o la Rete nella sua totalià" (Lev Manovich p. 31).
23 M. Lupone, Ibidem
24 Cfr. M. Lupone, Storie Mandaliche: il suono in divenire, in A. Balzola- A. Monteverdi, Storie mandaliche. Spettacolo tecno-interattivo, Pisa, Nistri-Lischi, 2005.
25 Cfr. Intervista a Daniela Nicolò e Enrico Casagrande a cura di Giorgia Sinicorni, Tesi di laurea Dal teatro aumentato al teatro espanso (Bologna, 2006).
26 Ci riferiamo ad alcune definizioni come "teatro espanso", "teatro allargato","chromakee performance", mutuati chiaramente dal cinema e dalla televisione.
27 Nella seconda e più elaborata versione di questo concerto dei cartoni animati dei Gorillaz nel 2006, Madonna duetta con loro, girando intorno e dietro ai personaggi. Vedi Madonna su youtube.
28 Le citazioni dal testo di Manovich sono tratte dal capitolo 2 (Composizione) e in particolare dal paragrafo Resistenza al montaggio.
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
I switch on
Play di Beckett in Virtual Reality
di Lance Gharavi (traduzione di Anna Maria Monteverdi)
In esclusiva per ateatro.
Nel 1996, pochi mesi dopo il successo dell'allestimento della nostra prima produzione di realtà virtuale, The Adding Machine da Elmer Rice, Mark Reaney e io cominciammo a far progetti per possibili esperimenti futuri. La nostra produzione di The Adding Machine fu il primo frutto della nuova struttura creata con Ronald Willis: l'Institute for the Exploration of Virtual Realites (abbreviato: VR), un'organizzazione dedita alla sperimentazione delle applicazioni dei nuovi media tecnologici a teatro. Sebbene non avessimo né il tempo né le risorse per produrre un progetto ambizioso come The Adding Machine, volevamo comunque cercare cose nuove, testare nuove tecnologie e interfacce, scoprire nuove modalità di applicazione della nostre attuali abilità. Nello specifico volevamo fare una sperimentazione integrando video stereoscopico nei mondi virtuali 3D e permettere al pubblico di interagire con essi attraverso gli occhialetti polarizzati da poco acquistati (Head Mounted Device). Questi HMD, creati da Virtual I-O, sono dotati di un paio di piccoli schermi video che aderiscono all'occhio di chi li indossa, oltre che di un paio di cuffie che permettono, oltre a una visione stereoscopica, anche un suono stereo.

Il pubblico indossa i visori per Play.
Inoltre questi occhiali hanno capacità immersive e parzialmente immersive: rimuovendo lo speciale schermo dall'esterno del minuscolo monitor video, hanno l’insolito vantaggio di permettere a chi li indossava di vedere un'immagine "stereoscopica mediata" - come un mondo virtuale o un video - e simultaneamente di osservare attraverso quell'immagine e vedere un attore sul palco. Tutto ciò che è richiesto a un oggetto o a un attore per essere visibile attraverso i visori HMD è che l'oggetto e l'attore siano sufficientemente illuminati.
Quando ho cominciato a cercare testi per un esperimento su piccola scala con questa tecnologia, Beckett mi è sembrato un autore particolarmente adatto. In primo luogo perché lo stile non realistico dei suoi drammi non avrebbe sofferto un trattamento con i nuovi media, e questo non tanto perché la brevità dei suoi lavori tardi fosse decisamente appropriata per questo progetto, ma soprattutto per il modo in cui il suo lavoro spesso giocava con l'idea di presenza, di assenza e di presenza apparente. Il dualismo presenza/assenza era stato - come notammo Reaney, Willis e io - un elemento chiave nel nostro lavoro con la realtà virtuale, e un aspetto significativo in quasi tutte le forme di cyberteatro -come noi lo chiamavamo un tempo - più innovative. Collegare Beckett alla realtà virtuale e giustapporre la problematica originale della "presenza" che essa genera sembrava una direzione appropriata e avvincente per le nostre sperimentazioni.
Dopo aver passato in rassegna diversi drammi brevi di Beckett, alla fine decisi per Play, un lavoro prodotto in Germania nel 1963. E’ un testo a tre personaggi: un uomo e due donne. Ciascuno di questi personaggi è intrappolato in una delle tre urne, da cui fuoriesce solo la testa. Per tutto il dramma, i personaggi parlano come rispondendo a un riflettore abbagliante che li illumina uno alla volta, o talvolta tutti insieme. Nella produzione questa luce divenne una specie di quarto “agente”, che interrogava i personaggi come fossero dei prigionieri, comandando loro di parlare, di confessare. Billie Whitelaw, commentando la sua esperienza nel rappresentare una di queste donne, ha detto: “Penso che Play sia un quartetto, non un trio. La luce è una parte molto attiva, una parte molto spaventosa, addirittura uno strumento di tortura” (James Knowlson, An Interview with Billie Whitelaw, “Journal of Beckett Studies”, no. 3 summer (1978) 86).

Lo schermo su cui è priettato un rozzo bozzetto del mondo virtuale della produzione i.e.V.R. di Play. Scena e regia di Lance Garavi. Foto di Mark Reaney.
Nelle produzioni tradizionali di questo testo, gli attori nelle urne sono vivi e il personaggio della luce è, ovviamente, rappresentato da una vera luce. Se anche ci fosse un "agente" umano dietro i movimenti del riflettore - come un operatore che segue la luce — questi non sarebbe affatto visibile al pubblico e non giocherebbe alcun ruolo nel mondo della finzione drammatica. Nel mio adattamento di Play ho invertito le funzioni. Il riflettore era l'unico "agente vivo" nella produzione. L'uomo e le due donne erano personaggi "tecnologicamente mediati". Questo approccio metteva in risalto il ruolo attivo della luce e rimodellava il dramma, ponendo al centro della produzione la tecnologia e il suo potere potenzialmente minaccioso. Attraverso gli schermi dei visori HMD il pubblico vedeva i personaggi nelle urne come immagini video stereoscopiche dentro un ambiente virtuale. Gli spettatori potevano guardare anche attraverso le immagini e scorgere le mie azioni, poiché io stesso assunsi il ruolo della Luce. Le immagini negli occhiali HMD apparivano sovrapposte al mio corpo; l'agente che manipolava l'ambiente virtuale e che comandava ai personaggi di parlare, divenne così una figura fantasmatica ma viva che prendeva posto in una porzione di luce fioca al centro del palco. L'operatore che normalmente manipola e guida il punto di vista del pubblico attraverso i mondi virtuali nelle produzioni di Virtual Reality - un ruolo che noi denominammo VED (Virtual Environment Driver) - occupava la posizione di “agente” un questa drammaturgia. Dal momento che il movimento attraverso gli ambienti virtuali non era preregistrato, ma manipolato in modo estemporaneo da un operatore che fa sì che l'ambiente interagisca liberamente con i performer in scena, l'ambiente stesso divenne in questo modo un “agente aggiunto”.
In The Adding Machine come nella successiva produzione in realtà virtuale, il VED e il suo computer erano dietro la scena, nascosti alla vista del pubblico. Gli spettatori potevano vedere lo spettacolo della scena generata al computer direttamente sullo schermo, ma non avevano la possibilità di sapere che i mondi virtuali non erano semplicemente delle animazioni preregistrate.
Per il mio lavoro con Play mi sembrava giusto evitare di nascondere il VED e i meccanismi con cui operava. Facendo così, il VED e l'ambiente sarebbero stati un agente attivo in maniera più evidente, così come sarebbe stata chiara anche la natura real time dei media utilizzati. Inoltre, portando la persona (VED) sulla scena, questi diventava una parte concreta e visibile della drammaturgia, sebbene non necessariamente una parte del mondo fittizio del dramma. Come il direttore nella buca dell’orchestra o il koken nel teatro Kabuki, la presenza visibile del VED e la sua influenza sulla drammaturgia sarebbe stata evidente anche se non gli veniva necessariamente conferito lo status di agente fittizio.

Da The Beckett Project. Foto di Patricia Clark.
Nel mio adattamento di Play feci un passo avanti, dando al VED il ruolo di agente fittizio, creando un manipolatore tecnologico come personaggio che il pubblico poteva vedere attraverso le lenti del mondo mediato tecnologicamente, dei personaggi di Beckett nelle loro urne.
Nella nostra produzione il pubblico in una piccola stanza di fronte a un lungo tavolo illuminato da riflettori. Un groviglio di computer e dispositivi video copriva quasi tutto lo spazio a disposizione sulla superficie del tavolo. Prima dell’inizio dello spettacolo, Reaney aveva l'insolito compito di aiutare il pubblico a indossare gli HMD. Dopo un lungo silenzio beckettiano, durante il quale gli spettatori ridevano nervosamente a causa dell'aspetto che avevano assunto indossando questi visori dall'apparenza futuristica, entravo nella stanza incarnando il personaggio della Luce. I miei capelli erano arruffati e grigi. Indossavo un abito inadatto alla taglia e di colore scuro, camminavo con passo strascicato e stanco; in alcuni momenti mi affaccendavo comicamente sulle attrezzature prima di sedermi e di cominciare a manipolare il video e i mondi virtuali.
Sovrapposto al tavolo, all'attrezzatura e al personaggio della Luce, il pubblico vedeva l'ambiente virtuale stereoscopico. Davanti a loro una enorme pianura deserta. Distante, si ergeva un'urna grigia gigantesca con i bordi superiori nascosti alla vista. All'orizzonte di questa scena surreale e apocalittica, un sole che tramontava suggeriva l'arrivo imminente della notte. Muovendo il mouse del computer il punto di vista del pubblico cominciò a cambiare, spostandosi lentamente verso la base dell’urna gigantesca. Prima di arrivare alla base, gli spettatori sembravano diventare leggeri, fluttuare lentamente nell'atmosfera fino a quando non rimanevano sospesi da terra, proprio sopra il bordo superiore dell'urna. Cominciavano a scendere dentro la cavità di quell'urna grande come un grattacielo, finché non si posavano sopra un piccolo ripiano quadrato, sempre fluttuando nel buio interno del recipiente. Tutto intorno centinaia di identici ripiani quadrati sospesi in una grata sembravano svanire in lontananza. Di fronte, su tre ripiani separati, stavano tre urne grigie, simili al contenitore in cui erano immerse ma più piccole.
Dopo pochi momenti di assoluto silenzio, non appena alzai la leva di un mixer video le teste dell'uomo e delle due donne apparvero all'imboccatura delle tre urne. Come il mondo virtuale tutto intorno, il video era stereoscopico, così che le teste apparivano tridimensionali, ed emergevano da urne ugualmente tridimensionali. Dopo un ulteriore momento di silenzio, i tre cominciarono a parlare. Come uno di loro iniziava a parlare. però, l'altro scompariva, per riapparire subito dopo e ricominciare un monologo opprimente e sforzato.

Da The Beckett Project. Foto di Patricia Clark.
A ogni cambio di oratore, la Luce schiacciava un bottone sul mixer video, quasi a scacciare il personaggio dalla scena e a comandare a un altro di apparire e parlare. A un certo punto, nel corso di questo crudele rituale, le teste scomparivano, sebbene le loro voci continuassero a essere udibili, e il pubblico in quel momento veniva trascinato in alto, fuori dall'urna, e fatto fermare in un punto sopraelevato di fronte a una piramide a quattro lati. Poi giravano intorno alla piramide lentamente; su ciascun lato della piramide veniva proiettato un film in bianco e nero dei personaggi.
Ciascuno di questi video a loop mostrava i personaggi che distoglievano lo sguardo nervosamente e occasionalmente guardavano in camera. Inframmezzati a questi video c'erano alcune sequenze che mostravano i personaggi con i volti distorti elettronicamente e colti mentre scrivevano in una apparente sofferenza. Nel lato retrostante la piramide era proiettato un breve video del personaggio LUCE, inframmezzato da un breve segmento distorto e colorizzato elettronicamente, della sua faccia contorta dalle risate. Dopo questo breve "viaggio", il pubblico ritornava nella posizione di partenza di fronte alle tre urne.
Le teste comparivano alla vista senza mai cessare la loro litania triste e dolorosa. Non appena i personaggi cominciavano a ripetere ancora una volta l'intera sequenza, le loro teste e le loro voci piano scomparivano fino a sparire del tutto. La Luce sedeva scomposta nella sedia, come fosse esausta della prova e fissava lo schermo del computer in silenzio. Dopo una pausa prolungata, si alzava e usciva lentamente dalla stanza.

Da The Beckett Project. Foto di Patricia Clark.
All'inizio del processo che mi ha condotto a creare queste immagini, mi sembrava vitale mantenere le urne come immagine centrale, un'immagine che suggeriva sia morte (le urne che contengono le ceneri dei morti) sia nascita (l'urna come utero che contiene la vita). Nel testo di Beckett era implicito che i personaggi di Play occupassero una specie di infernale post mortem.
Nel mio progetto volevo suggerire esattamente questo, il che implicava anche che le tre urne e i loro occupanti non fossero altro che una singola manifestazione di una formula ripetuta all'infinito. Si alludeva a questo attraverso la natura di matrioske delle urne. Il progetto richiedeva che ci fossero urne dentro urne dentro urne e una progressione infinita dello stesso rituale di domande. La griglia di ripiani quadrati e vuoti dentro l'urna gigantesca rinforzava questa idea. Questa serie infinita di ripiani che si estendeva per un lungo tratto non solo doveva suggerire l'idea di infinità ma anche l'esistenza di un numero infinito di posti vacanti in attesa di essere occupati da urne identiche, contenenti prigionieri riluttanti e timorosi.
Il processo di creazione delle immagini video delle due donne e dell'uomo fu piuttosto lungo e coinvolgente quanto quello di costruzione del mondo virtuale. Per registrare le loro azioni sedevo in una zona di fronte a un set in green screen. Di fronte a loro un grande piano verde mascherava i loro corpi dalle spalle in giù. Li ho ripresi con un paio di telecamere vicine, per ciascun lato. Il segnale da ciascuna di queste videocamere passava a un mixer che combinava i due segnali per registrare. Ciascun segnale sarebbe stato poi mandato al monitor appropriato così che le immagini sarebbero apparse tridimensionali.
Durante la proiezione usai un mixer video per bucare lo sfondo verde e piazzare le immagini degli attori sulle immagini del mondo virtuale in modo che le teste degli attori apparissero come emergere dall'imboccattura delle urne. Usando una leva sul mixer potevo farli apparire e scomparire a mio piacimento mentre le loro voci continuavano a recitare (e a essere udibili, ndc) attraverso le cuffie degli HMD. Al termine di questo esperimento ebbi l'opportunità di discutere con il pubblico.
Essendo solo la nostra seconda produzione teatrale che mescolava realtà virtuale e teatro e il primo sforzo di utilizzare i visori HMD come dispositivi di interfaccia, non eravamo sicuri se il pubblico sarebbe stato in grado di capire il senso di questa operazione che mescolava media elettronici e performance live. Dalle loro risposte fu chiaro che avevano estratto il significato dello spettacolo dall’interazione tra diversi linguaggi dal vivo e mediati.
Molti dei commenti puntavano ad alcune delle caratteristiche di questi nuovi dispositivi di interfaccia che per noi in precedenza non erano affatto chiari. Per esempio, gli spettatori potevano scegliere di rivolgere la loro attenzione dai personaggi nelle urne guardando attraverso le immagini elettroniche all'attore in scena di fronte a loro e viceversa. La facilità con cui potevano farlo dipendeva per lo più dalla quantità di luce sull'attore e dalla luminosità delle immagini dentro i display HMD. Inoltre scoprirono che, muovendo la testa, potevano controllare la relazione spaziale tra l'attore in scena e gli oggetti dentro al mondo virtuale. Infine discussero animatamente sulle possibilità di questa tecnologia e sulle sue applicazioni nel teatro. Reaney e io accogliemmo con piacere il successo di questa produzione e usammo la conoscenza acquisita per dare forma alla successiva produzione: Arthur Kopit’s Wings. www.ku.edu/~mreaney/
Il teatro di marionette catalano
Una intervista con Carles Canellas
di Anna Maria Monteverdi
Carles Canellas è arrivato in Italia ad agosto per una breve tournée estiva tra Cremona e Bergamo. Nato a Barcellona nel 1954, Carles è considerato dalla critica europea uno dei protagonisti del Teatre de marionetes i titelles catalano contemporaneo, ovvero il teatro di marionette e burattini.

(Archivio personale Giacomo Verde)
Nella sua carriera ha partecipato a più di 200 festival e rassegne di teatro distribuite per 12 paesi in 3 continenti.
Figlio di un fabbro, allievo indiretto di Harry Vernon Tozer, il più famoso marionettista anglo-catalano, Canellas è stato il fondatore del Col.lectiu d’animaciò nel 1978 e dello storico gruppo Els Rocamora, e ha aderito al progetto di fondazione del Circ Cric – che raccoglieva i migliori artisti circensi e di strada di Barcellona. Uno dei più richiesti “virtuosi” delle marionette leggere a filo, oggi insegnante alla Scuola d’arte drammatica, Carles Canellas è stato un rinnovatore del genere: membro attivo del Movimento dei Titellaires indipendentes dalla metà degli anni Settanta ha sostenuto una battaglia -in parte vinta grazie anche alla costituzione di una rete nazionale, l’UNIMA - per il riconoscimento artistico del teatro di animazione. Canellas è oggi portavoce di un progetto ANIMACIONS con il quale intende richiedere all’amministrazione di Barcellona la creazione di maggiori spazi dedicati a quest’arte: “Questa é un'iniziativa dedicata a promuovere il teatro d’animazione -teatro di burattini e di marionette, d’ombre, d’oggetti, etc.- ed il cinema d’animazione - cartoni animati, modellini in plastilina, animazione digitale, etc. - in tutte le loro modalità, dalle più tradizionali alle più innovative. A questo scopo si intende aprire a Barcellona uno spazio polivalente, teatrale e cinematografico, in grado di ospitare le diverse realizzazioni d’animazione (teatrali, cinematografiche, audiovisive, multimediali, musicali, etc.) e in modo da facilitare la cooproduzione e lo scambio di esperienze e sperimentazioni tra i diversi ambiti artistici.”

(Archivio personale Giacomo Verde)
Canellas ha mescolato generi e integrato tecniche diverse per accrescere l’espressione teatrale, in performance titellaire con proiezioni d’ombre e sofisticati effetti cinematografici e sonori. Ammiratore del Bread and Puppet, dopo un giovanile periodo dedicato alla creazione di un teatro spontaneo con azioni effimere politicamente provocatorie sulla Rambla di Barcellona, approda nel 1982 come artista di strada in Italia, chiamato da amici teatranti che frequentavano il Centro Sperimentale di Pontedera; rimane in Toscana tre anni tra Pontedera, Certaldo, Vinci ed Empoli, e tra teatro di strada, clownerie, maschere di cartapesta e terzo teatro (presenti tra l'altro, nella gloriosa edizione di Santarcangelo del 1978 con la direzione collegiale di Roberto Bacci, Mario Candalora e Leo Canducci) intravede una possibilità concreta di rinascita e di rinnovamento del teatro popolare anche per la Spagna; crea alcuni degli spettacoli menzionati come fondamentali del genere, per virtuosismi e innovazione, dal Dizionario del Teatro di Burattini Catalano come Air mail e El perseguidor. Partecipa nel 1995 a Gavà al convegno di Arte marionettistica con i migliori specialisti della scuola anglocatalana di marionette a filo in omaggio a Tozer ed è per alcuni anni presidente dell’UNIMA.
Ha ricevuto il Premio alla carriera nel 2004 in Italia al Festival di San Miniato La luna azzurra.
Collaboratrice e compagna di Canellas è la danzatrice Susanna Rodriguez.
www.rocamorateatre.com
Per conoscere l’attività del teatro di burattini e marionette in Catalogna e i protagonisti:
Josep A. Martin, El teatre de titelles a Catalunya, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca Serra D’Or, 1998.

Quale è stata la tua formazione come manovratore di marionette?
Ho cominciato a fare teatro a dieci anni amatorialmente coi burattini, e inizialmente senza nessun maestro, in un modo improvvisato. Dopo, a 14 anni ho lasciato quest’arte e ai 20, in piena dittatura di Franco, cominciai insieme ad altri studenti a fare attività teatrale in un modo spontaneo, in una maniera che si potrebbe catalogare vicino ai provos: per le strade facevamo delle azioni per smuovere qualcosa, ma da queste poi dovevamo scappare subito perché era vietato riunirsi più di 4 persone, e queste azioni provocavano assembramenti di folla e pubblico che andavano contro la legge. Con questo gruppo, il TIZ abbiamo fatto azioni fino al 1976. Per la Ramblas di Barcellona trovai poi un marionettista che in modo povero stava manovrando uno dei suoi pupazzi: la situazione ricreata era quella di un indù che incantava un cobra con il flauto e direi proprio che quel flauto incantò me! Qualcosa legava i miei inizi di bambino con i pupazzi a questo artista. In quel periodo studiavo scultura, mi piaceva la musica e facevo teatro: la marionetta fu una specie di incontro di tutte le arti che mi attiravano. Andai con lui, mollai tutto; con lui sono rimasto per un anno e mezzo durante il quale ho imparato le basi delle marionette a filo perché lui era allievo del maestro dell’unica scuola di Barcellona, dell’inglese di Harry Vernon Tozer. Finì perché non potevo andare oltre, avevo anche provato all’interno della compagnia di professionalizzare il lavoro che si faceva.

Quale era il clima politico e come lo vivevano i teatranti? Era possibile per esempio allestire e teatralizzare una forma di dissenso al regime o di critica?
Eravamo ancora in un periodo pre-democratico, non c’era nessun tipo di sovvenzione pubblica, i teatri erano praticamente tutti chiusi e gli spettacoli si dovevano fare in piazza o in spazi come l’università o presso organismi privati di interesse culturale o artistico ma in modo semi clandestino, indipendentemente dai contenuti perché era difficile avere il permesso, occorreva tempo. Alcune compagnie che avevano produttori potevano usufruire di spazi importanti, noi no.
Io tentavo di andare oltre, avevamo fatto dei viaggi per la Francia e per l’Italia così avevamo visto il lavoro di altre persone; io avevo voglia di fare progressi, di fare ricerca senza ripetermi.
Avevamo rifatto un pezzo del Bread and puppets antimilitarista che non potevamo sviluppare veramente per la marginalità in cui ci dovevamo muovere. Raccontavamo storie con caricature di Hitler ma non potevamo farlo con Franco perché rischiavi la vita. Non solo per i poliziotti ma per i fascisti paramilitari. Tutta la critica politica si doveva fare poi, sempre come sottotesto, potevi leggere il vero significato tra le righe, anche i cantanti facevano così con i loro testi, c’era sempre un significato interno diverso, un doppio senso; noi in teatro dovevamo giocare con questa ambiguità di significato per garantirci l’integrità.

Che tipo di teatro rappresentava per voi un modello?
Un modello che mi piaceva era il Bread and Puppet, c’era stato anche il Living Theatre a Barcellona che colpì tutti noi e poi Django Edwards, un clown straordinario anticlericale e antimilitarista. Quelli erano i nostri centri di attenzione anche per la lotta antifascista. Queste influenze ci diedero stimoli per andare avanti.
Quando hai riunito gli artisti per fondare la compagnia del Collectiu d’animaciò e poi di Els Rocamora, e cosa si intendevate per teatro di animazione, quali le tecniche?

Mi unii dapprima alla compagnia Taller de marionetas di Pepe Otal. L’idea era inizialmente di fare una cosa come il Bread and Puppet, di avere una seconda compagnia interna in modo che il gruppo potesse funzionare economicamente; avevamo occupato una casa e si viveva come in una comune, c’era un lavoro comune, ognuno portava la propria parte, i lavori venivano divisi in modo anarchico. Ci siamo separati ma in modo pacifico. Ho fondato allora il Collectiu d’animaciò, la mia prima compagnia con cui ho lavorato su tecniche molto diverse. L’idea era di cominciare a mettere in pratica la teoria che in quel momento stavo sviluppando sul teatro di animazione, sul senso più “largo”, più esteso che deve avere il teatro di animazione, che comprendesse burattini a stecco, a guanto, teste giganti, teatro di ombre, tecniche in cui l’attore Usa un elemento alieno a se stesso per rappresentare con questo un fatto teatrale.
Gli spettacoli erano molto diversi, c’erano in compagnia, artisti di circo, pantomini, attori di testo, manovratori di burattini ecc e dall’insieme del lavoro di tutti venivano fuori spettacoli dove all’interno si poteva trovare una versione de Il concerto per transistor di John Cage insieme a un numero classico del Pierrot Lunaire fatto con marionette a filo, il tutto con una coerenza estetica e drammatica.
Il gruppo è andato avanti fino a quando mi hanno fatto la proposta di aderire e far parte di un circo-teatro, il Circ Cric. La maggior parte degli artisti della mia compagnia sono venuti con me. Avevamo un tendone per 1000 persone, di cui sono stato non solo il costruttore di tutte le strutture di ferro -mio padre era fabbro e questo mestiere mi è servito per costruire torri e gradinate del circo- ma ero anche direttore tecnico, il responsabile della sicurezza, guidavo un camion di 36 tonnellate, facevo il tecnico del suono e una parte dello spettacolo ovviamente. Ognuno portava quello che conosceva, ciò che sapeva, tutti facevano vari ruoli magari non tanti quanti me..... Anche se ben avviato il Circ Cric durò solo un anno durante il quale partecipò per periodi brevi Leo Bassi e l’italiano Bustric con molti altri artisti internazionali. L’idea era quella di fare anche una scuola, portare artisti già affermati e mentre stavano lì dovevano mostrare la tecnica a tutti quanti del circo volevano. Da questa scuola sono nati molti artisti oggi rinomati.
Quando il circo finì, fu un colpo duro per me che avevo messo tanta energia ed illusioni per costruirlo, ed avevo sciolto la mia compagnia per questo progetto in comune. L’avventura finì per contrasti di carattere con uno dei fondatori.

L’avventura italiana è legata a Pontedera....
Venni in Italia chiamato da amici teatranti all’epoca studenti del Centro sperimentale di Pontedera. C’era Giacomo Verde che mi ospitò alla comune che aveva fondato a Petroio, vicino a Vinci. Feci la valigia, presi le marionette che avevo e misi insieme uno spettacolo proprio dal nome La valigia. Venni inizialmente per 3 mesi per fare dei lavori a Pontedera. Il periodo durò però tre anni perché lì il mio lavoro delle marionette a filo piaceva molto e poi perché la situazione in Italia era assolutamente diversa che in Spagna. Gli artisti erano pagati il doppio, i giornali parlavano di te.
Anche in Spagna, quando c’erano Els Comediants, i Marduix, questo genere di teatro popolare, di burattini e di strada stava andando molto forte. Iniziava poi il governo autonomo catalano. Ma in Italia questo movimento si era già consolidato, era un momento ideale. In Italia vedevo realizzarsi quelle cose che avevo sognato. Presi contatto con il Teatro delle Briciole che sia a livello creativo, sia a livello produttivo che come sistema teatrale di distribuzione era un modello davvero ideale. Lo spettacolo Nemo era splendido! Un lavoro di attori e pupazzi insieme per i piccoli di una qualità eccelsa, di una immaginazione senza pari, con un uso molto semplice ma ricco, dei mezzi; senza grandi attrezzature creavano mondi magici, uno spettacolo per i bimbi teneva come incantati anche i grandi: Kamillo Kromo sui fumetti di Altan, il disegnatore della Pimpa.
Il richiamo della foresta di London è un lavoro a cui ho assistito praticamente dalle prime idee, era il massimo che una compagnia poteva fare in quel momento, e proprio in quello spettacolo vedevo riassunte tutte le idee che volevo mettere insieme con la mia compagnia! Con burattini di ogni genere, fatti di legno o con la gommapiuma, mossi con le dita o a filo: il cambiamento delle misure arricchisce in modo visuale lo spettacolo facendolo diventare un “film” come concezione di uso dello spazio.
Dallo spunto de Il richiamo della foresta in Spagna feci Air mail, una storia “gialla” con lo stile plastico del cinema noir americano e il fumetto, per cui si lavorava con attori di carne ed ossa che facevano i primi piani e poi scendevamo di misura, via via passando alla marionetta di filo e poi ad altri burattini ognuno sempre più piccolo. Potevamo fare una stessa scena per esempio ripetuta tre volte con piccoli sfasamenti visivi e temporali: Piano americano, campo medio, primo piano, dettaglio. I pupazzi piccoli si muovevano poco o in modo meccanico, poi veniva la marionetta a filo che ha più espressione fisica e poi l’attore con la mimica facciale. La storia si svolgeva seguendo un classico: lo scrittore di fumetti che inventa una storia e poi ci finisce dentro e diventa lui il detective, visto che quel personaggio altro non era che la trasposizione di un suo ideale, un duro alla Bogart o ispettore Marlowe, un personaggio così. Questo spettacolo girò un po’ in Europa, ma non moltissimo perché eravamo tanti, ma ha avuto critiche buonissime. Eravamo nel 1987.
In Spagna le cose non ingranavano benissimo. C’era bisogno di questo tipo di spettacolo per fare vedere un altro modo di fare teatro, ma probabilmente ero in anticipo culturalmente parlando; da lì la compagnia cominciò a crescere facendo scommesse una più difficile dell’altra. L’ultima fu un adattamento di Il persecutore, un racconto di Cortazar, uno scrittore argentino che viveva a Parigi. E' un racconto sul mondo del jazz, sulla figura di Charlie Parker che lui ammirava molto. Lì nello spettacolo presi tutta la parte di allucinazioni del musicista che si confronta con un critica d’arte che lo ammirava (che è poi l’alter ego di Cortazar); usai molti mezzi, un suono quadrifonico perché volevo che gli effetti sonori avvolgessero il pubblico, i rumori della Senna... La musica era l’asse principale della drammaturgia e cercavo di fare in modo che un suono potesse inseguire l’altro, che desse l’effetto di essere lì. Si facevano scene con marionette a filo con situazioni anche di flashback in cui il musicista si ricordava per esempio come aveva perso lo strumento. Però la sfida per il tipo di teatro che c’era in quel momento in Spagna, troppo aderente a un mercato commerciale e che si ripete all’infinito, era troppo grossa e lo spettacolo non ha avuto il riscontro dovuto. Se Air Mail era difficile da rappresentare a Barcellona, questo ancora di più. Economicamente l’impresa fallì, eravamo in 16 e sciogliemmo la compagnia, tornai al piccolo gruppo con marionette a filo riducendoci a un livello quasi amatoriale senza volerlo essere, dovendo lavorare a incassi bassi, con mezzi scarsi, senza ascolto dei mass media, riconosciuti solo come un intrattenimento infantile senza interesse da parte dell’ambito culturale ufficiale!
I teatranti spagnoli sono classisti: chi fa teatro d’animazione non è riconosciuto alla stessa stregua di un artista di teatro recitato. Questo ha impedito la collaborazione di teatranti di animazione con registi e altri attori di testo, non c’è stata questa confluenza che è invece a mio avviso è necessaria...

Quali sono state le ultime produzioni?
Una delle ultime cose che ho prodotto, è la ricreazione di Piccoli suicidi di Gyula Molnàr che secondo me è un pezzo fondamentale del teatro contemporaneo e soprattutto del teatro di oggetti. E’ una lezione magistrale, non si può prescindere da questo testo e lo feci con lo stesso spirito degli inizi, di riformare la scena. Se fossi rimasto qui in Italia le cose sarebbero andate diversamente professionalmente ma sono tornato a Barcellona per fare vedere cosa succedeva fuori, per portare delle novità. Ma non sono riuscito a risvegliare un vero interesse. Pensavo di riuscirci e a livello di pubblico e di critica la risposta è stata molto buona ma i programmatori teatrali dato che non hanno referenti su questo genere di teatro, non vogliono rischiare. Così ho in mano un pezzo splendido, questi Piccoli suicidi che posso fare vedere pochissimo in Spagna.

Che tipo di abilità occorre per lavorare con marionette a filo e che temi proponi?
Il solista è uno spettacolo di marionette a filo, che porto in giro già da tempo ed è quello che definisco uno spettacolo di “manipolazione virtuosa” ma che nasconde molto di più a chi vuol vedere a chi sa leggere altri sensi: tutti i numeri hanno una critica sociale, una critica politica o servono a far riflettere su quello che accade, con i commenti che aggiungo. Nel numero della ballerina di flamenco dico che lei vorrebbe girare il mondo ma finora ne ha girato solo la metà e sta aspettando che nell’altra metà la guerra finisca. E’ uno spettacolo che si può fare all’aperto e al chiuso e cattura sia i bambini che gli adulti più severi, per il buon livello di manipolazione. In questo spettacolo c’è molto lo spirito della commedia dell’arte; si prendono al volo le cose che possono succedere, ho un filo di argomenti minimo, con cui lavoro ma sempre in funzione del pubblico che ho davanti in quel momento, dell’età, della loro abitudine a vedere spettacolo, tutto varia di volta in volta, di rappresentazione in rappresentazione.
I vestiti nuovi dell’imperatore è una libero adattamento del racconto di Andersen; libero perché mi sono permesso di trattare altri temi prima: i tessitori che nel racconto di Andersen sono vigliacchi che vogliono ingannare l’imperatore, da me diventano gli artigiani catalani che nel medio evo, in epoca di guerra con le enormi tasse che richiedeva il re, facevano la fame e avevano dovuto prima muoversi di mercato in mercato poi andare fuori dal paese per trovare lavoro come immigrati da questo imperatore che non ama il teatro e spende tutto in nuovi vestiti. Perciò mi permetto di trattare temi che vanno oltre quello che il pubblico si aspetta!
Quanto alle abilità, un marionettista a filo ha le stesse difficoltà di un qualsiasi concertista di strumento, ci vuole sensibilità e pratica. E buoni strumenti, nel mio caso io mi costruisco personalmente tutte le marionette.
Quali sono i materiali che impieghi?
Nei Vestiti Nuovi le marionette sono tradizionali, in legno ritagliato; in Solista ho fatto marionette grandi che manovro con il braccio dall’alto, per questo devono essere molto leggere. Da questa mia ricerca per marionette è uscito un nuovo stile, la marionetta leggera, che ha pesi minimi, e i pesi sono lì dove devono esserci per farla muovere come vuoi. Una marionetta di 65 cm di altezza va a pesare 5 etti. Fai poca fatica e puoi anche lanciarla in aria.
In altri spettacoli uso tecniche diverse, uso oggetti simbolici che fanno più ricca la scena e mi servono per spiegare la storia; non limito la tecnica: in uno spettacolo la marionetta a filo è importante ma ci sono anche pupazzi, burattini, non mi importa questa varietà se usata in maniera coerente.
Ci sono scuole per manovratori di titelles e marionetes?
Ogni marionettista ha cercato un suo proprio stile, io mi sono basato sul lavoro di Tozer ma ho poi sviluppato un mio stile personale, per le posizioni di certi fili, per la marionetta leggera che ha movimenti molto più veraci senza perdere la sua essenza di marionetta!
Quali gruppi spagnoli riescono a uscire dal proprio Paese e acquistare fama all’estero e quali compagnie o artisti italiani normalmente vengono in Spagna?
Gruppi spagnoli che abbiano lavorato in Italia saranno 4 o 5 non di più. Ancor oggi la comunicazione tra i vari Paesi non è fluida come dovrebbe: ci sono le spese di viaggio, ci sono difficoltà organizzative.... Gli artisti italiani vengono poco, forse per come è organizzato il mercato in Spagna (anche in Italia, ndc) che impedisce la contrattazione di compagnie straniere, si fa il cosiddetto “scambio”. Almeno per il teatro ragazzi. Il fatto della lingua potrebbe essere un’altra difficoltà, io ho alcuni spettacoli con testo che non porto all’estero, ma per lo più i problemi sono di tipo organizzativo. In Spagna abbiamo cachet diversi, minori che in Italia, minori di quello che prendono le compagnie italiane. A livello di Festival tra gli artisti italiani vengono il Teatro gioco- vita, i pupari siciliani come Mimmo Cuticchio, ma sono situazioni isolate che non permettono veramente di aprire le porte ai teatranti italiani.
Burattinai tradizionali italiani che usano i personaggi come Brighella Gianduia o Meneghino che hanno origini dalla commedia dell’arte, non vengono in Spagna per il loro carattere dialettale, che può risultare incomprensibile, però secondo me sarebbe necessario che si muovessero dall’Italia per far recuperare la memoria del burattino tradizionale che durante Franco è scomparsa del tutto. E’ cosa ormai storicamente accertata che il burattino dal 1600 in avanti dall’Italia si è sparso in tutta Europa lasciando chiare tracce in vari Paesi, come il “Punch and Judy” inglese che è Pulcinella. Questa tradizione da noi è definitivamente scomparsa nel 1939, dopo la Guerra civile perché molti burattinai sono morti, alcuni andavano in guerra nella prima linea a far spettacolo, altri sono fuggiti in Sudamerica altri hanno smesso per paura perché sia la religione cattolica che i militari non vedevano di buon occhio ciò che facevano i burattinai (dai tempi dell’Inquisizione!). Per cui hanno tagliato tutta la tradizione che durava da molti secoli, persino i nomi de burattini sono scomparsi e c’è stato un deserto fino agli anni Sessanta quando si è cercato di recuperare le cose rimaste dagli scampati burattinai ma che hanno però perso la forza originaria: non avevano gli stessi canovacci, erano molto più infantilizzati per non offendere il regime franchista e per continuare a lavorare. Venivano recuperati solo per celebrare comunioni, per festeggiamenti popolari, e avevano perso quella carica di ironia che in Italia con i burattinai tradizionali è invece continuata. Dico questo affinché i burattinai tradizionali italiani tornino in Spagna per far ritrovare questo filo della memoria e mettere in chiara luce queste connessioni culturali europee.
Le recensioni di ateatro: Ur-Hamlet, drammaturgia e regia di Eugenio Barba
L'utopia teatrale multiculturale dell'Odin Teatret
di Oliviero Ponte di Pino
Tra i numerosi meriti di Eugenio Barba, uomo di teatro e teorico, ci sono la creazione di alcuni memorabili spettacoli; la fondazione e la guida di un gruppo teatrale come l’Odin Teatret che ha ormai superato i trent’anni di vita, oltre che la puntuale riflessione sul significato di questa esperienza; l’invenzione del Terzo Teatro come movimento alternativo globale; la messa a punto dei meccanismi dell’improvvisazione con gli attori e degli strumenti drammaturgici per il loro montaggio; e naturalmente l’invenzione dell’antropologia teatrale, la disciplina dove per la prima volta le diverse culture dello spettacolo dal vivo sono state analizzate e messe a confronto, alla ricerca degli elementi distintivi - fondanti - del teatro e dell’arte dell’attore.

Nella sua impostazione multiculturale, Ur-Hamlet, lo spettacolo che ha debuttato a Russi nell’ambito di Ravenna Festival, è con ogni evidenza un prodotto dell’ISTA (International School of Theatre Anthropology, fondata nel 1979), l’istituto che nelle sue numerose sessioni ha esplorato, messo a punto e diffuso i principi dell’antropologia teatrale. Nel cast dello spettacolo figurano infatti, oltre ai sei attori del gruppo danese, una new entry come Augusto Omolù, formatosi nella tradizione del candomblè, un’attrice del Nō giapponese, Akira Matsui, e un’intera compagnia balinese, quella del Gambuh Pura Desa Ensemble di Batuan; infine un folto gruppo dei giovani attori (“43 attori di 21 nazionalità diverse”, specifica la locandina) del “Primo Mondo” che hanno partecipato a una serie di seminari preparatori e che costituiscono il “Coro degli stranieri”.

Fin dal casting lo spettacolo si muove dunque in una prospettiva multiculturale, nell’interazione di tradizioni diverse. Su questa strada si sono mosse in questi decenni diverse altre esperienze, secondo un’ampia gamma di possibilità, nell’ambito del continuo scambio tra Oriente e Occidente che ha caratterizzato la storia del teatro novecentesco.
L’operazione più semplice consiste ovviamente nell’allestire un testo della tradizione occidentale secondo uno stile “orientale”. Lo ha fatto per esempio Ariane Mnouchkine, quando ha immerso i testi di Shakespeare in atmosfere e suggestioni che rimandavano alle tradizioni orientali: nel Riccardo II (1984) e nella Notte dei re (Avignone, 1984) la messinscena riprendeva gli stilemi del teatro giapponese e indiano. Per certi versi affine è l’operazione condotta con Samritechak, “l’Otello khmer” chiamato da Peter Sellars alla Biennale Teatro 2005: in questo caso una compagnia orientale, l’Ensemble di Danza e Musica della Royal University of Fine Arts di Phnom Penh, ha portato in scena uno dei testi più noti della tradizione occidentale. In operazioni di questo genere, l’intreccio riguarda tre elementi: un testo (che fa parte della tradizione occidentale, o meglio del “canone” occidentale, visto che portano la firma autorevole di Shakespeare), una compagnia di attori addestrati all’interno di una tradizione (nel primo caso occidentale, nell’altro orientale) e uno “stile teatrale” più o meno ibrido (nel primo caso attori occidentali che usano tecniche espressive orientali, con tutte le inevitabili; nell’altro attori orientali che seguono la tradizione in cui si sono formati).

Ovviamente questa è una drastica semplificazione (naturalmente esistono diverse tradizioni orientali, così come la tradizione occidentale è assai variegata, e da più di un secolo continuamente arricchita da contaminazioni e innesti), ma la schematizzazione può essere utile per capire la ricchezza delle possibilità offerte dalla pratica di un teatro multiculturale.
Di segno diverso l’atteggiamento di Peter Brook, che al suo CIRT ha raccolto attori con origine e formazione molto diverse, dall’Inghilterra alla Francia, dal Giappone all’Africa: senza certamente costringerli ad abbandonare il loro imprinting, anzi, ma cercando un punto d’incontro semplicemente umano, all’interno di una cornice teatrale essenziale e quasi originaria, adatta a rappresentare testi presi da tradizioni assai diverse, da Shakespeare a Farid Attar, dal Mahabharata ad Athol Fugard. Analoga era, per certi versi, l’impostazione di Jerzy Grotowski, che nel “Teatro delle Fonti” cercava di riattivar una dimensione originaria dell’esperienza umana di cui restano tracce in varie tecniche e tradizioni, dallo yoga indiano al voodoo haitiano, ma cercando elementi utili anche nella ginnastica occidentale, che fu alla base di alcuni esercizi del training del Teatr Laboratorium, e nelle sperimentazioni teatrali di Stanislavskij con gli attori.

In altri casi, si può cercare invece un punto di contatto specifico tra due universi culturali lontani: un esempio è la ricerca delle Albe sulle affinità tra i griot senegalesi e i fûler romagnoli, due figure di attore-autore-narratore presenti nelle due tradizioni, che è diventato il tema di uno spettacolo, Ruh. Romagna + Africa =.
Eugenio Barba e il suo “Theatrum Mundi” si muovono in una prospettiva diversa. Il drammaturgo-regista ha evitato le trappole psicologiche e le infinite interpretazioni politiche del testo di Shakespeare, per risalire direttamente alla sua fonte, il racconto di Saxo Gramaticus, il primo cronista e scrittore danese. Il suo testo ha dato origine a uno dei rari miti moderni, in un poker, chiosa Barba, che si completa con Arlecchino, Don Giovanni e Faust.
Dunque non Amleto, ma - appunto - Ur-Hamlet, con una serie di interpolazioni e di interventi drammaturgici (la consulenza letteraria è di Nando Taviani), a cominciare dalla presenza in scena dell’autore Beda (Julia Varley), che diventa personaggio e filo conduttore della vicenda.
Ancor prima a colpire è l’organizzazione dello spazio. Più che uno spettacolo teatrale occidentale, ricorda uno di quei riti che possono durare una notte intera: solo un ampio spiazzo erboso, rischiarato dalle fiaccole, e il pubblico sistemato tutto intorno. S’immagina facilmente che non dovrebbero esserci né le tribune né i riflettori che permettono la visione di un folto pubblico da festival.
Come il lavoro di Brook e di Grotowski, anche questo spettacolo di Barba è fondato su una generosa utopia. Nel caso di Brook e Grotowski si scommette su un livello “umano” - o addirittura su una sorta di “grado zero” - dove la comunicazione sia in ogni caso possibile al di là e malgrado le diversità, alleggerendo (o addirittura eliminando) le successive stratificazioni culturali che segnano il nostro modo di vedere, muoverci, pensare... Il “Theatrum Mundi” - un’etichetta barocca, che però tradotta in inglese rimanda anche a World Music, genere ugualmente contaminato e ibrido - di Barba invece non chiede ai suoi attori di rinunciare il peso della loro tradizione, o di alleggerirlo. Anzi, li prende così come sono: con i loro costumi colorati, la gestualità stilizzata e formalizzata, la vocalità addestrata per decenni, addirittura con le maschere... La scommessa - l’utopia - è che questi diversi colori e tonalità possano convivere e interagire sulla scena, arricchendosi a vicenda. Il regista ha il compito di montare (con adattamenti minimi) i diversi spezzoni all’interno del suo progetto, facendo interagire attori con storie e formazioni diverse (un postulato implicito, anche se non strettamente indispensabile, è quello su cui è fondata l’antropologia teatrale di Barba: cioè il fatto che nelle diverse tradizioni l’attore si faccia carico di un surplus di energia). Si creano così momenti di notevole fascino e suggestione, in particolare in alcuni duetti. Tuttavia la discrezionalità del regista non può non porre alcuni interrogativi, al di là dell’apparente necessità di certe scelte (o forse proprio per questo). Da un certo punto di vista è ovvio che un attore del teatro No, dove la drammaturgia è costruita spesso intorno all’apparizione soprannaturali di morti, può essere il più adatto a rappresentare la Regina dei Ratti, con effetti di grande suggestione. Allo stesso modo, un Amleto etimologico come questo (nell’antico norvegese “Amlodhi” era l’idiota, lo sciocco), lontanissimo dall’archetipo dell’intellettuale occidentale creato da Shakespeare, può benissimo essere incarnato da un demone inarticolato e primitivo, cui Augusto Omolù dà una presenza sempre inquietante, potente ed efficace.

Ma - al di là delle buone intenzioni - all’interno della logica drammaturgica di un determinato spettacolo, il casting può non essere innocente. Semplificando fino alla caricatura: se gli attori khmer, poniamo, sono molto bravi a rappresentare i malvagi, non si rischia alla fine di aprire la strada all’equazione “cambogiani=cattivi”, un po’ come capitava ai pellirossa nei primi western?
Il testo di Beda, di cui si sottolinea l’oggettività nella descrizione dei meccanismi del potere, al di là di ogni giudizio morale, limita un rischio di questo genere, così come la suggestiva cornice dello spettacolo, tra la festa e il rito. Ma sul lungo periodo, nel momento in cui un teatro “multitradizionale” di questo genere inizierà a svilupparsi, quale potrà essere il ruolo affidato alle singole culture? Gli stili recitativi vengono utilizzati da un regista-arrangiatore solo come i colori sulla tavolozza di un pittore, in base alla loro efficacia e funzionalità? Oppure ciascuna di quelle diverse tradizioni porta in sé qualche valore specifico, che può arricchire lo spettacolo di significati? In questa composizione, che ruolo può avere l’Occidente, nelle sue varie articolazioni, a cominciare dall’istituzione stessa della regia come principio regolatore e garante del senso complessivo dello spettacolo?
Naturalmente è possibile giocare di contrappunto, e Barba lo fa con sottigliezza. In questo Ur-Hamlet per esempio la scena - la Danimarca - viene invasa da una popolazione di immigrati: sono i giovani stagisti “senza tradizione” ma inequivocabilmente figli del primo mondo e della sua cultura globalizzata, in un curioso ribaltamento rispetto allo scenario reale...
Ancora, è evidente che un frammento di una cultura (e di una tradizione teatrale) astratto al di fuori del proprio contesto perde la sua organicità; è anche evidente che non esistono culture “pure”, isolate e autosufficienti: ogni tradizione è scambio e contaminazione. Allora, che cosa lasciare indietro e cosa conservare in ogni incontro? Come far fiorire il seme di questo incontro?
L’interesse di questo ambizioso esperimento sta prima di tutto nelle suggestioni immediate che offre, nella straordinaria maestria dei suoi interpreti, nello sforzo di ricreare la magia di un rituale notturno inquietante e struggente. Ma sta anche nella maniera in cui questo Ur-Hamlet organizza e fa incontrare uomini e culture, nel modo in cui le coinvolge e le valorizza. Nelle domande che si pone, e che ci pone: che sono domande, prima ancora che teatrali, politiche.
A cosa servono tutti questi organizzatori?
L'intervento per il convegno Management culturale e formazione
di Mimma Gallina
Si tiene tra Venaria Reale e Torino, il 22-23 settembre prossimo, il convegno Management culturale e formazione, organizzato da Regione Piemonte, Fondazione Fitzcarraldo e Fondazione Crt, in collaborazione con Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo, Encarc e Associazione Alumni Fitzcarraldo.
Qui di seguito, l'intervento di Mimma Gallina.
Come molti operatori teatrali, negli ultimi otto-dieci anni ho dedicato sempre più tempo e energie alla formazione, presso corsi professionali e universitari in molte città d’Italia, e già dalla metà degli anni Settanta insegno al Corso per Organizzatori dello spettacolo della Paolo Grassi a Milano, dove mi sono a mia volta diplomata e dove ho contribuito a definire piani di studi e metodo.
Da “docente a contratto” il mio osservatorio non è privilegiato ma abbastanza articolato. Questo incontro mi dà l’occasione per pormi ad alta voce alcune domande e mettere a fuoco qualche considerazioni.
1) Con riferimento all’offerta formativa
Un certo disordine nella moltiplicazione e caratterizzazione dei corsi specialistici e professionali, richiede una riflessione e forme di coordinamento a livello nazionale, e forse europeo, da un lato perché i finanziamenti ne hanno favorito la diffusione ma anche condizionato nomi, forme e contenuti (alimentando un creatività apprezzabile, ma non di rado fine a se stessa), dall’altro per la tendenziale dimensione internazionale del settore.
Non è sufficientemente diffusa invece la formazione sull’organizzazione dello spettacolo a livello di lauree triennali, che dovrebbe essere estesa, almeno come opportunità, a tutti i corsi in discipline umanistico-artistiche e non solo (non mi riferisco alle lauree triennali già indirizzate alla gestione dell’attività culturale, sulla cui utilità –in quanto triennio- si potrebbe discutere).
La formazione di base è una condizione perchè gli insegnamenti specialistici siano davvero tali e per individuare (o favorire) le “vocazioni”.
La qualità dei corsi: cosa rende un soggetto davvero idoneo a garantirla? E come si valuta la qualità di un progetto formativo in questo settore? Quale è il profilo culturale e tecnico di un organizzatore di spettacolo? Non esistono metodi univoci e personalmente sono contraria a qualunque soluzione corporativa o burocratica (albi, certificazioni etc.). Ho opinioni in proposito, ma non soluzioni. Però, se esiste la possibilità di un impegno collettivo dei soggetti formatori, una delle finalità dovrebbe essere la chiarezza (scientifica, di linea, di metodo, di prospettive), nei confronti degli utenti, su basi comuni e come condizione per un effettivo confronto dell’offerta.
Vedo infine nella diffusione di seminari altamente qualificati e tecnici rivolti prevalentemente ad operatori una risposta alla necessità di aggiornamento continuo e di “metodo”, spesso molto avvertita dai singoli (non sempre dalle imprese), e anche la possibilità di rimediare a qualche lacuna dei processi formativi eventualmente seguiti.
2) Con riferimento alla domanda
Gli studenti. Il numero assoluto è alto, troppo. La fisionomia degli studenti è inoltre mutata drasticamente col tempo. A spingere i giovani verso l’organizzazione dello spettacolo una volta era la passione tanto a livello di tradizione che di ricerca, spesso intrecciata a convinzioni forti sul piano politico e civile, e ci trovavamo di fronte giovani informati, non di rado davvero colti, che qualche volta “ripiegavano” da professioni artistiche (con quella maturità che fa capire per tempo che è più utile e gratificante essere un buon organizzatore che un mediocre artista). Con il tempo le motivazioni si rivelano sempre più spesso di ripiego – la sede universitaria più vicino casa, un percorso formativo che si suppone più leggero - o frutto di falsi miti e incerti obiettivi candidamente confessati: il principale è entrare nel “mondo dello spettacolo” anche se dalla porta di servizio (il modello è quello televisivo – non sono rari gli studenti che non sono mai stati o quasi a teatro o a un concerto che non sia rock - e la tipologia “velina” è arrivata anche da noi). Questa evoluzione è molto indicativa del ruolo dello spettacolo dal vivo nella nostra società. Ora, ci sono eccezioni, certo (si lavora con passione per loro), e io non credo affatto che per occuparsi di spettacolo occorra un sacro fuoco, ma se sta ai docenti alimentare in corso d’opera motivazioni autentiche, le selezioni sono davvero fondamentali: devono garantire un’articolata formazione di base e verificare almeno quella “curiosità” di fondo (e le attitudini nei corsi professionali) senza cui l’insegnamento è dispersione di energie.
L’insieme delle imprese (e delle attività). In che misura, e quale tipologia di giovani organizzatori richiede il sistema? Ci sono state ricerche e altri potranno dare elementi più obiettivi dei miei. Ma al di là dei probabili riscontri positivi sul piano quantitativo, e delle tipologie e specializzazioni che potremmo descrivere come le più richieste, resta molto grave il problema dell’inquadramento, della precarietà, dei compensi vergognosi, della sottoccupazione.
Il sistema teatrale e musicale non richiede nei fatti gli elementi qualificati che noi vorremmo fornirgli (e in parte forniamo), non certo perché non ne abbia bisogno. E’ UNO dei problemi del mancato rinnovamento del settore e ha a che vedere con la sua povertà cronica, ma anche con tradizioni operative e malcostumi radicati, con la mentalità assistenzialistica, con i condizionamenti politici, con una –incredibile ma diffusa- percezione culturale non professionale della specificità organizzativa (anche in ambienti professionistico). Succede così sempre più spesso che l’impatto dei nostri studenti con la professione sia avvilente e che eviti la frustrazione solo chi ha attitudini imprenditoriali (e magari fortuna) e rischia in proprio, o con altri, o con giovani gruppi (non è raro che giovani compagnie siano infatti meglio organizzate, decisamente più dinamiche, di realtà consolidate). Ma una cosa balza agli occhi e dovremmo spiegarci questa contraddizione: la crescita e l’articolazione della formazione non ha determinato una qualificazione organizzativa del sistema dello spettacolo nel suo complesso. Anzi. Il suo degrado è vistoso e progressivo. Attraverso la formazione si può agire sulla realtà del teatro? E come?
3) Gli enti locali
Sono i principali promotori e organizzatori di spettacolo, e esprimono in quanto tali una domanda di competenze professionali e tecniche. Inoltre: competono alle Regioni forme di sostegno e “controllo” dei progetti formativi? intendo della qualità e della specificità dei corsi e soprattutto del rapporto con la ricettività occupazionale a livello territoriale. Penso di si. Potranno anche farsi promotori del coordinamento nazionale di cui sottolineavo la necessità. Dovrebbero inoltre sostenere la ricerca: penso alla ipotizzata diffusione degli osservatori, ma anche ai margini e ai tempi per la ricerca che si dovrebbero trovare all’interno delle Università e delle centrali formative più qualificate.
Ma quello che mi sentirei di raccomandare in particolare, tornando al punto precedente, è una vigilanza sulla professionalità organizzativa almeno a livello dei soggetti pubblici, o riconosciuti e finanziati. Le Regioni dovrebbero indirettamente -ma anche con incentivi diretti- favorire l’assorbimento dei quadri che i corsi dalle stesse sostenuti andranno a formare. Tanto più che il rapporto e la conoscenza del territorio si dimostra sempre più una competenza importante per l’organizzatore di spettacolo.
4) Per concludere due parole sulla Paolo Grassi di Milano. Vorrei sintetizzare i punti di forza della sua impostazione, non troppo diversa da quella teorizzata da Giorgio Guazzotti quasi quarant’anni fa (vedi in proposito il libro dedicato a Goorgio Guazzotti, curato da Franco Ferrari, e il capitolo che ho curato):
- pochi studenti, tempo pieno, biennalità;
- un rapporto molto stretto con le pratiche del teatro (a livelllo di produzione, distribuzione/diffusione e esercizio);
- docenti prevalentemente attivi nell’organizzazione dello spettacolo, ma impegnati per un numero di ore tali da consentire un rapporto stretto e non anonimo con gli studenti;
- una cura particolare nel scegliere e monitorare gli stages (con attenzione anche alle nuove aree del sistema e agli sbocchi occupazionali);
- un contesto che ospita anche corsi per registi, attori, tecnici, drammaturghi, che favorisce quindi il confronto e la “convivenza” con le diverse componenti del teatro.
Un’evoluzione degli ultimi anni riguarda inoltre:
- ricerche di gruppo su temi legati alle trasformazioni organizzative del teatro, che sostituiscono le tesi individuali conclusive;
- i seminari specialistici – a volte aperti all’esterno - che caratterizzano il secondo anno.
Tutto questo sulla base di una precisa linea didattica ed “etica”: “sulla conoscenza teorica e pratica del fare teatro in Italia, si innesta la consapevolezza della funzione pubblica e della dimensione economica del teatro, presupposto per la formazione di un operatore critico, aperto al confronto con altri sistemi”. Se questa linea per qualche anno è parsa superata – proprio in rapporto all’introduzione di nuove discipline e specializzazioni apparentemente distanti dal teatro reale - sulla distanza mi sembra ancora sostanzialmente efficace.
Milano, 5 settembre 2006
Santarcangelo 2006 tra continuità e innovazione
Catherine Diverrès, Forced Entertainment, MK, Roberto Castello, Rodrigo García
di Giorgia Sinicorni
Dopo lunghi dibattiti sulla nuova direzione, e grande attesa per le novità in programma, ecco che anche questa trentaseiesima edizione del Festival di Santarcangelo si è conclusa. Un’edizione a metà francese, nata con una disponibilità di mezzi limitata, che ha saputo muoversi in continuità con il passato cercando, allo stesso tempo, di dare alcuni segnali di svolta.
Ma cosa resta, al di là dei propositi e delle intenzioni, di questa settimana passata a rincorrere spettacoli e artisti tra la Fabbrica di Gambettola, il teatro degli Atti di Rimini, il Lavatoio e il Teatrino della Collegiata, trasformato in un seducente “disimpegno spazio-lounge”? Dal punto di vista dell’atmosfera resta un festival un po’ meno popolare, più compresso nei tempi e nei luoghi, più attento a creare momenti di riflessione tra critici e pubblico, piuttosto che luoghi di aggregazione come lo era il Circo Inferno.
Dal punto di vista dei contenuti, invece, appare chiara la volontà della direzione di non fare distinzioni di genere (ed ecco che la dicitura International Festival of the Arts espelle definitivamente la parola “teatro” dal vocabolario festivaliero), facendo proprio un criterio di scelta che già dalle edizioni passate guardava allo spettro ampio del performativo. Nell’insieme, un panorama non scintillante, un percorso vagamente accidentato nel quale orientarsi per scovare scheggie di autentica bellezza.

Una delle prime tappe del nostro viaggio è il controverso spettacolo di Catherine Diverrès, dal 1998 direttrice del Centre Choréographique International di Rennes. Con Solides la coreografa francese mette letteralmente in scena un compendio delle teorie che, dai primi del Novecento a oggi, hanno contribuito all’evoluzione della danza contemporanea. Di fronte a una enorme lavagna, sulla quale vengono immancabilmente segnati i nomi dei maestri, da Eleonora Duse a Merce Cunningham, i danzatori ne riportano in vita il pensiero e il segno, generando immagini dal sapore inevitabilmente antico. Operazione discutibile quella della Diverrès, tra l’altro ospite tra i più attesi del Festival, che si risolve in un omaggio al passato, in una celebrazione dei padri che non lascia nessuno spiraglio aperto ai figli, ingabbiati nella ripetizione, indiscutibilmente virtuosa, di tensioni che non gli appartengono loro.

Attesa, questa volta più soddisfatta, anche per i Forced Entertainment. Il gruppo inglese, ospite di Santarcangelo per la seconda volta, con il suo Exquisite Pain riconferma la capacità di muoversi in maniera trasversale tra formati e linguaggi. In una situazione insolitamente “teatrale” per il gruppo, sia per la scelta di un testo a cui attenersi (Doleur Exquis di Sophie Calle), sia per la scelta di uno spazio-tempo definiti, un uomo e una donna siedono di fronte al pubblico con alcuni fogli da leggere. Si alternano nel raccontare di sofferenze passate, la donna ogni volta ripete la medesima storia, l’uomo invece incarna tutti gli interlocutori che la donna ha incontrato e ai quali ha chiesto di condividere la propria pena per alleviare la sua. Un fiume di parole scorre per due ore, parole secche, giornalistiche, quasi totalmente prive di interpretazione che diventano un mantra. Nel ripercorrere infinite volte la notte in cui è stata abbandonata dall’uomo che amava, infatti, la donna conquista il distacco e si libera della sofferenza. Inoltre, contemporaneamente, i due intessono un rapporto con lo spettatore che rimane coinvolto in una dinamica di scambio di esperienze. Solo apparentemente restaurativo, Exquisite Pain, indaga una parola-azione più che narrazione, che automaticamente aggira e supera qualsiasi trappola retorica.
MK, uno dei più interessanti gruppi nel panorama della danza contemporanea, l’anno scorso aveva colpito per l’originalità e la forza di Real Madrid, ma il nuovo lavoro, Funzione, lascia leggermente delusi. Incentrato sull’alternanza di movimento e suono (quello di Sinistri con cui hanno già collaborato), la performance porta con sé i segni tipici della ricerca rigorosa del gruppo, il lavoro tuttavia appare più che altro come una tappa, la traccia di un passaggio (forse di Tourism, lavoro portato alla Biennale danza 2006), o come prefigurazione di un approdo futuro.

Accanto a MK, in un’altra sala della Fabbrica di Gambettola ristrutturata, Roberto Castello, con il suo Racconta, costruisce una radiografia di una situazione domestica. Sequenze di movimenti quotidiani si congelano in un immobilità che rivela non solo la plasticità dei corpi, ma anche la sottile ironia che li abita. Muovendosi idealmente al polo opposto rispetto al virtuosismo, l’occhio del coreografo scandaglia il gesto e la parola ordinari e li incastra in un montaggio quasi cinematografico. Il risultato è lieve e rigoroso allo stesso tempo. Un ritorno a casa, in un certo senso, ma in una casa-acquario in cui le dinamiche tra individui sono decostruite lasciando emergere la tessitura plastica e spaziale che le sottende.

Infine Rodrigo García con Borges+Goya, due monologhi, risalenti l’uno al 1999 e l’altro al 2004, dedicati ai due artisti. Provocatorio come al solito, l’artista argentino affida la propria voce dapprima a un alieno, impegnato nella cura di mele transgeniche, e successivamente a un padre che decide di investire tutti i suoi risparmi in una notte brava. Le invettive si scagliano contro alcune delle contraddizioni della nostra società: l’indifferenza di un intellettuale davanti alla dittatura, la mitizzazioni di personaggi o beni, il consumismo sregolato. Con la lucidità e il cinismo che gli sono propri García riesce a diffondere in chi guarda un senso di disagio non solo attraverso le parole, ma anche esponendo sulla scena corpi in uno stato precario (l’alieno si muove con passo lunare e lentissimo, mentre il padre di famiglia indossa un pesantissimo e ridicolo costume della mascotte dell’Atletico Madrid). Modalità tipica, questa, di altri lavori molto più estremi e fisici dell’artista, che però qui sceglie la strada della parola quasi pura, risultando senza dubbio più retorico e meno efficace.
Le recensioni di ateatro: The Secret Room di Renato Cuocolo con Roberta Bosetti
Invito a cena con segreto
di Andrea Balzola
Approda a Roma The Secret Room, un lavoro teatrale nato in Australia nel 2000 e consacrato da un migliaio di repliche e dai più importanti premi australiani. Fa parte di un progetto più ampio intitolato “Interior Sites Project”, che prevede una serie di episodi ispirati alla vita reale e ambientati in spazi privati a cui possono accedere solo un numero limitato di spettatori (nel caso di The Secret Room, 7 o 8). Un progetto generato dalla convinzione della coppia Cuocolo/Bosetti (lui regista e lei attrice, italiani con un illustre curriculum teatrale ma residenti in Australia) che “lo spettatore debba essere nello spazio/performance piuttosto che guardarlo dall’esterno”. Non è una novità assoluta nel teatro di ricerca, ma è indubbiamente originale la modalità registica e drammaturgica con cui questo teatro d’appartamento è concepito.
Gli spettatori sono ospiti delle abitazioni che l’attrice occupa nelle differenti città, sono invitati a una cena da lei preparata e servita, dialogano fra loro e insieme a lei in un intreccio apparentemente inestricabile tra finzione e realtà, fra copione scritto e improvvisazione. Spariscono tutte le mediazioni consuete degli spazi teatrali, si prenota al Teatro Eliseo che cura l’organizzazione (tutto esaurito x un mese e mezzo di repliche) e poi una volta acquistato il biglietto tutto si svolge come una visita privata in una casa sconosciuta. Giustamente Cuocolo/Bosetti dicono che “la casa non è una scenografia ma una trappola per la realtà.” Gli spettatori sono accolti da una padrona di casa bella e gentile, e nello stesso tempo distaccata, quasi aliena, con una sorprendente capacità di somatizzare gli stati d’animo, talvolta il suo corpo e la sua mimica si irrigidiscono come quelli di una bambola, altre volte ritrovano tenerezza e agilità infantili, in una modulazione di gesti quotidiani (mai però “naturali”) e di improvvise abissali distanze. Le distanze di un segreto famigliare “inconfessabile” che viene distillato per i convitati-voyeurs in dolorosissime gocce, lacrime, che l’attrice si provoca ostentamente tagliando e inalando una cipolla dopo aver servito, a fine cena, un “dessert” immangiabile: un cuore congelato. Questo momento è la chiave drammaturgica di tutto il lavoro: come si può raccontare a degli sconosciuti (7 per volta fino a raggiungere le centinaia di migliaia nel corso degli anni di replica) un trauma infantile irraccontabile, il più intimo, doloroso e inaccettabile dei traumi che una bambina possa subire dal padre? Soltanto mediante l’esorcismo crudele eppure terapeutico di un artificio dichiarato, di una finzione ritualizzata nei minimi dettagli, di un gioco al massacro di cui l’attrice è però, nel medesimo istante, vittima e carnefice. L’effetto è straniante, perché tutto è vero: l’appartamento, l’arredo, il video e le fotografie dell’infanzia, la tavola apparecchiata sul terrazzo, il cibo e il vino, si intuisce che anche il tema subito dominante nelle frasi laconiche dell’attrice – l’infanzia – potrebbe essere un vissuto autentico, tutta questa verità è però distorta, deviata, dalla frontiera invisibile (ma percettibilissima) e invalicabile della recitazione asciutta, quasi stilizzata, della padrona di casa.
C’è imbarazzo tra gli spettatori, non solo perché tra loro non si conoscono e perché diventano loro stessi necessariamente attori, ma anche perché quasi subito prendono coscienza della loro vocazione voyeuristica. L’attrice garbatamente ma spietatamente li provoca: Cosa vi aspettavate venendo qui? Cosa andate cercando? Noi spettatori ci accorgiamo, guardandoci nello specchio dell’attrice, che siamo venuti per spiare un segreto, un dolore e un amore, l’intreccio tragico di un amore perduto e di un dolore inatteso, insostenibile. Siamo quindi anche noi, in quanto testimoni volontari, sicuramente coinvolti, e in qualche modo complici silenziosi dell’efferratezza e del sacrificio di una bambina che ogni volta si consuma, ritualmente, nella memoria evocata della donna. E la Bosetti è bravissima a destare l’emozione, dosando nello stesso tempo l’”invadenza” degli spettatori nel flusso di ricordi e nella rivelazione dei segreti, è una costante alchimia recitativa fatta di “solve et coagula”, di apertura e chiusura, di accoglienza e di allontanamento.
Arte dello spaesamento: quando ti sembra di avere davanti l’attrice trovi la donna, e viceversa. Nel climax emotivo, quando lo spettatore potrebbe mettersi troppo a suo agio nel pathos attoriale, perdendo tensione e concentrazione, l’attrice rilegge sul copione alcune battute che potevano apparire spontanee e improvvisate durante la cena, per rimarcare così quel limite invalicabile della finzione che non può essere oltrepassato, né da una parte né dall’altra, perché il vero nell’arte è garantito proprio dalla finzione, questo è il paradosso del miglior teatro dove “tutto è finto ma nulla è falso”. Un processo di astrazione che usa materia viva e cuce senza anestesia ferite aperte, che si potrebbe chiamare “creatività della consapevolezza” perché fa emergere il rimosso indirettamente, mediante il doppio della persona: l’essere attore, il poter essere in quanto attore (senza tale filtro sarebbe pura autodistruzione, quella che la Bosetti racconta con rara forza poetica parlando della sua fase anoressica). E poi l’archeologia della memoria è fin dall’inizio, anche, impronta onirica, sintesi visionaria del sogno e ripercorrimento che mescola i ricordi e le maschere dell’immaginario, perché memoria e immaginazione sono parenti strette e spesso si con-fondono, tessendo le trame di uno stesso arazzo. Alla fine di un percorso circolare, che parte dal salotto col video acceso, attraversa la zona pranzo, si immerge nella massima intimità di una cameretta con letto e poi ritorna al salotto per un rapido congedo (l’attrice saluta e dice semplicemente: “Adesso vorrei restare un po’ da sola”), resta la strana sensazione di essere degli intrusi. Nello stesso tempo ci si sente legati a quella creatura che ci ha accolti e che ora ci manda via come a qualcuno che spogliandosi l’anima per un istante davanti a noi, non solo ci ha fatto affacciare al suo segreto, ma è entrata anche nel nostro, in un gioco di specchi dove le ombre notturne si riflettono in speranze aurorali, di rinascite in altre vite o, come solo gli attori sanno fare, di rinascite in altri personaggi. E si spera o ci si illude, da estranei, di avere in piccolissima parte, col semplice ascolto, contribuito a un coraggioso, arduo e ardito, percorso autoterapeutico.
Per chi vuole approfondire, esce in questi giorni The Secret Room di Renato Cuocolo e Roberta Bosetti (le ariette - libri, 10,00 euro), l'autobiografia dello spettacolo del Teatro dell'Iraa, creato nel 2000 e ormai giunto a 1000 repliche.
Le recensioni di ateatro: Faccia di fuoco di Marius Von Mayenburg
Regia di Oskaras Koršunovas
di Stefania Bevilacqua
Il regista lituano Oskaras Koršunovas porta in scena, per la prima volta nei primi mesi del nuovo secolo, la pièce scritta dal drammaturgo Marius Von Mayenburg e con essa le patologie della società contemporanea: il figlio Kurt è un piromane, la sua relazione con la sorella è incestuosa, i figli uccidono i loro genitori poiché, più tardi, interferiscono con la loro vita e alla fine il protagonista mette a fuoco la casa e se stesso.
Koršunovas mostra la mancanza di valori di una certa classe sociale, evita una dichiarazione morale, rivela come all’interno di una famiglia “normale”, quando la Verità emerge, si metta in atto la tragedia.
Il disagio fisico e mentale dei personaggi è mostrato fin dall’inizio: essi osservano gli spettatori che stanno arrivando con odio a mala pena represso.
Si crea un elemento innovativo per lo spettatore: non si tratta più di subire l’effetto catartico o restare immobilizzato e impassibile dinanzi ad una notizia appresa dal telegiornale, c’è un vero coinvolgimento psichico, un’autoanalisi in tempo reale perché la tragedia è lì, si sta svolgendo e lo spettatore ne prevede l’inevitabile conclusione.
Lo spazio scenico è una vista generalizzante di oggetti tipici della cultura domestica occidentale: tra essi un deposito degli articoli infiammabili, tra pareti incolori e insignificanti.
Non c’è spazio per l’intimità qui: i personaggi osservano gli altri permanentemente. Assistiamo all’”atomizzazione” della famiglia che nasce appunto dalla mancanza di qualunque tipo di valore.
I personaggi si parlano difficilmente, i genitori sono estranei ai figli. Il regista ci indica come in superficie tutto sembra che scorra, in realtà, al suo interno, ognuno vive tenendo per sé la consapevolezza dei propri drammi, così intimi e allo stesso tempo così mostruosi.
Kurt, il figlio, precipita nel vortice più degli altri componenti, il suo pensiero si stacca sempre più dalla realtà e al vuoto sopraggiunge l’uscita da sé uccidendo i genitori e distruggendo completamente se stesso.

Kurt e la sorella Olga.

La madre e il padre.
© Foto di Dmitrij Matvejev.
Il nuovo cda del Piccolo Teatro da Rosa a Risè
Gli enti locali lavorano alle nomine
di redazioni ateatro
Dopo la tornata elettorale, si rinnova il consiglio d’amministrazione del Piccolo Teatro, ormai scaduto.
Il Comune, rimasto al centrodestra, ha confermato l’avvocato Giuseppe Nanni (in quota AN) e sostituito Roberto Ruozi con Claudio Risè, psicoanalista junghiano e professore di Sociologia dei processi culturali e delle comunicazioni all'Università dell'Insubria di Varese, che il neosindaco Letizia Moratti ha nominato presidente.
La provincia, che è lo scorso anno passata dal centrodestra al centrosinistra, ha sostituito Rosa Giannetta Alberoni con Andrea Margheri, docente di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche presso l’Università di Trento.
Ancora in discussione i rappresentanti della Regione (che nelle ultime elezioni, lo scorso anno, è rimasta al centrodestra del governatore Formigoni): in quella che i giornali definiscono "area CL" Luca Doninelli, scrittore, giornalista e drammaturgo, dovrebbe prendere il posto di Emanuele Banterle (e dunque invertendo la staffetta della Commissione Prosa).
Rappresentante del Ministero (passato di recente da Buttiglione a Rutelli) resta l'editore l'editore Federica Olivares.
Nell'insieme si tratta di una sostanziale continuità con il precedente CDA, con gli abituali meccanismi lottizzatori che determinano le nomine.
Hystrio 3 - 2006
Il sommario e i vincitori del Premio
di Hystrio
2 Premio Hystrio
Speciale Premio Hystrio alla Vocazione
di Hystrio
La vocazione? Una partita tutta da giocare
di Roberto Rizzente
Premi Hystrio 2006: le motivazioni
di Hystrio
Le motivazioni dei vincitorti dei 6 Premi Hystrio 2006: Patrizia Milani (Premio Hystrio all’interpretazione), César Brie (Premio Hystrio alla regia), Vittorio Franceschi (Premio Hystrio alla drammaturgia), Festival delle Colline Torinesi (Premio Hystrio Altre Muse), Teatro della Cooperativa (Premio Hystrio-Provincia di Milano) e Antonio Albanese (Premio Hystrio-Arlecchino d’oro, in gemellaggio con il festival mantovano “Teatro-Arlecchino d’oro.
I vincitori Premio Hystrio alla Vocazione
di Hystrio
Dopo aver esaminato, il 15,16,17giugno al Teatro Litta di Milano, un gruppo di circa cento giovani attori provenienti dalle scuole di teatro istituzionali sul territorio nazionale, la Giuria del Premio Hystrio alla Vocazione 2006 -Ugo Ronfani (presidente), Marco Bernardi, Fabrizio Caleffi, Claudia Cannella, Arturo Cirillo, Monica Conti, Nanni Garella, Lorenzo Loris, Sergio Maifredi, Lamberto Puggelli, SerenaSinigaglia, Andrea Taddei -è giunta all’unanimità alla seguente decisione: quest ’anno la dotazione del Premio Hystrio è stata suddivisa in tre parti uguali. Si attribuisce quindi ad ALICE ARCURI, FABRIZIO CAREDDU, MASSIMO NICOLINI la somma di 1.000 euro, accompagnata dai più fervidi auguri della Giuria.
10 vetrina
il ritorno del suo teatro
Copiright italiano
di Stefano Casi, Massimo Marino, Valeria Ravera, Giuseppe Schillaci, Laura Bevione, Claudia Cannella
Una conversazione a Milano, un convegno a Bologna e molti spetta-coli rilanciano il genio scomodo di Raul Damonte,in arte Copi, disegnatore, attore, drammaturgo, romanziere surreale arrivato a Parigi dall’Argentina nel 1962 e morto di Aids nel 1987 -Un artista poliedrico dall’umorismo nero, in cerca dei confini più incerti delle nostre identità mutanti
17 memoria
Il Teatro d ’Arte fra Europa e America
Stanislavskij: incompreso di successo
di Fausto Malcovati
Su uno dei maestri del teatro più fraintesi del Novecento è uscito in Francia un volume che fa chiarezza sulle cattive interpretazioni della sua ricerca sul lavoro dell’attore e sui suoi falsi seguaci
20 la questione teatrale
Aumentano gli spettatori, non diminuiscono i problemi
di Ugo Ronfani
Dopo l’euforia delle promesse elettorali, compreso il mirifico obbiettivo dell’un per cento del Pil ai Beni Culturali, la penuria dellerisorse, l’inerzia dei vertici istituzionali, il vizio del consociativismo che s’accontenta dell’assistenzialismo e la povertà dei progetti di riforma inducono a non sperare in una soluzione nel breve periodo della crisi del teatro
22 teatromondo
Parigi
Le illusioni teatrali di Olivier Py
di Filippo Bruschi
Il Théâtre du Rond-Point sugli Champs-Élysées ha dedicato una personale a Olivier Py, drammaturgo, regista, attore e molto altro -In scena cinque diversi spettacoli, una serata di cabaret e una conversazione sul futuro del teatro popolare
Irlanda/Inghilterra
Endgame, di Samuel Beckett. Regia di Charles Sturridge. Beckett Centenary Festival 2006
di Laura Bevione
I diciannove plays di Beckett proposti in contemporanea al Gate Theatre di Dublino e al Barbican di Londra
Parma/Milano
Marthaler tra Viviani e Monteverdi
di Claudia Cannella
Die zehn gebote (I dieci comandamenti),di Raffaele Viviani. Drammaturgia di Andrea Koschwitz. Adattamento e regia di Christoph Marthaler.
Pechino
Pura acrobazia made in China
di Anna Ceravolo
Il teatro cinese sta emergendo sulla scia della crescita economica nazionale -Ma quanto rischia di contaminarsi per far piacere a noi?
New York
Viaggio nella macchina del tempo
di Alessandra Nicifero
Da trent’anni Richard Foreman,uno dei padri dell’avanguardia teatrale americana, ripete ogni stagione il rito del suo Ontological Hysteric Theatre -Nella sala dell’East Village un pubblico affezionatoe composito viene chiamato a performance che si interrogano sulla percezione delle molte realtà possibili
Steppenwolf Theatre Company
Terremoti emotivi
di Maja Promotarova
30 dossier
Teatro leggero
a cura di Camaldo Albarosa, Roberta Arcelloni
Nelle ultime stagioni si è allargata a dismisura l’offerta di spettacoli comici e brillanti. Dall’one man (woman)show alla commedia musicale alla Garinei e Giovannini, dal musical d’importazione americana alla classica commedia leggera, il teatro diventa sempre più il luogo dello spettacolo inteso come puro passatempo e intrattenimento. Dove talvolta si solleticano i peggiori gusti televisivi degli spettatori.
l ’invasione dei cartelloni
Stasera evado a teatro
di Domenico Rigotti
teatro vittima della tv?
Non creiamoci comodi alibi
di Ugo Ronfani
mercato del teatro commerciale
Diamo i numeri
di Giovanna Crisafulli
soubrette e comici
Le perdute follie del varietà
di Vito Molinari
L’avanspettacolo, nato dopo la primaguerra mondiale dalla contaminazione tra café-chantant e operetta, a metà degli anni Trenta conta già centocinquanta compagnie che si esibiscono nei teatri di tutta Italia. Molti grandi attori hanno cominciato così: da Totò alla Magnani, da Rascel a Walter Chiari a Tognazzi. Il successo continua fino a metà degli anni Cinquanta con i lussuosi spettacoli di rivista, poi il boom economico e la televisione segnano la sua fine. E oggi dove lo si ritrova?
Maurizio Micheli
La battaglia quotidiana del comico
di Camaldo Albarosa
Intervista ad uno dei protagonisti del teatro leggero
Aldo,Giovanni e Giacomo
Talenti in orbita
di Camaldo Albarosa
Anplagghed, di Aldo, Giovanni, Giacomo. Prod. Paolo Guerra per A.gi.di., Bologna.
voglia di divertimento
Non ci restache ridere
di Giuseppe Liotta
È crollato il muro scenico fra teatro serioe teatro leggero e la tendenza a mischiare generi teatrali diversi sembra essere andata tutta a favore della commedia, a discapito dei testi “classici ” del repertorio brillante che in scena si dimostrano fragili e ormai vecchi
Fiorello:l ’attore come lo voleva Grotowski
di Camaldo Albarosa
Intervista al regista Giampiero Solari
Garinei padre del musical italiano
C ’è un amicoin meno
di Domenico Rigotti
Nato nel 1919 aveva inventato e lanciato insieme a Sandro Giovannini e a Giorgio Kramer la commedia musicale italiana che a partire da Attanasio cavallo vanesio con Renato Rascel, seguita poco dopo da Giove in doppiopetto con Dapporto e una sconosciuta Delia Scala, conoscerà un’infilata contiua di successi -Con lui scompare un teatro di forte richiamo popolare che divertiva senza mai essere volgare
In teatro tutto si ricrea
di Camaldo Albarosa
Intervista a Enrico Montesano
trionfo della volgarità
Sogni in ballo
di Alvise Sapori
Si giustificano certe scelte di ispirazione televisiva con i desideri di bassa lega del pubblico -Eppure quando viene prodotto uno spettacolo di qualità il successo arriva immancabile
Oggi i giovani sono preparati
di Camaldo Albarosa
Intervista a Lorella Cuccarini
musical
to sing?meglio cantare
di Sandro Avanzo
Con l’arrivo dei primi musical in Italia, si sono subito manifestate due scuole diverse: una optava per una aderenza alla versione originale e l’altra sosteneva l’adattamento italiano -Ad avere la meglio fra il pubblico è stata quest’ultima, dando il via alla produzione di commedie musicali nostrane
l ’evoluzione dagli anni ‘80 a oggi
Zelig: riso industriale
di Anna Ceravolo
Comici in batteria, carriere standardizzate, iter professionali intercambiabili: insomma non c ’è da stare allegri
La mia vitalità la sfogo nel musical
di Camaldo Albarosa
Intervista a Loretta Goggi
incontro con Johnny Dorelli
Un ragazzoirresistibile
di Camaldo Albarosa
Dall’esordio come cantante nel 1955 alla recente messa in scena del celebre testo di Neil Simon, cinquant ’anni da protagonista della scena d ’intrattenimento in Italia
Londra
Week end low cost con musical all inclusive
di Delia Giubeli
Il mercato di questo genere teatrale che è un’icona della città inglese siè ormai stabilizzato -Male ultime produzioni di successo guardano tutte al cinema americano
Parigi
Qui si ride sul serio
di Giuseppe Montemagno
Sorprende la qualità di alcune commedie leggere capaci di mettere alla berlina, con intelligenza, turbamenti e piccole manie ma anche vere e proprie crisi esistenziali legate alla nostra vita di tutti i giorni
60 drammaturgia
Il barocco degradatodi una scrittura mutante
di Stefania Maraucci
C o n s i d e r a t o , conSantanelli e Ruccello alla fine degli anni ’70, uno dei nomi di punta della “nuova drammaturgia napoletana ”, Enzo Moscato si è sempre distinto per tematiche e linguaggio -Malattia, follia, morte, personaggi portatori di corruzione e di devianza popolano le sue pièce, composte in un dialetto profondamente contaminato e frantumato, capace di superare, attraverso la “carne ” dell ’attore, l ’angustia della pagina scritta
64 nati ieri
i protagonisti della giovane scena/26
Scacco matto a Beckett
di Patrizia Bologna
L’incontro al Dams di Bologna, la fondazione della compagnia nel 1995, le tournée internazionali e la recente rivelazione “in patria ” con un Finale di partita per pupazzi e attori -Teatrino Giullare, nella sua sede sulle colline di Sasso Marconi, fabbrica artigianalmente spettacoli popolati di attori artificiali di grande potenza evocativa -Dopo Euripide, Aristofane, la Commedia dell’Arte e Beckett, affronteranno Bernhard e Koltès
67 humour
foyer
Siamo uomini o Moggi?
di Fabrizio Caleffi
68 critiche
Le recensioni della seconda parte delle stagioni teatrali
Doppio Bernhard a Milano -De Capitani affronta Müller -Adulteri pinteriani per Lievi -I Giganti dei Marcido -La Locandiera secondo Cobelli -Il ritornodi Rossi-Kowalski -Celestini al call center -Lavia nel sottosuolo diDostoevskij -La Comencini tra madri e figlie -Drammaturgia del Sud aCastrovillari -Siracusa:Gas e Castri alla guerra di Troia
la recensione in versi
L'urlo di Delbono
di Ugo Ronfani
94 danza
Xing a Bologna
Paesaggio con figure(in movimento)
di Andrea Nanni
Tre compagnie, provenienti da Gran Bretagna, Svizzera e Francia, propongono una nuova figuralità in bilico tra serialità ed eccezionaità, incandescenza e apatia, continuità e interruzione per decifrare l ’enigma del presente
Red e Adda Danza
I soliti noti dal profondo nord
di Domenico Rigotti
A Reggio Emilia trionfa il Cullberg Ballet con As if e Alluminium, mentre alla rassegna lombarda, accanto ai nomi “di casa ” ( Simona Buccie Antonino &Kaiser), spiccano le eclettiche coreografie dell’afroamericano Alonzo King
Milano/Uovo
Un respiro,regia e coreografia di Virgilio Sieni. Prod.Fondazione Teatro A.Ponchielli,CRE- MONA -Compagnia Virgilio Sieni, Firenze
di Domenico Rigotti
99 teatroragazzi
Streghe,segreti e Cappuccetto rosso senza papà
di Nicola Viesti
100 biblioteca
Le novità editoriali
a cura di Camaldo Albarosa
102 testi
L'uomo che mangiava i coriandoli di Vittorio Franceschi
Premio Hystrio alla drammaturgia 2006
116 la società teatrale
notiziario
I festival dell'estate e tutta l'attualità nel mondo teatrale
a cura di Roberto Rizzente
Da Cividale del Friuli a Taormina, viaggio nell ’Italia delle rassegne estive: la hit parade di Hystrio
in copertina
illustrazione di Giovanni Da Re
hanno collaborato
Marco Andreoli,Nicola Arrigoni,goni,Sandro Avanzo,Giovanni Ballerini,Laura Bevione,Patrizia Bologna,Filippo Bruschi,Simona Buonomano,Fabrizio Caleffi,Giulia Calli- garo,Stefano Casi,Anna Ceravolo,Giovanna Crisafulli,Lorenzo Donati,Loredana Faraci, Gastone Geron,Gigi Giacobbe,Delia Giubeli,Silvia Guidi,Giuseppe Liotta,Fausto Malcovati,Stefania Maraucci,Antonella Melilli, Vito Molinari,Giuseppe Montemagno,Andrea Nanni,Nico Nanni,Alessandra Nicifero, Pier Giorgio Nosari,Gianni Poli,Maja Promotarova,Valeria Ravera,Domenico Rigotti, Laura Santini,Alvise Sapori,Enrico Saravalle,Giuseppe Schillaci,Barbara Sinicco, Francesco Tei, Nicola Viesti,Giusi Zippo.
Cascina: bando per residenze di nuovo teatro
La Città del Teatro lancia Contact
di Città del Teatro
In Italia vi sono molte esperienze di nuovo teatro, esperienze variegate, talvolta “nascoste” che hanno grandi difficoltà a rintracciare spazi concreti di studio, indispensabili per la ricerca e la visibilità artistica.
La città del teatro propone un Bando per residenze rivolto a giovani formazioni teatrali e/o di arti performative in generale, nel quale il nuovo teatro possa germinare, confrontarsi e svilupparsi.
I gruppi e gli artisti interessati dovranno farne richiesta scritta alla Città del Teatro in conformità alle seguenti indicazioni :
• Dati anagrafici, indirizzo e telefono.
• Natura giuridica : gruppo – associazione – cooperativa – singolo ecc.
• Motivazioni generali per le quali si partecipa al bando.
• Indicazioni generali sulla propria linea di ricerca artistica.
• Indicazioni riferite a eventuale specifico progetto artistico - produttivo per il quale si concorre alla residenza
• Altre motivazioni.
Le richieste dovranno essere inviate a Centro Studi – Bando Contact - LaCittàdelTeatro via Tosco Romagnola 656 – 56021 Cascina (Pisa),in busta chiusa entro e non oltre il 31 ottobre 2006.
La selezione avverrà entro il 31 novembre 2006 a seguito della quale:
LaCittàdelTeatro trasmetterà comunicazione dei soggetti ritenuti conformi, mettendo a disposizione una struttura teatrale o altre forme di sostegno valutate opportune, per un periodo di residenza da concordare con ogni singolo soggetto in funzione di peculiari caratteristiche progettuali.
I soggetti selezionati avranno come unico vincolo quello di mettere a disposizione della città del teatro la documentazione del lavoro svolto e la presentazione in esclusiva della performance scaturita dalla residenza che potrà essere eventualmente inserita nei programmi del teatro o in qualunque altro contenitore - proposta ritenuto opportuno.
via toscoromagnola 656 - 56021 cascina (pisa)
Tel 050 744400 fax 050 744233
centrostudi@lacittadelteatro.it
www.lacittadelteatro.it
Altofragile: un percorso formativo con i Motus
Per la realizzazione di un lungometraggio
di Motus
Altofragile è un percorso formativo, teorico e pratico, centrato sulla realizzazione di un lungometraggio: dallo sviluppo del soggetto, al lavoro sui dialoghi e la costruzione dei personaggi, al confronto con il set e la recitazione cinematografica.
Sono sempre più frequenti in teatro gli spettacoli che prevedono l'utilizzo del mezzo cinematografico e video, così come nel campo delle arti visive e della musica: ci pare fondamentale, nel 2006, pensare a una nuova figura di performer contemporaneo che abbia padronanza dei mezzi espressivi classici del teatro, ma che sappia anche confrontarsi con una telecamera, le luci, i microfoni e la confusione di un set cinematografico. Un attore preparato alla versatilità e allo spirito di iniziativa, affinché possa essere parte attiva dei progetti che lo vedono coinvolto e capace anche di iniziative autonome nel campo della performance.
Il lungometraggio nascerà dall'intreccio di sei differenti storie con giovani protagonisti, al cui sviluppo e realizzazione gli allievi lavoreranno suddivisi in gruppi.
Gli allievi saranno impegnati in tutte le fasi del percorso insieme agli attori e ai registi della compagnia: si tratta di un aspetto fondante del progetto, rivolto a coniugare incessantemente il lavoro teorico con quello pratico, per giungere a un risultato tangibile e presentabile a un ampio pubblico, cui tutti hanno collaborato rivestendo di volta in volta differenti ruoli. Altofragile vuole formare un attore “consapevole” pronto ad affrontare le richieste sempre più complesse e articolate del mercato, anche capace di inaugurare e curare, in tutti gli aspetti, autonomi progetti artistici nel campo del teatro, del cinema e delle arti visive.
Per maggiori informazioni e per presentare la domanda di ammissione al corso, consultare il bando di Altofragile.
www.motusonline.com
www.emiliaromagnateatro.com
Premio "Dante Cappelletti" per le arti sceniche
Il bando
di Tuttoteatro.com
terza edizione
Bando di concorso
L’Associazione culturale Tuttoteatro.com ha istituito nel 2004 il Premio alle arti sceniche intitolato “Dante Cappelletti”. La terza edizione del Premio si svolge nel 2006, con la direzione di Mariateresa Surianello.
Dedicata a Dante Cappelletti (studioso, critico teatrale e docente universitario, scomparso tragicamente nel 1996), l’iniziativa vuole ricordare l’uomo e la sua alta lezione di vita e di scienza, che ha saputo trasmettere alle nuove generazioni. In questo solco, tracciato e prematuramente interrotto, Tuttoteatro.com si impegna a promuovere, diffondere, valorizzare e sostenere lo spettacolo dal vivo e le arti sceniche nella loro complessità, nonché la ricerca e la sperimentazione dei linguaggi, attraverso la produzione di nuove opere. Senza limitazioni di genere, forma e linguaggi.
La giuria del Premio selezionerà progetti di spettacoli presentati da singoli artisti o da gruppi, i quali saranno liberi di sviluppare i propri percorsi creativi, seguendo ciascuno le soggettive necessità espressive. Non si farà distinzione tra categorie di artisti (attori, cantanti, danzatori, musicisti, artisti visivi), né si metteranno steccati tra discipline (danza, musica, parola, arti visive). Questa interdisciplinarità non dovrà necessariamente riscontrarsi nei progetti, che potranno privilegiare anche un solo linguaggio.
A dieci anni dalla morte di Dante Cappelletti, con la sua terza edizione il Premio cercherà nuovamente di raccogliere quanto si agita e rende viva la scena contemporanea.
1. L’Associazione culturale Tuttoteatro.com bandisce per il 2006 la terza edizione del Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche intitolato “Dante Cappelletti”.
2. Al concorso possono partecipare cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari senza limiti di età.
3. Al concorso possono partecipare singoli artisti o gruppi.
4. Ai candidati è lasciata piena libertà di genere, forma e linguaggio.
5. Ai candidati è richiesta la presentazione di un progetto di spettacolo in forma scritta (massimo dieci cartelle), corredato da eventuale materiale fotografico, in otto copie. Tale progetto deve essere fornito anche su supporto informatico (floppy, cd, dvd).
6. I progetti presentati devono essere inediti e comunque mai allestiti in forma di spettacolo.
7. Qualora il progetto avesse come scopo l’allestimento di un testo drammaturgico inedito, è richiesta la presentazione del copione integrale (cartaceo e digitale).
8. I candidati devono compilare e firmare la scheda di partecipazione allegata con l’impegno ad accettare il presente regolamento in ogni sua parte.
9. I candidati devono versare la quota di iscrizione di euro 18,00 sul conto corrente postale n. 50820562 intestato a Tuttoteatro.com Associazione Culturale e allegare al progetto il bollettino di avvenuto pagamento.
10. I progetti devono essere inviati entro e non oltre il 14 ottobre 2006, farà fede il timbro postale, a Tuttoteatro.com Associazione Culturale C.P. 301 - 00187 Roma San Silvestro.
11. Tra tutti i progetti di spettacolo presentati la giuria ne selezionerà un massimo di dodici, che dovranno essere presentati in forma di studio scenico (durata massima 15 minuti), nel corso della fase semifinale in programma al Teatro Valle di Roma, il 21 e il 22 novembre. Tra i lavori semifinalisti, la giuria sceglierà cinque finalisti che saranno allestiti in forma di studio scenico (durata massima 20 minuti) al Teatro Valle di Roma il 17 dicembre.
12. Tra i cinque finalisti la giuria sceglierà l’opera vincitrice, alla quale andrà un premio di 6.000,00 euro quale contributo alla produzione. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 17 dicembre 2006, al Teatro Valle di Roma.
13. All’opera vincitrice è fatto obbligo di citare in tutti i materiali promozionali, nulla escluso, e in ogni futura rappresentazione il riconoscimento ottenuto: «Vincitrice del Premio Tuttoteatro.com “Dante Cappelletti”».
14. La giuria ha inoltre la facoltà di segnalare altre due opere tra le cinque finaliste. A queste due opere è fatto obbligo di citare in tutti i materiali promozionali, nulla escluso, e in ogni futura rappresentazione il riconoscimento ottenuto: «Segnalato al Premio Tuttoteatro.com “Dante Cappelletti”.
15. Qualora le opere finaliste, ad esclusivo giudizio della giuria, risultassero di particolare valore l’Associazione Tuttoteatro.com promuoverà la loro circuitazione sul territorio nazionale e internazionale.
La giuria della terza edizione, presieduta da Vincenzo Maria Vita, Assessore alle Politiche Culturali della Provincia di Roma, è composta da Roberto Canziani, Gianfranco Capitta, Massimo Marino, Renato Nicolini, Laura Novelli, Aggeo Savioli, Mariateresa Surianello.
La mente da sola: un mosaico di lettere per giovani attori
Il saggio finale del Scuola di perfezionamento per attori del Centro Teatrale Santacristina diretto da Luca Ronconi e Roberta Carlotto
di Centro Teatrale Santa Cristina
LA MENTE DA SOLA
Mosaico di lettere
a cura di Luca Ronconi
23 settembre 2006 – ore 19.30
Teatro Morlacchi, Perugia
Si conclude la Scuola di perfezionamento per attori del Centro Teatrale Santacristina diretto da Luca Ronconi e Roberta Carlotto con la presentazione del saggio, La mente da sola. Mosaico di lettere il 23 settembre al Teatro Morlacchi di Perugia nell’ambito del programma di celebrazioni per l’Ottantesimo anniversario della fondazione dell’Università per Stranieri di Perugia. Il saggio, a cura di Luca Ronconi, vede coinvolti i 33 allievi, che per oltre un mese hanno partecipato al corso, su una selezione di lettere scelte da Emanuele Trevi tra gli epistolari di celebri artisti. Si tratta di alcuni fra i più grandi scrittori della modernità: poeti come Emily Dickinson e Keats si alternano a grandi narratori contemporanei come John Fante e Charles Bukowski… Ma con loro ci sono anche Mozart, Vita Sackville-West, Kafka, Pasternak, Marina Cvetaeva, Katherine Mansfield, Georg Trackl e l’epistolario tra Artaud e Rivière.
Dice Ronconi: “Non è una novità fare epistolari a teatro, però quando si fanno succede sempre che l'attore finisce con l'identificarsi con l'autore della lettera. Qui invece la lettera può essere vista da due parti: chi la scrive e chi la riceve, le due attività sono completamente diverse. La lettera può essere scritta e letta. A noi interessano tutti e due gli aspetti. Simultaneamente. A intermittenza. Dialetticamente”.
Accostando alle splendide lettere della poetessa americana Emily Dickinson autori diversi per epoca, carattere, stile, La mente da sola offre quindi agli attori una vasta gamma di toni, situazioni psicologiche, stili d’espressione. Dal “corpo centrale” dell’epistolario della Dickinson, la cui selezione è scandita in due parti, si staccano altre voci, ora tristi ora allegre, ora maschili ora femminili, sincere e bugiarde, amiche e innamorate. Non esiste fra di esse un legame tematico e la loro successione non segue un preciso filo narrativo, ma è tutta giocata sulle assonanze, le divergenze, le possibili simmetrie che gli attori e il pubblico intenderanno cogliervi.
La Scuola di Perfezionamento per Attori del Centro Teatrale Santacristina compie quest’anno il suo terzo anno di vita.
Come nelle precedenti edizioni, molte sono state le domande di partecipazione pervenute, oltre 350, segno questo del grande interesse verso la didattica della scuola. I 25 allievi attori scelti, insieme a 2 registi e a 8 attori professionisti in qualità di uditori, hanno frequentato il corso, che si è svolto dal 17 luglio al 30 agosto nella sede della Scuola a Santa Cristina, nei pressi di Morleschio, nel comune di Gubbio.
Il Corso, della durata complessiva di 350 ore, è impostato secondo un modello di college che prevede un lavoro a tempo pieno nella sede attrezzata per le esigenze della scuola, con alloggi, due ampie sale prove, una biblioteca e altri spazi di studio.
Qui allievi e insegnanti, lavorando in maniera intensiva ma anche trascorrendo insieme i diversi momenti della giornata, hanno dato vita a una sorta di “comunità teatrale”. Accanto a Luca Ronconi hanno lavorato in questa edizione diversi docenti tra cui gli studiosi Pietro Boitani, Giuseppe Aurelio Privitera, Nadia Fusini, Barbara Lanati, Serena Vitale, Emanuele Trevi, il regista Mario Martone e l’attrice Mariangela Melato.
La scelta dei materiali intorno ai quali si è svolto il programma del corso si è orientata anche su un terreno drammaturgico. Così, oltre alle esercitazioni sull’epistolario, si sono succedute quelle sul Gabbiano di Anton Cechov, Itaca di Botho Strauss, e con Massimo De Francovich sugli atti unici di Italo Svevo.
L’edizione 2006 della Scuola che si conclude con il saggio La mente da sola. Mosaico di lettere nasce grazie alla collaborazione dell’Università per Stranieri di Perugia e con il sostegno della Regione Umbria, Provincia e Comune di Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e Teatro Stabile dell’Umbria, e con la sponsorizzazione del Gioco del Lotto – Lottomatica.
Teatro Morlacchi
Piazza Francesco Morlacchi, 19
Perugia
La mente da sola.
Mosaico di lettere.
a cura di Luca Ronconi
lettere di
Emily Dickinson, Franz Kafka, Wolfgang Amadeus Mozart,
John Keats, Katherine Mansfield, Antonin Artaud, Vita Sackville-West,
Georg Trackl, Dylan Thomas, Charles Bukowski, Marina Cvetaeva,
Susette Gontard, Boris Pasternak, John Fante
selezione a cura di Emanuele Trevi
gli attori in scena
Lorenzo Bartoli, Tommaso Cardarelli, Elena Cepollaro, Fortunato Cerlino,
Francesca Ciocchetti, Claudia Coli, Anna Della Rosa, Giovanna Di Rauso,
Ilaria Falini, Elisabetta Ferrari, Riccardo Festa, Ilaria Genatiempo,
Vincenzo Giordano, Mariangela Granelli, Tatiana Lepore, Alessandro Loi, Michele Maccagno, Leonardo Maddalena, Vinicio Marchioni,
Silvia Masotti, Cristiano Nocera, Alberto Onofrietti, Pilar Pérez Aspa,
Irene Petris, Lorenzo Piccolo, Matteo Romoli,
Benedetto Sicca, Giovanni Vaccaro, Marco Vergani,
Greta Zamparini, Giulia Zeetti, Camilla Zorzi
e con Fabrizio Arcuri e Roberto Latini
i collaboratori
Carmelo Rifici, Maria Consagra, Antonio Bertusi, Alessio Maria Romano,
Claudia Di Giacomo – PAV, Flaminia Caroli
La mente da sola
Mosaico di lettere
Prima parte
Emily Dickinson a Samuel Bowles – 1858 Francesca Ciocchetti
Emily Dickinson a Martha Dickinson – 1882 Pilar Pérez Aspa
Emily Dickinson a Louise Norcross – 1872 Irene Petris
Franz Kafka Lettera a Milena – 1920/1922 Vincenzo Giordano
Emily Dickinson a Thomas W. Higginson –1885 Pilar Pérez Aspa
Wolfgang Amadeus Mozart Lettere alla cugina – 1778 Tommaso Cardarelli
Wolfgang Amadeus Mozart Lettere alla cugina – 1777 Marco Vergani
John Keats a Fanny Brawn – 1820 Matteo Romoli
Katherine Mansfield a John Middleton Murry – 1915 Mariangela Granelli
Emily Dickinson a Thomas W. Higginson – 1862 Claudia Coli
Emily Dickinson a Thomas W. Higginson – 1862 Greta Zamparini
Emily Dickinson a Thomas W. Higginson – 1862 Elisabetta Ferrari
Emily Dickinson a Thomas W. Higginson – 1862 Anna della Rosa
Carteggio Artaud - Rivière
Jacques Rivière a Antonin Artaud – 1923, 1924 Michele Maccagno,
Antonin Artaud a Jacques Rivière – 1923, 1924 Vinicio Marchioni,
Benedetto Sicca, Fortunato Cerlino
Emily Dickinson a Thomas W. Higginson – 1869 Francesca Ciocchetti
Seconda parte
Emily Dickinson a Elizabeth Holland – 1866 Elisabetta Ferrari
Emily Dickinson a Elizabeth Holland – 1870 Claudia Coli
Emily Dickinson al Dottore e alla Signora Holland – 1858 Anna Della Rosa
Georg Trackl a Hermine Von Rauterberg – 1908 Irene Petris
Vita Sackville-West a Virginia Woolf – Cartolina illustrata – 1926 Elena Cepollaro
Vita Sackville-West a Virginia Woolf – 29 gennaio – 1926 Elena Cepollaro
Dylan Thomas Lettera d’amore a Caitlin – 1950 Lorenzo Piccolo, Leonardo Maddalena
Charles Bukowski ad Ann Barman – 1963 Cristiano Nocera
Emily Dickinson a Otis P. Lord – 1878 Giulia Zeetti
Emily Dickinson a Otis P. Lord – 1878 Giovanna Di Rauso
Emily Dickinson a Otis P. Lord – 1878 Silvia Masotti
Emily Dickinson a Otis P. Lord – 1878 Ilaria Falini
Marina Cvetaeva a Boris Pasternak – 1929 Camilla Zorzi
Susette Gontard Diotima a Hölderlin - 1798 Ilaria Genatiempo, Tatiana Lepore
Boris Pasternak a Eugenija – 1931 Fortunato Cerlino
Franz Kafka Lettera a Milena Riccardo Festa
Emily Dickinson a Otis P. Lord – 1883 Pilar Perez Aspa
John Fante, Lettera a Stan e Howard – febbraio 1954 Alessandro Loi,
Giovanni Vaccaro,
Alberto Onofrietti,
Lorenzo Bartoli
LA MENTE DA SOLA. UN MOSAICO DI LETTERE
di Emanuele Trevi
Più di una volta, nel corso della sua corrispondenza, la grande poetessa americana Emily Dickinson ha paragonato la scrittura di una lettera all’ «immortalità». Non si tratta infatti, ragiona Emily, di una forma di comunicazione in cui si esprime «la mente da sola, senza compagno corporeo?». Questa circostanza non indica certo un minor potere della lettera rispetto ad altre possibilità di scambio linguistico. Fin da Platone, che dedica il Fedro all’analisi di questo argomento fondamentale, la scrittura è diversa dall’oralità proprio perché è una lingua che si allontana dalla potestà, e dal controllo, di chi la parla. Non c’è più un corpo, una presenza reale a garanzia di ciò che viene detto.
Così, secondo la “platonica” Emily Dickinson funziona lo scambio epistolare, fondando una specie di quarta dimensione, di spazio intermedio tra la presenza fisica e l’assenza assoluta. Ed è proprio un sondaggio delle possibilità drammaturgiche insite in questo spazio intermedio – una “scena” mentale che potrà anche essere intesa come metafora possibile dello spazio teatrale – che questo progetto si propone di compiere, accostando alle splendide lettere della Dickinson autori diversi per epoca, carattere, stile, atteggiamento verso il destinatario. Il ruolo di quest’ultimo non può minimamente essere sottovalutato proprio da chi indaghi sulle potenzialità drammaturgiche degli epistolari. Non solo perché a una lettera segue il più delle volte una riposta, alla quale a sua volta seguirà una nuova lettera, fino a che l’intero carteggio assumerà l’aspetto di un dialogo “differito” nello spazio e nel tempo. A questa prima, e ovvia considerazione, ne va subito aggiunta un’altra, forse ancora più decisiva. La presenza del destinatario è infatti evidente anche nella singola lettera, anche nella lettera che non ha mai avuto una risposta. Come il recipiente dà forma al liquido che vi viene versato, così ogni lettera, in maniera più o meno esplicita a seconda dei casi, è un ritratto del destinatario. Tanto più veridico, paradossalmente, quanto più è arbitrario, dettato da interessi personali, deformato dall’urgenza degli affetti, delle passioni, dei timori. Il più “informe” dei generi di scrittura, il più svincolato (almeno nella modernità) da regole stilistiche e retoriche precise, si rivela insomma capace, nelle mani dei grandi scrittori, di un grado insospettabile di realismo psicologico, senso della realtà, capacità di “fotografare” in immagini credibili il continuo e inarrestabile fluire del tempo e dei sentimenti.
Una ulteriore e affascinante possibilità di spremere il massimo di senso dai testi prescelti è data agli attori dal fatto che, nella loro “esecuzione” della lettera, essi non sono affatto obbligati a identificarsi esclusivamente con chi scrive. Questa è solo una possibilità, visto che la lettera, in quanto evento reale di una comunicazione, viene ricevuta, e il primo a “recitarla” è sempre il suo destinatario. Il ricorso ad una celebre opera figurativa potrà forse aiutare a chiarire ulteriormente questo concetto: si tratta della tela di Vermeer dedicata a un’anonima lettrice, che tiene in mano i fogli di una lettera appena arrivata, creando attorno a sé un’atmosfera, mirabilmente eseguita dal grande pittore, di solitudine e intensa concentrazione. Questo spazio fisico e mentale ha il suo baricentro nello sguardo che la ragazza, quasi volesse penetrarne l’intima essenza, affonda nella scrittura dei fogli che tiene in mano. Allo spettatore non è dato capire se le notizie della lettera siano buone o cattive, e questa accortezza degna di Vermeer arricchisce incredibilmente la pregnanza psicologica della rappresentazione. Non solo gli occhi della giovane donna e le mani che reggono i fogli della lettera sono coinvolti in questa esperienza, perché tutto il suo corpo, immobile e circondato di luce, collabora in qualche modo all’avventura, al silenzioso dramma che si sta svolgendo. Un dramma di cui non sapremo mai nulla, e di cui possiamo immaginare tutto. Senza pensarci, Vermeer ha costruito un vero e proprio spazio scenico, un luogo di continuo scambio e contaminazione tra ciò che appartiene al regno invisibile dei sentimenti e delle emozioni e ciò che è invece visibile, gli spazi e i gesti di un certo momento dell’esistenza.
La scelta di lettere di cui si compone La mente da sola offre agli attori una grande gamma di toni, situazioni psicologiche, stili d’espressione. Dal “corpo centrale” dell’epistolario di Emily Dickinson, si staccano altre voci, ora tristi ora allegre, ora maschili ora femminili, sincere e bugiarde, amiche e innamorate. Si tratta di alcuni fra i più grandi scrittori della modernità, a volte accompagnati (come nel caso di Antonin Artaud) dai loro interlocutori. Poeti come Keats e Rilke si alternano a grandi narratori contemporanei come Charles Bukowski…Una vera e propria “drammaturgia epistolare” è inserita inoltre all’interno del “mosaico”: si tratta del famoso carteggio tra Artaud e il critico Jacques Rivière, che comprende l’autenticità e il valore umano e intellettuale del suo giovane interlocutore, pur rimanendo diffidente sul punto centrale della “follia”. Tra i materiali selezionati, è stata utilizzata anche una lunga lettera di John Fante, datata 1954, che è un vero e proprio “romanzo condensato” in forma epistolare.
La successione dei testi non segue un preciso filo narrativo, ma è tutta giocata sulle assonanze, le divergenze, le possibili simmetrie che gli attori e il pubblico intenderanno cogliervi. Al termine di ognuno di questi piccoli “labirinti epistolari”, sarà sempre un nuovo gruppo di lettere di Emily Dickinson a riannodare e rilanciare il filo del discorso.
I Premi della Critica teatrale 2006
La consegna al Teatro Argentina il 21 settembre
di ANCT
Giovedì 21 settembre alle ore 20.00 al Teatro Argentina di Roma verranno assegnati gli annuali premi promossi dall’Anct, Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, che intendono segnalare gli eventi, le persone, i momenti più significativi che, nel corso della stagione 2005-2006, hanno caratterizzato la vita teatrale nel nostro Paese dal punto di vista spettacolare, ma anche scientifico e organizzativo.
Quest’anno i riconoscimenti sono andati a: La cena de le ceneri di Antonio Latella come spettacolo dell’anno, Elisabetta Pozzi per la sua interpretazione di Ecuba di Euripide, Eros Pagni, splendido interprete di Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller, Luigi Lo Cascio, per il suo doppio impegno nel Silenzio dei comunisti con la regia di Ronconi e La tana da Kafka, di cui ha firmato anche la regia. Premiata per il versante comico anche Paola Cortellesi. Giancarlo Cauteruccio è risultato il miglior regista per il suo Trittico beckettiano messo in scena con Krypton, mentre il Teatrino Giullare è stato premiato per il suo originale Finale di partita con pupazzi e scacchiera. Al regista francese Roger Planchon è stato assegnato il premio per il complesso della sua attività, mentre due sono i riconoscimenti ai progetti: Altri percorsi del Teatro Stabile di Bolzano, stagione dedicata alle nuove tendenze del teatro italiano, e Arrevuoto, laboratorio di Marco Martinelli promosso con il Teatro delle Albe dal Teatro Mercadante di Napoli, che ha visto impegnati in una rielaborazione della Pace di Aristofane i ragazzi del quartiere di Scampia insieme con giovani studenti napoletani. La chiusa di Conor McPherson, spettacolo proposto dallo Stabile di Genova con la regia di Valerio Binasco, si è imposto come miglior novità straniera apparsa sui nostri palcoscenici.
In campo universitario riconoscimenti a Luigi Squarzina e a Paolo Puppa. Premiati anche Il Centro per la fotografia dello spettacolo “Occhi di scena”, Michele Perriera e il light designer Gigi Saccomandi. A Giorgio Albertazzi verrà consegnato il Premio Speciale intitolato alla memoria del grande critico Paolo Emilio Poesio.
Per quanto riguarda il Premio delle Riviste di Teatro, iniziativa inaugurata quest’anno, la Rivista HYSTRIO premierà Il Teatro dell’Argine di San Lazzaro di Savena, mentre INSCENA consegnerà il suo premio all’attrice Elisabetta Valgoi.
Tre stabili per una compagnia
La Fondazione del Teatro Stabile di Torino, il Teatro di Roma e la Fondazione Teatro Due di Parma uniscono le forze
di Ufficio Stampa TeatroStabile Torino
Iniziano, questa settimana, le prove di due dei cinque spettacoli realizzati dalla Compagnia del Teatro Stabile di Torino: Antigone di Sofocle, traduzione di Massimo Cacciari e Gli incostanti di Thomas Middleton e William Rowley, traduzione di Luca Fontana. La direzione dei due allestimenti è di Walter Le Moli e lo spazio scenico è ideato da Tiziano Santi.
Il progetto di creare una base permanente di attori vede coinvolte tre importanti realtà italiane quali la Fondazione del Teatro Stabile di Torino, il Teatro di Roma e la Fondazione Teatro Due di Parma, e rappresenta una prospettiva di lavoro che si colloca nel quadro dell’attuale internazionalizzazione ed europeizzazione del nostro sistema socio-economico e culturale. La strutturazione basata sulla presenza di attori permanenti è ispirata alle modalità europee e alla necessità di uniformarsi, quali Teatri d’Europa, alle modalità dell’Union des Théâtres de l’Europe.
LA STAGIONE
Per la stagione 2006-2007 il nucleo permanente di attori composto da Valentina Bartolo, Fausto Cabra, Enzo Curcurù, Paola De Crescenzo, Alberto Onofrietti, Franca Penone, Francesco Rossini, Elia Schilton, Maria Grazia Solano, Marco Toloni, Nanni Tormen e Lino Guanciale, operante tra Torino, Parma e Roma affronta alcune opere del repertorio classico e moderno: Antigone di Sofocle, nuova traduzione di Massimo Cacciari; debutto: Torino, febbraio 2007; repliche: Parma e Roma. Gli incostanti di Middleton e Rowley, nuova traduzione di Luca Fontana; debutto: Torino, febbraio 2007; repliche: Parma e Roma. Direttore: Walter Le Moli. La folle giornata o Il matrimonio di Figaro di De Beaumarchais, nuova traduzione di Valerio Magrelli; debutto: Parma, marzo 2007; repliche: Roma e Torino; direttore: Claudio Longhi. A voi che mi ascoltate di Lula Anaghnostaki, traduzione Nicola Crocetti; debutto: Torino, maggio 2007; direttore: Victor Arditti. Ifigenia in Aulide di Euripide; debutto: Torino, ottobre 2007; direttore Eli Malka.
I diversi allestimenti - oltre a segnare l’acquisizione di un titolo fino ad ora sconosciuto ai nostri cartelloni -, possono avvalersi di 4 traduzioni originali, realizzate appositamente per le produzioni della Compagnia.
Nel corso dell’anno, attraverso la messa in scena di Antigone, Gli incostanti, Il matrimonio di Figaro, A voi che mi ascoltate e Ifigenia in Aulide, il nucleo permanente di lavoro opera nell’arco di 12 mesi consecutivi. Ciò consentirà un confronto sistematico - nell’ambito di un gruppo omogeneo - con testi, personaggi, modalità creative diverse, grazie anche alla presenza di 4 direttori, italiani e stranieri. È una concreta esemplificazione e dimostrazione della vocazione internazionale e artisticamente e produttivamente aperta del nuovo ensemble: per il periodo settembre 2006/ottobre 2007 il lavoro della Compagnia è affidato a Walter Le Moli, Claudio Longhi, Victor Arditti, Eli Malka a cui si accompagnano differenti team di collaboratori artistici.
Per consentire la realizzazione del programma, la Compagnia adotterà un sistema di lavoro fondato sulla integrazione di prove e recite. L’accordo e la disponibilità di Roma e Parma rappresentano inoltre una ipotesi di superamento delle normali logiche di distribuzione e coproduzione del nostro teatro.
Il progetto, dunque, potrebbe davvero essere il primo passo verso una diversa idea di stabilità, incentrata non più e non solo sulle strutture, ma sull’arte degli attori e delle attrici che il teatro fanno vivere.
ATTORI
Valentina Bartolo
Fausto Cabra
Enzo Curcurù
Paola De Crescenzo
Alberto Onofrietti
Franca Penone
Francesco Rossini
Elia Schilton
Maria Grazia Solano
Marco Toloni
Nanni Tormen
Lino Guanciale
DIRETTORI
Walter Le Moli
Claudio Longhi
Victor Arditti
Eli Malka
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO
FONDAZIONE TEATRO DUE
TEATRO DI ROMA
ANTIGONE
di Sofocle
traduzione Massimo Cacciari
direzione Walter Le Moli
scene Tiziano Santi
Torino, Teatro Astra, febbraio 2007
Parma, Teatro Due, marzo 2007
Roma, Teatro India, aprile 2007
GLI INCOSTANTI
di Thomas Middleton e William Rowley
traduzione Luca Fontana
direzione Walter Le Moli
scene Tiziano Santi
Torino, Teatro Astra, febbraio 2007
Parma, Teatro Due, marzo 2007
Roma, Teatro India, aprile 2007
LA FOLLE GIORNATA O IL MATRIMONIO DI FIGARO
di Pierre-Augustin Caron De Beaumarchais
traduzione Valerio Magrelli
direzione Claudio Longhi
scene Csaba Antal
Parma, Teatro Due, marzo/aprile 2007
Roma, Teatro India, aprile 2007
Torino, maggio 2007
A VOI CHE MI ASCOLTATE
di Lula Anaghnostaki
traduzione Nicola Crocetti
direzione Victor Arditti
scene Tiziano Santi
Torino, maggio 2007
IFIGENIA IN AULIDE
di Euripide
in preparazione
direzione Eli Malka
Torino, ottobre 2007
PRELAZIONE E VENDITA BIGLIETTI:
I biglietti di tutti gli spettacoli realizzati dalla Compagnia del Teatro Stabile di Torino saranno messi in vendita a partire dal mese di gennaio 2007 presso la Biglietteria del TST.
A partire dal 10 ottobre 2006 sarà comunque possibile effettuare la prelazione su tutti gli spettacoli collegandosi al sito internet www.teatrostabiletorino.it
Per ulteriori informazioni telefonare alla Biglietteria del TST tel. 011/5176246.
I vincitori dei Premi Olimpici al Quirinale
Giorgio Napolitano riceve il teatro italiano
di Ufficio Stampa ETI
Il Quirinale apre le porte ai rappresentanti del Teatro italiano, in occasione della quarta edizione dei Premi Olimpici. Mercoledì 20 settembre, alle ore 11, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano riceverà i vincitori e i finalisti del premio Eti – Gli Olimpici del teatro insieme a una delegazione di artisti e professionisti della scena per celebrare la quarta edizione del “Premio Eti - Gli Olimpici del Teatro”, promosso dall'Ente Teatrale Italiano e dal Teatro Stabile del Veneto.
Dopo l’incontro con Carlo Azeglio Ciampi nel 2005, si conferma quest’anno l’attenzione del Quirinale per il Teatro italiano e per i Premi Olimpici. L’udienza premia così gli sforzi degli Olimpici di rappresentare tutte le componenti culturali, geografiche e produttive del Teatro italiano.
All’udienza parteciperanno i vincitori di quest’anno e i finalisti delle quattro edizioni, i membri delle giurie di esperti, i vertici degli enti promotori e dell’Agis, il Presidente della Giuria Gianni Letta e una folta rappresentanza di artisti e professionisti del teatro.
L’udienza al Quirinale segue di alcuni giorni la serata finale del Premio, che si è svolta a Vicenza, sul palcoscenico del teatro Olimpico, venerdì 15 settembre. La serata, come negli anni scorsi, è stata condotta da Tullio Solenghi e trasmessa da Rai Uno (la sera stessa, alle 23.15), ed ha avuto quale ospite d’onore il Ministro per i Beni e le Attività Culturali Francesco Rutelli.
I vincitori di quest’anno sono:
SPETTACOLO DI PROSA
Morte di un commesso viaggiatore regia di Marco Sciaccaluga
MUSICAL O COMMEDIA MUSICALE
The producers regia di Saverio Marconi
SPETTACOLO D'INNOVAZIONE
Altri giorni felici regia di Claudio Remondi e Riccardo Caporossi
ATTORE PROTAGONISTA
Eros Pagni per Morte di un commesso viaggiatore
ATTRICE PROTAGONISTA
Giulia Lazzarini per Giorni felici
ATTORE NON PROTAGONISTA
Ugo Maria Morosi per Morte di un commesso viaggiatore
ATTRICE NON PROTAGONISTA
Sara Bertelà per L’illusione comica
ATTORE/ ATTRICE EMERGENTE
Federica Di Martino per La forma delle cose
INTERPRETE DI MONOLOGO O “ONE MAN SHOW”
Paola Cortellesi per Gli ultimi saranno ultimi
REGISTA
Marco Sciaccaluga per Morte di un commesso viaggiatore
SCENOGRAFO
Emanuele Luzzati per Il ponte di San Luis Rey
COSTUMISTA
Odette Nicoletti per La donna vendicativa
AUTORE DI MUSICHE
Ramberto Ciammarughi per La sagra del signore della nave
AUTORE DI NOVITÀ ITALIANA
Vittorio Franceschi per Il sorriso di Daphne
PREMIO SPECIALE DEL PRESIDENTE DELLA GIURIA GIANNI LETTA A
Rossella Falk
A proposito dei Premi Olimpici, riceviamo e volentieri pubblichiamo.
Gentile redazione,
ho assistito l'altra sera alla xxxesima edizione dei premi olimpici.
premesso che sono contento che di Teatro si parli anche in Tivvù, sono però rimasto (ancora una volta) allibito nel vedere (ancora una volta) le solite facce note. mi sono subito connesso al vostro sito, cercando consolazione in tema: e l'ho trovata in archivio in una corrispondenza tra O.PdP e Giammusso. roba di tre anni fa, mi è parso, ma che sembra tuttavia ancora attuale.
Ancora di più, stavolta, è sembrata essere una edizione che premia se stessa e i propri organizzatori, con un occhio di riguardo alle "famiglie" del teatro, come a fare quadrato in difesa di una categoria (le famiglie) in difficoltà. certo è tipico dell'economia che quando il sistema è in crisi si tenda a escludere la nuova concorrenza per garantire la sopravvivenza dell'esistente, ma è poco elegante, poco liberale. tutti bravi e meritevoli, segnalati e vincitori, ma prodotti da una visione che francamente mostra un po' miopia, un po' conservatrice. unica eccezione, a mio avviso, il meritato premio a Franceschi come (splendido) autore. ma lo stesso autore è autore meritevole da molto tempo, e non vorrei che fosse il segno della solita perversione del sistema: diventa più un riconoscimento alla "resistenza" che un incoraggiamento a "resistere".
dico questo non essendo chiamato in causa sulla vicenda, non avendo cioè "conflitti d'interesse" in materia.
saluti e buon lavoro.
angelo

