
L'editoriale
Un foro di proiettile
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro49.htm#49and1
Dell'Utri direttore culturale del Teatro Lirico
Reazioni & commenti
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro49.htm#49and3
Livorno e la casa del teatro
Progetto per un teatro-studio a Livorno
di Anna Maria Monteverdi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro49.htm#49and4
Per un teatro necessario
Appunti di un fabbricante di maschere
di Ferdinando Falossi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro49.htm#49and5
The Merchant of Venice con la regia di Trevor Nunn
Lo spettacolo del National Theatre dal Cottesloe all'Olivier
di Vera Cantoni
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro49.htm#49and6
Riapre il Teatro Na Dubrovka, torna in scena Nord Ovest
A pochi mesi dalla strage nella sala di Mosca
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro49.htm#49and8
Città in condominio
Progetto di reading
di Out Off
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro49.htm#49and9
Le segnalazioni di tnm
Stelle della sera, exibart, the great war
di Redazione tnm
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro49.htm#49and10
suicide bombers on air. PRIMETIME a Berlino
Il nuovo lavoro di Hans-Werner Kroesinger sui Kamikaze
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro49.htm#49and11
L'editoriale
Un foro di proiettile
di Redazione ateatro
"Sono contento di tornare sul palcoscenico, ma c’è come un retrogusto di ricordi che tornano spontaneamente. Su una delle passerelle sulla scena c’è un foto di proiettile che non abbiamo potuto riparare".
(Andreij Bogdanov, attore ed ex ostaggio del Teatro Na Dubrovka di Mosca)
I venti di guerra soffiano sempre più forte, e crescono le mobilitazioni per la pace e contro un conflitto che sta coinvolgendo sempre di più il nostro paese. Il teatro reagisce come può, e come sa. ateatro cerca da sempre di offrire informazioni e riflessioni su questi temi, e continuerà a farlo con la massima attenzione e la certezza che non saremo all’altezza di questi tempi oscuri.
Nelle news troverete qualche informazione sulle iniziative in corso; alcune notizie sono ovviamente nel forum apposito, altri e aggiornamenti li metterete - speriamo - nei prossimi giorni.
Nel forum sul teatro di guerra si parla anche della politica della cultura teatrale. Sono vicende minime rispetto ai grandi scenari della politica internazionale, ma ci sembra giusto continuare a seguire anche queste trame: un po’ perché questo è da sempre uno degli obiettivi e dei punti di forza di ateatro, un po’ perché inevitabilmente i "grandi giochi" finiscono per riflettersi anche su quelli più piccoli.
La notizia di questi giorni è ovviamente la direzione culturale del Teatro Lirico a Marcello Dell’Utri, eletto senatore di Forza Italia proprio nel collegio di Milano 1 dove si trova il teatro (per la cronaca, Silvio Berlusconi è stato eletto nel collegio di Milano 2). Ma questo nuovo Teatro Lirico strettamente collegato alle sale gestite da Gianmario Longoni (Smeraldo, Ciak, Nazionale) e alle iniziative mecenatesche, culturali e politiche del senatore Dell’Utri (che garantisce sponsor e rapporti con il gruppo Fininvest) è solo un tassello del riassetto complessivo del sistema teatrale milanese. Da un lato il Piccolo Teatro (con le sue tre sale) e una direzione sotto tutela di un cda tutto polista: dunque la principale istituzione del teatro pubblico italiano dove l’opposizione non ha alcun reale potere di controllo. Ma sono anche in corso la ristrutturazione del Teatro Franco Parenti, con la sua multisala, e le lunghe procedure che stanno assegnando il Teatro Puccini ai Teatridithalia (che dopo la chiusura del Teatro di Porta Romana hanno trovato ospitalità alla sala Leonardo da Vinci) e l’ex Cinema Eolo all’Out Off.
Sono evidenti le difficoltà a finanziare costose ristrutturazioni (per il Lirico si parla di un investimento di 15 milioni di euro). Ma è anche interessante immaginare nuovo spazi per lo spettacolo (e non solo). Questo vale sia per istituzioni teatrali già consolidate, sia soprattutto per i nuovi spazi da reinventare, ristrutturare, riaprire.
Infine, una importante novità nel sito. E’ da qualche tempo attiva la locandina di ateatro, dove è possibile segnalare e consigliare gli spettacoli in cartellone; dal database il sito ricava automaticamente gli spettacoli di oggi, ma è possibile fare ricerche per titolo e per città. Ci sembra un tool utile e importante, che può essere migliorato (grazie anche alle vostre indicazioni) e che arricchisce il sito. Ma questo strumento può funzionare solo grazie alla collaborazione dei visitatori del sito, delle compagnie, dei festival e dei loro uffici stampa: per la redazione di ateatro è nella pratica impossibile inserire sistematicamente questi dati, e soprattutto ci sembra più corretto (e più "internet style", vista l’interattività offerta dal mezzo) che siate voi a poter segnalare le iniziative più interessanti (e perché vi interessano e le consigliate...).
Dell'Utri direttore culturale del Teatro Lirico
Reazioni & commenti
di Redazione ateatro
Dai quotidiani del 6 febbraio 2003:
"Abbiamo interpellato l’Avvocatura dello Stato per sapere se potevamo andare avanti, essendo il garante indicato per il progetto culturale una persona in quel momento indagata dalla magistratura. L’avvocatura ci ha risposto che questo non era influente per la valutazione. E abbiamo proseguito". (Severino Salvemini, membro della commissione "tecnica" che ha giudicato i progetti e docente alla Bocconi).
"Più ancora del fatto che Dell’Utri sia imputato in un processo per concorso esterno in associazione mafiosa e che abbia già una condanna alle spalle, è grave il marchio politico che si porta dietro. (...) E’ l’inventore di Forza Italia, così almeno ci viene raccontato dagli agiografi di Berlusconi. (...) So che ha la biblioteca di via Senato, che finanzia spettacoli, per quello che si sa ha la passione per i libri antichi e i soldi per comprarlo. (...) Adesso sta mettendo su una rete di circoli culturali che hanno però finalità e matrice politica. Vuole riorganizzare la destra in termini culturale". (Giovanni Raboni)
"La scelta di Dell’Utri non è stata una scelta del Comune ma del gestore privato che si è aggiudicato l’appalto. Questo non vuol dire che mi dissoci dalla scelta". (Gabriele Albertini, sindaco di Milano)
"Ma proprio la sinistra parla la lottizzazione? Ma guardi in casa propria, a Milano quando ha governato e monopolizzato tutto, ha fatto tabula rasa". (Riccardo De Corato, vicesindaco di Milano)
"Una grottesca infinita ballata, una follia. Perché allora non fare Bossi responsabile della cultura italiana?". (Dario Fo)
"Insomma, questi privati che mettono 20 miliardi per riaprire il Teatro Lirico, avranno il diritto di nominare il direttore che gli pare? Il teatro milanese è dominato dalla sinistra, questa è la prima nomina del centrodestra. E poi Dell’Utri porta in dote la più grande biblioteca di teatro in Italia, quella di Paolo Grassi." (Andrée Ruth Shammah)
"Per l’offerta culturale Milano è ormai una ex capitale europea. Le grandi opere infrastrutturali non bastano, occorrono progetti di eccellenza in campo culturale. E occorrono idee nuove. Che al momento non si vedono. (...) Bisogna incalzare i miei amici Dell’Utri e Rampello, chiedere che cosa intendono fare per risollevare le grandi istituzioni della città. (...) ..il Piccolo: perché gli negate i fondi e lasciate in miseria Ronconi, il più gran de regista italiano? (...) Milano è una città piena di energia, ci sono tantissime persone brave, competenti, ma soffocate nella loro volontà di fare politica non certo dai Dell’Utri o dai Rampello, ma da una certa sinistra ulivista, che snobba energia fresche e giovani per dare il posto di deputato a Tizio o lo scranno di consigliere comunale a Caio. E’ chiaro che alla fine prevale la potenza di fuoco mediatica del Cavaliere." (Massimo Cacciari, da "la Reèubblica", 7 febbraio 2003)
Altre info e aggiornamenti nel forum Fare un teatro di guerra?
Livorno e la casa del teatro
Progetto per un teatro-studio a Livorno
di Anna Maria Monteverdi
Nel 2000 a Livorno l'assessore allo spettacolo Marco Bertini profondo conoscitore e appassionato sia del teatro di lirica che di prosa, dà vita al Progetto La casa del teatro, un progetto di attività teatrali di alta formazione ispirato al lavoro dei grandi maestri del teatro internazionale con sede al Teatro delle Commedie. Nelle intenzioni dell'assessore e di Fernando Mastropasqua, docente di Antropologia teatrale del Dams di Torino, chiamato a esserne coordinatore e curatore, la Casa del teatro sarebbe dovuta diventare la casa di tutti le arti, spazio per la sperimentazione dei linguaggi della scena e luogo aperto alla creatività collettiva. Il coraggioso progetto con cui costruire questo nuovo teatro e dargli un'identità e un carattere proprio si chiama Per un Teatro Studio.
La Casa del teatro è il Teatro delle Commedie, attualmente in corso di ristrutturazione, di ammodernamento e di ampliamento dei locali di sala e degli spazi laboratoriali e sarà inaugurato nella nuova, rinnovata veste nel settembre 2003.
Questi gli intenti programmatici della Casa del teatro definiti da Fernando Mastropasqua: "Un palco non destinato alla rappresentazione di prodotti confezionati secondo criteri commerciali per essere venduti ai circuiti teatrali ma un palco consacrato alla ricostruzione del mito, un teatro-studio, come nella visione di Craig e di Mejerchol’d, o un gioco estremo come fu il teatro di Kantor, colui che forse più di tutti è stato in grado di rivivere il rapporto istituito da Dioniso fra gioco e teatro, tra memoria e rappresentazione. Il teatro-studio della Casa del Teatro vuole essere Scuola da cui nasca il teatro e non scuola di teatro. Questa era l’idea di Mejerchol’d. Il progetto della Casa del Teatro è quello appunto di costituire un luogo di rifondazione del mito, inteso come riappropriazione della propria umanità, attraverso la ricerca di un nuovo teatro. Non è il luogo della esibizione dello spettacolo, né della programmazione teatrale. In questo spazio si devono riunire le forze migliori che lavorano nella direzione dello studio e della ricerca teatrale."
Nel corso dei suoi due anni di attività la Casa del teatro ha realizzato conferenze pomeridiane sulla storia del teatro, sul teatro di ricerca (da Wilson a Ronconi a Remondi e Caporossi) e incontri con i protagonisti della scena internazionale, tra gli altri Judith Malina e Marisa Fabbri, con approfondimenti sul nuovo teatro italiano e sul videoteatro. Le iniziative continuavano poi, nella serata con proiezioni o con eventi di spettacolo. Nell'intervallo tutti i partecipanti, artisti e spettatori, erano, per tradizione, "ospiti del teatro": nel foyer veniva allestita una cena informale per conoscersi in un'ambiente decisamente conviviale (un po' come quello della Cartoucherie di Ariane Mnouchkine). Tra i laboratori ospitati dalla Casa del teatro, quello con Giuliano Vasilicò e con il Living theatre (una presenza molto cara a Livorno, che quest'anno li ospiterà per la terza volta) Il laboratorio del Living di quest'anno, che ha coinvolto 40 studenti provenienti da tutta Italia, aveva come tema centrale la creazione collettiva ed è terminato con la realizzazione di uno spettacolo dal titolo Livorno 5 ottobre 2002, una giornata della vita della città. Judith Malina ci ricorda spesso come la creazione collettiva non sia soltanto una tecnica teatrale ma soprattutto "una questione politica e sociale: dare la spinta alla possibilità creativa di ognuno, lasciare emergere la creatività, la spontaneità". Parole che ci ricordano Julian Beck: "Ognuno è un artista subime e noi che lavoriamo nell'arte dobbiamo liberare questa creatività che è in ciascuno".

Il Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno
La Casa del Teatro 2003
Venerdì 7 febbraio con un incontro su Mito e teatro di Fernando Mastropasqua, Anna Monteverdi e Ferdinando Falossi e con uno spettacolo dei Sacchi di Sabbia, Orfeo è stato inaugurata la nuova stagione de La casa del teatro con un nuovo ciclo di approfondimenti, incontri e spettacoli che coinvolgerà, da febbraio a ottobre, anche i Dipartimenti di Storia delle Arti dell’Università di Pisa, e i Dams di Torino e Bologna. I tre dipartimenti universitari costituiscono una presenza costante e permanente nella stagione 2003 attraverso laboratori nei quali ognuno dei tre enti porterà avanti, autonomamente, il proprio lavoro di ricerca su mito e teatro, scrittura scenica, e drammaturgia dell'attore (a cura di Concetta D'angeli, Marco De Marinis, Roberto Tessari) mentre su un piano più strettamente pratico alcuni artisti (Michele Monetta, Enzo Moscato, Antonio Damasco) proporranno, sempre nei modi di un work in progress, gli esiti della propria ricerca teatrale, in modo da assicurare ai giovani che parteciperanno un coerente processo di acquisizione di forme e di riflessione.
In attesa della riapertura della sua sede storica, La Casa del Teatro si trasferisce per il 2003 al Teatro Goldoni e nei locali di Theatralia.
La Casa del Teatro 2003
SEZIONE TEATRO
a cura di Fernando Mastropasqua
000 Con il patrocinio del Dipartimento di Storia delle Arti, Università di Pisa, DAMS di Torino e del DAMS di Bologna
000
1. LABORATORIO DEL DAMS DI TORINO "MITO E TEATRO"
19, 20 e 21 marzo Borgo Cappuccini 180/A (Theatralia)
Docenti: Roberto Tessari e Antonio Damasco
0000
0000
2. LABORATORIO STORIA DELLE ARTI UNIVERSITÀ DI PISA
"LA SCRITTURA DI SCENA" (7 – 11 aprile Borgo Cappuccini 180/A- Theatralia-)
7, 8 e 9 aprile: Concetta D’Angeli. 10, 11 aprile: Enzo Moscato.
10 aprile ore 21.30 Compleanno spettacolo di Enzo Moscato
3. LABORATORIO DEL DAMS DI BOLOGNA "DRAMMATURGIA DELL'ATTORE"
27 – 31 maggio dalle ore 16.00 alle ore 20.00 Borgo Cappuccini 180/A (Theatralia)
I fase stage teatrale con Marco De Marinis
28 luglio – 3 agosto Borgo Cappuccini 180/A (Theatralia)
dalle ore 9.30 alle ore 15.30
II fase stage teatrale: Open class: Riflessi. Il corpo immaginario a cura di Michele Monetta.
4. GIORNATA CONCLUSIVA
3 ottobre Via Mayer (La Goldonetta)
ore 17.30
Fernando Mastropasqua e Alfonso Cardamone Edipo l’antieroe dei confini
ore 21.30
Xear.org
ovmm Metamorfosi di Ovidio
di e con Marco Sodini, Mauro Lupone, Giacomo Verde, Massimo Magrini.
INFO:
Comune di Livorno Politiche dello spettacolo tel.0586-820572
spettacolo@comune.livorno.it
Per un teatro necessario
Appunti di un fabbricante di maschere
di Ferdinando Falossi
Ferdinando Falossi è storico del teatro e artigiano costruttore di maschere (di legno, di cartapesta, di lino), allievo di Umberto Sartori. Per più di vent'anni ha raccolto e studiato maschere antiche provenienti da tutte le regioni della Grecia, dell'Indonesia e dell'Africa. I risultati dei suoi appassionanti studi sul teatro greco, tragico e comico, tratti da iconografie vascolari (in particolare quelli realtivi al cratere di Pronomos da lui interpretato come "discorso sul teatro"), le ricostruzioni filologiche della maschera greca dell'epoca classica, se si eccettua una pubblicazione edita del Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni popolari di Roma (Morfologia della maschera comica, 1990), sono attualmente inediti ed è una vera perdita per lo studio della storia del teatro intesa (come voleva Ragghianti) come "storia delle immagini".
Da qualche anno Ferdinando Falossi ha messo a disposizione i suoi studi e la sua abilità di artista creatore di maschere al territorio del disagio in alcuni Centri della Toscana, con l'intento di "fare comunità-fare un teatro"; nei suoi laboratori con la cooperativa Crea, i disabili costruiscono con le mani, con le parole, con i disegni, miti e riti, reinventando il mondo, dando così un volto e un'anima (thumòs) al loro bisogno di "stare in cerchio". Diverso e Tutto cominciò con un grande vento sono gli spettacoli basati sull'uso della maschera creati collettivamente da un gruppo di disabili psichici. Ed è in questo territorio della diversità (intesa come diversa abilità o diversa socialità) come Falossi spiega, che il teatro può essere più che terapeutico, "necessario". Falossi ha gentilmente lasciato ad ateatro un suo articolo inedito che porta ad interrogarci -artaudianamente- proprio su questa necessità.
amm

C'è una minuscola strada, lunghissima e dritta, che conduce dall'orizzonte ancestrale, primitivo, in cui fermentarono i primi germogli del teatro, a un territorio misterioso, mai del tutto esplorato, che si situa ai confini della Storia e della Civiltà: quasi una sorta di Giardino delle Esperidi, il luogo mitico e indeterminato in cui i Greci collocavano quelle creature divine ma dissimili dall'uomo che ritenevano nate spontaneamente dalla fecondità iperbolica della Terra, dotate di poteri eccezionali; affascinanti e temibili soprattutto perché diverse. In questa terra di confine, banlieu della civiltà, si trova da sempre il regno della Diversità. Oggi più che mai sarebbe opportuna una ridefinizione di "diverso", un termine pesantemente schiacciato dall'inflazione e dall'abuso, reso talmente sfrangiato nei suoi limiti periferici da poter comprendere tutto e il contrario di tutto. Comunque, dove si intenda "diverso" come rivolto altrove, possiamo realmente vedere una umanità intera attraversare la Storia, mescolata a tutte le maggioranze possibili, ma girata dall'altra parte, come la celebre figura dell'omosessuale degli indiani Lakota che cavalca seduto all'incontrario. La diversità è poi territorio del disagio, e questo, fisico e psichico, sociale che sia, proietta chi ne è portatore in una dimensione dlel'esistenza nella quale la sua presenza non gode delle certezze, delle garanzie, delle sicurezze e delle conferme che sostengono il cosidetto "normale". Lo stare nel mondo del diverso rischia continuamente di annullarsi nell'impossibilità di comunicazione con l'ambiente esterno e alla fine, nel disinteresse per esso. L'isolamente è il denominatore comune che unisce le situazioni più varie, da quelle di tipo patologico ai casi di semplice ma prolungato malessere. La confusione tra il dentro e il fuori di sé scivola nella chiusura della gestualità in atteggiamenti stereotipati e ripetitivi che rispondono ad una capacità di sentire che non raggiunge mai la possibilità di rimandare all'esterno. Si pensi non solo agli atteggiamenti tipici del ritardo mentale, ma anche alla forte ritualizzazione irrelativa del disagio psichico, o più semplicemente alle manifestazioni di autoesculsione e di autolesionismo delle tossicodipendenze, o ancora, la tendenza alla chiusura comunicativa e alla ritualizzazione comportamentale che caratterizza il disagio sociale, sia nel caso del barbone che in quello del gruppo/branco che trova solo in sé e mai fuori di sé la conferma del proprio esserci. In tutti questi casi a mancare non è la capacità di sentire, che spesso è anzi intensificata dalla condizione di isolamento, ma la possibilità di riconoscere come simile il mondo esterno, e quindi di trovare canali di comunicazione accettati e prenderne possesso. Il mondo esterno è estraneo, è dato, è costituito, mentre la propria presenza in esso è incerta, priva di conferme, latente. L'io stesso è in fieri, debole, labile, difeso dalla stratificazione della propria crisi comunicativa.
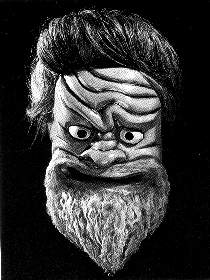
E' a questo punto che una simile condizione dell'esistenza disagiata avvicina la sua orbita a quella del mondo primitivo dal quale il teatro trae la sua propria origine. Il punto di contatto è un Io percepito come labile, incapace di dominare il mondo che lo circonda; un Io che ha bisogno per affermarsi dell'istituzione di un'impalcatura magica che gli consenta di influire su sé e su ciò che è altro da sé, per non soccombere di fronte ad eventi che sfuggono al suo controllo. Occorre duque un atto creativo che possa plasmare e rimodellare un Io debole e un mondo ostile, costringendo entrambi a comunicare tra loro, in breve, a corrispondere. La necessità che tutto corrisponda porta così a ripercorrere eventi turbolenti condizionando il loro svolgimento, ovvero a imitare la vita mentendo. Per fare questo occorre costruire uno spazio, danzare, imitare, dipingersi il corpo e il volto, trasformare quell'io limitato e particolare in un doppio potenziato, divinizzato e capace di esercitare la propria influenza. La Maschera è l'epicentro di un tale cataclisma che sconvolge e rifonda il vivere quotidiano, e la sua presenza come oggetto cavo nel quale si potrà entrare e che mentirà per dire il vero, è presenza necessaria e funzionale alla sopravvivenza di un'intera comunità.
Il teatro, che scaturisce dal rito, porta con sé il potere della metamorfosi della Maschera, che restituisce all'individuo e al gruppo sociale che la produce, una dimensione oltreumana di creatore del mondo, strappando questa dimensione al regno dell'utopia. Ma è proprio il pensiero dell'utopia, come possibilità negata a priori, che rende inattuabile quell'atto creativo necessario al passaggio dalla condizione angosciosa del disagio all'impresa magica della presa di possesso del mondo.
Le patologie intervengono pesantemente a differenziare il primitivo che combatte la paura del mondo ricostruendo magicamente, dal portatore di disagio che rimane paralizzato nella propria impotenza creativa. Forse il senso di un intervento di operatori specializzati è proprio in questo: nel tentativo di rimuovere blocchi per ripristinare possibilità comunicative, facendo leva su una molteplicità più estesa possibile di stimoli nei confronti di una sensibilità che, per quanto occultata, comunque esiste. La caratteristica del teatro di essere, per natura e per origine, globalità di linguaggi, porta questa forma di espressione ad essere la più vicina alla domanda di creatività che viene dal disagio, e allo stesso tempo, la più lontana da quell'idea di creatività che caratterizza l'arte contemporanea. Il teatro richiede un forte grado di partecipazione e di condivisione laddove l'arte è individualistica; implica l'integrazione tra gli attori, e tra attori e pubblico, laddove l'arte richiede solo di essere contemplata e consumata; è funzionale ad uno scambio emozionale tra tutti i componenti di un gruppo, mentre l'arte mira a una funzione di tipo estetico soggettivo.
E non solo: in quanto mimesi della vita, il teatro può forse contribuire a risvegliare una vitalità dormiente.
Le ragioni della necessità di un teatro del disagio non risiedono dunque soltanto nelle numerose somiglianze di condizione tra l'uomo arcaico e il portatore di disagio, bensì nel potere fondante insito nel teatro stesso. Ma è prima di tutto il teatro ad aver bisogno di essere utile, di recuperare il senso delle proprie origini. In un intervento teatrale in un contesto didattico riabilitativo lo spettacolo non basta al teatro, anzi rischia di accomunare quest'ultimo alla semplice opera d'arte moderna. In un'epoca in cui produrre e consumare sono imperativi etici che dominano la fisiologia stessa delle coscienze, il teatro rischia di identificarsi con il suo prodotto: lo Spettacolo come opera d'arte finita, come oggetto da esibilre, da mostrare, perché sia consumato ed applaudito. L'applauso come prova d'acquisto di una digestione avvenuta. Occorre al teatro ripercorrere le tappe della propria evoluzione verso una forma d'arte compiuta, ritrovando la dimensione antica di espressione culturale di una comuità. In questo senso bisogna ripartire dal mito, che era necessario per spiegarsi il mondo, e inventare collettivamente una storia, per poi scandagliare ogni passaggio della narrazione, approfondire ogni personaggio fino a raggiungere la certezza della sua immagine, per poter poi costruire volti e corpi, maschere e costumi, trovarne i movimenti, i suoni,i colori, le azioni. Il risultato del percorso è una creazione collettiva in cui le tracce di ogni apporto individuale, fondamentali per il processo creativo, si perdono nella creazione generale, nel suono orchestrale del tutto, nel quale le voci dei singoli strumenti dell'orchestra sono riconoscibili ma acquistano il loro senso compiuto soltanto nel suono generale dell'insieme. Il senso della necessità dello spettacolo non sta dunque nello spettacolo in sé, ma nel percorso ontogenetico dello spettacolo stesso. Necessari non sono né la performance né l'entertainement, bensì il fare teatro, per il potere aggregante che ripercorrere il cammino dal mito alla messa in scena comporta e per i riflessi che la necessità di comunicare implica nel suo attuarsi.
Quando nella prefazione a Il teatro e i suo doppio Antonin Artaud lamentava una perdita di senso della cultura da parte del mondo moderno, attribuiva la colpa di tale perdita a una precisa idea occidentale dell'arte, in particolare agli ideali estetici della vecchia Europa responsabili di aver allontanato arte e teatro dalla loro essenza magica capace di fondare linguaggio. Nell'attività di drammatizzazione in contesti extrateatrali, il teatro può e deve recuperare il proprio valore di esperienza rinunciando ad identificare il proprio ruolo con lo spettacolo, e rinunciando anche alla prassi consueta del teatro moderno, dove un regista sceglie un gruppo di attori, di scenografi, di musicisti, per attuare una propria idea di messa in scena più o meno innovativa, più o meno efficace, più o meno valida a giudizio dei critici. Proprio il territorio del disagio può dare al teatro la possibilità di riscoprire modalità diverse da quelle del teatro di regia. Diverse e oramai dimenticate; tanto diverse da riavvicinarlo miracolosamente alle proprie origini rituali, quando era un villaggio, un gruppo, e prima ancora una tribù a produrre quella forma di evento, festa, danza e rito che solo molto più avanti avrebbe trovato una struttura definitiva, e con essa il nome stesso di teatro. Il rito perduto era emanazione di una collettività che della rappresentazione produceva tutto: la storia da raccontare, la musica da suonare, i personaggi da far agire, trasformando se stessa per diventare altro: non più branco sperduto di fronte a un orizzonte ignoto, ma avi fondatori, dèmoni onnipontenti, serpenti piumati, capaci di piegare le forze della natura e di modellare il mondo per renderlo conoscibile, accettabile, meno spaventoso, meno ignoto. La necessità di cui si ammanta il teatro primordiale è necessità di magia, necessità di conoscenza, di sopravvivenza, ma questa non è prerogativa esclusiva dell'alba dell'umanità. Vi è una necessità di teatro ogni volta che si voglia plasmare la vita per superarne la limitatezza. La necessità del teatro è la necessità del sogno. E come il sogno fonda realtà parallele libere dai limiti, così il teatro crea legami tra individui, manipola i linguaggi interiori per renderli esternabili, obbliga l'azione di ciascuno a fondersi, a dipendere, a risultare dall'azione di altri; costringe i singoli esseri ad esserci, qui e ora, condividendo una contemporaneità che sfugge alla "vita normale". E il potere fondante della storia inventata insieme diventa potere aggregante dell'azione scenica; l'azione individuale si fa gioco di squadra; i corpi diventano portatori di segni e i gesti segnali che vogliono comunicare; la performance è avventura vissuta insieme e la gratificazione dell'applauso diviene ricordo e spinta alla ripetizione del gioco. Nel teatro che nasce dalla necessità di riabilitare, di risvegliare la comunicazione decade, il ruolo di interprete del regista, in nome di una evocazione-scrittura collettiva, che nasce come emanazione diretta di un gesto creativo unitario che trova in se stesso, e non nella prospettiva dell'essere osservato, la propria ragione di esistere: il momento espressivo crea a sua volta legami, stabilisce intese, fonda realtà coesive prima non verificabili. Nel momento dell'uscita all'esterno tutta l'energia investita nello sforzo della comunicazione rimbalza poi sul pubblico per tornare a ridistribuirsi sul gruppo, ma il momento veramente importante, imprescindibile è il mentre e non il prodotto. E questo avvicina ancora una volta il teatro del disagio al teatro delle origini.
Tutto questo descrive le dinamiche di una scena che vive fuori dal teatro, in contesti estranei e di confine. Allora viene da chiedersi quanto quel teatro di regia in cui un singolo si pone come organizzatore del materiale in una forma che è quella della comunicazione in senso artistico, borghese, del prodotto, abbia da dare a se stesso e a quegli ambiti ai quali si ritenga opportuno estenderlo, e quanto invece le esperienze di drammatizzazione in contesti scolastici, come pure nei territori del disagio, nei quali si sperimentano una dimensione e una funzione primordiali del teatro, abbiano da dare al teatro stesso.
La risposta forse non è nei nostri palchi a teatro, ma tra le rovine assolate e mute di Epidauro. Epidauro: una città piccolissima con un teatro di 12.300 posti, il più grande teatro che il modno greco abbia mai avuto. Tra gli scavi migliaia di ex voto provenienti da tutta l'Asia minore, e decine di lapidi ci ricordano che qui, nel teatro/santuario, Asclepio, nume misterioso e ctonio, padre di tutte le cure, faceva guarire "col sonno e col sogno".
LA COOPERATIVA C.RE.A
La coop. C.RE.A lavora da oltre dieci anni nel settore dell'handicap ed ha condotto progetti nel campo della formazione e preformazione professionale e delle attività occupazionali e di socializzazione. Le attività si sono sempre caratterizzate per una grande apertura e confronto con il contesto sociale ponendosi come tramite per quel processo di integrazione/normalizzazione che è l'obbiettivo primario dei nostri interventi nel campo dell'handicap. La cooperativa si propone di attirare nuove risorse e investirle nella produzione di benessere sociale. Tramite varie articolazioni si propone di accompagnare le persone attraverso l'individuazione, le scelte e la pratica di ruoili molteplici nel processo di ricomposizione della propria vita. Promuove attività lavorative nel settore socio assistenziale attraverso il perseguimento di obbiettivi di efficacia e di efficienza nella pianificazione e gestione dei servizi impiegando personale qualificato; realizza integrazione sociale e promozione del benessere dei soggetti svantaggiati in quanto parte integrante di una comunità educante che promuove l'autonomia dei cittadini/utenti attraverso i servizi erogati facilitando la messa in rete e la fruizione delle risorse del territorio, diventando essa stessa risorsa.
E-mail giocoraggio@supereva.it
GIOCORAGGIO
Giocoraggio è un CDSD, ovvero un Centro di Socializzazione per Disabili attivo dal 1998 e finalizzato ad offrire uno spazio educativo e di socializzazione tale da favorire l'acquisizione e il mantenimento di abilità relazionali, sociali e cognitive rispettando e valorizzando le capacità di ciascuno. Uno degli obiettivi è la sperimentazione di diverse attività manuali ben integrate fra di loro per realizzare un progetto unitario, come ad esempio lo spettacolo.
TUTTO COMINCIO'
Il centro diventa una tribù che inventa un proprio mito sulla creazione del mondo.

Nascono personaggi fantastici che vengono subito costruiti in cartapesta .Si cercano i loro suoni; le loro voci, i loro movimenti fino a farli vivere sulla scena. Lo spettacolo viene replicato più volte in luoghi diversi e gli "attori" scoprono il gusto della "tournée" in contesti normali, ovvero senza alcuna etichetta che ne ghettizzi la provenienza.

Foto di Andrea Dalle Luche
DIVERSO
La proposta, che parte dalla scuola media Viani di Viareggio di un esperimento di integrazione tra il centro e una classe della Seconda Media, è stata l' occasione per un laboratorio biennale sulla diversità, sulla paura e sul mostruoso di cui lo spettacolo è il risultato. Il serpente senza fine del tempo avverte un fastidioso prurito che lo obbliga ad avvolgersi su se stesso e quindi a sospendersi. Causa del malessere l'eterna stupida lotta tra il bene e il male.
Il tempo chiuso in cerchio si fa teatro che ospiterà le vicende di un bambino primordiale , unico essere con testa, gambe e braccia in un mondo arcaico popolato di fantasiosi mostri nati dalle paure degli dei e dai sogni degli uomini, che si confronterà con la propria diversità.

Frame da video di Duri Cuonz
The Merchant of Venice con la regia di Trevor Nunn
Lo spettacolo del National Theatre dal Cottesloe all'Olivier
di Vera Cantoni
Al Teatro Olivier di Londra il 21 febbraio anteprima di Love's Labour's Lost, con la regia di Trevor Nunn. Si tratta dell'ultima regia di Trevor Nunn come direttore del National Theatre. Nunn è stato direttore artistico della Royal Shakespeare Company dal 1968 al 1986, quando era stato costretto a dimettersi, dopo le accuse di aver commercializzato la compagnia con produzioni da West End, come i fortunatissimi Cats, Nicholas Nickleby (1981) o Les Miserables. Nel 1992 aveva ben sei spettacoli sulle scene del West End. Direttore del National Theatre dal 1997 (avrebbe dovuto mantenere la carica fino al marzo 2003), anche in questo caso, è stato accusato dalla stampa di arricchirsi vendendo ai teatri commerciali le produzioni del National Theatre. All'atto delle dimissioni, Trevor Nunn ha lasciato al teatro un fondo di 4 milioni di euro, destinati all'allestimento di nuove opere.
Tra le produzioni del National firmate Trevor Nunn, A Streetcar Named Desire, The Coast of Utopia, South Pacific, The Relapse, My Fair Lady, Albert Speer, Summerfolk, The Merchant of Venice e Troilus and Cressida.
Vera Cantoni, laureata brillantemente in Lettere presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, ci illustra in questo saggio lo spettacolo di Nunn The Merchant of Venice; la Cantoni ha analizzato le due diverse versioni dello spettacolo, quella realizzata al Cottesloe (di cui ha potuto visionare il prompt book) e quella dell'Olivier (esiste anche un film tratto dallo spettacolo, per la regia dello stesso Nunn e realizzato per la televisione britannica, ricostruito in set). Si tratta anche di due spazi scenici estremamente diversi: lo "Shakespeare da camera" pensato per il Cottesloe è stato necessariamente trasformato per l'Olivier a causa dellla enorme differenza di grandezza del palco.
Vera Cantoni ha cercato di definire alcuni "macro temi" e il loro trattamento registico nelle due versioni: il rapporto con il testo (il numero di versi troncati, sospesi, o ancora spostati o attribuiti a un altro personaggio), l'utilizzo dello spazio scenico, la recitazione, i costumi, la posizione del pubblico, l'immagine dell'ebreo Shylock. L'opera di Shakespeare ha spesso offerto lo spunto per parlare a teatro dei problemi legati al razzismo, alla non integrazione delle minoranze o di soggetti a rischio di emarginazione. (n.d.r.)
Gli spettacoli che nascono nel contesto di un teatro stabile inglese, a meno che siano inseriti in specifici progetti di tournée, sono in genere destinati a legare tutta la propria durata ad un unico spazio scenico, e così doveva essere in origine anche per Il mercante di Venezia messo in scena nel 1999 da Trevor Nunn con l’NTEnsemble99. Un enorme successo di pubblico e critica ha però spinto il National Theatre a riprendere lo spettacolo in una sala più capiente, ma anche strutturalmente diversa, poco dopo la data di chiusura prevista, un’interessante "riapertura" a metà strada fra un semplice prolungamento delle repliche ed un vero e proprio secondo allestimento della medesima messinscena: al primo la avvicina la quasi totale identità del cast, in direzione opposta muove l’adattamento ad un luogo scenico completamente diverso, con modifiche ancor più radicali di quelle normalmente richieste da una tournée, che in genere visita teatri relativamente omogenei per struttura e dimensioni. Quando poi, l’anno successivo, le stesse ragioni hanno spinto a produrre una versione filmata dello spettacolo per la televisione e il mercato dello home video, per alcuni aspetti si è tornati alle scelte iniziali, e per altri sono stati necessari nuovi cambiamenti.
1. La scenografia
A subire i cambiamenti più evidenti è stata la scenografia, come era inevitabile poiché le tre versioni dello spettacolo corrispondono ad altrettanti luoghi diversi per dimensioni (una sala per un massimo di 300 posti, una da 1150, e la virtuale illimitatezza del video) che per disposizione (un teatro tipo studio, uno "ad arena", e di nuovo una situazione indefinita con le riprese sul set).
Più specificamente il Cottesloe, in cui è nata questa messinscena, è una sala rettangolare relativamente piccola che grazie ai sedili mobili può essere articolata di volta in volta in maniera diversa ridistribuendo le zone destinate al pubblico e agli attori secondo le scelte di registi e scenografi. In questo caso (vedi la figura 1) il pubblico occupa la parte centrale dei due lati più lunghi della sala su tre livelli, mentre lo spazio scenico include le due estremità e la zona al centro della sala, compreso uno stretto passaggio fra i posti a sedere su entrambi i lati, nonché il terzo lato all’altezza delle prime gallerie: agli spettatori è così concesso uno spazio minimo, rispetto alle potenzialità dell’auditorium, mentre sono i luoghi scenici ad occupare l’intera sala, circondando il pubblico su tre lati.
Alla diversità strutturale dell’Olivier, che riprende lo schema dei teatri classici, con koilon, orchestra e proskenion, si è unita per Il mercante di Venezia una particolare scelta nel suo utilizzo, tendente a limitare piuttosto che ad espandere i luoghi scenici. L' "orchestra" infatti è stata ricoperta con un piano d’ardesia trasformandola in una sorta di proscenio, in modo tale da ottenere un palcoscenico paragonabile a quelli dei teatri all'italiana, rispetto al quale le estremità delle gradinate sono posizionate come dei palchi di proscenio (vedi la figura 2).
Nel caso delle riprese televisive infine non vi sono inquadrature o movimenti di macchina che permettano di ricostruire il set nel suo complesso: le scelte di montaggio sfruttano la possibilità del video di non definire i luoghi in cui è ambientato.
La scenografia originaria prevede tre aree costituenti all’interno della spazio scenico un sistema quasi a luoghi deputati: Belmont, il Ghetto, i luoghi pubblici. Tali zone possono sovrapporsi ampiamente, e anche arrivare a occupare tutto lo spazio a disposizione, ma appaiono comunque generate da un punto preciso. Il palazzo di Portia si colloca sul lato della comune, ed è caratterizzato da pochi pezzi di arredamento art déco, mentre illuminazione e rumori possono ricrearne la veranda (II.1, V.1). All’estremità opposta, la casa di Shylock e i suoi dintorni: la parete è occupata quasi interamente da saracinesche abbassate, per gli interni cala dall’alto una lampada rossa decorata con una stella di David e vengono eventualmente introdotti dei semplici mobili (una sedia, un tavolino). Nell’area centrale si sviluppano invece i luoghi pubblici: tavolini e sedie rappresentano per metonimia un caffè; con l’aggiunta di un pianoforte, una batteria e un microfono, un night-club; luci e suoni evocano il molo su cui è ambientata III.1; il tribunale è reso con una scrivania e una poltrona per il doge, un tavolo per gli avvocati e alcune sedie che strutturano lo spazio definendo inequivocabilmente il posto dell’imputato, del pubblico, e così via. La pavimentazione riproduce lastre di marmo variegate per colore e dimensioni e rimane costante per l'intero spettacolo, modificata solo dalle diverse illuminazioni. Sedie, tavolini e oggetti sono portati in scena e fuori dai protagonisti stessi, e gli unici elementi automatizzati visibili sono la lampada della casa di Shylock e il dipinto klimtiano che copre la parete di Belmont nelle scene degli scrigni.
Nell’Olivier invece i fondali vengono sostituiti, o meglio in genere sovrapposti, facendoli scorrere su ruote in un breve momento di buio fra una scena e l'altra, mentre i pezzi d'arredamento vengono cambiati dalle comparse in costume di camerieri. Il passaggio a questa sala ha comportato modifiche riconducibili sostanzialmente a due differenze fra i palcoscenici: le dimensioni e l'orientamento. Dalla prima, accentuata fra l'altro dal fatto che l'Olivier venga usato sempre nella sua interezza, mentre il Cottesloe risultava quasi diviso in diversi luoghi deputati, discendono il frequente aumento delle distanze fra i diversi elementi scenografici (per esempio in I.2 e III.4), la moltiplicazione di tali elementi (per esempio tavolini e sedie nei vari caffè e club) e nel caso dell’arredamento di Belmont la scelta di mobili dello stesso stile ma più voluminosi (una poltroncina al posto di una sedia e così via). Il problema dell'orientamento presenta una certa ambiguità, giacché esso risulta univoco nell'Olivier, dove il pubblico è disposto solo ad un lato del palco, ma molteplice nel Cottesloe, dove gli spettatori occupano due lati opposti, e per di più solo nella zona centrale. Resta comunque indiscutibile che i due teatri richiedano in questo senso una diversa disposizione degli elementi scenici, in particolare in relazione alle pareti di fondo: nell'Olivier una, sul lato più lungo, ineludibile, nel Cottesloe due, sui lati più corti, e con la possibilità di limitare l'azione al centro della scena, senza alcun fondale. Ne conseguono scenografie talvolta semplicemente ruotate di 90° (il tribunale in IV.1), talvolta interamente ridisposte. È questo in particolare il caso delle scene degli scrigni (II.7, II.9, III.2), la cui ambientazione ha un che di solenne e rituale, ancorché prettamente laico: due inginocchiatoi, una copia della prima parte del Fregio di Beethoven di Klimt (L’anelito alla felicità), una tenda dal soffitto a terra, che inizialmente copre il mobiletto sui cui tre ripiani trasparenti sono poste le possibili scelte. La rigorosa geometria della disposizione di questi elementi ha dovuto subire notevoli modifiche per essere adattata ad un palco completamente diverso, come dimostrano le figure 3 (Cottesloe) e 4 (Olivier). Alla disposizione in profondità, che sottolinea il percorso dai due inginocchiatoi agli scrigni e al quadro, inizialmente nascosti come il cuore e la parte più sacra di un tempio, si sostituisce sul palco più vasto una composizione tendenzialmente bipolare, con gli scrigni e gli inginocchiatoi in posizione quasi simmetrica e solo il dipinto a sottolineare la preminenza dei primi. Anche la tenda non li cela più a sguardi indiscreti, sostituita all'inizio delle scene interessate dalle cameriere schierate, schermo ben più umano e meno imponente.
Per quanto riguarda i passaggi da una scena alla successiva il video segue decisamente l'uso televisivo e non documenta in alcun modo le modifiche al set, staccando invece da un'immagine ad un'altra completamente diversa. I problemi di dimensione e orientamento sono in questo caso risolti dalla libertà dei movimenti di macchina e dalla possibilità di delimitare uno spazio di dimensioni varianti da una scena all'altra, per cui da questo punto di vista il video può rappresentare una sorta di scelta incondizionata di regista e scenografo: luoghi più circoscritti per le stanze del palazzo di Belmont, per la casa di Shylock e per il bar del Ghetto (I.3), più vasti per gli esterni e il tribunale; la disposizione di oggetti del Cottesloe per la scena degli scrigni, ma con la possibilità di variarne la prospettiva, che poi nelle scene del tribunale fa sì che non si possa parlare affatto di un orientamento della scena. Più in generale, i luoghi del video sono meno definiti, dal momento che quasi mai ne viene data un'inquadratura complessiva né vengono descritti dai movimenti di macchina, che al contrario tendono a frammentarli rendendoli difficilmente riconoscibili. Questa scelta fa parte di una tendenza generale a cercare una sorta di equilibrio fra le esigenze della televisione e quelle originarie dello spettacolo teatrale, per cui le scenografie usate sono spesso le stesse per luoghi diversi, come in teatro, ma inquadrature, illuminazione e montaggio collaborano nel renderle difficilmente riconoscibili, così come si mescolano elementi di stilizzazione teatrale e di realismo televisivo. Una sorta di compromesso è realizzato ad esempio nelle molte scene ambientate in caffè e locali notturni. Si è accennato al fatto che in teatro essi sono rappresentati per metonimia da pochi tavolini con sedie, talvolta solo uno. Per le riprese, tali elementi vengono moltiplicati fino a raggiungere un numero credibile, ma nello stesso tempo la stilizzazione teatrale viene in parte mantenuta col non arricchire la scena di altri elementi (quali un bancone o simili): anche nel caso delle stanze di I.2 e III.4, in cui sono aggiunti alcuni pezzi di arredamento, essi arrivano a soddisfare la necessità di non lasciare troppi spazi vuoti nell'immagine, senza peraltro costituire un tutto realistico.
In conclusione si può dire che le scenografie, pur adattate alle diverse situazioni, siano state validamente mantenute in linea con la loro concezione iniziale.
2. Le comparse e la posizione del pubblico
Cambiamenti affini a questi ultimi si possono riscontrare nel cast: il realismo richiederebbe la presenza nei locali pubblici di altri personaggi oltre a quelli al centro della vicenda, e nella stessa direzione pesa nell'Olivier la necessità di riempire uno spazio scenico molto più vasto di quello del Cottesloe, nel quale le comparse sono veramente pochissime. Nel complesso, tuttavia, l'horror vacui televisivo e le esigenze di un palco più vasto non hanno vanificato l'essenzialità stilizzata della messinscena originaria, i personaggi aggiunti sono pochi, e in quasi tutti i casi non sono altro che la moltiplicazione di figuranti presenti fin dall'inizio. L'eccezione che salta subito agli occhi sono i "magnifici" previsti da Shakespeare per la scena del tribunale (IV.1), eliminati nel primo teatro ma reintrodotti nelle altre due versioni, dai quali si può prendere spunto per una riflessione più ampia. Si tratta di figure mute, in qualche modo ambigue perché da un lato dotate di autorità e dall'altro private di ogni potere concreto dalla sostanziale estraneità all'azione: autorevoli testimoni, giudici impossibilitati ad eseguire la loro sentenza. Questa descrizione non può non ricordare il ruolo che ha in questa fase il pubblico, che partecipa emotivamente al processo, ne giudica i protagonisti, ma non può intervenire nella loro vicenda, anche se quella scena si svolge proprio per lui ed ha in lui il suo interlocutore privilegiato. Se poi si prende in considerazione la posizione attribuita ai seggi dei senatori sulla scena dell'Olivier vi si trova una chiara conferma di questa interpretazione: al posto dei giurati nel Cottesloe ci sono degli spettatori, ciascuno interpretando questo ruolo per quelli di fronte e al tempo stesso rispecchiandovisi egli stesso. Ciò non è possibile, naturalmente, nell'Olivier, sia per il numero che per la collocazione degli spettatori, e tanto meno nel caso delle riprese televisive, per le quali spazio e tempo degli spettatori sono necessariamente diversi da quelli degli attori.
Il coinvolgimento degli spettatori in questa scena spinge poi a considerare tutte le altre, e a notare come tutte le scene ambientate in luoghi pubblici si svolgano nel Cottesloe nella parte centrale della sala, con tavolini e sedie posti sullo stesso piano e a breve distanza dai sedili del pubblico, così trasformato nella comunità veneziana che quei luoghi frequenta. Il ruolo affidato in questo modo agli spettatori non è peraltro connotato da particolari legami con una parte dei personaggi. In particolare se nelle scene ambientate nei caffè e nel cabaret (I.1, II.2, II.4, II.6, II.8) il pubblico condivide gli svaghi dei giovani veneziani (e in particolare in II.6 si trova a guardare lo stesso spettacolo e a ridere delle stesse battute, il cui oggetto è Shylock), in I.3 costituisce la popolazione ebraica del ghetto. D'altra parte al pubblico non è concessa alcuna possibilità d'intervento, e i senatori al processo rappresentano anche questo aspetto della condizione spettatoriale, indignandosi o solidarizzando con gli esseri umani che osservano ma senza mai poter esprimere con parole o azioni efficaci le loro opinioni.
Questo è evidentemente l’aspetto dello spettacolo che più è stato messo a rischio dal trasferimento all’Olivier e poi in televisione, con un graduale allontanamento, fisico e psicologico, degli spettatori dagli attori. Tuttavia bisogna riconoscere che grazie ad un consapevole sforzo di mantenere il rapporto stretto fra scena e platea che si era creato nel Cottesloe, l’intimità della messinscena è rimasta in gran parte intatta, anche sfruttando le possibilità proprie dei nuovi contesti (ad esempio nelle riprese lo sguardo in macchina).
3. La recitazione e il trucco
Il mutato rapporto con il pubblico nelle diverse situazioni si manifesta naturalmente anche nell'impostazione della recitazione e nei suoi cambiamenti. I due teatri hanno in comune il fatto che non è possibile nascondervisi, nel caso del Cottesloe per la minima distanza che separa il pubblico dagli attori, nel caso dell'Olivier perché la scena è quasi circondata dalle gradinate su tre lati. Tuttavia ben più grosse sono le differenze dovute alle dimensioni, che impongono nell'Olivier voci più potenti, movimenti più chiari ed ampi, e insomma una generale enfatizzazione e semplificazione della recitazione. Personaggi come Morocco e Arragon, le cui parole e azioni avevano già "dimensioni" notevoli, non vi hanno dovuto subire grosse modifiche, ma il lavoro più sottile su Shylock, Portia o Antonio è stato sicuramente appiattito e "teatralizzato" nello spostamento, per non parlare degli ammiccamenti del clown. Più ambiguo è l'effetto sulla recitazione del passaggio alle riprese televisive: senz'altro le distanze si restringono di nuovo, superando in vicinanza il Cottesloe stesso con la possibilità dei primi piani, ma ciò non si traduce esclusivamente in una recitazione ancora più intima e sotto le righe. Il mezzo televisivo, infatti, riduce la distanza dell'immagine ma aumenta quella della persona in sé, se così si può dire, e quest'osservazione teorica è tutt'altro che sterile: la mancanza della compresenza fisica, così come i limiti imposti alla visione da inquadrature e montaggio, annullano tutta una serie di mezzi espressivi legati, ad esempio, alla prossemica tridimensionale della scena, e richiedono di conseguenza un cambiamento non sempre in direzione di una maggiore interiorizzazione. L'interpellazione dello spettatore si deve esplicitare con uno sguardo in macchina, dal momento che non vi è altro modo di avvicinarsi al pubblico, e se i gesti possono essere ridotti e sfumati rispetto a quelli richiesti da un teatro come l'Olivier, i volti in primo piano richiedono un’intensificazione espressiva che concentri nel viso quanto comunicava sulla scena l'intero corpo.
Un cambiamento connesso a quelli recitativi è sicuramente avvenuto nel trucco degli attori, ma è quello su cui meno si può dire: obiettivo delle modifiche è infatti, in questo caso, il renderlo in generale impercettibile o comunque apparentemente immutato. Nel video i costumi, le pettinature e il trucco dei personaggi cambiano molto di più fra le scene, non essendo condizionati da pressanti esigenze di velocità di mutamento, ma rimangono sostanzialmente in linea con le scelte della messinscena teatrale. Un caso particolare è dovuto non tanto ai diversi mezzi a disposizione nei due casi quanto alle loro diverse convenzioni e regole di opportunità. Tubal in scena sfoggia una lunga barba rossa, folta e non molto curata, che rimanda allo stereotipo comico dell'ebreo assai diffuso nel teatro inglese fra sedicesimo e diciottesimo secolo, mentre in televisione appare perfettamente rasato, e per di più bruno di capelli. Senz'altro il trucco adottato per questo personaggio in teatro sarebbe risultato troppo pesante in televisione, ma ciò che si verifica non è un suo alleggerimento, bensì la sua completa scomparsa. La spiegazione di questo mutamento non risiede dunque nel diverso codice estetico, bensì nel diverso codice morale: anche se nei fatti Tubal non riproduce certo quella macchietta razzista, il politically correct televisivo non permette nemmeno di citarla sul piano dell'immagine, neanche per confutarla.
4. Il testo
La riduzione del testo per le riprese televisive è stata complessivamente di 600 versi (equiparando un verso e una riga di prosa nell’edizione Arden) sui 2417 totali. In termini di tempo lo spettacolo teatrale durava circa tre ore, intervallo escluso, mentre la videocassetta è di 161 minuti: dunque i tagli riguardano in maggioranza le parti parlate, piuttosto che l’azione muta. Ciò può costituire una conferma del fatto che obiettivo principale del video è la registrazione di questa specifica messinscena, piuttosto che una generica resa televisiva del Mercante di Venezia, nonché dell’importanza assunta dall’azione muta nella regia di Trevor Nunn. La piccola differenza di durata spinge inoltre a pensare che l'abbreviazione non fosse l'unico scopo (e forse nemmeno quello principale) di tale operazione. Dall'esame delle parti scartate emerge infatti ben più forte la tendenza a semplificare, non solo il testo (l'eliminazione di passi dall'interpretazione controversa si potrebbe dare quasi per scontata), ma anche i personaggi e i loro rapporti. In genere sono state eliminate le complesse sequenze di immagini che caratterizzano soprattutto i monologhi piuttosto che i momenti di dialogo, e se questa scelta potrebbe essere letta anche come il sacrificio sull'altare della funzionalità di tutto ciò che può essere giudicato ornamentale, a parte il fatto che la poesia non è certo un elemento accessorio nell'economia del teatro shakespeariano, le conseguenze dei tagli operati non possono essere ignorate, e l'analisi di alcune di esse mostra come si prestino ad altre coerenti interpretazioni.
Innanzitutto non è trascurabile che la parte di Shylock, per molti versi il protagonista dello spettacolo, sia notevolmente meno ridotta delle altre (circa 40 versi su quasi 350), e con un unico taglio esteso: 11 versi in I.3, la narrazione dell'episodio biblico dell'espediente di Giacobbe. Le modalità con cui questo monologo viene accorciato esemplificano fra l'altro un’interessante tecnica utilizzata anche altrove nelle riprese: è Antonio a interrompere Shylock con la sua osservazione. In questo modo alla perdita di un brano più o meno lungo di testo corrisponde invece una nuova occasione espressiva, in questo caso per esempio dell'insofferenza di Antonio per Shylock.
Assai proficuo risulta il confronto fra due personaggi dai ruoli paralleli, Morocco e Arragon, i due pretendenti sfortunati di Portia. Il primo perde circa il 37% dei suoi versi, il secondo il 19%, una differenza che non può non saltare all'occhio. Per spiegarla si potrebbe ricorrere al fatto che in origine la parte di Morocco è molto più lunga, e i diversi tagli la rendono grosso modo equivalente a quella di Arragon, ma basterebbe a spingere in direzione contraria il fatto che alle scene di Morocco, il primo a tentare la sorte nella scelta dello scrigno, è attribuito il compito di spiegare il funzionamento di questo rito, mentre ogni illustrazione dello stesso nella scena di Arragon è una pura ripetizione (dal punto di vista degli spettatori, ovviamente). La scena di Arragon, tutto considerato una di quelle meno ridotte, è però stata piuttosto uniformemente giudicata la più divertente dell'intero spettacolo (le uniche voci di dissenso fra i recensori riguardano non la sua capacità di suscitare il riso, bensì le modalità e le cause di tale divertimento), ed è difficile scartare l'ipotesi che sia stato il suo carattere ai limiti del farsesco a preservarla intatta. Morocco, invece, è un personaggio problematico, almeno per la nostra sensibilità, e tutt'altro che comico. La messinscena teatrale ha risolto i problemi posti dal suo ruolo in chiave di commedia sofisticata, soluzione tutt'altro che pacifica e soprattutto tendente a complicare la psicologia sia del principe che di Portia, e che sfrutta in maniera funzionale i lunghi e complessi discorsi di Morocco (come del resto fa anche, in tono comico, la scena di Arragon). Per le riprese televisive invece la scelta è stata più semplicemente di tagliare il verso più critico (II.7.79, la conclusione razzista di Portia) e ridurre drasticamente i monologhi del principe, evitando ogni possibile questione a costo di ledere la portata della scena.
In non pochi casi sono stati scartati i momenti in cui un personaggio manifesta aspetti apparentemente contraddittori del suo carattere. In III.4 ad esempio è stata conservata la battuta che può far ridere il pubblico (vv.61-62), ma nessun altro spazio è lasciato all'espressione della dimensione del gioco nel piano di Portia (vv.65-78): l'eroina che va a salvare l'amico del marito non si può soffermare sull'aspetto divertente della sua missione. Nella scena precedente viene espunto invece il riferimento alla complessità della situazione sul piano economico-politico, che riguarda la rivalità economica di Antonio e Shylock ma soprattutto la ragion di stato e gli interessi economici della Repubblica (vv.21-31). Con la scomparsa della bugia di Jessica a Shylock (II.5.43-44) il tema del padre ingannato rimane confinato ai discorsi di Shylock stesso.
Tutta la linea tematica riguardante la fuga di Lorenzo e Jessica appare del resto piuttosto sacrificata per la rimozione della quasi totalità del loro dialogo in III.5, per la quale forse si sommano le due principali motivazioni di taglio osservate: l'eliminazione di passi in cui la ricchezza formale e poetica esorbiti nettamente dalle necessità informative e la rimozione o semplificazione di aspetti contraddittori nel ruolo dei personaggi. Lorenzo e Jessica sono figure inevitabilmente difficili, in quanto principali autori di un inganno e di un furto, ma nello stesso tempo guidati, almeno apparentemente, da una sensibilità amorosa e cortese, e insomma al centro di una scelta sofferta e problematica. La messinscena teatrale enfatizzava la drammaticità della loro situazione con il finale, mantenuto nelle riprese televisive, e i tagli operati nella loro sceneggiatura non vanno in direzione di una contraddizione di quelle scelte, ma tendenzialmente ne riducono il peso diminuendone l'impatto sul piano quantitativo.
Un'altra "vittima" della drastica riduzione di III.5 è il clown Launcelot, in assoluto il personaggio la cui parte è stata maggiormente ridotta. I dati nel suo caso diventano anche più significativi se si considera il fatto che il suo ruolo non risponde affatto a quelle caratteristiche di ricercatezza poetica che sembrano motivare molte semplificazioni. Inoltre il suo è un ruolo unico, e non inserito in una collettività come quella costituita dai giovani veneziani che, al di là delle singole personalità individuali, permette in alcuni casi di considerare complessivamente l'espressione di un punto di vista comune, attutendo così l'impatto dei tagli. A favorire una riduzione della sua parte si possono osservare la sua limitata partecipazione alle vicende principali e la sostanziale estraneità di tono rispetto al resto della commedia, giocata su intrecci e dialoghi brillanti piuttosto che su gag e battute, ma queste caratteristiche non bastano certo a spiegare un cambiamento di proporzioni simili, tanto più che la diversa comicità di Launcelot è stata resa sostanziale dalla messinscena coll'attribuirgli uno specifico ruolo di intrattenitore. Piuttosto sembrerebbe determinante la difficoltà di rendere nelle riprese l'apparenza di improvvisazione delle sue "prodezze", i suoi ammiccamenti, la fisicità delle trasformazioni nel modo di parlare e di muoversi, l'effetto spiazzante dei suoi giochi sugli altri personaggi e sul pubblico, tutto un insieme di caratteristiche legate alla compresenza di attori e pubblico e alla libertà convenzionale della tradizione del clown che non può non cozzare con la diversità di situazione ed il realismo televisivo. Inoltre, e su un piano più banalmente concreto, Launcelot sembra risentire del generale ridimensionamento della trama legata alla famiglia di Shylock, di cui principalmente fa parte.
Restando nell'ambito dei non molti personaggi direttamente legati a Shylock, merita un accenno Tubal, che in III.1 perde solo 5 versi, ma di un certo interesse. Si tratta infatti del momento tragicomico in cui le sue parole, mischiando notizie della fuga e degli sperperi di Jessica a informazioni sulle perdite di Antonio, causano nell'amico un'alternanza di sentimenti opposti. Da una parte, coerentemente con le modifiche apportate all'aspetto di Tubal, viene così cancellato il riferimento alla tradizione comica dello stereotipo teatrale dell'ebreo, dall'altra viene del pari eliminato un momento importante del percorso di Shylock. Nel corso di questa scena, sia nel dialogo con Salerio e Solanio sia in quello con Tubal, sono per la prima volta associati la fuga di Jessica con Lorenzo e la probabile inadempienza di Antonio, con un effetto di crescendo ritmico dato dagli scambi fra i due argomenti, nelle seconda parte ben più frequenti. Poiché la scena si chiude (e con essa la prima parte dello spettacolo teatrale) con la prima azione di Shylock contro Antonio, è inevitabile vedere, almeno in un'interpretazione come questa, che non fa di Shylock una semplice incarnazione del male e della crudeltà, la graduale affermazione della possibilità di vendicarsi una volta per tutte su di Antonio. In questa ottica, è drammaticamente molto interessante che a tale sviluppo contribuiscano gli amici di Antonio, che vorrebbero difenderlo, e l'unico amico di Shylock, dall'inizio alla fine contrario a tale vendetta. Drastica appare quindi la riduzione di questo personaggio, cui invece la messinscena aveva dato uno spessore superiore a quello attribuitogli dal testo con l'aggiunta del suo muto ma significativo intervento al processo.

La scena del processo
In conclusione, i cambiamenti apportati al testo per il video ne variano notevolmente gli equilibri secondo tre principali vettori, naturalmente fortemente connessi fra di loro. Per cominciare, la tendenza a rendere relativamente più asciutto il dialogo ha per effetto un appiattimento dei personaggi per i quali la ricchezza poetica è un tratto caratterizzante, come Morocco, Lorenzo, la coppia costituita da Portia e Bassanio rispetto a quella formata da Nerissa e Gratiano, nonché un generale smussamento della contrapposizione fra il mondo cortese e quello mercantile. Di molte figure, inoltre, risultano in ombra i tratti di ambiguità. Per finire, e per molti aspetti come risultato delle due tendenze appena sintetizzate, assume una netta preminenza la trama "giudiziaria" (indicativo il fatto che la lunghissima scena del processo abbia perso solo un decimo dei suoi versi), sia sul piano contenutistico, data la riduzione degli spazi dedicati a quella sentimentale, sia su quello strutturale, con la semplificazione delle possibili contraddizioni psicologiche in favore di una più chiara consequenzialità di atteggiamenti ed azioni.
Conclusioni
Nel complesso la vicenda del Mercante di Venezia diretto da Trevor Nunn costituisce un esempio positivo di come un’idea di messinscena possa mantenere intatto il suo spirito, pur perdendo gradualmente la vicinanza col pubblico che ne era fondamento, grazie allo sforzo di conservare anche in un teatro meno intimo e poi nelle riprese televisive l’atmosfera e l’atteggiamento che da quella strettissima prossimità erano nati. Il suo percorso può però esemplificare anche il pericolo che nel passaggio dalla scena al video non viene dalle diverse condizioni e tecniche, bensì dalle esigenze specifiche della televisione, che tende a richiedere una sorta di semplificazione dello spettacolo, non per l’impossibilità di realizzarlo nella sua forma originaria bensì per adeguarlo al minore impegno intellettuale che presuppone nello spettatore. Ancora una volta, insomma, al lodevole tentativo di amplificare il pubblico di un’opera si accompagna la tentazione di snaturarla per renderla più appetibile.
Riapre il Teatro Na Dubrovka, torna in scena Nord Ovest
A pochi mesi dalla strage nella sala di Mosca
di Redazione ateatro
"Una battuta ricorrente tra di noi era: ‘conservate il biglietto, così, la prossima volta, potrete vedere lo spettacolo fino alla fine’", ricorda Georgij Vassilev, produttore e regista di Nord Ovest
Il teatro di Mosca dove il 25 ottobre 2002 si è consumata la strage di sequestratori ceceni e di ostaggi ha riaperto i battenti, tra imponenti misure di sicurezza. Qualcosa è cambiato (le poltrone e la moquette della platea sono blu, la buca dell’orchestra è più vicina alla prima fila), ma lo spettacolo resta lo stesso, il musical Est Ovest. Per il produttore e regista, lo spettacolo doveva tornare in scena. Anche se il primo nome sulla targa che ringrazia coloro che hanno aiutato a riaprire il teatro è quello di Vladimir Putin, i fondi per la riapertura sono arrivati per l’ottanta per cento dai privati e solo per il venti per cento dallo stato.
"Sono contento di tornare sul palcoscenico", ha dichiarato Andreij Bogdanov, attore ed ex ostaggio, "ma c’è come un retrogusto di ricordi che tornano spontaneamente. Su una delle passerelle sulla scena c’è un foto di proiettile che non abbiamo potuto riparare".
Città in condominio
Progetto di reading
di Out Off
da dove comincia la guerra
cosa ci sta in mezzo
continuare a vivere fino alla fine
primo coro 3 marzo
secondo coro 10 marzo
terzo coro 17 marzo
a cura di Renata Ciaravino, Renata Molinari, Renato Gabrielli, Giampaolo Spinato, Roberto Traverso
coro di scrittori ma anche coro di voci dalla città
persone, incroci, storie, vite in condominio
l’origine della guerra, nei giorni: il conflitto che
ci portiamo addosso
quello che sta nel mezzo
le pareti per separare, proteggerci, isolarci anche
le stesse pareti che prolungano, nella nostra casa, le case degli altri
luoghi e modi di condurre la vita
che continua
Teatro Out Off, via Dupré, 4 Milano ore 21.00
Ingresso libero
Informazioni tel. 02.39262282
teatro-outoff@libero.it
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
Le segnalazioni di tnm
Stelle della sera, exibart, the great war
di Redazione tnm
sabato 15 febbraio 2003, ore 21
Teatro Petrella, Longiano (FC)
STELLE DELLA SERA
uno spettacolo di Gabriele Frasca e Roberto Paci Dalo'
regia, musica, scene: Roberto Paci Dalo'
testo: Gabriele Frasca
con: Michele Chiaruzzi, Azzurra Migani e la voce di Nicoletta Fabbri
live video: Filippo Giunchedi
luci: Nevio Cavina
software live video: Tom Demeyer - STEIM Amsterdam
assistente alla regia: Laura Casadei
produzione Giardini Pensili
in collaborazione con Serrateatro
con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini
[ anteprima nazionale ]
prenotazioni: 0547 665113, ingresso euro 10
info: 348 2930262, lab@giardini.sm,
http://giardini.sm
"I due testi di Stelle della sera fanno parte di un'unica raccolta intitolata Tele: cinque "tragediole" che rappresentano altrettanti quadri di un'unica messa in scena. Si tratta, in realta', di cinque stazioni nel percorso che procede verso la dissoluzione del personaggio e la progressiva "messa in scena" dello stesso spettatore affidando all'impiego delle tecnologie teatrali (diffusori sonori variamente posizionati, luci in funzione di personaggi, musica come elemento compositivo ecc.) il compito di creare un'atmosfera tesa e fortemente orientata sulle reazioni dello spettatore. Queste tragediole si offrono non solo come una piccola, replicabile "mostra delle atrocita'" ma anche e soprattutto come evocazione di un sinestetico teatro musicale, e dunque, infine, come uno studio sul concetto stesso di catarsi.
Se da un lato, dunque, e' facile reperire in questi testi la prosecuzione dello stesso parossismo tecnologico che isola le larve teatrali dell'ultima produzione beckettiana (e giusto a partire da quella televisiva), dall'altro la riduzione progressiva dello spazio scenico a "macchia" (o addirittura a materia residuale da far colare addosso a ogni singolo spettatore) trasforma l'intero ambiente teatrale (non già il solo palco) in un mondo parallelo latamente psicotico (come se insomma si finisse, dalla tranquillita' della propria poltrona, con l'essere risucchiati e "messi a fuoco" in uno schermo). Si tratta dunque di un teatro dei sensi (o delle iperstimolazioni sensoriali) e della loro camera d'eco: un teatro insomma che lavora su un coinvolgimento "fisico" e percettivo dello spettatore nell'azione, in virtu' di quel "proprio" del teatro (luci, suoni, immagini, palco, platea) assolutamente irriproducibile anche nella piu' emotivamente coinvolgente rappresentazione massmediale.
Nell'anteprima presentata a Longiano viene avviato - in una prima stesura spaziale e acustica - il lavoro di attraversamento e materializzazione scenica di queste parole.
Tele e' pubblicato dalle edizioni Cronopio
http://www.cronopio.it
Gabriele Frasca e' nato nel 1957. Ha pubblicato raccolte di versi, saggi e romanzi per Einaudi e Cronopio. Con Pinotto Fava e Luca Sossella cura la collana di testi fonografici Audiobox. Per Einaudi sta curando le traduzioni da Samuel Beckett"
R.Paci Dalò
exbibart
Su www.exibart.com,
webmagazine di arte contemporanea diretto da Massimiliano Tonelli da questa settimana parte una nuova rubrica
arteatro dedicata al territorio “mutante” di confine tra arti visive e arti performative.
Direttore della sezione: Pietro Gagliano. Tra i collaboratori (oltre alla sottoscritta...), Francesca Pagliuca, Elena Bari e Iacopo Milani.
New territories-International Festival of Live Arts
(Glasgow, 3 febbraio 15 marzo)

Sabato 15 febbraio
Hotel Modern e Arthur Sauer
The great war
suicide bombers on air. PRIMETIME a Berlino
Il nuovo lavoro di Hans-Werner Kroesinger sui Kamikaze
di Redazione ateatro
suicide bombers on air. PRIMETIME
Premiere 15. Februar 2003, 20h
Vorstellungen 16. & 18. - 23. Februar 2003, 20h
Sophiensaele, Sophienstr. 18, 10178 Berlin, Telefon 030/ 283 52 66
Konzept & Regie: Hans-Werner Kroesinger / Bühne & Kostüme: Valerie von Stillfried / Sound: Daniel Dorsch / Dramaturgie: Tom Mustroph / Mitarbeit Bühne: Carolin Senftleben / Regieassistenz: Johanna von Rigal / Produktionsmanagement: Klaus Dörr
Mit Judica Albrecht, Tjadke Biallowons, Armin Dallapiccola, Uwe Schmieder
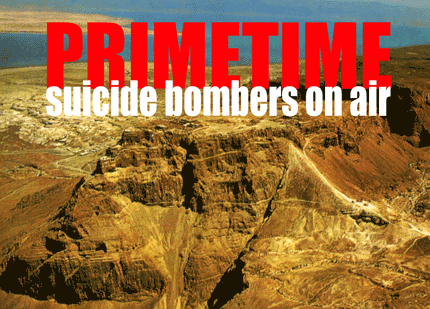
"Selbstmordattentate sind politisch motivierte Gewaltakte durch Personen, die absichtlich ihren eigenen Tod herbeiführen, indem sie sich mit dem ausgewählten Ziel in die Luft sprengen."
"Manche Männer sind bekannt geworden, weil sie sich aus Liebe zu einer Frau umgebracht haben. Wir mögen dies verstehen, aber wir halten es für dumm. Aber können Sie angesichts dessen nicht verstehen, dass sich jemand umbringt für Gott und den Sieg über die Feinde ? Das ist keine dumme Art zu sterben."
"Am schlimmsten ist es, wenn einer sich in einem Bus gesprengt hat: Diesen Geruch aus Benzin und verbranntem Fleisch wirst du erst nach Wochen wieder los. Vergessen kannst du ihn nie."
Januar 2003. Zwei junge Palästinenser aus Nablus legen ein Armenviertel in Tel Aviv in Schutt und Asche. Sie töten sich selbst und 22 andere Menschen, viele von ihnen illegale Einwanderer. Ihre Tat ist noch nicht in die im Internet abrufbare Statistik des israelischen Institute of Counter Terrorism (ICT) aufgenommen worden. 68 Selbstmordattentate zählt das ICT von April 1993 bis November 2002, 76 lebende Bomben sprengten sich in die Luft und töteten 360 Opfer. Die Hamas, eine 1988 während der ersten Intifada gegründete muslimisch-palästinensische Organisation, zählt in ihrem "Glory Record", ebenfalls via Internet abrufbar, von April 1988 bis Oktober 1994 85 Operationen auf; 16 von ihnen sind Selbstmordattacken, 22 junge Menschen geben sich als "Märtyrer" auf; manchmal sind sie erfolglos, manchmal reißen sie mehr als 20 Menschen in den Tod.
//Überprüfe vor der Reise deine Waffe. Binde deine Schuhe sehr eng zu. // Laßt uns zum Schwert greifen, solange unsere Hände noch frei sind, mögen sie uns zu einer letzten ruhmvollen Tat dienen. // Ein totes Kind kann zuweilen eine Straße blockieren, so eng sind sie, fast nur spaltbreit, und die Toten so zahlreich.//
suicide bombers on air. PRIMETIME untersucht aus der Ferne - in drei szenischen Arrangements - diese Vorgänge.
Vor etwa 50 Jahren schrieb Frantz Fanon (bezogen auf Indochina): "Der Eingeborene hat immer gewusst, dass er von der anderen Seite nichts zu erwarten hat. Die Arbeit des Kolonialherrn ist es, selbst die Freiheitsträume des Kolonisierten unmöglich zu machen. Die Arbeit des Kolonisierten ist es, sich alle nur möglichen Kombinationen zur Vernichtung des Kolonialherrn auszudenken." Fanon kam zu dem Schluss: "Die Gewalt des Kolonialregimes und die Gegengewalt des Kolonisierten halten sich die Waage und entsprechen einander in einer ausserordentlichen Homogenität."
(aus: "Die Verdammten dieser Erde")
Eine Produktion von SBOA in Koproduktion mit Sophiensæle und dem Forum Freies Theater Düsseldorf. Gefördert durch die Senatsverwaltung für Forschung, Wissenschaft und Kultur und die Stiftung Kunst und Kultur des Landes NRW.

